“Prima o poi, ci scappa il morto”. Una frase a mezza bocca, per non svegliare i cattivi spiriti. E non evocare parole della nostra storia, lontana, diversa e archiviata: squadracce, spedizioni punitive, prenderne uno per educarne cento. Prima o poi…. Dà il senso del tempo che scorre, dei grani di sabbia che riempiono la clessidra.Read more
Mese: luglio 2016
Il punto di non ritorno
“Prima o poi, ci scappa il morto”. Una frase a mezza bocca, per non svegliare i cattivi spiriti. E non evocare parole della nostra storia, lontana, diversa e archiviata: squadracce, spedizioni punitive, prenderne uno per educarne cento. Prima o poi…. Dà il senso del tempo che scorre, dei grani di sabbia che riempiono la clessidra.Read more
Il punto di non ritorno
“Prima o poi, ci scappa il morto”. Una frase a mezza bocca, per non svegliare i cattivi spiriti. E non evocare parole della nostra storia, lontana, diversa e archiviata: squadracce, spedizioni punitive, prenderne uno per educarne cento. Prima o poi…. Dà il senso del tempo che scorre, dei grani di sabbia che riempiono la clessidra.Read more
Il punto di non ritorno
“Prima o poi, ci scappa il morto”. Una frase a mezza bocca, per non svegliare i cattivi spiriti. E non evocare parole della nostra storia, lontana, diversa e archiviata: squadracce, spedizioni punitive, prenderne uno per educarne cento. Prima o poi…. Dà il senso del tempo che scorre, dei grani di sabbia che riempiono la clessidra.Read more
Il punto di non ritorno
“Prima o poi, ci scappa il morto”. Una frase a mezza bocca, per non svegliare i cattivi spiriti. E non evocare parole della nostra storia, lontana, diversa e archiviata: squadracce, spedizioni punitive, prenderne uno per educarne cento. Prima o poi…. Dà il senso del tempo che scorre, dei grani di sabbia che riempiono la clessidra.Read more
Ramadan 2016: uno dei più sanguinosi della storia moderna?
Foto credit: AFP/AP/Reuters Di Sigurd Neubauer. Al-Arabiya (4/04/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina. Negli ultimi 30 giorni ci sono stati una serie di attacchi terroristici che hanno sconvolto tutto il mondo per quanto per la portata che hanno avuto in termini di tempi, luoghi e violenza. I militanti hanno scelto di colpire i diversi obiettivi durante il […]
L’articolo Ramadan 2016: uno dei più sanguinosi della storia moderna? sembra essere il primo su Arabpress.
L’omicida di Emmanuel a piede libero. “In prima fila al comizio di Salvini”
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato denuncia del CSOA Officina Trenino.
I rifugiati che non possono pagare i trafficanti venduti per gli organi
La confessione di un trafficante di esseri umani alla polizia dopo lo shock causato dal numero di morti tra i migranti ¶
I migranti che…
Idomeni (borders kill)
Fotografare Idomeni. ¶
Se in questi mesi c’e un posto in Europa dove migliaia di scatti si sono riversati come una grandine digitale …
Bush & Blair alla sbarra per l’attacco all’Iraq: storico evento, omertà dei media, anche sulla condanna
Originally posted on MAKTUB:
mcc43 Quante volte hanno ripetuto la notizia che Interpol e ICC avevano emesso ordini di cattura per i Gheddafi e altri personaggi del regime, assimilandoli a una condanna già avvenuta. Quanti, invece, hanno sentito o letto una notizia sul procedimento in corso a Kuala Lampur per gli imputati Tony Blair e…![]()
Bush & Blair alla sbarra per l’attacco all’Iraq: storico evento, omertà dei media, anche sulla condanna
Originally posted on MAKTUB:
mcc43 Quante volte hanno ripetuto la notizia che Interpol e ICC avevano emesso ordini di cattura per i Gheddafi e altri personaggi del regime, assimilandoli a una condanna già avvenuta. Quanti, invece, hanno sentito o letto una notizia sul procedimento in corso a Kuala Lampur per gli imputati Tony Blair e…![]()
Bush&Blair alla sbarra per l’attacco all’Iraq: storico evento, omertà dei media, anche sulla condanna
Originally posted on MAKTUB:
mcc43 Quante volte hanno ripetuto la notizia che Interpol e ICC avevano emesso ordini di cattura per i Gheddafi e altri personaggi del regime, assimilandoli a una condanna già avvenuta. Quanti, invece, hanno sentito o letto una notizia sul procedimento in corso a Kuala Lampur per gli imputati Tony Blair e…![]()
Il fumetto arabo a Marsiglia
L’Associazione Alifbata di Marsiglia questo venerdì organizza un incontro pubblico con sei disegnatori del collettivo di Samandal provenienti da Egitto, Libano, Tunisia e Marocco. Saranno presenti Lena Merhej (Libano), Barrack Rima (Libano), Mai Koraiem (Egitto), Noha Habaieb (Tunisia) e Zineb Benjelloun (Marocco). L’incontro si svolgerà alle 19 in Rue Adolphe Tiers 59. Alifbata è un’associazione … Continua a leggere Il fumetto arabo a Marsiglia →![]()
Il fumetto arabo a Marsiglia
L’Associazione Alifbata di Marsiglia questo venerdì organizza un incontro pubblico con sei disegnatori del collettivo di Samandal provenienti da Egitto, Libano, Tunisia e Marocco. Saranno presenti Lena Merhej (Libano), Barrack Rima (Libano), Mai Koraiem (Egitto), Noha Habaieb (Tunisia) e Zineb Benjelloun (Marocco). L’incontro si svolgerà alle 19 in Rue Adolphe Tiers 59. Alifbata è un’associazione … Continua a leggere Il fumetto arabo a Marsiglia →![]()
Il fumetto arabo a Marsiglia
L’Associazione Alifbata di Marsiglia questo venerdì organizza un incontro pubblico con sei disegnatori del collettivo di Samandal provenienti da Egitto, Libano, Tunisia e Marocco. Saranno presenti Lena Merhej (Libano), Barrack Rima (Libano), Mai Koraiem (Egitto), Noha Habaieb (Tunisia) e Zineb Benjelloun (Marocco). L’incontro si svolgerà alle 19 in Rue Adolphe Tiers 59. Alifbata è un’associazione … Continua a leggere Il fumetto arabo a Marsiglia →![]()
Il fumetto arabo a Marsiglia
L’Associazione Alifbata di Marsiglia questo venerdì organizza un incontro pubblico con sei disegnatori del collettivo di Samandal provenienti da Egitto, Libano, Tunisia e Marocco. Saranno presenti Lena Merhej (Libano), Barrack Rima (Libano), Mai Koraiem (Egitto), Noha Habaieb (Tunisia) e Zineb Benjelloun (Marocco). L’incontro si svolgerà alle 19 in Rue Adolphe Tiers 59. Alifbata è un’associazione … Continua a leggere Il fumetto arabo a Marsiglia →![]()
Uscita e rientro in Italia in attesa del permesso di soggiorno
Aggiornato al 06/07/2016 a cura dell’Ambasciata dei Diritti di Ancona.
Fermo — Riduce un migrante in fin di vita dopo aver insultato la sua compagna: “scimmia”
Articolo in aggiornamento. ¶
Una vigliacca aggressione rischia di spegnere la vita ad un coppia di nigeriani che aveva scelto l’Italia…
Scheda pratica Ingressi fuori quota
Aggiornata al 06/07/2016 a cura dell’Ambasciata dei Diritti di Ancona ¶
Quali lavoratori possono fare accesso in Italia fuori dal regime…
Le tipologie di visti di ingresso
1. Visto per “adozione” (V.N.)
Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo…
“La guerriera dagli occhi verdi” di Marco Rovelli
Avesta è una giovane donna che ha scelto la strada della guerriglia. Avesta ha il cuore spezzato a causa della crudele morte del fratello Harun, ucciso dai militari turchi. Avesta ha scelto di vendicare suo fratello e il suo popolo. Avesta è una guerrigliera curda. Marco Rovelli ci regala questo toccante e drammatico romanzo, edito […]
L’articolo “La guerriera dagli occhi verdi” di Marco Rovelli sembra essere il primo su Arabpress.
Migranti:Commissione Ue con voto Pe rafforzamento frontiere
Migranti:Commissione Ue, con voto Pe rafforzamento frontiere
http://ift.tt/29O2c8u
La ruta de Siria a Europa. Capitolo IV: Ferita
Vi proponiamo la traduzione di questo articolo (link articolo originale) tratto dal blog seguirconvida.msf.es,
Il terzo anno di al-Sisi a capo dell’Egitto
L’opinione di Al-Quds al-Arabi (04/07/2016). Traduzione e sintesi di Antonia Maria Cascone. Ieri (3 luglio) è ricorso il terzo anniversario dalla cacciata del Presidente egiziano Mohamed Morsi e dalla presa di potere da parte del generale Abdel Fattah al-Sisi con un colpo di Stato “popolare” al quale hanno concorso numerosi fattori e che ha portato […]
L’articolo Il terzo anno di al-Sisi a capo dell’Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
Francia — Grande-Synthe avrà il suo muro della vergogna
Il campo profughi di Grande-Synthe è situato tra i binari della ferrovia e l’autostrada.
Muri e filo spinato
Ungheria: un anno dopo. In attesa del referendum di ottobre per il piano rifugiati
via Migrano http://ift.tt/29wah56
“Ciao Abbas”, l’attore iraniano Babak Karimi ricorda il maestro Kiarostami
Intervista di Katia Cerratti “Ciao Abbas, sei stato un padre, un fratello maggiore, un amico, un maestro del cinema. Ora improvvisamente mi sento solo. Il vento ti ha portato via “. Così, l’attore iraniano Babak Karimi, Orso d’Argento a Berlino come miglior attore per il film di Asghar Farhadi Una separazione (Premio Oscar come Miglior film […]
L’articolo “Ciao Abbas”, l’attore iraniano Babak Karimi ricorda il maestro Kiarostami sembra essere il primo su Arabpress.
Negli ultimi giorni ondata di arresti di presunti trafficanti in Italia.
http://ift.tt/1WECiZa
http://ift.tt/29lDuyV
http://ift.tt/29crMTV
http://ift.tt/29lDGOk
Negli stessi giorni sono stati arrestati in…
Qui Baghdad. Babilonia è in fiamme…
mcc43 Jehan Bseiso è una figlia della diaspora palestinese ed è una poetessa. Jehan è anche un medico che collabora con Médecins sans Frontières, lavora come ricercatore al Cairo, è nata a Los Angeles, è cresciuta in Giordania e ha compiuto gli studi in Libano. Conosce com’è essere senza una patria in cui vivere al […]![]()
Qui Baghdad. Babilonia è in fiamme…
mcc43 Jehan Bseiso è una figlia della diaspora palestinese ed è una poetessa. Jehan è anche un medico che collabora con Médecins sans Frontières, lavora come ricercatore al Cairo, è nata a Los Angeles, è cresciuta in Giordania e ha compiuto gli studi in Libano. Conosce com’è essere senza una patria in cui vivere al […]![]()
Qui Baghdad. Babilonia è in fiamme…
mcc43 Jehan Bseiso è una figlia della diaspora palestinese ed è una poetessa. Jehan è anche un medico che collabora con Médecins sans Frontières, lavora come ricercatore al Cairo, è nata a Los Angeles, è cresciuta in Giordania e ha compiuto gli studi in Libano. Conosce com’è essere senza una patria in cui vivere al […]![]()
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Italia: bambini bloccati in inadeguati centri di accoglienza
Permanenze prolungate, nessuna divisione dagli adulti ¶
Milano — Secondo quanto riferito da Human Rights Watch, bambini dell’età di 12…
Un’analisi sul recente accordo tra Israele e Turchia
Di Mueen Al Taher. Al-Araby al-Jadeed (03/07/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. L’articolo che segue vuole offrire una diversa chiave di lettura in merito alla restaurazione dei legami tra Turchia e Israele, al di là di ideologie politiche o conclusioni affrettate espresse da sostenitori e oppositori alla politica di Erdoğan nella regione. Senz’altro la […]
L’articolo Un’analisi sul recente accordo tra Israele e Turchia sembra essere il primo su Arabpress.
Le aziende europee di armamenti traggono profitti dalla crisi dei rifugiati
Uno studio di Stop Wapenhandel pubblicato da TNI indaga i comportamenti anche di Finmeccanica-Leonardo
via Migrano http://ift.tt/29gt6Va
Eid Mubarak, soprattutto oggi
Una lunga striscia di sangue, tra Ramadan e Eid al Fitr, tra Dakha e Baghdad, e Medina e Qatif e Gedda, e Istanbul. Ancora più forte, dunque, l’abbraccio ai miei amici musulmani. I laici e i meno laici, i più devoti e i molto devoti. Un abbraccio forte, qui in Italia, a Gerusalemme e alRead more
Eid Mubarak, soprattutto oggi
Una lunga striscia di sangue, tra Ramadan e Eid al Fitr, tra Dakha e Baghdad, e Medina e Qatif e Gedda, e Istanbul. Ancora più forte, dunque, l’abbraccio ai miei amici musulmani. I laici e i meno laici, i più devoti e i molto devoti. Un abbraccio forte, qui in Italia, a Gerusalemme e alRead more
Eid Mubarak, soprattutto oggi
Una lunga striscia di sangue, tra Ramadan e Eid al Fitr, tra Dakha e Baghdad, e Medina e Qatif e Gedda, e Istanbul. Ancora più forte, dunque, l’abbraccio ai miei amici musulmani. I laici e i meno laici, i più devoti e i molto devoti. Un abbraccio forte, qui in Italia, a Gerusalemme e alRead more
Eid Mubarak, soprattutto oggi
Una lunga striscia di sangue, tra Ramadan e Eid al Fitr, tra Dakha e Baghdad, e Medina e Qatif e Gedda, e Istanbul. Ancora più forte, dunque, l’abbraccio ai miei amici musulmani. I laici e i meno laici, i più devoti e i molto devoti. Un abbraccio forte, qui in Italia, a Gerusalemme e alRead more
Eid Mubarak, soprattutto oggi
Una lunga striscia di sangue, tra Ramadan e Eid al Fitr, tra Dakha e Baghdad, e Medina e Qatif e Gedda, e Istanbul. Ancora più forte, dunque, l’abbraccio ai miei amici musulmani. I laici e i meno laici, i più devoti e i molto devoti. Un abbraccio forte, qui in Italia, a Gerusalemme e alRead more
L’Occidente ama la propaganda di Daesh e meno la Siria
Di Lizzie Porter. Middle East Eye (03/07/2016). Traduzione e sintesi di Sebastiano Garofalo. C’è una foto della Siria che ho visto troppe volte. È quella di un combattente vestito di nero, con la bandiera dello Stato Islamico in una mano e un AK-47 nell’altra. Marcia lungo una strada di condomini in quello che dovrebbe essere […]
L’articolo L’Occidente ama la propaganda di Daesh e meno la Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Hotspot — Le “Procedure Operative Standard (SOP)”
A inizio di giugno il Ministero dell’Interno ha pubblicato le nuove disposizioni amministrative, denominate “Procedure Operative Standard…
Padova — Accoglienza e diritto d’asilo al tempo degli hotspot
Lunedì 4 luglio ore 21 ¶
Accoglienza e diritto d’asilo al tempo degli hotspot ¶
Sherwood Festival 2016
Park Nord Stadio Euganeo
Second…
Roma — Centinaia i migranti lasciati in strada
Roma, 4 luglio — Medici per i Diritti Umani richiede alle istituzioni e alla sindaca Virginia Raggi di fornire delle risposte all’ennesima…
La ruta de Siria a Europa. Capitolo III: La Fuga
Vi proponiamo la traduzione di questo articolo (link articolo originale) tratto dal blog seguirconvida.msf.es,
Violenze della polizia in Grecia contro profughi minori non accompagnati
Testimoni di Medici Senza Frontiere hanno riferito di violenze avvenute presso il Centro di Accoglienza e Identificazione di Moria, a Lesbo…
Meno migranti si accolgono da vivi più ne arrivano morti
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Rete Antirazzista Catanese.
L’Appello avverso un ordinanza di diniego sospende automaticamente l’ordinanza negativa
Si ringrazia l’Avv. Cristian Valle per la segnalazione ed il commento.
Il villaggio dei diritti a Torino
 Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Il villaggio dei diritti a Torino
 Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Il villaggio dei diritti a Torino
 Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Dal 2 al 31 luglio 2016 nello spazio di Torino-Esposizioni per promuovere le pari opportunità per tutti e per diffondere i principi di non discriminazione e uguaglianza, senza distinzione diorientamento sessuale, genere, disabilità, età, provenienza geografica. Mostre, dibattiti, campagne sociali, spettacoli musicali, danza, teatro e cabaret, cinema, sport e gioco.
Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa”
La settimana scorsa VICE ITALIA ha pubblicato una mia intervista con Saleem Haddad, l’autore di Ultimo giro al Guapa, che in italiano è stato pubblicato da e/o nella traduzione di Silvia Castoldi. Il romanzo ha suscitato molto clamore perché ha per protagonista Rasa, un giovane traduttore arabo di 27 anni che vive in una imprecisata … Continua a leggere Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa” →![]()
Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa”
La settimana scorsa VICE ITALIA ha pubblicato una mia intervista con Saleem Haddad, l’autore di Ultimo giro al Guapa, che in italiano è stato pubblicato da e/o nella traduzione di Silvia Castoldi. Il romanzo ha suscitato molto clamore perché ha per protagonista Rasa, un giovane traduttore arabo di 27 anni che vive in una imprecisata … Continua a leggere Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa” →![]()
Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa”
La settimana scorsa VICE ITALIA ha pubblicato una mia intervista con Saleem Haddad, l’autore di Ultimo giro al Guapa, che in italiano è stato pubblicato da e/o nella traduzione di Silvia Castoldi. Il romanzo ha suscitato molto clamore perché ha per protagonista Rasa, un giovane traduttore arabo di 27 anni che vive in una imprecisata … Continua a leggere Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa” →![]()
Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa”
La settimana scorsa VICE ITALIA ha pubblicato una mia intervista con Saleem Haddad, l’autore di Ultimo giro al Guapa, che in italiano è stato pubblicato da e/o nella traduzione di Silvia Castoldi. Il romanzo ha suscitato molto clamore perché ha per protagonista Rasa, un giovane traduttore arabo di 27 anni che vive in una imprecisata … Continua a leggere Vi presento Saleem Haddad e “Ultimo giro al Guapa” →![]()
Nei processi migratori al tempo della globalizzazione il Mediterraneo ha assunto una ruolo di…
cerniera ed al tempo stesso di frontiera, tra sud e nord del mondo, ed in qualche misura anche tra alcuni stati del vicino o del lontano…
Le migrazioni qualificate ai tempi dei tagli alla ricerca
Nel 2015, secondo l’Istat, sono rimpatriati 30.052 italiani, mentre 102.259
Ousta, l’app più scaricata d’Egitto
Di Radwa Rashad. Wamda (29/06/2016). Traduzione e sintesi di Emanuela Barbieri. Lanciata a marzo 2016, già operativa in 10 città egiziane e con circa un download al minuto, l’app Ousta prevede di espandersi a luglio nel mercato offshore. Nader El Batrawi, fondatore del network professionale Jobzella, e Omar Salah, ex manager della Nestle Waters, hanno lanciato Ousta promettendo […]
L’articolo Ousta, l’app più scaricata d’Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
20 anni di Mondiali Antirazzisti
Un compleanno importante per la manifestazione Uisp che si batte contro violenza, razzismo e sessismo.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a pronunciarsi sull’Accordo con la Turchia…
The legal justification for the EU-Turkey refugee deal has been challenged in the European Court of Justice by three asylum seekers. Their…
Dhaka: le parole sono fondamentali! – con noterelle a margine
Pillole di radio, tra stanotte e stamattina: “Diplomatici occidentali”. Ma erano in gran parte imprenditori. Ed erano italiani e giapponesi. I giapponesi sono occidentali? Sono forse filo-occidentali? “Ma allora ci chiediamo, come si chiede il premier del Bangladesh, che musulmani sono questi?” Il premier del Bangladesh è una donna (e in Italia ancora non ciRead more
Dhaka: le parole sono fondamentali! – con noterelle a margine
Pillole di radio, tra stanotte e stamattina: “Diplomatici occidentali”. Ma erano in gran parte imprenditori. Ed erano italiani e giapponesi. I giapponesi sono occidentali? Sono forse filo-occidentali? “Ma allora ci chiediamo, come si chiede il premier del Bangladesh, che musulmani sono questi?” Il premier del Bangladesh è una donna (e in Italia ancora non ciRead more
Dhaka: le parole sono fondamentali! – con noterelle a margine
Pillole di radio, tra stanotte e stamattina: “Diplomatici occidentali”. Ma erano in gran parte imprenditori. Ed erano italiani e giapponesi. I giapponesi sono occidentali? Sono forse filo-occidentali? “Ma allora ci chiediamo, come si chiede il premier del Bangladesh, che musulmani sono questi?” Il premier del Bangladesh è una donna (e in Italia ancora non ciRead more
Dhaka: le parole sono fondamentali! – con noterelle a margine
Pillole di radio, tra stanotte e stamattina: “Diplomatici occidentali”. Ma erano in gran parte imprenditori. Ed erano italiani e giapponesi. I giapponesi sono occidentali? Sono forse filo-occidentali? “Ma allora ci chiediamo, come si chiede il premier del Bangladesh, che musulmani sono questi?” Il premier del Bangladesh è una donna (e in Italia ancora non ciRead more
Dhaka: le parole sono fondamentali!
Pillole di radio, tra stanotte e stamattina: “Diplomatici occidentali”. Ma erano in gran parte imprenditori. Ed erano italiani e giapponesi. I giapponesi sono occidentali? Sono forse filo-occidentali? “Ma allora ci chiediamo, come si chiede il premier del Bangladesh, che musulmani sono questi?” Il premier del Bangladesh è una donna (e in Italia ancora non ciRead more
Special Ramadan: fatteh hummus
Molto diffuso nel Levante, in particolare in Libano, Palestina e Siria, il nome di questo piatto viene consumato sia come pasto di rottura del digiuno durante il Ramadan, sia come pietanza completa per la colazione. Il suo nome viene dalla parola araba fatteh, che significa “pane sbriciolato, spezzettato”. Scopriamo come preparare il fatteh hummus! Ingredienti: 500g di […]
L’articolo Special Ramadan: fatteh hummus sembra essere il primo su Arabpress.
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
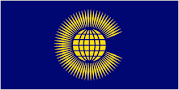 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
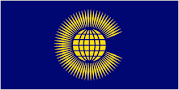 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
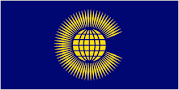 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
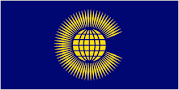 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
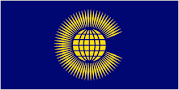 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Turchia: sull’attacco all’aeroporto di Istanbul
Di Mustafa Akyol. Hurriyet Daily News (02/07/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. L’aeroporto Atatürk di Istanbul è uno di quei posti che ti fanno ancora pensare con ottimismo al futuro della Turchia. Più di un milione di persone passano di là ogni anno. All’interno del terminale internazionale, sembra di trovarsi al centro del mondo, si possono […]
L’articolo Turchia: sull’attacco all’aeroporto di Istanbul sembra essere il primo su Arabpress.
Almeno 42 morti nel violento attentato all’aereporto di Istanbul
Il governo ha incolpato l’ISIS per l’attacco. Abitazioni di privati cittadini ed hotel delle maggiori città turche hanno ospitato i passeggeri rimasti bloccati ad Istanbul.
Almeno 42 morti nel violento attentato all’aereporto di Istanbul
Il governo ha incolpato l’ISIS per l’attacco. Abitazioni di privati cittadini ed hotel delle maggiori città turche hanno ospitato i passeggeri rimasti bloccati ad Istanbul.
Almeno 42 morti nel violento attentato all’aereporto di Istanbul
Il governo ha incolpato l’ISIS per l’attacco. Abitazioni di privati cittadini ed hotel delle maggiori città turche hanno ospitato i passeggeri rimasti bloccati ad Istanbul.
Almeno 42 morti nel violento attentato all’aereporto di Istanbul
Il governo ha incolpato l’ISIS per l’attacco. Abitazioni di privati cittadini ed hotel delle maggiori città turche hanno ospitato i passeggeri rimasti bloccati ad Istanbul.
Almeno 42 morti nel violento attentato all’aereporto di Istanbul
Il governo ha incolpato l’ISIS per l’attacco. Abitazioni di privati cittadini ed hotel delle maggiori città turche hanno ospitato i passeggeri rimasti bloccati ad Istanbul.
Putin, Erdogan, il jet abbattuto e il make up delle notizie
mcc43 E’ una forma di bispensiero orwelliano: il pubblico sa che i media mentono ma crede lo stesso, consentendo loro di continuare a truccare le notizie. La Cina si è seccata di questo make up deformante e ha commissionato un pezzo rap contro i mass media occidentali «che hanno fabbricato una falsa immagine» della Repubblica popolare. A […]![]()
Putin, Erdogan, il jet abbattuto e il make up delle notizie
mcc43 E’ una forma di bispensiero orwelliano: il pubblico sa che i media mentono ma crede lo stesso, consentendo loro di continuare a truccare le notizie. La Cina si è seccata di questo make up deformante e ha commissionato un pezzo rap contro i mass media occidentali «che hanno fabbricato una falsa immagine» della Repubblica popolare. A […]![]()
Putin, Erdogan, il jet abbattuto e il make up delle notizie
mcc43 E’ una forma di bispensiero orwelliano: il pubblico sa che i media mentono ma crede lo stesso, consentendo loro di continuare a truccare le notizie. La Cina si è seccata di questo make up deformante e ha commissionato un pezzo rap contro i mass media occidentali «che hanno fabbricato una falsa immagine» della Repubblica popolare. A […]![]()
Putin, Erdogan, il jet abbattuto e il make up delle notizie
mcc43 E’ una forma di bispensiero orwelliano: il pubblico sa che i media mentono ma crede lo stesso, consentendo loro di continuare a truccare le notizie. La Cina si è seccata di questo make up deformante e ha commissionato un pezzo rap contro i mass media occidentali «che hanno fabbricato una falsa immagine» della Repubblica popolare. A […]![]()
Riad Sattouf: né siriano, né francese, solo un disegnatore
Oggi vorrei forzare leggermente i confini di questo blog. Non tanto per quanto riguarda la letteratura, perché credo fortemente che i graphic novel ne facciano parte, quanto per le origini dell’autore di cui voglio parlarvi. Riad Sattouf, infatti, è di padre siriano e madre francese, nato e cresciuto tra Libia, Siria e Francia, in vari […]
L’articolo Riad Sattouf: né siriano, né francese, solo un disegnatore sembra essere il primo su Arabpress.
Assemblea di Over The Fortress: Andare oltre la fortezza
Assemblea di Over The Fortress ¶
Sherwood Festival, sabato 2 luglio 2016 ore 14.00
L’arabismo: fonte di delusione e di regimi ostili
Di Talal Salman. As-Safir (29/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Cassata. Le relazioni tra gli arabi non sono sempre state fraterne e dominate dal sentimento condiviso di un destino comune. I confini tracciati dai colonizzatori hanno impedito la fratellanza tra i popoli, seminando sentimenti di ostilità reciproca. Gli arabi vivono, oggigiorno, una situazione di schizofrenia […]
L’articolo L’arabismo: fonte di delusione e di regimi ostili sembra essere il primo su Arabpress.





