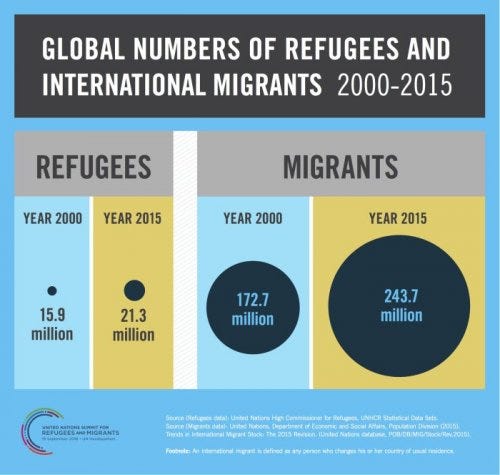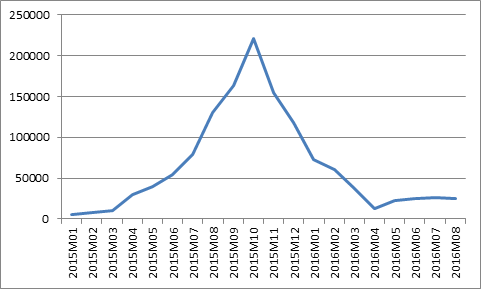Come è stato delineato il sistema di accoglienza capitolino negli ultimi tre anni?
Mese: ottobre 2016
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione. La nota è della redazione.
Un’interessante ordinanza del Tribunale di Genova che riconosce la protezione sussidiaria ad un giovane cittadino nigeriano proveniente da…
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione. La nota è della redazione.
Con questa ordinanza il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino gambiano.
Il ricorrente ha proposto…
Libertà va cercando, ch’è sì cara
di Francesco Matteo Landi Molta gente legge quotidianamente la parola “privacy” sul proprio cellulare, non curandosi di ciò che può significare, e quali servizi (positivi e negativi) possa offrire. Personalmente, la privacy è qualcosa di molto importante, è la mia vita privata, le mie relazioni, le mie amicizie, insomma tutto ciò che mi riguarda. ERead more
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
In Libano la partita presidenziale finisce con Teheran 1 e Ryad quasi 0
mcc43 L’elezione a Presidente di Michel Aoun suggerisce che dal braccio di ferro delle capitali che contano in Libano: Teheran, via Hezbollah, e Ryad, via Hariri, quest’ultima esce sconfitta. Presumibilmente scontenti la Francia, che puntava su Samir Geagea, e gli Usa, che annoverano Saad Hariri fra i loro fedelissimi. Scrivevamo a maggio 2014 nell’articolo Libano: le difficili […]![]()
Egitto. Proseguono le intimidazioni alla libertà di informazione
Nelle università, nelle fabbriche, nella politica, nei media, nell’arte e nella letteratura: ogni settore della vita civile è stato investito da una strategia che ha fatto di tutte le voci contrarie ad al-Sisi e di chi lo sostiene dei nemici da annientare.
Egitto. Proseguono le intimidazioni alla libertà di informazione
Nelle università, nelle fabbriche, nella politica, nei media, nell’arte e nella letteratura: ogni settore della vita civile è stato investito da una strategia che ha fatto di tutte le voci contrarie ad al-Sisi e di chi lo sostiene dei nemici da annientare.
Egitto. Proseguono le intimidazioni alla libertà di informazione
Nelle università, nelle fabbriche, nella politica, nei media, nell’arte e nella letteratura: ogni settore della vita civile è stato investito da una strategia che ha fatto di tutte le voci contrarie ad al-Sisi e di chi lo sostiene dei nemici da annientare.
Michel Aoun eletto 13° presidente del Libano
(Agenzie). Michel Aoun, ex capo delle forze armate libanesi, è stato eletto dal parlamento nuovo presidente del Libano, il 13° dall’indipendenza del paese dalla Francia nel 1943. L’elezione di Aoun mette fine a un vuoto presidenziale durato più di due anni, dopo la fine del mandato dell’ex presidente Michel Suleiman nel maggio 2014. Dopo 45 […]
L’articolo Michel Aoun eletto 13° presidente del Libano sembra essere il primo su Arabpress.
La Grecia e la lunga lunga attesa
Si chiudono le porte, rombano i motori e dall’oblò si vedono le luci di Igoumenitsa che si allontanano.
Marocco: proteste e indignazione dopo la morte atroce di un pescivendolo
Si chiamava Mouhcine Fikri. Venerdì, il suo corpo è stato triturato da un compattatore di rifiuti in circostanze non chiare. La sua morte ha spinto migliaia di marocchini in strada, mentre le autorità cercano di calmare la situazione
L’articolo Marocco: proteste e indignazione dopo la morte atroce di un pescivendolo sembra essere il primo su Arabpress.
Chiamami ghetto
via Migrano http://ift.tt/2eq8TPu
Espulsi dalle forze di Assad, i cittadini di Daraya ricevono un benvenuto da eroi nei territori dei ribelli
“Lei è di Daraya, signore. Avete tutto. Siete i nostri maestri.”
Espulsi dalle forze di Assad, i cittadini di Daraya ricevono un benvenuto da eroi nei territori dei ribelli
“Lei è di Daraya, signore. Avete tutto. Siete i nostri maestri.”
Espulsi dalle forze di Assad, i cittadini di Daraya ricevono un benvenuto da eroi nei territori dei ribelli
“Lei è di Daraya, signore. Avete tutto. Siete i nostri maestri.”
Espulsi dalle forze di Assad, i cittadini di Daraya ricevono un benvenuto da eroi nei territori dei ribelli
“Lei è di Daraya, signore. Avete tutto. Siete i nostri maestri.”
Libano: chi ci guadagna dall’elezione di Michel Aoun?
Lunedì 31 ottobre i deputati libanesi eleggeranno finalmente un nuovo presidente, dopo un lungo periodo in cui questa carica è rimasta vuota
L’articolo Libano: chi ci guadagna dall’elezione di Michel Aoun? sembra essere il primo su Arabpress.
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico Roma 12/11/2016 Ore 10:00 – 11:30 LUISS Guido Carli Incontro organizzato nell’ambito del ciclo Traditions and Boundaries Lectures Series TABLES e del corso di Lingua e cultura araba del Dipartimento di Scienze … Continue reading →
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico Roma 12/11/2016 Ore 10:00 – 11:30 LUISS Guido Carli Incontro organizzato nell’ambito del ciclo Traditions and Boundaries Lectures Series TABLES e del corso di Lingua e cultura araba del Dipartimento di Scienze … Continue reading →
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico Roma 12/11/2016 Ore 10:00 – 11:30 LUISS Guido Carli Incontro organizzato nell’ambito del ciclo Traditions and Boundaries Lectures Series TABLES e del corso di Lingua e cultura araba del Dipartimento di Scienze … Continue reading →
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico Roma 12/11/2016 Ore 10:00 – 11:30 LUISS Guido Carli Incontro organizzato nell’ambito del ciclo Traditions and Boundaries Lectures Series TABLES e del corso di Lingua e cultura araba del Dipartimento di Scienze … Continue reading →
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico
Musulmani in Italia: società civile e dibattito pubblico Roma 12/11/2016 Ore 10:00 – 11:30 LUISS Guido Carli
Siria. Mazen, sopravvissuto: “Denuncerò il regime finché avrò vita”
Si chiama Mazen, ha 40 anni ma non li dimostra, è molto alto ed ha il volto scavato. Le sue mani sottili hanno qualcosa di innaturale e, insieme alla sua magrezza, rivelano qualcosa di lui: Mazen è un sopravvissuto, un uomo che ha attraversato il girone più terrificante dell’inferno in terra e ne è uscito vivo.
Siria. Mazen, sopravvissuto: “Denuncerò il regime finché avrò vita”
Si chiama Mazen, ha 40 anni ma non li dimostra, è molto alto ed ha il volto scavato. Le sue mani sottili hanno qualcosa di innaturale e, insieme alla sua magrezza, rivelano qualcosa di lui: Mazen è un sopravvissuto, un uomo che ha attraversato il girone più terrificante dell’inferno in terra e ne è uscito vivo.
Siria. Mazen, sopravvissuto: “Denuncerò il regime finché avrò vita”
Si chiama Mazen, ha 40 anni ma non li dimostra, è molto alto ed ha il volto scavato. Le sue mani sottili hanno qualcosa di innaturale e, insieme alla sua magrezza, rivelano qualcosa di lui: Mazen è un sopravvissuto, un uomo che ha attraversato il girone più terrificante dell’inferno in terra e ne è uscito vivo.
Tunisia. La corruzione come stato endemico
Per quanto la storia non si ripeta mai nello stesso modo, la situazione attuale in Tunisia si compone di elementi ricorrenti. Mancanza di prospettive di miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, repressione del dissenso e ritorno a forme di autoritarismo stridono con l’immagine della “primavera” riuscita .
Tunisia. La corruzione come stato endemico
Tunisia. La corruzione come stato endemico
29 Ottobre 2016di: Damiano Duchemin e Debora Del Pistoia
Palestina. Divide et impera: le divisioni che uccidono la speranza di libertà
“Non ci sarà mai una Palestina libera se prima i palestinesi non libereranno se stessi dalla repressione delle divisioni e del fazionalismo”: il punto di vista dell’analista palestinese Ramzy Baroud sulle ultime elezioni locali (rimandate).
Libia: nuovi equilibri di potere e campanelli di allarme
A 5 anni dalla caduta del regime di Gheddafi, il processo di transizione in Libia è ben lontano dall’essersi concluso e nel paese è in corso uno stravolgimento degli equilibri di potere, mentre il paese sembra sempre più orientato a privilegiare la sicurezza a discapito della democrazia.
Iraq. Mosul, forse Daesh ha già vinto
A Mosul e all’Iraq non basta un intervento esclusivamente militare. Se non ci sarà una risposta politica che risponda ai bisogni di una popolazione martoriata da quarant’anni di violenza, la prossima potrà soltanto essere un’altra delle tante guerre ancora possibili, in Iraq.
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno)
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Avremmo adorato continuare ad ignorare la questione del complottismo, ancorché informi senza ombra di dubbio gran parte dello Zeitgeist contemporaneo, ma troppi fatti coincidenti la chiamano in causa in maniera veemente e non più eludibile.…
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno) è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno)
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Avremmo adorato continuare ad ignorare la questione del complottismo, ancorché informi senza ombra di dubbio gran parte dello Zeitgeist contemporaneo, ma troppi fatti coincidenti la chiamano in causa in maniera veemente e non più eludibile.…
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno) è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno)
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Avremmo adorato continuare ad ignorare la questione del complottismo, ancorché informi senza ombra di dubbio gran parte dello Zeitgeist contemporaneo, ma troppi fatti coincidenti la chiamano in causa in maniera veemente e non più eludibile.…
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno) è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno)
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Avremmo adorato continuare ad ignorare la questione del complottismo, ancorché informi senza ombra di dubbio gran parte dello Zeitgeist contemporaneo, ma troppi fatti coincidenti la chiamano in causa in maniera veemente e non più eludibile.…
La filologia del grande complottone, da Raqqua [sic!] ar Torrino (e ritorno) è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Coming from the port of Igoumenitsa, the #overthefortress van lands in Southern Italy to conduct an…
Support crowdfunding for the solidarity campaign #overthefortress (link).
Cucina marocchina: tajine di cozze
Oggi voliamo in Marocco alla scoperta di un’altra delle decine di varianti del piatto tipico della cucina marocchina: ecco come preparare il tajine di cozze! Ingredienti: 500g di cozze sgusciate 250g di passata di pomodoro ½ mazzetto di coriandolo 2 spicchi d’aglio ½ cucchiaino di cumino ½ cucchiaino di pimento dolce ¼ limone candito 5 cucchiai di olio di oliva Preparazione: Lavare […]
L’articolo Cucina marocchina: tajine di cozze sembra essere il primo su Arabpress.
TheShukran il nuovo social network fotografico interculturale
Treviso — Immagini di persone, luoghi, cibi che raccontano storie da ogni parte del mondo.
Sandra Solomon: da nipote di un palestinese intimo di Arafat, a cristiana che difende Israele
(Times of Israel). Nipote di Saher Habash – uno dei fondatori del partito palestinese Fatah, tra i leader della seconda Intifada e intimo confidente di Yasser Arafat – Sandra Solomon è nata da musulmana a Ramallah sotto un altro nome, ma è cresciuta in Arabia Saudita, prima di trasferirsi in Canada e convertirsi al cristianesimo. “Sono cresciuta in […]
L’articolo Sandra Solomon: da nipote di un palestinese intimo di Arafat, a cristiana che difende Israele sembra essere il primo su Arabpress.
Piazzale Spadolini: il non luogo della solidarietà
Foto: Matteo Nardone (27 ottobre 2016)
Roma 27 Ottobre 2016
Dopo lo sgombero forzato di via Cupa e l’assenza di soluzioni proposte dall…
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
La Campagna LasciateCIEntrare visita l’Hotel Grillo (Amendolara — CS)
In data 22 ottobre una delegazione della Campagna “LasciateCIEntrare” si è recata in visita presso l’Hotel Grillo, sito in Amendolara…
Benvenuti ad Agadez capitale africana del contrabbando
Centinaia di migliaia di persone, dalla città del Niger centrale, tentano di attraversare il Sahara e raggiungere l’Europa.
La giungla di Calais
Le operazioni di sgombero possono essere tanto la base di un approccio alla questione migratoria differente, quanto alimentare il populismo in vista delle prossime elezioni
L’articolo La giungla di Calais sembra essere il primo su Arabpress.
Presentato il Dossier Statistico immigrazione 2016
Giovedì 27 ottobre è stato presentato a Roma e in contemporanea su tutto il territorio nazionale il Dossier Statistico immigrazione 2016.
Medfilm Festival – 22° Edizione
 Dal 4 al 12 novembre torna a Roma il MedFilm Festival, il primo e più importante evento in Italia dedicato al cinema del Mediterraneo e del Medio Oriente. Lo storico festival romano si conferma un osservatorio irrinunciabile sul presente e sul futuro della settima arte, attraverso un ricchissimo programma che conta 90 film, di cui 60 anteprime italiane, europee ed internazionali.
Dal 4 al 12 novembre torna a Roma il MedFilm Festival, il primo e più importante evento in Italia dedicato al cinema del Mediterraneo e del Medio Oriente. Lo storico festival romano si conferma un osservatorio irrinunciabile sul presente e sul futuro della settima arte, attraverso un ricchissimo programma che conta 90 film, di cui 60 anteprime italiane, europee ed internazionali.
Chiamami ghetto
via Migrano http://ift.tt/2fdqaQR
La settimana di Arabpress in podcast – V puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – V puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Cosa sta succedendo in Algeria?
A parte la minoranza che circonda il presidente, nessuno in Algeria sa esattamente chi prende le decisioni e chi governa
L’articolo Cosa sta succedendo in Algeria? sembra essere il primo su Arabpress.
Il Marocco sblocca Whatsapp, Skype e applicazioni simili in vista della conferenza dell’ONU sul clima
“Per evitare di dar l’impressione di essere uno Stato di polizia durante la #COP22, il Marocco sblocca temporaneamente i servizi VoIP,” ha twittato un utente.
Il Marocco sblocca Whatsapp, Skype e applicazioni simili in vista della conferenza dell’ONU sul clima
“Per evitare di dar l’impressione di essere uno Stato di polizia durante la #COP22, il Marocco sblocca temporaneamente i servizi VoIP,” ha twittato un utente.
Il Marocco sblocca Whatsapp, Skype e applicazioni simili in vista della conferenza dell’ONU sul clima
“Per evitare di dar l’impressione di essere uno Stato di polizia durante la #COP22, il Marocco sblocca temporaneamente i servizi VoIP,” ha twittato un utente.
Il Marocco sblocca Whatsapp, Skype e applicazioni simili in vista della conferenza dell’ONU sul clima
“Per evitare di dar l’impressione di essere uno Stato di polizia durante la #COP22, il Marocco sblocca temporaneamente i servizi VoIP,” ha twittato un utente.
Jungle au-revoir!
La bidonville di Calais rasa al suolo, i migranti espulsi con la forza, l’”operazione umanitaria” prosegue la “pulizia” della “jungle” con…
La tassa sul permesso di soggiorno è definitivamente tolta
Con questa sentenza il Consiglio di Stato conferma la sentenza n.
Wael cammina per la pace
Da Pozzallo a Barcellona. Oltre 5 mila chilometri a piedi per lanciare un messaggio di pace
Saad Alaa ElDin Mohammed Osman, o, pi…
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Against Ontologies of Hospitality: About Syrian Refugeehood in Northern Lebanon (October, 2016)
http://www.mei.edu/content/map/against-ontologies-hospitality-about-syrian-refugeehood-northern-lebanon This essay explores the relationship between Syrian refugees and local Lebanese. In particular, it discusses the dominance of the discourse of ‘hospitality’ in the international media depiction of this relationship and in the humanitarian response informed by it. As this essay will show, these tendencies have resulted in the ‘hospitality’ discourse informing and reinforcing […]![]()
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
La nuova jahiliyya del mondo arabo
Il mondo arabo ridisegnato
L’articolo La nuova jahiliyya del mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
La nuova jahiliyya del mondo arabo
Il mondo arabo ridisegnato
L’articolo La nuova jahiliyya del mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
Sharm El Sheikh tra declino e ripresa
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Sharm El Sheikh tra declino e ripresa sembra essere il primo su Arabpress.
Sharm El Sheikh tra declino e ripresa
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Sharm El Sheikh tra declino e ripresa sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – Nuova legge del regime militare contro l’immigrazione illegale. Ennesimo inganno sulla pelle dei migranti.
Riceviamo e pubblichiamo. È passato un mese da quando un barcone di migrati è affondato 12 km a largo delle coste egiziane. Le cifre ufficiali parlano di 162 sopravvissuti (119 egiziani, 26 sudanesi, 13 eritrei, 2 somali, un siriano e … Continue reading →
Napoli — Welcome Refugees: accoglienza e solidarietà nella città rifugio
Sono 465, oltre alla salma di una donna di 24 anni in stato di gravidanza, tra cui un centinaio di minori non accompagnati le persone…
All’altro mondo non ti chiedono il visto (per ora)
Ventimiglia, 15 e 16 ottobre 2016.
Partiamo la mattina presto per poter arrivare in tempo per il funerale di Milet, la ragazza di 16 anni…
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Human, Economic, and Social Flows Beyond Crisis: Understanding the “Urbanitarian” (HESF)
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/human-economic-and-social-flows-beyond-crisis-understanding-the-urbanitarian-hesf/index The Bartlett’s Development Planning Unit (DPU), University College London and the Humanitarian Affairs Team at Save the Children UK have embarked on a research programme at the intersection of urban, humanitarian and forced migration studies. The project aims to inform humanitarian action and policy makers in urban contexts of protracted displacement. As protraction of crises […]![]()
Partenza lunedì 31 ottobre 2016 da Pozzallo (RG): conferenza stampa alle ore 11.00
Due mesi in viaggio dalla Sicilia, attraverso Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Lazio con tappa finale a Roma il 22 dicembre.…
Gorino e le vergognose barricades
I rivoltosi parigini che verso la fine del Cinquecento usarono per la prima volta le famose barricades, le barricate, contro le truppe del…
La disperazione della Tunisia: incontro con Rached Ghannouchi
In occasione della sua visita in Italia, abbiamo incontrato Rached Ghannouchi, leader del partito tunisino Ennahda
L’articolo La disperazione della Tunisia: incontro con Rached Ghannouchi sembra essere il primo su Arabpress.
La disperazione della Tunisia: incontro con Rached Ghannouchi
In occasione della sua visita in Italia, abbiamo incontrato Rached Ghannouchi, leader del partito tunisino Ennahda
L’articolo La disperazione della Tunisia: incontro con Rached Ghannouchi sembra essere il primo su Arabpress.
Gorino e le vergognose barriques
I rivoltosi parigini che verso la fine del Cinquecento usarono per la prima volta le famose barriques, le barricate, contro le truppe del…
“Variazioni di luna” di Patrizia Fiocchetti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Variazioni di luna” di Patrizia Fiocchetti sembra essere il primo su Arabpress.
“Variazioni di luna” di Patrizia Fiocchetti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Variazioni di luna” di Patrizia Fiocchetti sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto: il Fondo Monetario Internazionale e le riforme di al-Sisi
Il governo pretende di riformare l’Egitto imponendo delle condizioni economiche inique ai suoi cittadini mentre le proteste si diffondono in tutto il paese
L’articolo Egitto: il Fondo Monetario Internazionale e le riforme di al-Sisi sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto: il Fondo Monetario Internazionale e le riforme di al-Sisi
Il governo pretende di riformare l’Egitto imponendo delle condizioni economiche inique ai suoi cittadini mentre le proteste si diffondono in tutto il paese
L’articolo Egitto: il Fondo Monetario Internazionale e le riforme di al-Sisi sembra essere il primo su Arabpress.
Il presente documento redatto e firmato da Associazione Babele, Associazione Ohana, Campagna…
D. ha 18 anni. È un richiedente asilo di nazionalità gambiana ospitato nel centro di accoglienza straordinaria di Via Gorelli, a Milano…
Il delitto di tortura in Italia. Dall’habeas corpus alla norma penale
Riceviamo e pubblichiamo questa tesi di laurea di Davide Fratta.
Barriere da superare: storia di uno stop al confine
Una valigia trascinata per mano, i passi tra la polvere, il caldo del deserto sulla pelle. E il confine. Attraversare il confine di uno qualunque degli stati del Medio Oriente non è per niente semplice, soprattutto se si tratta della… Continue Reading →![]()
#overthefortess in Grecia — Nei campi governativi attorno a Salonicco
Il nostro viaggio prosegue nei dintorni di Salonicco, all’interno dei campi governativi dove quotidianamente siamo costretti a scontrarci…
I curdi siriani ridanno i nomi antichi alle città arabizzate
I curdi residenti nella Siria del nord stanno invertendo un processo iniziato poco prima della presa del potere del partito Baath: l’arabizzazione dei nomi delle loro città
L’articolo I curdi siriani ridanno i nomi antichi alle città arabizzate sembra essere il primo su Arabpress.
I curdi siriani ridanno i nomi antichi alle città arabizzate
I curdi residenti nella Siria del nord stanno invertendo un processo iniziato poco prima della presa del potere del partito Baath: l’arabizzazione dei nomi delle loro città
L’articolo I curdi siriani ridanno i nomi antichi alle città arabizzate sembra essere il primo su Arabpress.
Da Calais al Regno Unito: che ne sarà dei bambini rifugiati?
C’è bisogno di un lavoro congiunto tra Gran Bretagna e Francia per rispondere anche alle esigenze dei rifugiati adulti che sono ancora nel campo di Calais
L’articolo Da Calais al Regno Unito: che ne sarà dei bambini rifugiati? sembra essere il primo su Arabpress.
Da Calais al Regno Unito: che ne sarà dei bambini rifugiati?
C’è bisogno di un lavoro congiunto tra Gran Bretagna e Francia per rispondere anche alle esigenze dei rifugiati adulti che sono ancora nel campo di Calais
L’articolo Da Calais al Regno Unito: che ne sarà dei bambini rifugiati? sembra essere il primo su Arabpress.
I limiti della legge contro il “caporalato”
Il 19 ottobre, a larga maggioranza, la Camera dei Deputati ha finalmente dato il via libera definitivo al disegno di legge (Ddl Martina…
Quale Iraq e quale Siria dopo le guerre di Mosul e Aleppo?
Il Medio Oriente, in seguito agli ultimi avvenimenti, potrebbe diventare il palcoscenico di una nuova Guerra Fredda
L’articolo Quale Iraq e quale Siria dopo le guerre di Mosul e Aleppo? sembra essere il primo su Arabpress.
Quale Iraq e quale Siria dopo le guerre di Mosul e Aleppo?
Il Medio Oriente, in seguito agli ultimi avvenimenti, potrebbe diventare il palcoscenico di una nuova Guerra Fredda
L’articolo Quale Iraq e quale Siria dopo le guerre di Mosul e Aleppo? sembra essere il primo su Arabpress.
Pestaggi e migranti morti in mare nel Mediterraneo centrale
Pestati da bastoni e “fatti naufragare” in mare. Questa è l’essenza dell’attacco da parte di un motoscafo della guardia costiera libica…
L’Auberge des Migrants e l’espulsione che si prepara
Pubblichiamo la traduzione di questa nota del 22 ottobre di L’Auberge des Migrants la più grande ONG locale che opera a Calais.
Erdoğan minaccia i turchi e i suoi vicini
La politica di Recep Tayyep Erdoğan non soddisfa né la Turchia né il mondo intero, mentre il presidente avanza nuove minacce
L’articolo Erdoğan minaccia i turchi e i suoi vicini sembra essere il primo su Arabpress.
Erdoğan minaccia i turchi e i suoi vicini
La politica di Recep Tayyep Erdoğan non soddisfa né la Turchia né il mondo intero, mentre il presidente avanza nuove minacce
L’articolo Erdoğan minaccia i turchi e i suoi vicini sembra essere il primo su Arabpress.
Un premio alla memoria a Nizar Qabbani (e un evento per celebrare la letteratura come dialogo)
Vi ricordate l’antologia di poesie del poeta siriano Nizar Qabbani, tradotta in italiano da Silvia Moresi e Nabil Salameh e pubblicata da Jouvence? Verrà premiata questo mercoledì a Roma, nel corso di un evento dedicato alla letteratura come “ponte di dialogo tra i popoli”, organizzato dall’Istituto euro-mediterraneo e per i paesi arabi (ADDAR), insieme allo … Continua a leggere Un premio alla memoria a Nizar Qabbani (e un evento per celebrare la letteratura come dialogo) →![]()
Un premio alla memoria a Nizar Qabbani (e un evento per celebrare la letteratura come dialogo)
Vi ricordate l’antologia di poesie del poeta siriano Nizar Qabbani, tradotta in italiano da Silvia Moresi e Nabil Salameh e pubblicata da Jouvence? Verrà premiata questo mercoledì a Roma, nel corso di un evento dedicato alla letteratura come “ponte di dialogo tra i popoli”, organizzato dall’Istituto euro-mediterraneo e per i paesi arabi (ADDAR), insieme allo … Continua a leggere Un premio alla memoria a Nizar Qabbani (e un evento per celebrare la letteratura come dialogo) →![]()
Calais — L’evacuazione sta per iniziare
Dopo l’incontro del 20 ottobre tra la Prefettura e le associazioni sui CAO (Centro d’Accoglienza e Orientamento), sappiamo come la…
Calais. Inizia l’evacuazione della jungle e la deportazione dei rifugiati
Lo smantellamento della bidonville di Calais inizia domani lunedì 24 ottobre, la distruzione del campo è prevista a partire da martedì 25…
Siria: in uscita un libro sul giornalismo partecipativo nella città deserta di Daraya
Una piccola casa editrice spagnola vuole lanciare un libro gratuito rigurdo uno dei più noti gruppi di giornalismo partecipativo attivi in Siria, “Enab Baladi.”
Siria: in uscita un libro sul giornalismo partecipativo nella città deserta di Daraya
Una piccola casa editrice spagnola vuole lanciare un libro gratuito rigurdo uno dei più noti gruppi di giornalismo partecipativo attivi in Siria, “Enab Baladi.”
Siria: in uscita un libro sul giornalismo partecipativo nella città deserta di Daraya
Una piccola casa editrice spagnola vuole lanciare un libro gratuito rigurdo uno dei più noti gruppi di giornalismo partecipativo attivi in Siria, “Enab Baladi.”
Siria: in uscita un libro sul giornalismo partecipativo nella città deserta di Daraya
Una piccola casa editrice spagnola vuole lanciare un libro gratuito rigurdo uno dei più noti gruppi di giornalismo partecipativo attivi in Siria, “Enab Baladi.”
Michel Aoun come presidente: un nuovo capitolo nella storia del Libano
Il segretario del Movimento il Futuro, Saad Hariri ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di Michel Aoun per la carica di presidente della repubblica
L’articolo Michel Aoun come presidente: un nuovo capitolo nella storia del Libano sembra essere il primo su Arabpress.
Michel Aoun come presidente: un nuovo capitolo nella storia del Libano
Il segretario del Movimento il Futuro, Saad Hariri ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di Michel Aoun per la carica di presidente della repubblica
L’articolo Michel Aoun come presidente: un nuovo capitolo nella storia del Libano sembra essere il primo su Arabpress.
La battaglia di Mosul tra identità, diritti e futuro in Iraq
La sconfitta di Daesh in Iraq potrebbe non significare affatto la fine delle ostilità e il riconoscimento dei diritti della popolazione
L’articolo La battaglia di Mosul tra identità, diritti e futuro in Iraq sembra essere il primo su Arabpress.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Terrorismo e violenza: Origine e strategie di prevezione
Convegno all’università di Roma “La Sapienza” Terrorismo e violenza Origine e strategie di prevezione il ruolo delle religioni Mercoledi 26 Ottobre 2016
Libia: un inferno con Gheddafi, un incubo senza di lui
Cinque anni dopo la morte di Muammar Gheddafi, il panorama della Libia è atroce.
L’articolo Libia: un inferno con Gheddafi, un incubo senza di lui sembra essere il primo su Arabpress.
Padova — La scuola Liberalaparola riprende i corsi d’italiano gratuiti e aperti a tutti
Padova — Inizia un nuovo anno scolastico per la scuola Liberalaparola, un progetto che è costituito a partire dalla condivisione di idee e…
Cucina palestinese: mnezalli, sformato di melanzane e carne
Le melanzane sono uno degli ingredienti più diffusi nella cucina mediorientale e in particolare in quella palestinese. Il piatto che vi proponiamo oggi è davvero gustoso e può essere preparato sia friggendo le melanzane che cuocendole al forno. Scopriamo come preparare il mnezalli, sformato di melanzane e carne! Ingredienti: 3 melanzane medie olio di oliva/burro chiarificato […]
L’articolo Cucina palestinese: mnezalli, sformato di melanzane e carne sembra essere il primo su Arabpress.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retormarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Oriente(d): percorso d’interazione tra identità
“ORIENTED”: così si intitola il film-documentario proiettato mercoledì 12 ottobre presso il cinema “Il Piccolo” a Matera (Trailer film). L’associazione materana “RiSvolta: i colori dei diritti” insieme a “Casa Netural” hanno accolto la richiesta di tre ragazzi omosessuali di proiettare… Continue Reading →![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Nella tragedia e fra i misteri di Lockerbie, anche l’umana solidarietà
mcc43 Volo PanAm 103 precipitato a Lockerbie: tragedia, complotto, fallimento della Giustizia, ma anche aspetti di umana solidarietà sconosciuti alle cronache. La notte del 21 dicembre 1988, una bomba esplose a bordo del volo Pan Am 103 diretto a New York, mandando in pezzi il velivolo. Il relitto precipitò sugli abitanti addormentati della cittadina scozzese […]![]()
Online Report #20GiugnoLasciateCIEntrare: numeri dati e report della società civile
A seguito della pubblicazione del rapporto “Accogliere: la vera emergenza” pubblicato a febbraio 2016, la rete degli attivisti e…
La settimana di Arabpress in podcast – IV puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – IV puntata sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – IV puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – IV puntata sembra essere il primo su Arabpress.
I giovani arabi si aspettano la caduta di Daesh, affascinati invece dal modello emiratino
Di Abdul Rahim al-Sharqawi. Hespress (19/10/2016). Traduzione e sintesi di Irene Capiferri. Secondo i risultati di un sondaggio, la stragrande maggioranza dei giovani arabi ripudia Daesh (ISIS) e non lo ritiene capace di costruire uno Stato islamico. Dall’ottavo sondaggio annuale dal titolo “Nei cuori e nelle menti dei giovani arabi”, basato su 3.500 interviste di ragazzi e […]
L’articolo I giovani arabi si aspettano la caduta di Daesh, affascinati invece dal modello emiratino sembra essere il primo su Arabpress.
I giovani arabi si aspettano la caduta di Daesh, affascinati invece dal modello emiratino
Di Abdul Rahim al-Sharqawi. Hespress (19/10/2016). Traduzione e sintesi di Irene Capiferri. Secondo i risultati di un sondaggio, la stragrande maggioranza dei giovani arabi ripudia Daesh (ISIS) e non lo ritiene capace di costruire uno Stato islamico. Dall’ottavo sondaggio annuale dal titolo “Nei cuori e nelle menti dei giovani arabi”, basato su 3.500 interviste di ragazzi e […]
L’articolo I giovani arabi si aspettano la caduta di Daesh, affascinati invece dal modello emiratino sembra essere il primo su Arabpress.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Consiglio di Lettura: “Rogers e la via del drago divorato dal sole” di Ahmed Nàgi
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di Lettura: “Rogers e la via del drago divorato dal sole” di Ahmed Nàgi sembra essere il primo su Arabpress.
Consiglio di Lettura: “Rogers e la via del drago divorato dal sole” di Ahmed Nàgi
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di Lettura: “Rogers e la via del drago divorato dal sole” di Ahmed Nàgi sembra essere il primo su Arabpress.
La Libia bloccata dalla guerra tra governi
Malgrado la formale vittoria dei meccanismi democratici, la Libia resta in balìa di interessi particolaristici che danno vita a governi da nomi retorici
L’articolo La Libia bloccata dalla guerra tra governi sembra essere il primo su Arabpress.
La Libia bloccata dalla guerra tra governi
Malgrado la formale vittoria dei meccanismi democratici, la Libia resta in balìa di interessi particolaristici che danno vita a governi da nomi retorici
L’articolo La Libia bloccata dalla guerra tra governi sembra essere il primo su Arabpress.
La CEDU condanna l’Italia al risarcimento danni per trattenimento illegittimo
Ringraziamo l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione di questa importante sentenza della Corte di Giustizia ottenuta dall’Avv.
CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Una soap opera per dire no alle mutilazioni genitali femminili
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Una soap opera per dire no alle mutilazioni genitali femminili sembra essere il primo su Arabpress.
Una soap opera per dire no alle mutilazioni genitali femminili
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Una soap opera per dire no alle mutilazioni genitali femminili sembra essere il primo su Arabpress.
Carte d’imbarco
Mi ha sempre colpito, nel Palestine Festival of Literature, ascoltare alla fine della rassegna la voce di Suheir Hammad. Poetessa palestinese-americana, intrisa dell’una e dell’altra lingua. Dell’una e l’altra memoria. Come quando si ascolta una vecchia radio, e non si riesce a sintonizzare bene una stazione, e si gira la manopola a destra e sinistra,Read more
Musulmani con Trump
Quando un modello ideologico è più forte dell’identità culturale.
L’articolo Musulmani con Trump sembra essere il primo su Arabpress.
Musulmani con Trump
Quando un modello ideologico è più forte dell’identità culturale.
L’articolo Musulmani con Trump sembra essere il primo su Arabpress.
La “green economy” marocchina
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
La “green economy” marocchina
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
La “green economy” marocchina
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
La “green economy” marocchina
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
Marocco. La condizione sociale sotto Mohammed VI
 |
| Jama’a al-Fna, Marrakech (Credit foto: Jacopo Granci) |
Marocco. La condizione sociale sotto Mohammed VI
 |
| Jama’a al-Fna, Marrakech (Credit foto: Jacopo Granci) |
Marocco. La condizione sociale sotto Mohammed VI
 |
| Jama’a al-Fna, Marrakech (Credit foto: Jacopo Granci) |
Marocco. La condizione sociale sotto Mohammed VI
 |
| Jama’a al-Fna, Marrakech (Credit foto: Jacopo Granci) |
Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso
Tutto come avevamo previsto. La vittoria del PJD alle elezioni del 7 novembre e la nomina del suo leader Abdelilah Benkirane a capo del governo marocchino, ha aperto il balletto delle trattative e delle possibili alleanze fra i partiti per costituire una maggioranza: il compito di Benkirane si sta rivelando tutt’altro che facile. Sono sette […]
L’articolo Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso sembra essere il primo su MaroccOggi.
Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso
Tutto come avevamo previsto. La vittoria del PJD alle elezioni del 7 novembre e la nomina del suo leader Abdelilah Benkirane a capo del governo marocchino, ha aperto il balletto delle trattative e delle possibili alleanze fra i partiti per costituire una maggioranza: il compito di Benkirane si sta rivelando tutt’altro che facile. Sono sette […]
L’articolo Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso sembra essere il primo su MaroccOggi.
Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso
Tutto come avevamo previsto. La vittoria del PJD alle elezioni del 7 novembre e la nomina del suo leader Abdelilah Benkirane a capo del governo marocchino, ha aperto il balletto delle trattative e delle possibili alleanze fra i partiti per costituire una maggioranza: il compito di Benkirane si sta rivelando tutt’altro che facile. Sono sette […]
L’articolo Benkirane e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso sembra essere il primo su MaroccOggi.
Benkiran e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso
Tutto come avevamo previsto. La vittoria del PJD alle elezioni del 7 novembre e la nomina del suo leader Abdelilah Benkiran a capo del governo marocchino, ha aperto il balletto delle trattative e delle possibili alleanze fra i partiti per costituire una maggioranza: il compito di Benkiran si sta rivelando tutt’altro che facile. Sono sette […]
L’articolo Benkiran e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso sembra essere il primo su MaroccOggi.
Benkiran e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso
Tutto come avevamo previsto. La vittoria del PJD alle elezioni del 7 novembre e la nomina del suo leader Abdelilah Benkiran a capo del governo marocchino, ha aperto il balletto delle trattative e delle possibili alleanze fra i partiti per costituire una maggioranza: il compito di Benkiran si sta rivelando tutt’altro che facile. Sono sette […]
L’articolo Benkiran e gli scenari futuri di governo: trattative ancora in corso sembra essere il primo su MaroccOggi.
Indie folk da Beirut: intervista ai Postcards
Attivi dal 2012, i Postcards sono una band indie folk di Beirut, formata da Julia Sabra, Marwan Tohme, Rany Bechara e Pascal Semerdjian. Con alle spalle già due EP, sono in fase di registrazione del loro primo album ufficiale. Li abbiamo conosciuti in occasione del loro concerto a Roma, nel quadro del tour italiano attualmente in corso, e abbiamo […]
L’articolo Indie folk da Beirut: intervista ai Postcards sembra essere il primo su Arabpress.
Indie folk da Beirut: intervista ai Postcards
Attivi dal 2012, i Postcards sono una band indie folk di Beirut, formata da Julia Sabra, Marwan Tohme, Rany Bechara e Pascal Semerdjian. Con alle spalle già due EP, sono in fase di registrazione del loro primo album ufficiale. Li abbiamo conosciuti in occasione del loro concerto a Roma, nel quadro del tour italiano attualmente in corso, e abbiamo […]
L’articolo Indie folk da Beirut: intervista ai Postcards sembra essere il primo su Arabpress.
Status di rifugiato a due fratelli palestinesi in fuga dalla persecuzione per motivi politici
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione.
Migranti:Germania800 attentati a centri accoglienza in 2016
Migranti:Germania,800 attentati a centri accoglienza in 2016
http://ift.tt/2e5c6Xs
I confini dell’accordo Sykes-Picot e la battaglia di Mosul
Di Alaa Halabi. As-Safir (18/10/2016). Traduzione e sintesi di Federico Seibusi. La battaglia per la liberazione di Mosul, ultima fortezza di Daesh (ISIS) in Iraq, rappresenta un elemento di una questione più complessa, quella del confine fra Siria e Iraq, regione sulla quale ha avuto gravi ripercussioni la presenza di questa organizzazione terroristica. L’organizzazione Daesh […]
L’articolo I confini dell’accordo Sykes-Picot e la battaglia di Mosul sembra essere il primo su Arabpress.
I confini dell’accordo Sykes-Picot e la battaglia di Mosul
Di Alaa Halabi. As-Safir (18/10/2016). Traduzione e sintesi di Federico Seibusi. La battaglia per la liberazione di Mosul, ultima fortezza di Daesh (ISIS) in Iraq, rappresenta un elemento di una questione più complessa, quella del confine fra Siria e Iraq, regione sulla quale ha avuto gravi ripercussioni la presenza di questa organizzazione terroristica. L’organizzazione Daesh […]
L’articolo I confini dell’accordo Sykes-Picot e la battaglia di Mosul sembra essere il primo su Arabpress.
Quando la guerra è raccontata dalle donne
 Una mostra a Palazzo Madama, Torino, fino al 13 novembre prossimo, racconta il lavoro delle donne fotoreporter, seguendole “In prima linea”. Per cercare la differenza femminile nello sguardo che racconta il dolore estremo che segna tutti i luoghi di guerra. Intervista con Andreja Restek, giornalista e fotoreporter, cheha curato l’iniziativa insieme alla giornalista Stefanella Campana.
Una mostra a Palazzo Madama, Torino, fino al 13 novembre prossimo, racconta il lavoro delle donne fotoreporter, seguendole “In prima linea”. Per cercare la differenza femminile nello sguardo che racconta il dolore estremo che segna tutti i luoghi di guerra. Intervista con Andreja Restek, giornalista e fotoreporter, cheha curato l’iniziativa insieme alla giornalista Stefanella Campana.
#overthefortress in Grecia — Fuori dal campo di Oraiokastro muoiono una giovane donna e suo figlio
Ritorniamo al campo di Oraiokastro, una delle tante municipalità di Salonicco che ospita un campo profughi.
L’acqua dei berberi, l’argento del re
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
L’acqua dei berberi, l’argento del re
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
L’acqua dei berberi, l’argento del re
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
L’acqua dei berberi, l’argento del re
 |
| (Credit foto: Jacopo Granci) |
Gambia — Status di rifugiato al richiedente. Frettolosa e superficiale l’audizione in Commissione
Si ringraziano gli Avv.ti Marcello e Chiara Damiata del foro di Palermo per la segnalazione.
I doveri dell’Ungheria verso i rifugiati
Strasburgo, Francia — Al recente summit dell’Unione Europea a Bratislava, in Slovacchia, gli approcci divergenti dei paesi membri su come…
#overthefortress in #Grecia — Il ritorno a Salonicco
Photo credit: Stefano Danieli
Ci lasciamo alle spalle Idomeni e andiamo verso Salonicco.
Il primo confronto tra Stati Uniti e ribelli Houthi in Yemen
Gli Houthi dovrebbero essere considerati un gruppo terroristico al pari di Al-Qaeda e DAESH, anche se non attaccano l’Occidente
L’articolo Il primo confronto tra Stati Uniti e ribelli Houthi in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
Il primo confronto tra Stati Uniti e ribelli Houthi in Yemen
Gli Houthi dovrebbero essere considerati un gruppo terroristico al pari di Al-Qaeda e DAESH, anche se non attaccano l’Occidente
L’articolo Il primo confronto tra Stati Uniti e ribelli Houthi in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
Con Dabiq, Daesh perde la città simbolo della sua propaganda
Piccolo borgo, quasi insignificante a livello militare, la città siriana era diventata una parte centrale della propaganda apocalittica di Daesh (ISIS)
L’articolo Con Dabiq, Daesh perde la città simbolo della sua propaganda sembra essere il primo su Arabpress.
Con Dabiq, Daesh perde la città simbolo della sua propaganda
Piccolo borgo, quasi insignificante a livello militare, la città siriana era diventata una parte centrale della propaganda apocalittica di Daesh (ISIS)
L’articolo Con Dabiq, Daesh perde la città simbolo della sua propaganda sembra essere il primo su Arabpress.
Tunisia. Gafsa, dove la ricchezza scompare e l’inquinamento resta
(Articolo originale pubblicato dal sito di informazione francofono Basta!, traduzione a cura di Osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gafsa, dove la ricchezza scompare e l’inquinamento resta
(Articolo originale pubblicato dal sito di informazione francofono Basta!, traduzione a cura di Osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gafsa, dove la ricchezza scompare e l’inquinamento resta
(Articolo originale pubblicato dal sito di informazione francofono Basta!, traduzione a cura di Osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gafsa, dove la ricchezza scompare e l’inquinamento resta
(Articolo originale pubblicato dal sito di informazione francofono Basta!, traduzione a cura di Osservatorioiraq.it)
Tunisia. Al cinema “la maledizione dei fosfati”
 |
| (Credit foto: Garboussi) |
Tunisia. Al cinema “la maledizione dei fosfati”
 |
| (Credit foto: Garboussi) |
Tunisia. Al cinema “la maledizione dei fosfati”
 |
| (Credit foto: Garboussi) |
Tunisia. Al cinema “la maledizione dei fosfati”
 |
| (Credit foto: Garboussi) |
Tunisia. Gabès, l’antica Takapes: una città maledetta?
 |
| (Credit foto: Laura Benetton) |
(Articolo originale pubblicato da Nawaat, traduzione a cura di http://osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gabès, l’antica Takapes: una città maledetta?
 |
| (Credit foto: Laura Benetton) |
(Articolo originale pubblicato da Nawaat, traduzione a cura di http://osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gabès, l’antica Takapes: una città maledetta?
 |
| (Credit foto: Laura Benetton) |
(Articolo originale pubblicato da Nawaat, traduzione a cura di http://osservatorioiraq.it)
Tunisia. Gabès, l’antica Takapes: una città maledetta?
 |
| (Credit foto: Laura Benetton) |
(Articolo originale pubblicato da Nawaat, traduzione a cura di http://osservatorioiraq.it)
The Jungle Calais (video)
Dal viaggio di Mara Scampoli e Mattia Alunni Cardinali (agosto 2016) nel campo informale di Calais è stato prodotto il reportage “Calais…
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. La nota è della redazione.
Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un giovane cittadino del Mali considerando il Paese in una situazione di…
Il premier israeliano contro la risoluzione dell’UNESCO
Alla risoluzione UNESCO sull’assenza di legame tra lo “Stato ebraico” e il Monte del Tempio, segue l’ira di Benjamin Netanyahu
L’articolo Il premier israeliano contro la risoluzione dell’UNESCO sembra essere il primo su Arabpress.
Si ringrazia Giovanna Cavallo di Action Diritti in movimento per la segnalazione.
Così ha decretato il tribunale di Roma con un’ordinanza ex art. 702 BIS C.P.C. nel ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Ferrara e…
Udine — Il coprifuoco per i richiedenti asilo è una grave discriminazione
La Rete Accoglienza del Friuli-Venezia Giulia invita il Prefetto a riflettere sulla proposta fatta in apertura del Tavolo Provinciale sull…
Les activistes de #overthefortress en Grèce : on départ d’où on a laissé…
Foto : Angelo Aprile, Idomeni (aprile 2016) #overthefortress
« Je suis un citoyen,
pas d’Athènes ou de la Grèce,
mais du monde »…
Si ringrazia l’Avv.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016, con la quale la Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e…
Le richieste di asilo fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere
Asilo in Europa invita alla giornata di formazione organizzata in collaborazione con MigraBo LGBTI presso il Cassero LGBT center, via Don…
Perché gli Islamisti hanno primeggiato nelle elezioni in Marocco?
Il discorso politico di Benkirane continua a riscuotere successi nonostante la volontà del Palazzo
L’articolo Perché gli Islamisti hanno primeggiato nelle elezioni in Marocco? sembra essere il primo su Arabpress.
Marocco. Viaggio tra i volti dell’Atlante
Marocco. Viaggio tra i volti dell’Atlante
Marocco. Viaggio tra i volti dell’Atlante
Marocco. Viaggio tra i volti dell’Atlante
L’infanzia perduta di Anfgou
L’infanzia perduta di Anfgou
L’infanzia perduta di Anfgou
L’infanzia perduta di Anfgou
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Rached Ghannouchi a Roma: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze
Evento a Roma organizzato dall’associazione Ennahda d’Italia: Tunisia e mondo arabo le sfide e le speranze Ospite Rached Ghannouchi presidente del partito tunisino Ennahda Venerdì 21/10/2016 ore 15:30 Via Principe Amedeo 5/B
Controversie tra Egitto e Arabia Saudita
L’Arabia Saudita ha interrotto le sue esportazioni di petrolio verso l’Egitto
L’articolo Controversie tra Egitto e Arabia Saudita sembra essere il primo su Arabpress.
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Sulla letteratura delle iraniane
http://www.iran-newspaper.com/?nid=6334&pid=12&type=0
Turchia-Russia: il trionfo del pragmatismo
L’accordo sul “Turkish Stream” suggella la riappacificazione tra Turchia e Russia
L’articolo Turchia-Russia: il trionfo del pragmatismo sembra essere il primo su Arabpress.
Studente tunisino denuncia le pessime condizioni della sua scuola e rischia la sospensione
L’amministrazione scolastica ha accusato Hamza Batti di “aver creato una campagna diffamante e distorta” contro l’istituto in questione, che sulla carta si considera pure “pionieristico”.
Studente tunisino denuncia le pessime condizioni della sua scuola e rischia la sospensione
L’amministrazione scolastica ha accusato Hamza Batti di “aver creato una campagna diffamante e distorta” contro l’istituto in questione, che sulla carta si considera pure “pionieristico”.
Studente tunisino denuncia le pessime condizioni della sua scuola e rischia la sospensione
L’amministrazione scolastica ha accusato Hamza Batti di “aver creato una campagna diffamante e distorta” contro l’istituto in questione, che sulla carta si considera pure “pionieristico”.
Un nuovo blog per connettere il Regno Unito al pubblico arabo
Il blog è stato creato dal centro Media e Comunicazioni regionali con base a Dubai con l’obiettivo di informare, ma anche di ascoltare il pubblico del Medio Oriente e del Nord Africa
L’articolo Un nuovo blog per connettere il Regno Unito al pubblico arabo sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in Podcast – III puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti
L’articolo La settimana di Arabpress in Podcast – III puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse”
La produzione di materiali di propaganda dello Stato Islamico è in drastica riduzione e coincide con i successi militari della coalizione internazionale in Siria e in Iraq. Lo afferma una ricerca pubblicata lunedì scorso dal Combat Terrorism Center di West Point. Il centro statunitense ha analizzato video e foto diffuse sui social network solo da “media […]
L’articolo Isis, propaganda crollata e territorio ridotto di 1/4. Analista: “Ripiegamento strategico per risparmiare risorse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Cucina libica: bazeen
Molto diffuso in tutto il Nord Africa, questo piatto è un caposaldo della cucina libica. Si tratta di una pietanza amazigh il cui ingrediente principale è l’orzo. Tradizionalmente preparato con carne di agnello, è possibile cucinare questo piatto anche con altri tipi di carne, pesce o legumi, per una versione vegetariana. Andiamo a scoprire come […]
L’articolo Cucina libica: bazeen sembra essere il primo su Arabpress.
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
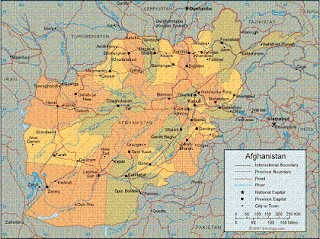 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
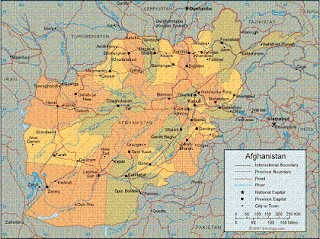 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
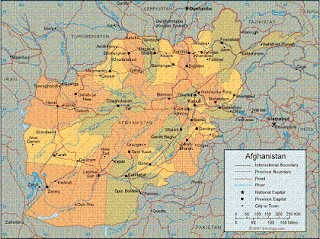 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
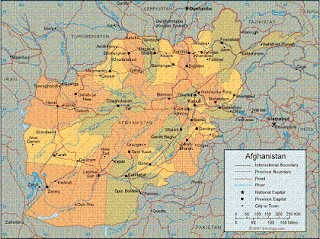 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
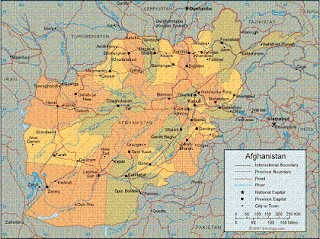 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
L’Oman è davvero neutrale nel conflitto in Yemen?
L’Oman si considera l’“amico di tutti”, affermazione dalla dubbia validità dal momento in cui si sospetta che il sultanato faciliti il contrabbando di armi ai ribelli Houthi in Yemen
L’articolo L’Oman è davvero neutrale nel conflitto in Yemen? sembra essere il primo su Arabpress.
#overthefortress in Grecia — Il ritorno a Idomeni / Coming back to Idomeni
Percorrendo la strada che porta alla stazione di Idomeni, quel piccolo villaggio al confine greco-macedone, non puoi non pensare alle…
La risposta sbagliata. Nuovo sgombero di migranti vulnerabili a Roma
Il fenomeno dei migranti in transito interessa la città di Roma da almeno 10 anni: dagli Afgani della stazione Ostiense, ai Somali dell’ex…
Tassa sul permesso di soggiorno: il Consiglio di Stato posticipa la decisione
Ieri, come spesso accade in questo Paese quando si tratta di riconoscere dei diritti ai cittadini stranieri, il Consiglio di Stato ha…
Esclusi a norma di legge. CITTADINANZA chiama Senato: subito la riforma
Il 13 ottobre del 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla riforma della cittadinanza (ddl Ius…
Passaggi: “La strega nera di Teheran” di Gina B. Nahai
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Passaggi: “La strega nera di Teheran” di Gina B. Nahai sembra essere il primo su Arabpress.
I Fratelli Musulmani in Egitto, Tunisia e Marocco
Uno stesso movimento, tre storie differenti: come adattarsi agli equilibri politici o affrontarli di petto porta a conclusioni differenti
L’articolo I Fratelli Musulmani in Egitto, Tunisia e Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Libia oggi: molti poteri, nessun potere centrale
mcc43 Che il governo “di accordo nazionale”, varato il 17 dicembre dell’anno scorso in Marocco, fosse per l’insieme dei libici una creatura aliena, imposta dall’estero attraverso l’Onu, era chiaro. L’articolo “Libia: i giochi di prestigio dell’Onu” illustrava tutte le riserve dei rappresentanti libici, costretti a firmare il documento che lo istituiva. Le Istituzioni in divenire/ I […]![]()
Libia oggi: molti poteri, nessun potere centrale
mcc43 Che il governo “di accordo nazionale”, varato il 17 dicembre dell’anno scorso in Marocco, fosse per l’insieme dei libici una creatura aliena, imposta dall’estero attraverso l’Onu, era chiaro. L’articolo “Libia: i giochi di prestigio dell’Onu” illustrava tutte le riserve dei rappresentanti libici, costretti a firmare il documento che lo istituiva. Le Istituzioni in divenire/ I […]![]()
Libia oggi: molti poteri, nessun potere centrale
mcc43 Che il governo “di accordo nazionale”, varato il 17 dicembre dell’anno scorso in Marocco, fosse per l’insieme dei libici una creatura aliena, imposta dall’estero attraverso l’Onu, era chiaro. L’articolo “Libia: i giochi di prestigio dell’Onu” illustrava tutte le riserve dei rappresentanti libici, costretti a firmare il documento che lo istituiva. Le Istituzioni in divenire/ I […]![]()
Libia oggi: molti poteri, nessun potere centrale
mcc43 Che il governo “di accordo nazionale”, varato il 17 dicembre dell’anno scorso in Marocco, fosse per l’insieme dei libici una creatura aliena, imposta dall’estero attraverso l’Onu, era chiaro. L’articolo “Libia: i giochi di prestigio dell’Onu” illustrava tutte le riserve dei rappresentanti libici, costretti a firmare il documento che lo istituiva. Le Istituzioni in divenire/ I […]![]()
Libia oggi: molti poteri, nessun potere centrale
mcc43 Che il governo “di accordo nazionale”, varato il 17 dicembre dell’anno scorso in Marocco, fosse per l’insieme dei libici una creatura aliena, imposta dall’estero attraverso l’Onu, era chiaro. L’articolo “Libia: i giochi di prestigio dell’Onu” illustrava tutte le riserve dei rappresentanti libici, costretti a firmare il documento che lo istituiva. Le Istituzioni in divenire/ I […]![]()
L’acquisto della cittadinanza italiana per chi nasce in Italia: una scheda pratica dell’ASGI
Chi nasce in Italia può dichiarare, dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana…
Mali. La protezione umanitaria va riconosciuta ai richiedenti provenienti da questo Paese
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Nigeria. Status di rifugiato al richiedente ricercato per il reato di omosessualità
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Una importantissima sentenza della Corte di Appello di Potenza che rigetta l’appello del Ministero…
Si ringrazia la Dott.ssa. Paola Andrisani per la segnalazione ed il commento.
Una importantissima sentenza della corte di Appello di Potenza che rigetta l’appello del Ministero…
Si ringrazia la Dott.ssa. Paola Andrisani per la segnalazione ed il commento.
Dopo un anno e mezzo di richieste formali, alla Prefettura, il centro di accoglienza allestito…
È dall’estate del 2015 che la Campagna LasciateCIEntrare, insieme ad alcune realtà che si occupano di richiedenti asilo in Friuli-Venezia…
Portami via documentario dedicato ai Corridoi Umanitari di Marta Santamato Cosentino
“Portami via” è un documentario autoprodotto da Marta Santamato Cosentino e da Gabriella Manfrè per Invisibile film.
#Overthefortress activists in Greece: we start again from where we had left
Foto: Angelo Aprile, Idomeni (aprile 2016) #overthefortress
“I am a citizen, not of Athens or Greece, but of the world” (Socrates)
The…
Eutanasia e islam
I punti di vista dal mondo arabo islamico sul tema dell’eutanasia.
L’articolo Eutanasia e islam sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – Il carcere della dittatura uccide!
239 decessi , 597 casi di mancata assistenza medica, 1031 casi di tortura, più 1083 casi di assassini dentro strutture detentive (fonte). Sono solo alcuni dei casi che si è riusciti a provare, provenienti dall’inferno del sistema carcerario egiziano, da … Continue reading →
L’identità irachena tra Turchia e Iran
Alla luce dell’imminente battaglia per la “liberazione” di Mosul, l’identità dell’Iraq è a rischio, schiacciata dalle forti influenze di Turchia e Iran
L’articolo L’identità irachena tra Turchia e Iran sembra essere il primo su Arabpress.
Chi ha vinto il premio Katara per il romanzo arabo 2016?
Ieri sera, in una sontuosa cerimonia che si è svolta all’Opera House di Doha, sono stati proclamati i vincitori del premio per il romanzo arabo Katara, seconda edizione. Il premio è organizzato dalla Fondazione culturale Katara del Qatar ed è nato nel 2014 per “celebrare” il romanzo arabo contemporaneo e darne risalto internazionale, sostenendo la … Continua a leggere Chi ha vinto il premio Katara per il romanzo arabo 2016? →![]()
Chi ha vinto il premio Katara per il romanzo arabo 2016?
Ieri sera, in una sontuosa cerimonia che si è svolta all’Opera House di Doha, sono stati proclamati i vincitori del premio per il romanzo arabo Katara, seconda edizione. Il premio è organizzato dalla Fondazione culturale Katara del Qatar ed è nato nel 2014 per “celebrare” il romanzo arabo contemporaneo e darne risalto internazionale, sostenendo la … Continua a leggere Chi ha vinto il premio Katara per il romanzo arabo 2016? →![]()
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
قاوم بصورة – Resisti con la foto
 L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.
L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.قاوم بصورة – Resisti con la foto
 L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.
L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.قاوم بصورة – Resisti con la foto
 L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.
L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.قاوم بصورة – Resisti con la foto
 L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.
L’amministrazione facebook si è definitivamente politicizzata,a quanto pare a favore di Israele. Da qualche mese parecchi account e pagine legate a Hezbollah,il movimento di resistenza libanese, sono scomparsi dai motori di ricerca. Parecchi amici denunciano la cancellazione dei propri account personal in seguito alla pubblicazione,o alla semplice condivisione di post e fotografie ritraenti Hassan Nasrallah,il leader del movimento di resistenza libanese,considerato un eroe da parte di chi sostiene la lotta contro l’entità sionista e un terrorista da Israele,Arabia Saudita e Stati Uniti.Le richieste di asilo fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere
Asilo in Europa invita alla giornata di formazione organizzata in collaborazione con MigraBo LGBTI presso il Cassero LGBT center, via Don…
Attraversare i confini restare. L’Europa alle prese con le migrazioni
Segnaliamo questo interessante appuntamento organizzato dal Club Alpbach Trentino in collaborazione con l’Università di Trento e il Centro…
Cittadini di fatto fantasmi per legge
Esattamente un anno fa, il 13 ottobre 2015, la Camera licenziò in prima lettura la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza n.91…
“Sognando Jane Austen a Baghdad” di Bee Rowlatt e May Witwit
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro.
L’articolo “Sognando Jane Austen a Baghdad” di Bee Rowlatt e May Witwit sembra essere il primo su Arabpress.
Libano: la carica presidenziale fra le fazioni confessionali e le piazze
Da ormai più di due anni il Libano non ha un capo di Stato
L’articolo Libano: la carica presidenziale fra le fazioni confessionali e le piazze sembra essere il primo su Arabpress.
‘New’ combat role for foreign troops in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
by Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
download the full Volume pages 101-102 CeMiSS OSS 1/2016
ISBN 978-88-99468-15-6
EXECUTIVE SUMMARY
One year has passed since the beginning of US combat Operation ‘Freedom’s Sentinel’ and NATO-led ‘Re…
‘New’ combat role for foreign troops in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
by Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
download the full Volume pages 101-102 CeMiSS OSS 1/2016
ISBN 978-88-99468-15-6
EXECUTIVE SUMMARY
One year has passed since the beginning of US combat Operation ‘Freedom’s Sentinel’ and NATO-led ‘Re…
‘New’ combat role for foreign troops in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
by Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
download the full Volume pages 101-102 CeMiSS OSS 1/2016
ISBN 978-88-99468-15-6
EXECUTIVE SUMMARY
One year has passed since the beginning of US combat Operation ‘Freedom’s Sentinel’ and NATO-led ‘Re…
‘New’ combat role for foreign troops in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
by Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
download the full Volume pages 101-102 CeMiSS OSS 1/2016
ISBN 978-88-99468-15-6
EXECUTIVE SUMMARY
One year has passed since the beginning of US combat Operation ‘Freedom’s Sentinel’ and NATO-led ‘Re…
Bolzano: diritti negati autonomia nella disumanità e irresponsabilità
Domenica sera nell’androne della stazione di Bolzano, A.
‘Nuovo’ ruolo di combattimento per le truppe straniere in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da CeMiSS – Osservatorio Strategico 1/2016 pp. 103-109 – Scarica il Volume
ISBN 978-88-99468-15-6
Quali dinamiche hanno investito la leadership dei taliban, il principale gruppo di opposizione armata operativ…
‘Nuovo’ ruolo di combattimento per le truppe straniere in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da CeMiSS – Osservatorio Strategico 1/2016 pp. 103-109 – Scarica il Volume
ISBN 978-88-99468-15-6
Quali dinamiche hanno investito la leadership dei taliban, il principale gruppo di opposizione armata operativ…
‘Nuovo’ ruolo di combattimento per le truppe straniere in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da CeMiSS – Osservatorio Strategico 1/2016 pp. 103-109 – Scarica il Volume
ISBN 978-88-99468-15-6
Quali dinamiche hanno investito la leadership dei taliban, il principale gruppo di opposizione armata operativ…
‘Nuovo’ ruolo di combattimento per le truppe straniere in Afghanistan (CeMiSS OSS 1/2016)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da CeMiSS – Osservatorio Strategico 1/2016 pp. 103-109 – Scarica il Volume
ISBN 978-88-99468-15-6
Quali dinamiche hanno investito la leadership dei taliban, il principale gruppo di opposizione armata operativ…
Obama e l’Afghanistan (TRECCANI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
in Atlante Geopolitico 2016 TRECCANI – "Gli USA verso le presidenziali del 2016. Le eredità di Obama"
La guerra in Afghanistan, ricevuta in eredità nel 2008
dall’amministrazione di George W. Bush, è da subito definita dal
neo-eletto presidente degli Stati Uniti Barack Obama «guerra giusta e
cruciale».
E già nel gennaio del 2009, Obama aumenta di
Obama e l’Afghanistan (TRECCANI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
in Atlante Geopolitico 2016 TRECCANI – "Gli USA verso le presidenziali del 2016. Le eredità di Obama"
La guerra in Afghanistan, ricevuta in eredità nel 2008
dall’amministrazione di George W. Bush, è da subito definita dal
neo-eletto presidente degli Stati Uniti Barack Obama «guerra giusta e
cruciale».
E già nel gennaio del 2009, Obama aumenta di
Obama e l’Afghanistan (TRECCANI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
in Atlante Geopolitico 2016 TRECCANI – "Gli USA verso le presidenziali del 2016. Le eredità di Obama"
La guerra in Afghanistan, ricevuta in eredità nel 2008
dall’amministrazione di George W. Bush, è da subito definita dal
neo-eletto presidente degli Stati Uniti Barack Obama «guerra giusta e
cruciale».
E già nel gennaio del 2009, Obama aumenta di
Obama e l’Afghanistan (TRECCANI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
in Atlante Geopolitico 2016 TRECCANI – "Gli USA verso le presidenziali del 2016. Le eredità di Obama"
La guerra in Afghanistan, ricevuta in eredità nel 2008
dall’amministrazione di George W. Bush, è da subito definita dal
neo-eletto presidente degli Stati Uniti Barack Obama «guerra giusta e
cruciale».
E già nel gennaio del 2009, Obama aumenta di
Afghanistan: la frantumazione del movimento taliban e il ruolo dello Stato islamico (ISPI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da ISPI – ispionline.it – scarica il COMMENTARY in pdf
L’incontrastata
offensiva dei taliban conferma una capacità di saper operare sia sul
piano operativo-strategico sia su quello politico-dip…
Afghanistan: la frantumazione del movimento taliban e il ruolo dello Stato islamico (ISPI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da ISPI – ispionline.it – scarica il COMMENTARY in pdf
L’incontrastata
offensiva dei taliban conferma una capacità di saper operare sia sul
piano operativo-strategico sia su quello politico-dip…
Afghanistan: la frantumazione del movimento taliban e il ruolo dello Stato islamico (ISPI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da ISPI – ispionline.it – scarica il COMMENTARY in pdf
L’incontrastata
offensiva dei taliban conferma una capacità di saper operare sia sul
piano operativo-strategico sia su quello politico-dip…
Afghanistan: la frantumazione del movimento taliban e il ruolo dello Stato islamico (ISPI)
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
da ISPI – ispionline.it – scarica il COMMENTARY in pdf
L’incontrastata
offensiva dei taliban conferma una capacità di saper operare sia sul
piano operativo-strategico sia su quello politico-dip…
UE: confermato il supporto internazionale all’Afghanistan
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Kunduz assediata dalle forze islamiche mentre il Governo è impegnato in Europa
Oggi 4 e domani 5 ottobre l’Unione Europea e il Governo Afghano si riuniscono a Bruxelles per la ‘Conferenza sull’Afghanis…
UE: confermato il supporto internazionale all’Afghanistan
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Kunduz assediata dalle forze islamiche mentre il Governo è impegnato in Europa
Oggi 4 e domani 5 ottobre l’Unione Europea e il Governo Afghano si riuniscono a Bruxelles per la ‘Conferenza sull’Afghanis…
UE: confermato il supporto internazionale all’Afghanistan
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Kunduz assediata dalle forze islamiche mentre il Governo è impegnato in Europa
Oggi 4 e domani 5 ottobre l’Unione Europea e il Governo Afghano si riuniscono a Bruxelles per la ‘Conferenza sull’Afghanis…
UE: confermato il supporto internazionale all’Afghanistan
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Kunduz assediata dalle forze islamiche mentre il Governo è impegnato in Europa
Oggi 4 e domani 5 ottobre l’Unione Europea e il Governo Afghano si riuniscono a Bruxelles per la ‘Conferenza sull’Afghanis…
Afghanistan: tranquilli, è sempre peggio
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Da L’INDRO
Dai talebani all’Isis, aumenta la minaccia; con i mujaheddin che potrebbero ricompattarsi contro IS/Daesh
Kabul, 19 aprile. I talebani rivendicano l’attacco commando-suicida che ha provocato …
Afghanistan: tranquilli, è sempre peggio
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Da L’INDRO
Dai talebani all’Isis, aumenta la minaccia; con i mujaheddin che potrebbero ricompattarsi contro IS/Daesh
Kabul, 19 aprile. I talebani rivendicano l’attacco commando-suicida che ha provocato …
Afghanistan: tranquilli, è sempre peggio
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Da L’INDRO
Dai talebani all’Isis, aumenta la minaccia; con i mujaheddin che potrebbero ricompattarsi contro IS/Daesh
Kabul, 19 aprile. I talebani rivendicano l’attacco commando-suicida che ha provocato …
Afghanistan: tranquilli, è sempre peggio
di Claudio Bertolotti
@cbertolotti1
Da L’INDRO
Dai talebani all’Isis, aumenta la minaccia; con i mujaheddin che potrebbero ricompattarsi contro IS/Daesh
Kabul, 19 aprile. I talebani rivendicano l’attacco commando-suicida che ha provocato …
Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane
Alla fine tutto è andato secondo le previsioni. Non c’è stata nessuna sorpresa come paventavano alcuni organi di stampa in Marocco. Ieri pomeriggio, 10 ottobre, il Re Mohamed VI ha dato udienza al Primo ministro uscente e leader del partito PJD , Abdililah Benkirane – che alle elezioni del 7 ottobre ha ottenuto 129 seggi […]
L’articolo Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane sembra essere il primo su MaroccOggi.
Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane
Alla fine tutto è andato secondo le previsioni. Non c’è stata nessuna sorpresa come paventavano alcuni organi di stampa in Marocco. Ieri pomeriggio, 10 ottobre, il Re Mohamed VI ha dato udienza al Primo ministro uscente e leader del partito PJD , Abdililah Benkirane – che alle elezioni del 7 ottobre ha ottenuto 129 seggi […]
L’articolo Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane sembra essere il primo su MaroccOggi.
Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane
Alla fine tutto è andato secondo le previsioni. Non c’è stata nessuna sorpresa come paventavano alcuni organi di stampa in Marocco. Ieri pomeriggio, 10 ottobre, il Re Mohamed VI ha dato udienza al Primo ministro uscente e leader del partito PJD , Abdililah Benkirane – che alle elezioni del 7 ottobre ha ottenuto 129 seggi […]
L’articolo Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane sembra essere il primo su MaroccOggi.
Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane
Alla fine tutto è andato secondo le previsioni. Non c’è stata nessuna sorpresa come paventavano alcuni organi di stampa in Marocco. Ieri pomeriggio, 10 ottobre, il Re Mohamed VI ha dato udienza al Primo ministro uscente e leader del partito PJD , Abdililah Benkirane – che alle elezioni del 7 ottobre ha ottenuto 129 seggi […]
L’articolo Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane sembra essere il primo su MaroccOggi.
Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane
Alla fine tutto è andato secondo le previsioni. Non c’è stata nessuna sorpresa come paventavano alcuni organi di stampa in Marocco. Ieri pomeriggio, 10 ottobre, il Re Mohamed VI ha dato udienza al Primo ministro uscente e leader del partito PJD , Abdililah Benkirane – che alle elezioni del 7 ottobre ha ottenuto 129 seggi […]
L’articolo Analisi del voto: ora la prova delle alleanze per Benkirane sembra essere il primo su MaroccOggi.
Gli attivisti di #overthefortress in Grecia: ripartiamo da dove ci eravamo lasciati
La campagna #overthefortress è iniziata a fine agosto del 2015 con una staffetta durata diversi mesi che ha coniugato un’azione di…
I leader mondiali si incontrano oggi e domani a New York per il meeting delle Nazioni Unite su…
Tutti (in Occidente) hanno familiarità con le tragiche storie ed immagini di barconi di migranti che intraprendono viaggi pericolosi…
Migranti attesi in 129 a Catania mercoledì mattina con la nave Aquarius di Sos Mediterranee
11 ottobre 2016 — Migranti, attesi in 129 a Catania mercoledì mattina con la nave Aquarius di Sos Mediterranee.
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. La nota è della redazione.
Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino del Pakistan.
La vicenda è emblematica del diverso modo in cui…
La memoria di pochi il silenzio di molti. A Pozzallo tre sbarchi e 29 salme
Ultimatum segreto dell’UE all’Afghanistan: accettare 80.000 rimpatriati o perdere gli aiuti
Una nota trapelata prima del summit di Bruxelles sugli aiuti internazionali rivela i piani dell’UE di rendere i contributi assistenziali…
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Sei mesi di Yarmuk e un peso sul cuore
– Papà… Che cos’è la verità? – È il riflesso della tua immagine nello specchio, mio caro. – Io…? – Sì, proprio tu.* (di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Mentre scrivo […]
Jayda Hany, la rivoluzionaria designer di scarpe egiziana
Barakabits. Jayda Hany, designer egiziana di scarpe, sta cambiando il mondo della moda con i suoi modelli di calzature unici, spingendosi ben oltre i confini della semplice scarpa alla moda! Prima di realizzare il suo sogno nel seyyore, Jayda ha studiato Ingegneria architettonica in Egitto, per poi conseguire un Master in Designer per calzature al London College of Fashion. […]
L’articolo Jayda Hany, la rivoluzionaria designer di scarpe egiziana sembra essere il primo su Arabpress.
Yemen: un raid di troppo a Sana’a?
Gli attacchi aerei che hanno fatto 140 morti in Yemen durante il weekend potrebbero avere gravi conseguenze, influenzando le relazioni tra Riyad e Washington
L’articolo Yemen: un raid di troppo a Sana’a? sembra essere il primo su Arabpress.
A Palermo torna il Festival delle Letterature Migranti
C’è un altro bel Festival siciliano in questi giorni, è il Festival delle Letterature Migranti che si terrà a Palermo dal 12 al 16 ottobre. 64 gli incontri letterari e artistici, 143 gli ospiti presenti, tra autori, editori e artisti, oltre al premio Nobel per la Letteratura, lo scrittore nigeriano Wole Soyinka – recita il … Continua a leggere A Palermo torna il Festival delle Letterature Migranti →![]()
A Palermo torna il Festival delle Letterature Migranti
C’è un altro bel Festival siciliano in questi giorni, è il Festival delle Letterature Migranti che si terrà a Palermo dal 12 al 16 ottobre. 64 gli incontri letterari e artistici, 143 gli ospiti presenti, tra autori, editori e artisti, oltre al premio Nobel per la Letteratura, lo scrittore nigeriano Wole Soyinka – recita il … Continua a leggere A Palermo torna il Festival delle Letterature Migranti →![]()
Parole che migrano
Wole Soyinka, Jenny Erpenbeck, Ahmed Saadawi, Saleem Haddad, Wlodek Goldkorn, Giuseppe Cederna, Teresa De Sio, Piergiorgio Paterlini, Omar Khouri, Lucia Goracci, Dimitri Deliolanes,…. L’elenco è troppo lungo. Sfogliate il programma. Palermo, da dopodomani, diventa il centro. Di molte cose. E allo stesso tempo, per fortuna, rimane periferia, così da mantenere la sua anima. Il programmaRead more
Il terrorismo e l’informazione in Israele ai tempi del «gag order»
C’è lui, l’aggressore, che arriva dalla Cisgiordania. Ci sono loro, le vittime (tra morti e feriti), israeliane. C’è la dinamica. Ci sono i fermi. L’inchiesta. Il solito codazzo di polemiche, politiche e militari. Poi c’è l’informazione. Che quando ha il marchio di cronisti come quelli di Haaretz e Yedioth Ahronoth, Maariv e Jerusalem Post, Canale […]![]()
Il terrorismo e l’informazione in Israele ai tempi del «gag order»
C’è lui, l’aggressore, che arriva dalla Cisgiordania. Ci sono loro, le vittime (tra morti e feriti), israeliane. C’è la dinamica. Ci sono i fermi. L’inchiesta. Il solito codazzo di polemiche, politiche e militari. Poi c’è l’informazione. Che quando ha il marchio di cronisti come quelli di Haaretz e Yedioth Ahronoth, Maariv e Jerusalem Post, Canale […]![]()
Il terrorismo e l’informazione in Israele ai tempi del «gag order»
C’è lui, l’aggressore, che arriva dalla Cisgiordania. Ci sono loro, le vittime (tra morti e feriti), israeliane. C’è la dinamica. Ci sono i fermi. L’inchiesta. Il solito codazzo di polemiche, politiche e militari. Poi c’è l’informazione. Che quando ha il marchio di cronisti come quelli di Haaretz e Yedioth Ahronoth, Maariv e Jerusalem Post, Canale […]![]()
Il terrorismo e l’informazione in Israele ai tempi del «gag order»
C’è lui, l’aggressore, che arriva dalla Cisgiordania. Ci sono loro, le vittime (tra morti e feriti), israeliane. C’è la dinamica. Ci sono i fermi. L’inchiesta. Il solito codazzo di polemiche, politiche e militari. Poi c’è l’informazione. Che quando ha il marchio di cronisti come quelli di Haaretz e Yedioth Ahronoth, Maariv e Jerusalem Post, Canale […]![]()
Il terrorismo e l’informazione in Israele a tempi del «gag order»
C’è lui, l’aggressore, che arriva dalla Cisgiordania. Ci sono loro, le vittime (tra morti e feriti), israeliane. C’è la dinamica. Ci sono i fermi. L’inchiesta. Il solito codazzo di polemiche, politiche e militari. Poi c’è l’informazione. Che quando ha il marchio di cronisti come quelli di Haaretz e Yedioth Ahronoth, Maariv e Jerusalem Post, Canale […]![]()
Guest post di Thomas Spijkerboer, Professore in Migration Law, Vrije Universiteit Amsterdam.
Il 18 marzo 2016 l’Unione Europea e la Turchia hanno concordato che tutti i migranti irregolari in arrivo sulle isole greche dovessero…
La settimana di Arabpress in Podcast – II puntata
Le notizie più rilevanti del panorama arabo in 5 minuti!
L’articolo La settimana di Arabpress in Podcast – II puntata sembra essere il primo su Arabpress.
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
La Siria nella coscienza dell’Europa
Santiago Alba Rico e Carlos Varea Ogni volta che scriviamo sulla Siria è per aggiungere morti e rovine ad una lista infinita. I bombardamenti indiscriminati su Aleppo delle ultime settimane e la situazione stessa della città, assediata e affamata dal regime e dai suoi alleati, difesa da milizie ribelli diverse e talvolta contrapposte tra loro, danno la misura esatta della […]
Il demos migrante
http://ift.tt/2dQGdlx
di Stefano Rota — Associazione transglobal La “domanda” d’asilo assume un ruolo egemone tra la molteplicità di…
A Doha la II edizione del Premio Katara per il romanzo arabo
Dal 10 al 12 ottobre si tiene a Doha, in Qatar, il Festival letterario Katara all’interno del quale verrà assegnato il Premio Katara per il romanzo arabo, che quest’anno celebra la sua seconda edizione. Il premio Katara si divide in tre categorie: romanzi pubblicati; romanzi non pubblicati; studi di critica letteraria. Per ogni categoria vengono … Continua a leggere A Doha la II edizione del Premio Katara per il romanzo arabo →![]()
I fili sulla tela
Ci ha lasciato una tela, e su quella abbiamo ricamato. Chi conoscendo la sua grande lezione di umiltà e gioia. Chi con un segno scritto in modo involontario. Fatima Mernissi, sociologa e intellettuale e femminista marocchina, ha dato, attraverso le sue riflessioni, contemporaneità a gesti antichi. Gesti che avevamo rifiutato perché linavevamo appaiati a unaRead more
Sciopero: se 150 milioni di persone che protestano non bucano il video
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi
Iphone e cortei
 Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
C’è chi fa le pulci
 |
| Asia Ramazan Antar nelle due immagini più note che, secondo gran parte dei media, mettono in rilievo la somiglianza con l’attrice Angiolina Jolie |
Fair, un’associazione americana che dal 1968 si occupa di censura, accuratezza e parzialità dei media, ha fatto le pulci anche ai giornali non indiani: non una menzione dai network americani Abc, Cbs, Nbc, Cnn, Fox, Msnbc. Npr. Anche giornali importanti come New York Times, Washington Post o USA Today si sono limitati a riprendere note d’agenzia, per altro scarse. Nessuno aveva sentito il bisogno di far muovere inviati o corrispondenti. In Italia? Lasciamo perdere.
Se si esclude qualche sito specializzato (anche italiano), 150 milioni di persone in sciopero semplicemente non c’erano. Oscurate. Da cosa? Fair fa un parallelo con la notizia dell’imminente uscita dell’ultimo iPhone di Apple. «Questo – scrive il direttore di Fair.org, Jim Naureckas – fa notizia»: per Cbs nel suo programma Money Watch e così per Npr nelle rubriche Morning Edition e All Things Considered. Iphone guadagna un titolo di prima in USA Today e nel Wall Street Journal o nella business section del New York Times.
Bambini in fuga
Anche i minori, nonostante sia un tema che suscita almeno compassione, sono abbastanza oscurati. Poca luce per l’ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” appena pubblicato dal Fondo dell’Onu per l’infanzia che spiega come quasi 50 milioni di ragazzi e bambini attraversino frontiere o scappino dai conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte fra loro proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da due sole nazioni: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci ma dell’Afghanistan assai meno perché quella guerra è ormai uscita dai riflettori. Oscurata dall’indifferenza per un conflitto considerato chiuso. Eppure ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano migliaia di persone, bambini compresi, che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
Sfollati afgani
 |
| L’Afghanistan, la guerra, i morti e gli sfollati sono spariti dai grandi media |
Secondo il sottosegretario generale per gli Affari umanitari (Ocha) Stephen O’Brien è necessario un intervento urgente per far fronte a quello che si pensa potrebbe presto essere il numero degli sfollati che attraversano la frontiera col Pakistan : un milione di persone entro dicembre. L’inverno, ha detto O’Brian, rischia di vedere centinaia di famiglie esposte con un flusso dalla frontiera pachistana di 5mila persone al giorno (già 245mila dall’inizio del 2016) che si aggiungeranno al milione di sfollati interni, in una situazione in cui 2,7 milioni di persone sono malnutrite: fra queste, un milione di bambini sotto i 5 anni. 120mila tra loro rischiano di morire di fame. Uscita se non altro su alcuni giornali locali, la notizia ha fatto rimandare a marzo la scadenza che i pachistani avevano fissato per i rimpatri. Il milione di sfollati è per ora rimandato a primavera.
Talebani sempre cattivi
Se restiamo in Afghanistan c’è anche un’altra notizia che è stata completamente oscurata. Anche dalla stampa locale: la smentita dei talebani sull’azione di commando che lunedi 5 settembre ha semidistrutto un ufficio dell’Ong “Care” a Kabul, dove alcuni militanti, con l’aiuto di un autobomba, avevano preso d’assalto Sharenaw, zona di ambasciate e Ong, sventrando diverse strutture. Care aveva messo le mani avanti sostenendo che a loro avviso l’obiettivo era altro e i talebani hanno chiarito che il target era «un centro di intelligence militare gestito dall’ex capo dell’intelligence dell’amministrazione di Kabul nella quale c’è anche una branca dello spionaggio straniero… la Ong ha sede in una strada della zona militarizzata e non aveva nulla a che vedere col piano. L’obiettivo – scrivono – non era Care International». Vero o falso che sia, la guerra afgana è anche una guerra di bugie visto che per il ministero dell’Interno l’obiettivo era senza dubbio Care pur se la Ong aveva smentito. I talebani hanno polemizzato anche con Amnesty, accusata per aver definito la loro azione un “crimine di guerra”. Amnesty però ha chiesto un’indagine indipendente per chiarire le responsabilità anche se purtroppo questo genere di proposte non vengono mai messe in opera. Restano, con tutte le altre, oscurate.
Incidenti ignoti
Anche l’esplosione alla Tampaco Folis in Bangladesh del 10 settembre è passata quasi inosservata. Come sempre in questi casi, il numero dei morti è andato aumentando sino ad arrivare a 26, un bilancio che potrebbe crescere. Il fuoco è divampato a Tongi, una quindicina di chilometri dalla capitale Dacca e c’erano almeno tre elementi di “notiziabilità”: il numero appunto delle vittime che, nel caso di esplosioni, tende sempre ad aumentare in seguito alle ustioni. Il fatto che la fabbrica lavorava per colossi internazionali come Nestlé o British American Tobacco. Il fatto che si tratta del più grave incidente da quello che nel 2014 uccise oltre mille persone nel collasso del Rana Plaza, un edifico che conteneva diverse fabbrichette tessili e che crollò perché la proprietà aveva deciso di innalzare l’altezza del palazzo. A ben vedere in realtà, nemmeno la vicenda Rana Plaza ebbe, soprattutto in Italia, una grande copertura mediatica. Figurarsi un incendio con “solo” 26 vittime. Fortunatamente del caso di sono occupate diverse associazioni e organizzazioni sindacali locali e internazionali che ormai tengono il Bangladesh sotto stretta sorveglianza. Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network hanno preso subito posizione chiedendo conto a Nestlé e Bat del perché facciano lavorare per loro azienda che non hanno standard adeguati di sicurezza. E’ per altro un caso comune – come nella Tampaco Foils – l’esplosione di boiler e l’incendio che ne consegue che divora rapidamente strutture spesso fragili e inadeguate. Il problema è che che l’accordo sulla prevenzione degli incendi non prevede la prevenzione di queste esplosioni (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Il caso Tampaco potrebbe essere la spinta a rivederlo.
A che serve una campagna
Stampa, televisione, radio possono fare molto. Ma ciò che fa davvero sono le mobilitazioni di associazioni e sindacati. Che a loro volta hanno però bisogno che i media si accorgano delle loro battaglie. I risultati si vedono. Grazie a una campagna durata quattro anni e dopo mesi di negoziato – raccontano alla Campagna “Abiti puliti” – è stato raggiunto finalmente un accordo per il pagamento di altri 5 milioni di dollari di risarcimenti ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime del più grande disastro industriale del Pakistan, avvenuto l’11 settembre 2012. Vi persero la vita più di 255 lavoratori e oltre 50 rimasero feriti nell’incendio divampato nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi. Alcuni lavoratori arsero vivi dietro finestre sprangate e porte bloccate mentre altre rimasero inferme dopo essersi lanciate dai piani più alti. Adesso, il distributore tedesco KiK, unico acquirente conosciuto della Ali Enterprises, ha accettato di versare una quota aggiuntiva di 5,15 milioni di dollari nel fondo per la perdita di reddito, cure mediche e costi di riabilitazione per i feriti e i familiari delle vittime. Precedentemente KiK aveva pagato un milione. La nuova decisione si deve alla campagna promossa da National Trade Union Federation, Piler, IndustriALL Global Union, Clean Clothes Campaign e altre alleanze tra cui UNI Global Union. All’accordo hanno contribuito anche IndustriALL, l’International Labour Organization (ILO) e una richiesta del Ministro dello sviluppo e della cooperazione economica tedesco. Poche settimane prima dell’incendio, l’azienda aveva ricevuto la certificazione SA8000 dalla società di revisione Sai (Social Accountability International) che aveva affidato l’incarico all’ente di certificazione italiano Rina: Teoricamente la fabbrica aveva presumibilmente soddisfatto gli standard internazionali in nove aree, compresa salute e sicurezza. Teoricamente.
Sciopero: se 150 milioni di persone che protestano non bucano il video
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi
Iphone e cortei
 Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
C’è chi fa le pulci
 |
| Asia Ramazan Antar nelle due immagini più note che, secondo gran parte dei media, mettono in rilievo la somiglianza con l’attrice Angiolina Jolie |
Fair, un’associazione americana che dal 1968 si occupa di censura, accuratezza e parzialità dei media, ha fatto le pulci anche ai giornali non indiani: non una menzione dai network americani Abc, Cbs, Nbc, Cnn, Fox, Msnbc. Npr. Anche giornali importanti come New York Times, Washington Post o USA Today si sono limitati a riprendere note d’agenzia, per altro scarse. Nessuno aveva sentito il bisogno di far muovere inviati o corrispondenti. In Italia? Lasciamo perdere.
Se si esclude qualche sito specializzato (anche italiano), 150 milioni di persone in sciopero semplicemente non c’erano. Oscurate. Da cosa? Fair fa un parallelo con la notizia dell’imminente uscita dell’ultimo iPhone di Apple. «Questo – scrive il direttore di Fair.org, Jim Naureckas – fa notizia»: per Cbs nel suo programma Money Watch e così per Npr nelle rubriche Morning Edition e All Things Considered. Iphone guadagna un titolo di prima in USA Today e nel Wall Street Journal o nella business section del New York Times.
Bambini in fuga
Anche i minori, nonostante sia un tema che suscita almeno compassione, sono abbastanza oscurati. Poca luce per l’ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” appena pubblicato dal Fondo dell’Onu per l’infanzia che spiega come quasi 50 milioni di ragazzi e bambini attraversino frontiere o scappino dai conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte fra loro proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da due sole nazioni: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci ma dell’Afghanistan assai meno perché quella guerra è ormai uscita dai riflettori. Oscurata dall’indifferenza per un conflitto considerato chiuso. Eppure ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano migliaia di persone, bambini compresi, che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
Sfollati afgani
 |
| L’Afghanistan, la guerra, i morti e gli sfollati sono spariti dai grandi media |
Secondo il sottosegretario generale per gli Affari umanitari (Ocha) Stephen O’Brien è necessario un intervento urgente per far fronte a quello che si pensa potrebbe presto essere il numero degli sfollati che attraversano la frontiera col Pakistan : un milione di persone entro dicembre. L’inverno, ha detto O’Brian, rischia di vedere centinaia di famiglie esposte con un flusso dalla frontiera pachistana di 5mila persone al giorno (già 245mila dall’inizio del 2016) che si aggiungeranno al milione di sfollati interni, in una situazione in cui 2,7 milioni di persone sono malnutrite: fra queste, un milione di bambini sotto i 5 anni. 120mila tra loro rischiano di morire di fame. Uscita se non altro su alcuni giornali locali, la notizia ha fatto rimandare a marzo la scadenza che i pachistani avevano fissato per i rimpatri. Il milione di sfollati è per ora rimandato a primavera.
Talebani sempre cattivi
Se restiamo in Afghanistan c’è anche un’altra notizia che è stata completamente oscurata. Anche dalla stampa locale: la smentita dei talebani sull’azione di commando che lunedi 5 settembre ha semidistrutto un ufficio dell’Ong “Care” a Kabul, dove alcuni militanti, con l’aiuto di un autobomba, avevano preso d’assalto Sharenaw, zona di ambasciate e Ong, sventrando diverse strutture. Care aveva messo le mani avanti sostenendo che a loro avviso l’obiettivo era altro e i talebani hanno chiarito che il target era «un centro di intelligence militare gestito dall’ex capo dell’intelligence dell’amministrazione di Kabul nella quale c’è anche una branca dello spionaggio straniero… la Ong ha sede in una strada della zona militarizzata e non aveva nulla a che vedere col piano. L’obiettivo – scrivono – non era Care International». Vero o falso che sia, la guerra afgana è anche una guerra di bugie visto che per il ministero dell’Interno l’obiettivo era senza dubbio Care pur se la Ong aveva smentito. I talebani hanno polemizzato anche con Amnesty, accusata per aver definito la loro azione un “crimine di guerra”. Amnesty però ha chiesto un’indagine indipendente per chiarire le responsabilità anche se purtroppo questo genere di proposte non vengono mai messe in opera. Restano, con tutte le altre, oscurate.
Incidenti ignoti
Anche l’esplosione alla Tampaco Folis in Bangladesh del 10 settembre è passata quasi inosservata. Come sempre in questi casi, il numero dei morti è andato aumentando sino ad arrivare a 26, un bilancio che potrebbe crescere. Il fuoco è divampato a Tongi, una quindicina di chilometri dalla capitale Dacca e c’erano almeno tre elementi di “notiziabilità”: il numero appunto delle vittime che, nel caso di esplosioni, tende sempre ad aumentare in seguito alle ustioni. Il fatto che la fabbrica lavorava per colossi internazionali come Nestlé o British American Tobacco. Il fatto che si tratta del più grave incidente da quello che nel 2014 uccise oltre mille persone nel collasso del Rana Plaza, un edifico che conteneva diverse fabbrichette tessili e che crollò perché la proprietà aveva deciso di innalzare l’altezza del palazzo. A ben vedere in realtà, nemmeno la vicenda Rana Plaza ebbe, soprattutto in Italia, una grande copertura mediatica. Figurarsi un incendio con “solo” 26 vittime. Fortunatamente del caso di sono occupate diverse associazioni e organizzazioni sindacali locali e internazionali che ormai tengono il Bangladesh sotto stretta sorveglianza. Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network hanno preso subito posizione chiedendo conto a Nestlé e Bat del perché facciano lavorare per loro azienda che non hanno standard adeguati di sicurezza. E’ per altro un caso comune – come nella Tampaco Foils – l’esplosione di boiler e l’incendio che ne consegue che divora rapidamente strutture spesso fragili e inadeguate. Il problema è che che l’accordo sulla prevenzione degli incendi non prevede la prevenzione di queste esplosioni (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Il caso Tampaco potrebbe essere la spinta a rivederlo.
A che serve una campagna
Stampa, televisione, radio possono fare molto. Ma ciò che fa davvero sono le mobilitazioni di associazioni e sindacati. Che a loro volta hanno però bisogno che i media si accorgano delle loro battaglie. I risultati si vedono. Grazie a una campagna durata quattro anni e dopo mesi di negoziato – raccontano alla Campagna “Abiti puliti” – è stato raggiunto finalmente un accordo per il pagamento di altri 5 milioni di dollari di risarcimenti ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime del più grande disastro industriale del Pakistan, avvenuto l’11 settembre 2012. Vi persero la vita più di 255 lavoratori e oltre 50 rimasero feriti nell’incendio divampato nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi. Alcuni lavoratori arsero vivi dietro finestre sprangate e porte bloccate mentre altre rimasero inferme dopo essersi lanciate dai piani più alti. Adesso, il distributore tedesco KiK, unico acquirente conosciuto della Ali Enterprises, ha accettato di versare una quota aggiuntiva di 5,15 milioni di dollari nel fondo per la perdita di reddito, cure mediche e costi di riabilitazione per i feriti e i familiari delle vittime. Precedentemente KiK aveva pagato un milione. La nuova decisione si deve alla campagna promossa da National Trade Union Federation, Piler, IndustriALL Global Union, Clean Clothes Campaign e altre alleanze tra cui UNI Global Union. All’accordo hanno contribuito anche IndustriALL, l’International Labour Organization (ILO) e una richiesta del Ministro dello sviluppo e della cooperazione economica tedesco. Poche settimane prima dell’incendio, l’azienda aveva ricevuto la certificazione SA8000 dalla società di revisione Sai (Social Accountability International) che aveva affidato l’incarico all’ente di certificazione italiano Rina: Teoricamente la fabbrica aveva presumibilmente soddisfatto gli standard internazionali in nove aree, compresa salute e sicurezza. Teoricamente.
Migranti: manifestazione a Belgradosi’ a profughi no guerre
Migranti: manifestazione a Belgrado,si’ a profughi no guerre
http://ift.tt/2d2GmOi
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
L’oasi di Jemna: una storia di resistenza
Habib Ayeb Da qualche settimana l’attenzione dei tunisini è rivolta a una piccola oasi chiamata Jemna che si trova nel deserto tunisino, da qualche parte fra le oasi di Kebili, a nord e quelle di Douz, a sud (1). Alcuni, in particolare il governo, una parte della “classe” politica e dei media dominanti, vi vedono un’ esemplare violazione della legge […]
Vivere in Libia e raccontarla: intervista a Khalifa Abo Khraisse
“Riassumere brevemente la situazione attuale in Libia sarebbe come voler riassumere le prime quattro stagioni del Trono di Spade in 5 minuti!”: sorridendo, così risponde Khalifa Abo Khraisse quando gli viene chiesto di parlare velocemente di quello che sta succedendo nel suo paese. Giornalista, traduttore, sceneggiatore e regista, Khalifa, più che concentrarsi sul conflitto politico in Libia, ha a […]
L’articolo Vivere in Libia e raccontarla: intervista a Khalifa Abo Khraisse sembra essere il primo su Arabpress.
Siria, la prima missione di Guterres a capo delle Nazioni Unite
Il nuovo Segretario Generale dell’Onu e l’eredità delle complesse relazioni internazionali animate da nuove tensioni nel quadro del conflitto siriano dopo l’impiego delle armi chimiche da parte della Russia
L’articolo Siria, la prima missione di Guterres a capo delle Nazioni Unite sembra essere il primo su Arabpress.
Oggi la Marcia Perugia Assisi per la pace: il programma
della pace e della fraternità
9 ottobre 2016
PROGRAMMA
Ore 7.00 – Perugia, Messa alla Basilica di San Pietro
Ore 7.30 Perugia, Giardini del Frontone
Accoglienza dei partecipanti
Ore 8.30 Perugia, Porta San Girolamo
Interventi di apertura
Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica
Andrea Romizi, Sindaco di Perugia
Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia
Famiglia Galasso
Don Pierluigi di Piazza, Centro di Accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano
Taisir Masrieh, Musicista palestinese
La Famiglia di Raffaella Presta
Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
studenti e insegnanti della scuola di Amatrice
Intervento musicale della Marching Band #AssaltoRitmico
Ore 9.00: Partenza della Marcia da Perugia
Dalle ore 10.00 A Santa Maria degli Angeli,… in attesa della Marcia:
Interventi musicali dei D.E.C. e dei Maram Oriental Ensemble
Interventi delle scuole partecipanti alla Marcia
Padre Kizito, Missionario comboniano
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni
Konstantinos Polikronopoulos, organizzatore della Cucina Sociale “L’altro uomo” di Atene
Mohamed Dachan Nour, Ucoi
Don Renato Sacco, Coordinatore Pax Christi
Pietro Suber, Carta di Roma
Enea Discepoli, fotografo
Giovani provenienti da paesi in guerra – Associazione Rondine Cittadella della pace di Arezzo
Caschi Bianchi operazione Colomba (Cile e Zambia)
Associazione Como senza confini
Intervento teatrale del gruppo Our Voice, giovani di Funima International e Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Conducono Mario Mirabassi, Guido Barbera e Piero Piraccini
Ore 14.00: Arrivo della Marcia nella Piazza inferiore di San Francesco
Saluti di
p. Egidio Canil e p. Enzo Fortunato del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi
Mons. Vincenzo Sorrentino, Vescovo
Ore 15.00 Assisi, Rocca Maggiore
“Manifestazione conclusiva”
Interventi musicali del Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
Intervento musicale di Erica Boschiero
Messaggi e interventi di:
gli studenti e gli insegnanti che partecipano alla PerugiAssisi
gli Enti Locali e le Regioni che partecipano alla PerugiAssisi
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi
Nando Mismetti, Presidente della Provincia di Perugia
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria
Andrea Ferrari, Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Nadia Bouzekri, Presidente Giovani Musulmani d’Italia
Kamal Abbas, Coordinatore del CTUWS, Egitto
Cecile Kyenge, Parlamentare europea
p. Alex Zanotelli, Missionario comboniano
Paolo Borrometi, giornalista Agi
Vittorio Di Trapani, segretario UsigRai
Giuseppe Giulietti, presidente FNSI
Jean Fabre, esperto Onu
Sergio Bassoli, Coordinatore della Rete della pace
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi
Coordina: Elisa Marincola
Ore 16.30 Conclusione della Marcia
Oggi la Marcia Perugia Assisi per la pace: il programma
della pace e della fraternità
9 ottobre 2016
PROGRAMMA
Ore 7.00 – Perugia, Messa alla Basilica di San Pietro
Ore 7.30 Perugia, Giardini del Frontone
Accoglienza dei partecipanti
Ore 8.30 Perugia, Porta San Girolamo
Interventi di apertura
Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica
Andrea Romizi, Sindaco di Perugia
Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia
Famiglia Galasso
Don Pierluigi di Piazza, Centro di Accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano
Taisir Masrieh, Musicista palestinese
La Famiglia di Raffaella Presta
Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
studenti e insegnanti della scuola di Amatrice
Intervento musicale della Marching Band #AssaltoRitmico
Ore 9.00: Partenza della Marcia da Perugia
Dalle ore 10.00 A Santa Maria degli Angeli,… in attesa della Marcia:
Interventi musicali dei D.E.C. e dei Maram Oriental Ensemble
Interventi delle scuole partecipanti alla Marcia
Padre Kizito, Missionario comboniano
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni
Konstantinos Polikronopoulos, organizzatore della Cucina Sociale “L’altro uomo” di Atene
Mohamed Dachan Nour, Ucoi
Don Renato Sacco, Coordinatore Pax Christi
Pietro Suber, Carta di Roma
Enea Discepoli, fotografo
Giovani provenienti da paesi in guerra – Associazione Rondine Cittadella della pace di Arezzo
Caschi Bianchi operazione Colomba (Cile e Zambia)
Associazione Como senza confini
Intervento teatrale del gruppo Our Voice, giovani di Funima International e Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Conducono Mario Mirabassi, Guido Barbera e Piero Piraccini
Ore 14.00: Arrivo della Marcia nella Piazza inferiore di San Francesco
Saluti di
p. Egidio Canil e p. Enzo Fortunato del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi
Mons. Vincenzo Sorrentino, Vescovo
Ore 15.00 Assisi, Rocca Maggiore
“Manifestazione conclusiva”
Interventi musicali del Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
Intervento musicale di Erica Boschiero
Messaggi e interventi di:
gli studenti e gli insegnanti che partecipano alla PerugiAssisi
gli Enti Locali e le Regioni che partecipano alla PerugiAssisi
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi
Nando Mismetti, Presidente della Provincia di Perugia
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria
Andrea Ferrari, Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Nadia Bouzekri, Presidente Giovani Musulmani d’Italia
Kamal Abbas, Coordinatore del CTUWS, Egitto
Cecile Kyenge, Parlamentare europea
p. Alex Zanotelli, Missionario comboniano
Paolo Borrometi, giornalista Agi
Vittorio Di Trapani, segretario UsigRai
Giuseppe Giulietti, presidente FNSI
Jean Fabre, esperto Onu
Sergio Bassoli, Coordinatore della Rete della pace
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi
Coordina: Elisa Marincola
Ore 16.30 Conclusione della Marcia
Turchia-Siria: il muro
La Turchia realizzerà un muro lungo tutto il confine con la Siria, formalmente per difendersi dal terrorismo, ma la situazione appare molto più complessa
L’articolo Turchia-Siria: il muro sembra essere il primo su Arabpress.
Report sull’attendibilità delle foto ”Caesar”
In Siria è in atto una vera e propria guerra mediatica senza esclusioni di colpi. Personalmente trovo davvero molta difficoltà nel tenermi aggiornato circa la situazione politica nazionale e mondiale. Da ben sei anni ho spento il televisore,ho boicottato buona parte dei principali giornali nazionali e occidentali ( per non parlare delle emittenti satellitari arabe come ” Al Jazeera” ) e spulcio le mie informazioni in giornali e siti in lingua araba,francese e inglese poco conosciuti,è questo per cercare di non cadere nella ragnatela della disinformazione e della propaganda,che adesso più che mai,sono riuscite a destabilizzare intere nazioni.
Nel mio blog ho messo a disposizione un report circa l’attendibilità delle fotografie di ”Caesar” che ritraggono i cadaveri tumefatti di presunti oppositori politici arrestati e torturati dalla polizia militare del regime di Assad.
Esattamente qualche giorno fa, nella sala spazio D del Maxxi , a Roma, è stata organizzata una mostra dal titolo : ” Nome in codice Caesar – detenuti siriani vittime di torture ”.
Caesar ”, è il nome in codice di un ex fotografo della polizia militare siriana,che secondo la sua stessa testimonianza,fu incaricato di fotografare i cadaveri dopo la loro esecuzione.
La guerra in Siria continua da ben cinque anni,e secondo le statistiche Onu , i morti del conflitto sono più di 250.000 morti (quasi l’11,5% della popolazione).
Il report è stato stillato dalle redazioni Sibaliria e Antidiplomatico.
Buona lettura
Report sull’attendibilità delle foto ”Caesar”
In Siria è in atto una vera e propria guerra mediatica senza esclusioni di colpi. Personalmente trovo davvero molta difficoltà nel tenermi aggiornato circa la situazione politica nazionale e mondiale. Da ben sei anni ho spento il televisore,ho boicottato buona parte dei principali giornali nazionali e occidentali ( per non parlare delle emittenti satellitari arabe come ” Al Jazeera” ) e spulcio le mie informazioni in giornali e siti in lingua araba,francese e inglese poco conosciuti,è questo per cercare di non cadere nella ragnatela della disinformazione e della propaganda,che adesso più che mai,sono riuscite a destabilizzare intere nazioni.
Nel mio blog ho messo a disposizione un report circa l’attendibilità delle fotografie di ”Caesar” che ritraggono i cadaveri tumefatti di presunti oppositori politici arrestati e torturati dalla polizia militare del regime di Assad.
Esattamente qualche giorno fa, nella sala spazio D del Maxxi , a Roma, è stata organizzata una mostra dal titolo : ” Nome in codice Caesar – detenuti siriani vittime di torture ”.
Caesar ”, è il nome in codice di un ex fotografo della polizia militare siriana,che secondo la sua stessa testimonianza,fu incaricato di fotografare i cadaveri dopo la loro esecuzione.
La guerra in Siria continua da ben cinque anni,e secondo le statistiche Onu , i morti del conflitto sono più di 250.000 morti (quasi l’11,5% della popolazione).
Il report è stato stillato dalle redazioni Sibaliria e Antidiplomatico.
Buona lettura
Report sull’attendibilità delle foto ”Caesar”
In Siria è in atto una vera e propria guerra mediatica senza esclusioni di colpi. Personalmente trovo davvero molta difficoltà nel tenermi aggiornato circa la situazione politica nazionale e mondiale. Da ben sei anni ho spento il televisore,ho boicottato buona parte dei principali giornali nazionali e occidentali ( per non parlare delle emittenti satellitari arabe come ” Al Jazeera” ) e spulcio le mie informazioni in giornali e siti in lingua araba,francese e inglese poco conosciuti,è questo per cercare di non cadere nella ragnatela della disinformazione e della propaganda,che adesso più che mai,sono riuscite a destabilizzare intere nazioni.
Nel mio blog ho messo a disposizione un report circa l’attendibilità delle fotografie di ”Caesar” che ritraggono i cadaveri tumefatti di presunti oppositori politici arrestati e torturati dalla polizia militare del regime di Assad.
Esattamente qualche giorno fa, nella sala spazio D del Maxxi , a Roma, è stata organizzata una mostra dal titolo : ” Nome in codice Caesar – detenuti siriani vittime di torture ”.
Caesar ”, è il nome in codice di un ex fotografo della polizia militare siriana,che secondo la sua stessa testimonianza,fu incaricato di fotografare i cadaveri dopo la loro esecuzione.
La guerra in Siria continua da ben cinque anni,e secondo le statistiche Onu , i morti del conflitto sono più di 250.000 morti (quasi l’11,5% della popolazione).
Il report è stato stillato dalle redazioni Sibaliria e Antidiplomatico.
Buona lettura
Report sull’attendibilità delle foto di ”Caesar”
In Siria è in atto una vera e propria guerra mediatica senza esclusioni di colpi. Personalmente trovo davvero molta difficoltà nel tenermi aggiornato circa la situazione politica,sia nazionale che mondiale. Da ben sei anni ho spento il televisore,ho boicottato buona parte dei principali giornali nazionali e occidentali ( per non parlare delle emittenti satellitari arabe come ” Al Jazeera” ) e spulcio le mie informazioni in giornali e siti in lingua araba,francese e inglese poco conosciuti,è questo per cercare di non cadere nella ragnatela della disinformazione e della propaganda,che adesso più che mai,sono riuscite a destabilizzare intere nazioni.
Nel mio blog ho messo a disposizione un report circa l’attendibilità delle fotografie di ”Caesar” che ritraggono i cadaveri tumefatti di presunti oppositori politici arrestati e torturati dalla polizia militare del regime di Assad.
Esattamente qualche giorno fa, nella sala spazio D del Maxxi , a Roma, è stata organizzata una mostra dal titolo : ” Nome in codice Caesar – detenuti siriani vittime di torture ”.
Caesar ”, è il nome in codice di un ex fotografo della polizia militare siriana,che secondo la sua stessa testimonianza,fu incaricato di fotografare i cadaveri dopo la loro esecuzione.
La guerra in Siria continua da ben cinque anni,e secondo le statistiche Onu , i morti del conflitto sono più di 250.000 morti (quasi l’11,5% della popolazione).
Il report è stato stillato dalle redazioni Sibaliria e Antidiplomatico.
Buona lettura
Report sull’attendibilità delle foto ”Caesar”
In Siria è in atto una vera e propria guerra mediatica senza esclusioni di colpi. Personalmente trovo davvero molta difficoltà nel tenermi aggiornato circa la situazione politica nazionale e mondiale. Da ben sei anni ho spento il televisore,ho boicottato buona parte dei principali giornali nazionali e occidentali ( per non parlare delle emittenti satellitari arabe come ” Al Jazeera” ) e spulcio le mie informazioni in giornali e siti in lingua araba,francese e inglese poco conosciuti,è questo per cercare di non cadere nella ragnatela della disinformazione e della propaganda,che adesso più che mai,sono riuscite a destabilizzare intere nazioni.
Nel mio blog ho messo a disposizione un report circa l’attendibilità delle fotografie di ”Caesar” che ritraggono i cadaveri tumefatti di presunti oppositori politici arrestati e torturati dalla polizia militare del regime di Assad.
Esattamente qualche giorno fa, nella sala spazio D del Maxxi , a Roma, è stata organizzata una mostra dal titolo : ” Nome in codice Caesar – detenuti siriani vittime di torture ”.
Caesar ”, è il nome in codice di un ex fotografo della polizia militare siriana,che secondo la sua stessa testimonianza,fu incaricato di fotografare i cadaveri dopo la loro esecuzione.
La guerra in Siria continua da ben cinque anni,e secondo le statistiche Onu , i morti del conflitto sono più di 250.000 morti (quasi l’11,5% della popolazione).
Il report è stato stillato dalle redazioni Sibaliria e Antidiplomatico.
Buona lettura
Iran: sostieni la campagna #FreeSaeed per scarcerare lo sviluppatore Saeed Malekpour
Saeed Malekpour è stato arrestato e incarcerato nel 2008, dopo che qualcuno ha usato il suo codice open source per caricare materiale pornografico in rete.
Iran: sostieni la campagna #FreeSaeed per scarcerare lo sviluppatore Saeed Malekpour
Saeed Malekpour è stato arrestato e incarcerato nel 2008, dopo che qualcuno ha usato il suo codice open source per caricare materiale pornografico in rete.
Iran: sostieni la campagna #FreeSaeed per scarcerare lo sviluppatore Saeed Malekpour
Saeed Malekpour è stato arrestato e incarcerato nel 2008, dopo che qualcuno ha usato il suo codice open source per caricare materiale pornografico in rete.
Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD
È stata una lunga notte quella di ieri per il Marocco. Già dalle prime ore del mattino gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere i 395 parlamentari. Ma la partecipazione alla fine non ha superato il 43%. Una percentuale bassissima se si pensa agli interessi in ballo, ed è l’ennesima prova che da […]
L’articolo Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD
È stata una lunga notte quella di ieri per il Marocco. Già dalle prime ore del mattino gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere i 395 parlamentari. Ma la partecipazione alla fine non ha superato il 43%. Una percentuale bassissima se si pensa agli interessi in ballo, ed è l’ennesima prova che da […]
L’articolo Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD
È stata una lunga notte quella di ieri per il Marocco. Già dalle prime ore del mattino gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere i 395 parlamentari. Ma la partecipazione alla fine non ha superato il 43%. Una percentuale bassissima se si pensa agli interessi in ballo, ed è l’ennesima prova che da […]
L’articolo Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD
È stata una lunga notte quella di ieri per il Marocco. Già dalle prime ore del mattino gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere i 395 parlamentari. Ma la partecipazione alla fine non ha superato il 43%. Una percentuale bassissima se si pensa agli interessi in ballo, ed è l’ennesima prova che da […]
L’articolo Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD
È stata una lunga notte quella di ieri per il Marocco. Già dalle prime ore del mattino gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere i 395 parlamentari. Ma la partecipazione alla fine non ha superato il 43%. Una percentuale bassissima se si pensa agli interessi in ballo, ed è l’ennesima prova che da […]
L’articolo Il Marocco ha scelto: un secondo mandato per il partito islamista PJD sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco: l’islamista PJD in testa alle elezioni legislative
(Agenzie). Gli islamisti del Partito Giustizia e Sviluppo (PJD) hanno vinto, per la seconda volta consecutiva dopo le votazioni del 2011, le elezioni legislative svoltesi ieri, 7 ottobre, in Marocco. I risultati definitivi, che attendono solo di essere approvati dalla Commissione Nazionale per le Statistiche, vedono il PJD in testa con 98 seggi, mentre il […]
L’articolo Marocco: l’islamista PJD in testa alle elezioni legislative sembra essere il primo su Arabpress.
Segnaliamo questo Master in Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Padova.
Università degli Studi di Padova
Master in Studi Interculturali
Saperi e pratiche per l’accoglienza dei richiedenti asilo
Iscrizioni aperte…
Cucina irachena: infuso di noomi basra (limone essiccato)
Il noomi basra, cioè il limone essiccato, è un ingrediente molto usato nella cucina mediorientale, specialmente in Iraq. Così chiamato perché veniva importato nel paese attraverso il porto di Bassora, questo frutto viene usato per preparare un infuso ricco di vitamine e usato anche come calmante per lo stomaco. Scopriamo come preparare l’infuso di noomi basra! Ingredienti: da […]
L’articolo Cucina irachena: infuso di noomi basra (limone essiccato) sembra essere il primo su Arabpress.
Un altro punto di vista sugli islamisti e la laicità
Nella fase del post rivoluzioni, si è imposto sulla scena araba un Islam politico dalle concezioni laiche, che riconosce nello Stato la fonte della legittimità
L’articolo Un altro punto di vista sugli islamisti e la laicità sembra essere il primo su Arabpress.
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. La nota è della redazione.
Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese proveniente dal zona del Casamance.
La Commissione…
L’UNHCR rileva seri problemi di protezione nelle zone recentemente rese accessibili della Nigeria
La maggior parte dei civili che vivono nella zona settentrionale della Nigeria, che dall’inizio dell’anno è stata riconquistata dalle forze…
Revoca del decreto di espulsione nei confronti di un cittadino senegalese
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Grecia Elliniko camp: una lettera di 141 famiglie
Lettera da 141 capifamiglia nel campo di Elliniko (area dello stadio di baseball)
23 settembre 2016
Nel nome di Dio:
Salutiamo tutti…
Ammissibilità responsabilità e sicurezza nelle procedure europee di asilo
Bruxelles, 7 settembre 2016: nell’adempimento dei rispettivi obblighi internazionali, gli stati europei e gli stati membri dell’Unione…
Le donne sfidano la custodia maschile in Arabia Saudita
Lo scorso 25 settembre 15.000 donne hanno firmato e presentato al governo una petizione per l’abolizione del sistema di custodia maschile
L’articolo Le donne sfidano la custodia maschile in Arabia Saudita sembra essere il primo su Arabpress.
Rachid Daif: il Libano tra lettere a scrittori morti e libertà sessuale
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Rachid Daif: il Libano tra lettere a scrittori morti e libertà sessuale sembra essere il primo su Arabpress.
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati.
La Turchia rinnova lo stato di emergenza
Dopo l’estensione dello stato di emergenza, ancora non si vede alcun progresso giudiziari e si percepisce la deriva sempre più autoritaria
L’articolo La Turchia rinnova lo stato di emergenza sembra essere il primo su Arabpress.
Festival Letterature Migranti – Palermo 12-16 ottobre
Ci siamo quasi. La seconda edizione del Festival Letterature Migranti si aprirà il 12 ottobre, ma già l’8 e il 9 ottobre ci sarà il prequel. Due tra i documentari che abbiamo scelto saranno proiettati al Rouge&Noir, partner d’eccezione. Gli incontri sono tanti. La trama è una: fitta, e il risultato è un ricamo diRead more
Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo
Arrivati all’aeroporto di Mohammed VI di Casablanca c’è un silenzio inconsueto. Girano solo gli addetti dello scalo e i passeggeri provenienti da tutto il mondo. Ma dove sono finiti i parenti e gli amici che, come vuole la consuetudine locale, accorrono in gruppo a dare il benvenuto ai propri cari? Bisogna arrivare fuori, a cielo […]
L’articolo Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo
Arrivati all’aeroporto di Mohammed VI di Casablanca c’è un silenzio inconsueto. Girano solo gli addetti dello scalo e i passeggeri provenienti da tutto il mondo. Ma dove sono finiti i parenti e gli amici che, come vuole la consuetudine locale, accorrono in gruppo a dare il benvenuto ai propri cari? Bisogna arrivare fuori, a cielo […]
L’articolo Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo
Arrivati all’aeroporto di Mohammed VI di Casablanca c’è un silenzio inconsueto. Girano solo gli addetti dello scalo e i passeggeri provenienti da tutto il mondo. Ma dove sono finiti i parenti e gli amici che, come vuole la consuetudine locale, accorrono in gruppo a dare il benvenuto ai propri cari? Bisogna arrivare fuori, a cielo […]
L’articolo Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo
Arrivati all’aeroporto di Mohammed VI di Casablanca c’è un silenzio inconsueto. Girano solo gli addetti dello scalo e i passeggeri provenienti da tutto il mondo. Ma dove sono finiti i parenti e gli amici che, come vuole la consuetudine locale, accorrono in gruppo a dare il benvenuto ai propri cari? Bisogna arrivare fuori, a cielo […]
L’articolo Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo
Arrivati all’aeroporto di Mohammed VI di Casablanca c’è un silenzio inconsueto. Girano solo gli addetti dello scalo e i passeggeri provenienti da tutto il mondo. Ma dove sono finiti i parenti e gli amici che, come vuole la consuetudine locale, accorrono in gruppo a dare il benvenuto ai propri cari? Bisogna arrivare fuori, a cielo […]
L’articolo Marocco, tra modernizzazione, diritti e lotta al terrorismo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Frank non ce la fa più!
Raccontare il Nord Est d’Italia è come immergersi nel classico goto de bianco, l’ombra veneta per eccellenza.
Richiesta cittadinanza italiana: certificato penale del Paese d’origine
Segnaliamo una circolare dello scorso anno, ma recepita in questi giorni da molte Prefetture che richiede, in caso di domanda di…
Crimini contro l’umanità: il caso di Aleppo
Tra l’indifferenza del mondo la tragedia dei cittadini di Aleppo privati della loro umanità
L’articolo Crimini contro l’umanità: il caso di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.
Festival delle Letterature Migranti – Palermo, dal 12 al 16 ottobre 2016
Scarica il PDF del programma
Effervescenza elettorale in Marocco
Le seconde dalla riforma costituzionale del 2011, le elezioni legislative del 7 ottobre vedono al centro dello scontro gli islamisti del PJD e i liberali del PAM e saranno cruciali per determinare il futuro del paese
L’articolo Effervescenza elettorale in Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Come combattere la violenza di genere nel mondo arabo
La violenza di genere aumenta con i conflitti e l’instabilità, ma il mondo arabo sta cercando il modo di combatterla. L’opinione di Lina Abirafeh, direttrice dell’Institute od Women’s Studies in the Arab World.
L’articolo Come combattere la violenza di genere nel mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
http://ift.tt/2dzgj3K
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati.
Sabir: il Mediterraneo si fa festival
Il Mediterraneo spazio aperto, di dialoghi, incroci, contaminazioni e incontri tra nord e sud, est e ovest. Il Mediterraneo che vorremmo tutti, diventa festival a Messina e Catania per due fine settimana di seguito: è il SABIRFEST. Cultura e cittadinanza mediterraneo, a Messina dal 6 al 9 ottobre e a Catania dal 13 al 16 … Continua a leggere Sabir: il Mediterraneo si fa festival →![]()
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
 |
| Soldi in cambio di uomini? |
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati. E nella capitale si prevede un nuovo scalo solo per loro
Dalla Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, dopo le buone notizie arriva la doccia fredda. E se la borsa è piena per circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020 che consentiranno al malridotto governo di Ashraf Ghani di tirare il fiato, gli aiuti sono stati condizionati all’accettazione di un piano segreto che riguarda i migranti afgani costato sei mesi di trattative. Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato una strategia per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Della cosa però non si era più saputo nulla e, addirittura, si era detto che la questione migranti non sarebbe stata vincolata agli aiuti elargiti dal vertice di Bruxelles. Ma la vicenda invece è saltata fuori proprio a Bruxelles che è stata la cornice dell’accettazione del piano da parte di Kabul: un piano che prevede che chiunque si veda rifiutato il diritto di asilo, una volta verificato che non vi siano altre possibilità di accettazione in un Paese membro, venga rispedito a casa. Lo voglia o no. In altre parole una deportazione concordata. A che ritmo? Per i prossimi sei mesi almeno 50 persone per aereo su voli diretti a Kabul o ad altro aeroporto afgano anche se il numero dei voli non viene quantificato. Si capisce però che non saranno pochi, tanto che le parti si sono accordate per un eventuale nuovo terminal dedicato agli espulsi nell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan che accetta di riceverli e integrarli, ossia farli semplicemente rientrare nel Paese.
 |
| La vignetta spiega bene come la vedono gli afgani: soldi in cambio del tutti a casa |
Sino ad ora solo 5mila migranti afgani hanno fatto ritorno volontario a casa su 178mila che, nel 2015, hanno fatto richiesta d’asilo nella Ue: quattro volte di più che nel 2014 e arrivando a costituire il secondo gruppo di migranti dopo i siriani. Kabul deve fare buon viso a cattivo gioco con oltre un milione di sfollati interni e la minaccia di Islamabad di rimandare a casa entro marzo un milione di afgani, un terzo dei quali è già stato espulso dal Pakistan.
Benché i funzionari di Bruxelles neghino che sia sia utilizzata la leva degli aiuti per far deglutire a Kabul l’amaro calice, è davvero difficile pensare che non sia stato così: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, è stato chiaro quando ha spiegato che la Ue sosterrà Kabul con denaro e programmi per nuovi posti di lavoro in Afghanistan e già da giorni per altro i tedeschi erano stati ancora più chiari: o l’Afghanistan si riprende i migranti o si chiude la borsa.
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
 |
| Soldi in cambio di uomini? |
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati. E nella capitale si prevede un nuovo scalo solo per loro
Dalla Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, dopo le buone notizie arriva la doccia fredda. E se la borsa è piena per circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020 che consentiranno al malridotto governo di Ashraf Ghani di tirare il fiato, gli aiuti sono stati condizionati all’accettazione di un piano segreto che riguarda i migranti afgani costato sei mesi di trattative. Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato una strategia per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Della cosa però non si era più saputo nulla e, addirittura, si era detto che la questione migranti non sarebbe stata vincolata agli aiuti elargiti dal vertice di Bruxelles. Ma la vicenda invece è saltata fuori proprio a Bruxelles che è stata la cornice dell’accettazione del piano da parte di Kabul: un piano che prevede che chiunque si veda rifiutato il diritto di asilo, una volta verificato che non vi siano altre possibilità di accettazione in un Paese membro, venga rispedito a casa. Lo voglia o no. In altre parole una deportazione concordata. A che ritmo? Per i prossimi sei mesi almeno 50 persone per aereo su voli diretti a Kabul o ad altro aeroporto afgano anche se il numero dei voli non viene quantificato. Si capisce però che non saranno pochi, tanto che le parti si sono accordate per un eventuale nuovo terminal dedicato agli espulsi nell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan che accetta di riceverli e integrarli, ossia farli semplicemente rientrare nel Paese.
 |
| La vignetta spiega bene come la vedono gli afgani: soldi in cambio del tutti a casa |
Sino ad ora solo 5mila migranti afgani hanno fatto ritorno volontario a casa su 178mila che, nel 2015, hanno fatto richiesta d’asilo nella Ue: quattro volte di più che nel 2014 e arrivando a costituire il secondo gruppo di migranti dopo i siriani. Kabul deve fare buon viso a cattivo gioco con oltre un milione di sfollati interni e la minaccia di Islamabad di rimandare a casa entro marzo un milione di afgani, un terzo dei quali è già stato espulso dal Pakistan.
Benché i funzionari di Bruxelles neghino che sia sia utilizzata la leva degli aiuti per far deglutire a Kabul l’amaro calice, è davvero difficile pensare che non sia stato così: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, è stato chiaro quando ha spiegato che la Ue sosterrà Kabul con denaro e programmi per nuovi posti di lavoro in Afghanistan e già da giorni per altro i tedeschi erano stati ancora più chiari: o l’Afghanistan si riprende i migranti o si chiude la borsa.
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,applicata dal 90 % dei musulmani nel mondo,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso di loro
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,applicata dal 90 % dei musulmani nel mondo,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso di loro
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,applicata dal 90 % dei musulmani nel mondo,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso di loro
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,che ingloba più del 90% degli adepti del mondo musulmano,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso i carnefici della discendenza del profeta.
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,applicata dal 90 % dei musulmani nel mondo,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso di loro
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,applicata dal 90 % dei musulmani nel mondo,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso i carnefici della discendenza del profeta.
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte di Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,che conta ingloba più del 90% degli adepti del mondo musulmano,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso i carnefici della discendenza del profeta.
Le linee sottili dell’Islam
(Maometto)
Una di queste sottili linee dottrinali sta nel fatto che gli sciiti hanno ereditato il sapere di Maometto e la sua linea interpretativa del corano,composta da pratiche e detti vari (la famosa ” sunna ” la seconda fonte giuridica dopo il Corano) attraverso la sua discendenza ( i famosi dodici imam infallibili ). Seguono un unica scuola giuridica fondata dall’Imam Ja’afar Sadiq, pronipote del profeta e sesto dei dodici imam infallibili.
I dodici imam infallibili sono :
1 ʿ-Alī ibn Abī Ṭālib (m. 661)
3 – al-Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib (m. 680)
Quindi credono che la loro interpretazione dell’Islam e del Corano siano quelli autentici predicati e applicati dal profeta 1400 anni fa,e questo per via della rigida catena di trasmissione del sapere che parte da Maometto,per poi passare da Ali,Fatima ( la figlia ) e i loro figli, Hassan e Hussein,per poi protrarsi attraverso i loro discendenti,che nel corso dei secoli si sono tramandati il sapere da padre a figlio. I musulmani sciiti credono che sia Dio,attraverso il Corano,che il profeta,attraverso i suoi detti,abbiano legittimato Ali Ibn Talib,suo cugino e marito di Fatima ad essere la guida politica e spirituale della comunità islamica dopo la morte d Muhamad (saas).
I sunniti invece credono che chiunque abbia conosciuto il profeta o suoi compagni più fedeli sono degni alla guida politica e spirituale della comunità islamica (la Umma) e alla trasmissione del sapere di Maometto e della sua linea interpretativa del Corano. Ragion per cui la giurisprudenza dell’islam sunnita,che conta più del 90% di adepti nel mondo musulmano,è regolata da ben quattro scuole giuridiche (scuola hanafita – scuola malikita- scuola shafiita – scuola hanbalita) fondate da quattro imam apparsi 150 anni dopo la sua morte e le varie guerre civili scoppiata tra gli stessi compagni del profeta.
Gli imam fondatori delle scuole giuridiche sunnite sono :
L’Imam Abu Hanifa al N’uman ibn Thabit ( nato nel 699 – morto nel 767 DC)
L’imam Malik ibn Anas (nato nel 711 – morto nel 795 DC )
L’imam Shafii ( nato il 767 — morto 820 DC )
L’imam Ahmed Hanbali. ( morto il 855 DC )
Maometto mori’ l’8 giugno 632 dopo Cristo.
I dotti dei due rami principali dell’Islam sono d’accordo sul fatto che uno dei fondatori di delle sopracitate scuole sunnite, L’imam Abu Hanifa (fondatore della scuola hanafita) fu contemporaneo e allievo del fondatore dell’unica scuola giuridica dei musulmani sciiti : L’imam Ja’afar Sadiq,il pronipote di Maometto.E che in seguito tramandò il suo sapere al suo allievo,l’Imam Malik Ibn Anas,che fondò a sua volta un altra scuola giuridica ( la scuola malikita)
Un altra differenza,dettata più dall’ignoranza che da motivi ideologici,è riscontrabile nella posizione verso i nemici e i carnefici della discendenza del profeta,come i califfi Omayadi e Abbassidi,che nel corso dei secoli tentarono di cancellare dalla faccia della terra qualsiasi traccia della discendenza del profeta. Gli sciiti maledicono tali califfi,colpevoli di aver tentato di far scomparire ” l’islam autentico ” per motivi prettamente politici,mentre i sunniti contemporanei invece non hanno assunto alcuna posizione verso i carnefici della discendenza del profeta.
Vite sospese. Relazione fra operatori e richiedenti asilo
Con questa prima pubblicazione apriamo su Melting Pot “Papers”, una rubrica che ospiterà tesi di laurea, ricerche e studi, convinti che la…
Bruxelles vs Kabul: doccia fredda sui migranti afgani
Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato un piano per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Ma adesso il memo – nella cornic della Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan – è un accordo che consente di espellere i richiedenti asilo dall’Unione e che Kabul ha dovuto accettare assieme alle elargizioni di aiuti…
continua domani su Great Game
Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no.
Negli ultimi decenni, con le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che il Marocco ha vissuto, il dibattito sulla laicità è cresciuto in quantità e qualità, perché quello che era un discorso elitario ed esclusivo di qualche intellettuale è diventato un argomento di dibattito pubblico che coinvolge politici, artisti, scrittori e molti strati della società […]
L’articolo Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no. sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no.
Negli ultimi decenni, con le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che il Marocco ha vissuto, il dibattito sulla laicità è cresciuto in quantità e qualità, perché quello che era un discorso elitario ed esclusivo di qualche intellettuale è diventato un argomento di dibattito pubblico che coinvolge politici, artisti, scrittori e molti strati della società […]
L’articolo Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no. sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no.
Negli ultimi decenni, con le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che il Marocco ha vissuto, il dibattito sulla laicità è cresciuto in quantità e qualità, perché quello che era un discorso elitario ed esclusivo di qualche intellettuale è diventato un argomento di dibattito pubblico che coinvolge politici, artisti, scrittori e molti strati della società […]
L’articolo Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no. sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no.
Negli ultimi decenni, con le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che il Marocco ha vissuto, il dibattito sulla laicità è cresciuto in quantità e qualità, perché quello che era un discorso elitario ed esclusivo di qualche intellettuale è diventato un argomento di dibattito pubblico che coinvolge politici, artisti, scrittori e molti strati della società […]
L’articolo Il ruolo dell’Islam nella gestione del potere in Marocco. Laicità si, laicità no. sembra essere il primo su MaroccOggi.
Giordania: bavaglio sui media imposto dal governo dopo l’assassinio di uno scrittore
Le autorità giordane hanno censurato tutte le notizia sull’assassinio di Nahed Hattar, scrittore e voce critica verso l’ISIS, ucciso il 25 settembre nella capitale Amman.
Giordania: bavaglio sui media imposto dal governo dopo l’assassinio di uno scrittore
Le autorità giordane hanno censurato tutte le notizia sull’assassinio di Nahed Hattar, scrittore e voce critica verso l’ISIS, ucciso il 25 settembre nella capitale Amman.
Giordania: bavaglio sui media imposto dal governo dopo l’assassinio di uno scrittore
Le autorità giordane hanno censurato tutte le notizia sull’assassinio di Nahed Hattar, scrittore e voce critica verso l’ISIS, ucciso il 25 settembre nella capitale Amman.
Tre paesi in cui l’UE dovrebbe investire per frenare il caos regionale
Dal blog Europa e mondo arabo di Roberta Papaleo
L’articolo Tre paesi in cui l’UE dovrebbe investire per frenare il caos regionale sembra essere il primo su Arabpress.
Il massacro di Aleppo e il circo di Beirut
“Aleppo muore mentre i signori del mondo arabo eseguono le loro acrobazie in un circo che si affaccia sull’assurdo”
L’articolo Il massacro di Aleppo e il circo di Beirut sembra essere il primo su Arabpress.
Un po’ meno poveri ma sempre in guerra
 La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
Mentre i talebani hanno lanciato una nuova massiccia offensiva proprio alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta ieri a Bruxelles, nella capitale belga arriva il momento delle promesse per un Paese dove – sono dati Ue – il 40% della popolazione vive sotto la linea di povertà e un terzo degli afgani ancora non sa leggere né scrivere. Mentre scriviamo si combatte a Kunduz, nell’Helmand e in altre aree a Nord e a Sud. E si litiga: in parlamento e nel governo, scaricandosi le responsabilità per l’ennesima battaglia in una città – Kunduz – tenuta un anno fa dalla guerriglia per quasi una settimana. C’è chi dice che l’offensiva finirà per favorire l’apertura della borsa dei Paesi amici. E c’è chi invece pensa che sia l’ennesimo colpo basso a un governo in perenne crisi e a una presenza della Nato che, pur ridotta nel numero dei soldati, è rimasta nel Paese a presidiare soltanto le caserme che proteggono i suoi militari.
 |
| Sempre in guerra: combattenti anti inglesi in una stampa del 1800. Sotto la bandiera Nato |
Ieri l’Unione Europea ha promesso, in aggiunta al suo programma 2014-2020 (circa 1,4 miliardi di euro) oltre 200 milioni annui per due anni dal 2017 per sostenere l’agenda del governo di Ashraf Ghani, il presidente “dimezzato” insediato due anni fa dopo faticose elezioni presidenziali (ora dovremmo essere alla viglia di una nuova corsa elettorale per il parlamento) che alla fine hanno sancito un governo a due teste: quella di Ghani e quella di Abdullah Abdullah, ex mujaheddin cui, in barba alla Costituzione, gli americani, veri artefici della nascita del nuovo governo, hanno ritagliato – per raffreddare le sue accuse di brogli – un ruolo di primo piano che lo apparenta al presidente. Col risultato che il governo a due teste – si sa ma non si dice – non funziona. Oggi, se tutto va secondo i piani, gli americani dovrebbero annunciare altri 3 miliardi di dollari l’anno cui dovrebbero aggiungersi – oltre ai 200 milioni figli dell’accordo Ue per favorire lo “State building” – il miliardo che l’insieme dei Paesi membri* verserà annualmente a Kabul almeno sino al 2020. Poi ci sono altri attori (a Bruxelles siedono settanta Paesi e venti tra organizzazioni e agenzie internazionali) e quindi il piatto si arricchirà. Ma con molti però e legando l’aiuto futuro a quanto gli afgani sapranno e soprattutto vorranno fare. Non è un assegno in bianco né per gli europei né per gli americani.
 Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Ma se Ghani tornerà a casa soddisfatto (un altro accordo prevede che l’aiuto militare continuerà ancora per anni e che il governo avrà i fondi per pagare gli stipendi ai soldati afgani) sul piano della pace, al di là di una retorica che ormai non viene neppure più utilizzata, passi avanti non se ne vedono come ben dimostra un Paese dove aumentano le vittime civili e dove la guerriglia – che si era sempre limitata ad attentati e a qualche azione eclatante – sembra aver cambiato strategia, puntando al cuore delle città. A Bruxelles nessuno si chiederà se abbia senso mantenere ancora una presenza militare dai costi enormi e che per un eventuale negoziato è l’ostacolo maggiore visto che per i talebani l’uscita degli stranieri dal Paese è il primo paletto per sedersi al tavolo della trattativa. Né gli alleati chiederanno conto agli Stati Uniti dell’accordo con Kabul che consente a Washington il controllo di dieci basi militari, ipoteca che ha fatto restare nel Paese 10mila soldati Usa, fermare il piano graduale di ritiro promesso da Obama e obbligare la Nato a rimanere. Un quadro dove, accanto alle nostre responsabilità, si sommano i disegni dei Paesi vicini: il Pakistan naturalmente, ma anche l’India, sempre più muscolare nel suo piano di avvicinamento a Kabul, o la Cina che, silenziosamente e “armoniosamente”, si sta accaparrando gran parte del tesoro minerario nazionale. Ci di dovrà accontentare dei quattrini.
* Ieri è stato approvato dall’Italia il Programma per la riduzione della mortalità infantile nelle province di Kabul e Herat, in Afghanistan, per 4 milioni di euro
Un po’ meno poveri ma sempre in guerra
 La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
Mentre i talebani hanno lanciato una nuova massiccia offensiva proprio alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta ieri a Bruxelles, nella capitale belga arriva il momento delle promesse per un Paese dove – sono dati Ue – il 40% della popolazione vive sotto la linea di povertà e un terzo degli afgani ancora non sa leggere né scrivere. Mentre scriviamo si combatte a Kunduz, nell’Helmand e in altre aree a Nord e a Sud. E si litiga: in parlamento e nel governo, scaricandosi le responsabilità per l’ennesima battaglia in una città – Kunduz – tenuta un anno fa dalla guerriglia per quasi una settimana. C’è chi dice che l’offensiva finirà per favorire l’apertura della borsa dei Paesi amici. E c’è chi invece pensa che sia l’ennesimo colpo basso a un governo in perenne crisi e a una presenza della Nato che, pur ridotta nel numero dei soldati, è rimasta nel Paese a presidiare soltanto le caserme che proteggono i suoi militari.
 |
| Sempre in guerra: combattenti anti inglesi in una stampa del 1800. Sotto la bandiera Nato |
Ieri l’Unione Europea ha promesso, in aggiunta al suo programma 2014-2020 (circa 1,4 miliardi di euro) oltre 200 milioni annui per due anni dal 2017 per sostenere l’agenda del governo di Ashraf Ghani, il presidente “dimezzato” insediato due anni fa dopo faticose elezioni presidenziali (ora dovremmo essere alla viglia di una nuova corsa elettorale per il parlamento) che alla fine hanno sancito un governo a due teste: quella di Ghani e quella di Abdullah Abdullah, ex mujaheddin cui, in barba alla Costituzione, gli americani, veri artefici della nascita del nuovo governo, hanno ritagliato – per raffreddare le sue accuse di brogli – un ruolo di primo piano che lo apparenta al presidente. Col risultato che il governo a due teste – si sa ma non si dice – non funziona. Oggi, se tutto va secondo i piani, gli americani dovrebbero annunciare altri 3 miliardi di dollari l’anno cui dovrebbero aggiungersi – oltre ai 200 milioni figli dell’accordo Ue per favorire lo “State building” – il miliardo che l’insieme dei Paesi membri* verserà annualmente a Kabul almeno sino al 2020. Poi ci sono altri attori (a Bruxelles siedono settanta Paesi e venti tra organizzazioni e agenzie internazionali) e quindi il piatto si arricchirà. Ma con molti però e legando l’aiuto futuro a quanto gli afgani sapranno e soprattutto vorranno fare. Non è un assegno in bianco né per gli europei né per gli americani.
 Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Ma se Ghani tornerà a casa soddisfatto (un altro accordo prevede che l’aiuto militare continuerà ancora per anni e che il governo avrà i fondi per pagare gli stipendi ai soldati afgani) sul piano della pace, al di là di una retorica che ormai non viene neppure più utilizzata, passi avanti non se ne vedono come ben dimostra un Paese dove aumentano le vittime civili e dove la guerriglia – che si era sempre limitata ad attentati e a qualche azione eclatante – sembra aver cambiato strategia, puntando al cuore delle città. A Bruxelles nessuno si chiederà se abbia senso mantenere ancora una presenza militare dai costi enormi e che per un eventuale negoziato è l’ostacolo maggiore visto che per i talebani l’uscita degli stranieri dal Paese è il primo paletto per sedersi al tavolo della trattativa. Né gli alleati chiederanno conto agli Stati Uniti dell’accordo con Kabul che consente a Washington il controllo di dieci basi militari, ipoteca che ha fatto restare nel Paese 10mila soldati Usa, fermare il piano graduale di ritiro promesso da Obama e obbligare la Nato a rimanere. Un quadro dove, accanto alle nostre responsabilità, si sommano i disegni dei Paesi vicini: il Pakistan naturalmente, ma anche l’India, sempre più muscolare nel suo piano di avvicinamento a Kabul, o la Cina che, silenziosamente e “armoniosamente”, si sta accaparrando gran parte del tesoro minerario nazionale. Ci di dovrà accontentare dei quattrini.
* Ieri è stato approvato dall’Italia il Programma per la riduzione della mortalità infantile nelle province di Kabul e Herat, in Afghanistan, per 4 milioni di euro
La Siria che scrive: Nihad Sirees e il “tumulto” del regime siriano
Nihad Sirees è nato ad Aleppo nel 1950 ed è autore di sette romanzi e di numerose sceneggiature, una delle quali, nel 1998, gli “guadagnò” il diritto ad essere censurato. Intellettuale di spicco, fortemente critico verso il regime di Bashar al-Assad, nel gennaio del 2012 ha preferito lasciare Aleppo, in un esilio auto-imposto per timore … Continua a leggere La Siria che scrive: Nihad Sirees e il “tumulto” del regime siriano →![]()
Lo strano caso dell’arabo contemporaneo …
Citate ” Yawm el Quds ” ( la Giornata di Gerusalemme ) evento in cui tutte le masse musulmane concentrate nel triangolo controllato dall”’Asse del male ” denunciano con forza i crimini del sionismo nel mondo e rivendicano la liberazione della Moschea di Gerusalemme ( Al Quds). Tenete bene in mente che la radice di questa loro bizzarra reazione è la paura verso un immaginaria ” persianizzazione ” delle loro società ( non lo dico io,ma un recente sondaggio di Al Jazeera dove gli arabi hanno accusato la repubblica islamica dell’Iran di essere all’origine di tutte le instabilità politiche e sociali del Medioriente)
Lo strano caso dell’arabo contemporaneo …
Citate ” Yawm el Quds ” ( la Giornata di Gerusalemme ) evento in cui tutte le masse musulmane concentrate nel triangolo controllato dall”’Asse del male ” denunciano con forza i crimini del sionismo nel mondo e rivendicano la liberazione della Moschea di Gerusalemme ( Al Quds). Tenete bene in mente che la radice di questa loro bizzarra reazione è la paura verso un immaginaria ” persianizzazione ” delle loro società ( non lo dico io,ma un recente sondaggio di Al Jazeera dove gli arabi hanno accusato la repubblica islamica dell’Iran di essere all’origine di tutte le instabilità politiche e sociali del Medioriente)
Lo strano caso dell’arabo contemporaneo …
Citate ” Yawm el Quds ” ( la Giornata di Gerusalemme ) evento in cui tutte le masse musulmane concentrate nel triangolo controllato dall”’Asse del male ” denunciano con forza i crimini del sionismo nel mondo e rivendicano la liberazione della Moschea di Gerusalemme ( Al Quds). Tenete bene in mente che la radice di questa loro bizzarra reazione è la paura verso un immaginaria ” persianizzazione ” delle loro società ( non lo dico io,ma un recente sondaggio di Al Jazeera dove gli arabi hanno accusato la repubblica islamica dell’Iran di essere all’origine di tutte le instabilità politiche e sociali del Medioriente)
Lo strano caso dell’arabo contemporaneo …
Citate ” Yawm el Quds ” ( la Giornata di Gerusalemme ) evento in cui tutte le masse musulmane concentrate nel triangolo controllato dall”’Asse del male ” denunciano con forza i crimini del sionismo nel mondo e rivendicano la liberazione della Moschea di Gerusalemme ( Al Quds). Tenete bene in mente che la radice di questa loro bizzarra reazione è la paura verso un immaginaria ” persianizzazione ” delle loro società ( non lo dico io,ma un recente sondaggio di Al Jazeera dove gli arabi hanno accusato la repubblica islamica dell’Iran di essere all’origine di tutte le instabilità politiche e sociali del Medioriente)
Décryptage/Pertinenza dell’uso del termine «illegale» in ambito migratorio
Tutte le settimane, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) comunica alla stampa la sua attività settimanale.
Muore ancora una volta la questione palestinese…..
Oggi, da giovane arabo e musulmano ,mi sento ancora più impotente al cospetto del movimento sionista,che m’impedisce di mettere piede nella Moschea di Gerusalemme.
Memorandum Italia — Sudan: il testo e il commento dell’ASGI
“Uno strumento di natura politica illegittimo sia perché adottato al di fuori del controllo parlamentare sia perché sottratto alle…
Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti
Scheda tecnica del sistema elettorale e dei partiti Sono 29 i partiti politici che concorrono per le prossime elezioni legislative in Marocco. Una moltitudine che ben rappresenta il dinamismo politico nel Paese e la diversità del suo panorama ideologico. Partiti islamisti moderati, partiti vicini alla sinistra radicale, partiti di centrosinistra e di centrodestra, nazionalisti, populisti, liberisti, socialisti, verdi. […]
L’articolo Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti sembra essere il primo su MaroccOggi.
Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti
Scheda tecnica del sistema elettorale e dei partiti Sono 29 i partiti politici che concorrono per le prossime elezioni legislative in Marocco. Una moltitudine che ben rappresenta il dinamismo politico nel Paese e la diversità del suo panorama ideologico. Partiti islamisti moderati, partiti vicini alla sinistra radicale, partiti di centrosinistra e di centrodestra, nazionalisti, populisti, liberisti, socialisti, verdi. […]
L’articolo Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti sembra essere il primo su MaroccOggi.
Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti
Scheda tecnica del sistema elettorale e dei partiti Sono 29 i partiti politici che concorrono per le prossime elezioni legislative in Marocco. Una moltitudine che ben rappresenta il dinamismo politico nel Paese e la diversità del suo panorama ideologico. Partiti islamisti moderati, partiti vicini alla sinistra radicale, partiti di centrosinistra e di centrodestra, nazionalisti, populisti, liberisti, socialisti, verdi. […]
L’articolo Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti sembra essere il primo su MaroccOggi.
Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti
Scheda tecnica del sistema elettorale e dei partiti Sono 29 i partiti politici che concorrono per le prossime elezioni legislative in Marocco. Una moltitudine che ben rappresenta il dinamismo politico nel Paese e la diversità del suo panorama ideologico. Partiti islamisti moderati, partiti vicini alla sinistra radicale, partiti di centrosinistra e di centrodestra, nazionalisti, populisti, liberisti, socialisti, verdi. […]
L’articolo Scheda elezioni: sistema elettorale e partiti sembra essere il primo su MaroccOggi.
“Clash”: uno strano film adatto a una strana situazione
Il film del regista egiziano Mohamed Diab concorrerà al BFI London Film Festival: la recensione che ne ha fatto Andeel per Mada Masr
L’articolo “Clash”: uno strano film adatto a una strana situazione sembra essere il primo su Arabpress.
Congiura di palazzo: esordio letterario con vendetta
“Orgogliosi di supportare il turismo verso l’Italia”, dice questo manifesto di Ryanair appeso alloscalo romano di Fiumicino. Come, scusi? Supportare? Cosa potrebbe fare al grafico pubblicitario e al responsabile delle campagne di Ryanair Claudia Palazzo, una giovane e brillante scrittrice alla sua prima opera letteraria da qualche mese in libreria? L’autrice di “Morte del piccolo principe e altre vendette” ha infatti una sacrosanta ossessione: l’italiano. E quei maledetti inglesismi di cui è piena la lingua scritta persino più di quella parlata (supportare, implementare o il terribile “di sempre” che ora impazza), Ma non solo; anche quel non meno terribile “piuttosto che” divenuto ormai una delle tante inesplicabili aberrazioni dell’italiano (c’è un’indagine in proposito della Crusca sulla sua origine, pare toscana). Il problema è che Claudia Palazzo non perdona. Non perdona non soltanto il cattivo uso dell’italiano, e dunque l’ignoranza, ma nemmen la supponenza, il potere mal esercitato, la spocchia. le ingiustizie. E, in ogni racconto della sua breve raccolta, punisce. Ferisce mortalmente e nella maniera più feroce. Dissacrando.
 Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Claudia Palazzo
Morte del piccolo principe e altre vendette
Il Palindromo 2016
pp 109
euro 10
Congiura di palazzo: esordio letterario con vendetta
“Orgogliosi di supportare il turismo verso l’Italia”, dice questo manifesto di Ryanair appeso alloscalo romano di Fiumicino. Come, scusi? Supportare? Cosa potrebbe fare al grafico pubblicitario e al responsabile delle campagne di Ryanair Claudia Palazzo, una giovane e brillante scrittrice alla sua prima opera letteraria da qualche mese in libreria? L’autrice di “Morte del piccolo principe e altre vendette” ha infatti una sacrosanta ossessione: l’italiano. E quei maledetti inglesismi di cui è piena la lingua scritta persino più di quella parlata (supportare, implementare o il terribile “di sempre” che ora impazza), Ma non solo; anche quel non meno terribile “piuttosto che” divenuto ormai una delle tante inesplicabili aberrazioni dell’italiano (c’è un’indagine in proposito della Crusca sulla sua origine, pare toscana). Il problema è che Claudia Palazzo non perdona. Non perdona non soltanto il cattivo uso dell’italiano, e dunque l’ignoranza, ma nemmen la supponenza, il potere mal esercitato, la spocchia. le ingiustizie. E, in ogni racconto della sua breve raccolta, punisce. Ferisce mortalmente e nella maniera più feroce. Dissacrando.
 Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Claudia Palazzo
Morte del piccolo principe e altre vendette
Il Palindromo 2016
pp 109
euro 10
Il referendum relativo al piano UE di reinsediamento dei migranti si è tenuto domenica 2 ottobre in…
«Il referendum del 2 ottobre non è sull’appartenenza all’Ue — si legge sul sito del Governo di Budapest — Quello lo abbiamo già tenuto nel…
La settimana di Arabpress in Podcast
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti
L’articolo La settimana di Arabpress in Podcast sembra essere il primo su Arabpress.
Immigrazione: questi 10 paesi accolgono metà dei rifugiati del mondo
(Agenzie). Sono solo dieci paesi, che insieme costituiscono il 2,5% del PIL mondiale, a ospitare più della metà dei rifugiati del mondo, secondo quanto riferito da Amnesty International, che ha puntato il dito contro l’egoismo delle nazioni più ricche. L’organizzazione ha infatti lamentato il fatto che il peso dei rifugiati mondiali (21 milioni) ricada soprattutto […]
L’articolo Immigrazione: questi 10 paesi accolgono metà dei rifugiati del mondo sembra essere il primo su Arabpress.
Ungheria la sconfitta di Orbàn
Ma resta saldamente al comando, nonostante il referendum sulle quote rifugiati e le polemiche
via Migrano http://ift.tt/2drikz5
Baobab: il transito dei migranti e la negata accoglienza
La rete di supporto legale realizzata da A Buon Diritto, Action Diritti in Movimento, Baobab Experience, Consiglio Italiano per i Rifugiati…
Roma — Via Cupa Alle 8:30 della mattina di venerdì 30 settembre i blindati della polizia sono…
“Pensavamo fosse la solita identificazione [dei migranti] come avviene ormai, con cadenza periodica, da questa primavera. Questo tipo di…
Bolzano una circolare della Provincia butta in strada i richiedenti asilo anche vulnerabili
Oggi in Trentino Alto Adige si celebra la prima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e comincia ufficialmente la settimana dell…
Quando il Mediterraneo era il centro
Un mare di isole, il Mar Mediterraneo. Un mare di cerchi, e due rettangoli. Quello più in alto, nella parte destra della mappa del Book of Curiosities, è la Sicilia. Stay tuned. Manca pochissimo.
Quando il Mediterraneo era il centro
Un mare di isole, il Mar Mediterraneo. Un mare di cerchi, e due rettangoli. Quello più in alto, nella parte destra della mappa del Book of Curiosities, è la Sicilia. Stay tuned. Manca pochissimo.
L’importanza dell’informazione indipendente in Egitto: intervista a Lina Attalah
In occasione del Festival di Internazionale a Ferrara, abbiamo incontrato Lina Attalah, co-fondatrice e direttrice del sito egiziano Mada Masr.
L’articolo L’importanza dell’informazione indipendente in Egitto: intervista a Lina Attalah sembra essere il primo su Arabpress.
Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo
Per raccontare e analizzare la politica dall’interno è importante averla un po’ vissuta. E quella marocchina non mi ha solo sfiorato. Ho accompagnato la parabola del PJD (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) per lunghe fasi, trovandomi per mia volontà o per caso a contatto con quel gruppuscolo politico e religioso che, nel 1975, […]
L’articolo Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo
Per raccontare e analizzare la politica dall’interno è importante averla un po’ vissuta. E quella marocchina non mi ha solo sfiorato. Ho accompagnato la parabola del PJD (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) per lunghe fasi, trovandomi per mia volontà o per caso a contatto con quel gruppuscolo politico e religioso che, nel 1975, […]
L’articolo Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo
Per raccontare e analizzare la politica dall’interno è importante averla un po’ vissuta. E quella marocchina non mi ha solo sfiorato. Ho accompagnato la parabola del PJD (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) per lunghe fasi, trovandomi per mia volontà o per caso a contatto con quel gruppuscolo politico e religioso che, nel 1975, […]
L’articolo Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo
Per raccontare e analizzare la politica dall’interno è importante averla un po’ vissuta. E quella marocchina non mi ha solo sfiorato. Ho accompagnato la parabola del PJD (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) per lunghe fasi, trovandomi per mia volontà o per caso a contatto con quel gruppuscolo politico e religioso che, nel 1975, […]
L’articolo Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Vi racconto la parabola del PJD, dalle prigioni segrete allo scrigno del governo
Per raccontare e analizzare la politica dall’interno è importante averla un po’ vissuta. E quella marocchina non mi ha solo sfiorato. Ho accompagnato la parabola del PJD (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) per lunghe fasi, trovandomi per mia volontà o per caso a contatto con quel gruppuscolo politico e religioso che, nel 1975, […]
3 ottobre: il ricordo non basta!
In questo 3 ottobre, ricordiamo le tante, le troppe, vite ingoiate dal Mar Mediterraneo.
Prima del 7 ottobre. L’esperienza democratica in Marocco, contesto e specificità di un’alternanza tutta marocchina.
Per addentrarsi e approfondire quello che avverrà con le elezioni parlamentari del 7 ottobre in Marocco, bisogna dotarsi di una nuova chiave di lettura che contestualizzi meglio l’evento. Intanto, si può asserire – senza ombra di dubbio – che l’esperienza democratica in Marocco ha una sua singolarità che la rende, di fatto, unica nel panorama […]
L’articolo Prima del 7 ottobre. L’esperienza democratica in Marocco, contesto e specificità di un’alternanza tutta marocchina. sembra essere il primo su MaroccOggi.
Prima del 7 ottobre. L’esperienza democratica in Marocco, contesto e specificità di un’alternanza tutta marocchina.
Per addentrarsi e approfondire quello che avverrà con le elezioni parlamentari del 7 ottobre in Marocco, bisogna dotarsi di una nuova chiave di lettura che contestualizzi meglio l’evento. Intanto, si può asserire – senza ombra di dubbio – che l’esperienza democratica in Marocco ha una sua singolarità che la rende, di fatto, unica nel panorama […]
L’articolo Prima del 7 ottobre. L’esperienza democratica in Marocco, contesto e specificità di un’alternanza tutta marocchina. sembra essere il primo su MaroccOggi.