Documento adottato da Amnesty International in vista del Consiglio Europeo di giugno
EU risks fuelling horrific abuse of refugees and…
Documento adottato da Amnesty International in vista del Consiglio Europeo di giugno
EU risks fuelling horrific abuse of refugees and…
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
La morte di Giulio Regeni non è un caso isolato ma fa parte della “banalità del male” insita nel regime del presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. E’ questo il filone su cui si sviluppa il libro “Giulio Regeni. Le verità ignorate”. L’instant book, scritto dall’esperto di Islàm Lorenzo Declich – e pubblicato da Alegre […]
L’articolo Giulio Regeni, “le verità ignorate” sull’omicidio del ricercatore italiano proviene da Il Fatto Quotidiano.
Di Soumaya Ghannouchi. Middle East Eye (28/06/2016). Traduzione e sintesi di Chiara Cartia. L’Islam durante la sua storia è stato oggetto di molteplici interpretazioni: religione chiusa o aperta, letterale o razionale, spirituale/ascetica o militante/politicizzata, per citarne alcune. Il carattere esplosivo e violento di numerose espressioni contemporanee dell’Islam non potrebbe essere più in contrasto con il lungo […]
L’articolo L’Islam deve giocare un ruolo in politica? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Mohammed ‘Aish. Al-Quds al-Arabi (28/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Formigari. Molti arabi e musulmani non comprendono che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (la cosiddetta Brexit) sarà per loro un duro colpo sul piano politico e economico, e questo vale sia per i paesi arabi, sia per gli arabi-britannici che rappresentano un bacino elettorale […]
L’articolo Cosa perde il mondo arabo con Brexit? sembra essere il primo su Arabpress.
Intervista con Giovanni Lepri, Vice Direttore per le operazioni dell’UNHCR in Grecia
via Migrano http://ift.tt/29clZ3r
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser, nel 50esimo anniversario della Rivoluzione dei Giovani Ufficiali. Ora, anno domini 2016, è Al Atlal (Le Rovine), uno deiRead more
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser, nel 50esimo anniversario della Rivoluzione dei Giovani Ufficiali. Ora, anno domini 2016, è Al Atlal (Le Rovine), uno deiRead more
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser, nel 50esimo anniversario della Rivoluzione dei Giovani Ufficiali. Ora, anno domini 2016, è Al Atlal (Le Rovine), uno deiRead more
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser, nel 50esimo anniversario della Rivoluzione dei Giovani Ufficiali. Ora, anno domini 2016, è Al Atlal (Le Rovine), uno deiRead more
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser, nel 50esimo anniversario della Rivoluzione dei Giovani Ufficiali. Ora, anno domini 2016, è Al Atlal (Le Rovine), uno deiRead more
Ho ritrovato negli archivi un articolo che avevo pubblicato su “Diario della Settimana” 14 anni fa. Era il 2002, e vivevo in Egitto. L’articolo era dedicato ai due miti egiziani, Umm Kulthoum e Gamal Abdel Nasser. Al Atlal (Le Rovine), uno dei brani più famosi di Umm Kulthoum, compie proprio in questo giugno difficile cinquant’anni.Read more
Campagna LasciateCIEntrare, delegazione costituita da Tania Poguisch, Elio Tozzi, Fulvio Vassallo, Yasmine Accardo, Agata Ronsivalle.
Campagna LasciateCIEntrare, delegazione costituita da Tania Poguisch, Elio Tozzi, Fulvio Vassallo, Yasmine Accardo, Agata Ronsivalle.
Ordinanza del Tribunale di Genova in cui viene riconosciuta la protezione umanitaria per un cittadino del Mali.
Il Giudice ha ritenuto il…
Ordinanza del Tribunale di Genova in cui viene riconosciuta la protezione umanitaria per un cittadino del Mali.
Il Giudice ha ritenuto il…
Di Eyad al-Dulaimi. Al-Araby Al-Jadeed (28-06-2016). Traduzione e sintesi di Mariacarmela Minniti. I politici arabi sunniti avevano annunciato che nella battaglia per la liberazione di Fallujah le unità di mobilitazione popolare non avrebbero trovato posto perché l’America e la coalizione internazionale avrebbe bombardato qualsiasi movimento di queste milizie in prossimità della città. Cercavano di vendere […]
L’articolo Iraq: la “finta” liberazione di Fallujah sembra essere il primo su Arabpress.
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Brindisi, 27 giugno 2016 — Dopo essere venuta a conoscenza che molti minori stranieri non accompagnati, giunti nel porto Brindisi a seguito…
Brindisi, 27 giugno 2016 — Dopo essere venuta a conoscenza che molti minori stranieri non accompagnati, giunti nel porto Brindisi a seguito…
L’accordo tra UE e Turchia viola il diritto internazionale, come dimostrano le sempre più corpose evidenze raccolte sul campo. Questo l…
L’accordo tra UE e Turchia viola il diritto internazionale, come dimostrano le sempre più corpose evidenze raccolte sul campo. Questo l…
Pubblichiamo una bella pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bari che attiene a due genitori georgiani che hanno ricevuto l…
Pubblichiamo una bella pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bari che attiene a due genitori georgiani che hanno ricevuto l…
mcc43 Solamente un anno fa, i Greci chiamati a un referendum che riguardava la UE votarono NO. Reazioni “la domanda che ci si pone tutti è la seguente: quali scenari si apriranno adesso? Il sistema europeo collasserà o semplicemente sarà costretto a cambiare?” Sul medesimo tono, logicamente più catastrofiste e squalificanti la votazione, quelle che […]![]()
mcc43 Solamente un anno fa, i Greci chiamati a un referendum che riguardava la UE votarono NO. Reazioni “la domanda che ci si pone tutti è la seguente: quali scenari si apriranno adesso? Il sistema europeo collasserà o semplicemente sarà costretto a cambiare?” Sul medesimo tono, logicamente più catastrofiste e squalificanti la votazione, quelle che […]![]()
Photo by Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images Di Krithika Varagur. Huffington Post Religion (21/06/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina Come ci si sente ad essere stato denunciato dallo Stato Islamico? “Sinceramente, è un onore”, ha detto l’imam americano Suhaib Webb, accusato di essere un murtadd – apostata – nell’ultimo numero di Dabiq, la rivista propagandistica di […]
L’articolo L’imam americano che combatte il radicalismo con Snapchat sembra essere il primo su Arabpress.
Dieci anni dalla prima operazione militare israeliana dopo il disimpegno dalla Striscia di Gaza: una raccolta di articoli per non dimenticare
a cura di Cecilia Dalla Negra e Christian Elia
Dieci anni dalla prima operazione militare israeliana dopo il disimpegno dalla Striscia di Gaza: una raccolta di articoli per non dimenticare
a cura di Cecilia Dalla Negra e Christian Elia
Dieci anni dalla prima operazione militare israeliana dopo il disimpegno dalla Striscia di Gaza: una raccolta di articoli per non dimenticare
a cura di Cecilia Dalla Negra e Christian Elia
Dieci anni dalla prima operazione militare israeliana dopo il disimpegno dalla Striscia di Gaza: una raccolta di articoli per non dimenticare
a cura di Cecilia Dalla Negra e Christian Elia
Il 28 giugno 2006 iniziava la prima offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza. Un dossier di OssIraq e Q Code Mag ripercorre la storia di questi 10 anni.
Il 28 giugno 2006 iniziava la prima offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza. Un dossier di OssIraq e Q Code Mag ripercorre la storia di questi 10 anni.
Il 28 giugno 2006 iniziava la prima offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza. Un dossier di OssIraq e Q Code Mag ripercorre la storia di questi 10 anni.
Il 28 giugno 2006 iniziava la prima offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza. Un dossier di OssIraq e Q Code Mag ripercorre la storia di questi 10 anni.
Migranti:Europol,trafficanti triplicano tariffe viaggi in Ue
http://ift.tt/28Yp8Sp
Migranti:Europol,trafficanti triplicano tariffe viaggi in Ue
http://ift.tt/28Yp8Sp
Migranti: Europol, 7mila nuovi trafficanti in sei mesi
http://ift.tt/28Y95qC
Migranti: Europol, 7mila nuovi trafficanti in sei mesi
http://ift.tt/28Y95qC
Di Nasri Sayegh. As-Safir (27/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. Il Libano chiede di esistere. Nonostante i suoi confini geografici e la sua costituzione siano noti a livello internazionale, il Paese sembra essere scomparso. Infatti, non riusciamo più a vederlo. È noto che il riconoscimento di uno Stato in quanto tale avviene mediante le […]
L’articolo Alla ricerca di un Libano che non c’è sembra essere il primo su Arabpress.
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
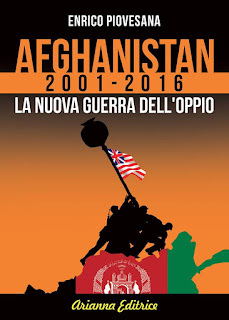 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
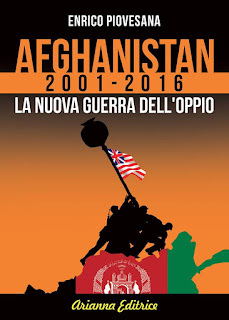 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
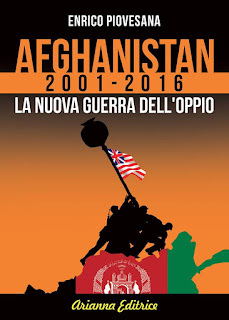 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
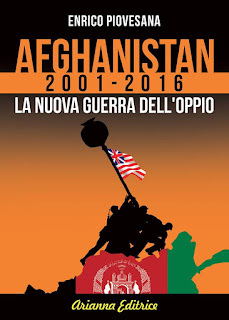 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
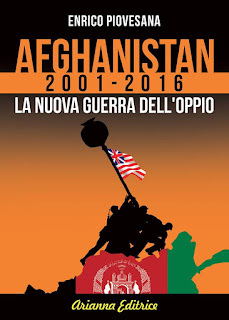 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Il Giudice del Tribunale di Genova, con questa ordinanza, riconosce “che le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Territoriale sono il…
Il Giudice del Tribunale di Genova, con questa ordinanza, riconosce “che le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Territoriale sono il…
Le immagini trasmesse dai TG nazionali, fissate dagli stessi occhi increduli che ad ogni strage, davanti ad ogni Alyan, si chiedevano come…
Le immagini trasmesse dai TG nazionali, fissate dagli stessi occhi increduli che ad ogni strage, davanti ad ogni Alyan, si chiedevano come…
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Tre bambini, quattro donne e un uomo sono stati uccisi mentre tentavano di fuggire dalla Siria settentrionale, secondo quanto riportato…
Tra Chio (Grecia) e Cesme (Turchia) un barcone con bambini e adulti in fuga dalla guerra e dai conflitti in Siria, Iraq e Eritrea, e…
Può un semplice mazzo di fiori aiutare i rifugiati in Brasile e in Grecia?
Di Mehdi Mabrouk. Al-Arabiy al-Jadeed (26/06/2016). Traduzione e sintesi di Sebastiano Garofalo. Stranamente le attuali elezioni tunisine non stanno provocando i tumulti e le tensioni che ci si aspettava, malgrado il probabile rimpasto di governo e il contesto politico ed economico catastrofico. Nemmeno la forte spinta al cambiamento, esplosa con la rivoluzione, ha distolto l’attenzione degli […]
L’articolo Tunisia: l’umiliazione della politica e dei politici sembra essere il primo su Arabpress.
Qualche giorno fa in Slovenia si è tenuta la prima conferenza euro-mediterranea sulla traduzione, organizzata da Anna Lindh Foundation, Università Euro-Mediterranea (EMUNI) e il Ministero degli Esteri sloveno. Translation 4 Dialogue, questo il titolo della conferenza, è la “prima conferenza di alto livello di questo tipo organizzata nella regione Euro-Med. Vi parteciperanno circa 100 esperti … Continua a leggere Manifesto per la traduzione euromediterranea →![]()
Qualche giorno fa in Slovenia si è tenuta la prima conferenza euro-mediterranea sulla traduzione, organizzata da Anna Lindh Foundation, Università Euro-Mediterranea (EMUNI) e il Ministero degli Esteri sloveno. Translation 4 Dialogue, questo il titolo della conferenza, è la “prima conferenza di alto livello di questo tipo organizzata nella regione Euro-Med. Vi parteciperanno circa 100 esperti … Continua a leggere Manifesto per la traduzione euromediterranea →![]()
Qualche giorno fa in Slovenia si è tenuta la prima conferenza euro-mediterranea sulla traduzione, organizzata da Anna Lindh Foundation, Università Euro-Mediterranea (EMUNI) e il Ministero degli Esteri sloveno. Translation 4 Dialogue, questo il titolo della conferenza, è la “prima conferenza di alto livello di questo tipo organizzata nella regione Euro-Med. Vi parteciperanno circa 100 esperti … Continua a leggere Manifesto per la traduzione euromediterranea →![]()
Qualche giorno fa in Slovenia si è tenuta la prima conferenza euro-mediterranea sulla traduzione, organizzata da Anna Lindh Foundation, Università Euro-Mediterranea (EMUNI) e il Ministero degli Esteri sloveno. Translation 4 Dialogue, questo il titolo della conferenza, è la “prima conferenza di alto livello di questo tipo organizzata nella regione Euro-Med. Vi parteciperanno circa 100 esperti … Continua a leggere Manifesto per la traduzione euromediterranea →![]()
Qualche giorno fa in Slovenia si è tenuta la prima conferenza euro-mediterranea sulla traduzione, organizzata da Anna Lindh Foundation, Università Euro-Mediterranea (EMUNI) e il Ministero degli Esteri sloveno. Translation 4 Dialogue, questo il titolo della conferenza, è la “prima conferenza di alto livello di questo tipo organizzata nella regione Euro-Med. Vi parteciperanno circa 100 esperti … Continua a leggere Manifesto per la traduzione euromediterranea →![]()
La cronaca degli ultimi sbarchi non segna soltanto l’ennesimo aumento degli arrivi dalla Libia, ma vede una crescita esponenziale del…
di Sarah Lazare* “Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato ‘cosa è successo a casa mia?’.
Di Peter Oborne. Middle East Eye (24/06/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. La cosiddetta “primavera araba”, scoppiata in Tunisia nel 201o dall’atto di immolazione di un giovane venditore ambulante, è stato di certo un momento di grande afflato democratico. Tuttavia, esso ha anche portato al caos totale in Siria, Libia ed Egitto. La decisione del popolo […]
L’articolo La primavera araba del Regno Unito sembra essere il primo su Arabpress.
Serve un “piano Marshall” per l’Africa? E come si inserirebbe tale piano nelle politiche di contenimento delle migrazioni?
di Luis J. Rodriguez Ricordo che una volta, quindici anni fa, appena tornato a Los Angeles da Chicago, camminavo lungo una strada della San…
Di Elias Khoury. Al-Quds al-Arabi (21/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Formigari. Non sorprendono le notizie sull’irrigidimento dei rapporti tra il regime di Bashar al-Assad e il suo protettore russo e tra l’esercito di regime e i suoi alleati iraniani, esse risuonano insieme all’intensificazione militare che colpisce le forze islamiche di opposizione e alla tensione tra […]
L’articolo La Siria tra il dolore del suo popolo e la necessità di una tregua sembra essere il primo su Arabpress.
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
Sull’ultimo numero de Lo Straniero, fondato da Goffredo Fofi, potete leggere un mio articolo sulla diaspora egiziana. Questione ancora poco affrontata, eppure importante per quello che succede, sotto il tappeto e nel silenzio, nell’Egitto di Al Sisi. Molti, dei rivoluzionari, sono nelle città europee. E’ facile seguire la produzione scientifica, artistica, la vita di alcuni di loro.Read more
“Questa paura esiste, ma solo in alcune occasioni”.
Scarica il rapporto 2016 in PDF ¶
La campagna #FilieraSporca — promossa dalle associazioni Terra!
Sindos is a camp located on a back-road near the village of Sindos, about 15km from Thessaloniki, which started around 20 days ago.
Sherwood Festival, Saturday 2nd of July 2016 02:00 PM ¶
It’s not easy to give an overall vision of the work done with Over the Fortress…
22 giugno — Proseguono le indagini sul Cara di Mineo nell’ambito dell’inchiesta di “Mafia Capitale” con nuovi avvisi di garanzia ed…
Oggi andiamo in Iraq alla scoperta di un dessert leggero ma gustoso preparato durante il mese di Ramadan: lo zarda wa haleeb, budino di riso bianco e allo zafferano! Ingredienti: Per il budino bianco: 100g di riso 750ml di acqua un pizzico di sale 500ml di latte 1 cucchiaio di zucchero 1 cucchiaio di acqua di […]
L’articolo Speciale Ramadan: zarda wa haleeb, budino di riso bianco e allo zafferano sembra essere il primo su Arabpress.
Oggi andiamo in Iraq alla scoperta di un dessert leggero ma gustoso preparato durante il mese di Ramadan: lo zarda wa haleeb, budino di riso bianco e allo zafferano! Ingredienti: Per il budino bianco: 100g di riso 750ml di acqua un pizzico di sale 500ml di latte 1 cucchiaio di zucchero 1 cucchiaio di acqua di […]
L’articolo Speciale Ramadan: zarda wa haleeb, budino di riso bianco e allo zafferano sembra essere il primo su Arabpress.
Di Muhammad Ali Farhat. Al-Hayat (23/06/2016). Traduzione e sintesi di Letizia Vaglia. Del referendum sull’uscita delle Gran Bretagna dall’Unione Europea, quello che interessa noi come arabi è la strumentalizzazione da parte dei fautori della Brexit delle ondate di profughi (per lo più siriani) che stanno sbarcando nel continente come argomento a sostegno delle loro rivendicazioni. Al momento, anche […]
L’articolo Uno sguardo su Giordania e Libano sembra essere il primo su Arabpress.
Di Muhammad Ali Farhat. Al-Hayat (23/06/2016). Traduzione e sintesi di Letizia Vaglia. Del referendum sull’uscita delle Gran Bretagna dall’Unione Europea, quello che interessa noi come arabi è la strumentalizzazione da parte dei fautori della Brexit delle ondate di profughi (per lo più siriani) che stanno sbarcando nel continente come argomento a sostegno delle loro rivendicazioni. Al momento, anche […]
L’articolo Uno sguardo su Giordania e Libano sembra essere il primo su Arabpress.
Può la magistratura trattare il fenomeno migratorio come mera questione di ordine pubblico? Possono essere incriminati dei volontari che…
Messi sotto pressione dall’Europa, i parlamentari greci hanno votato per cambiare la composizione delle commissioni che hanno ostacolato le…
Vi proponiamo la traduzione di questo articolo (link articolo originale) tratto dal blog seguirconvida.msf.es,
“Il giorno che avrebbe dovuto rendere la mia vita più facile è stata invece l’esperienza più difficile che abbia mai fatto in tutta la mia…
I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europa (salvo i casi di esenzione) per fare ingresso legalmente in Italia hanno l’obbligo…
Di Bakr Sidqi. Al-Quds al-Arabi (23/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Cassata. Alcuni giornali hanno parlato del completamento degli accordi per la normalizzazione dei rapporti tra la Turchia e Israele. Fonti israeliane sostengono che i due paesi si trovano d’accordo sul 95% dei problemi, il restante 5% è ancora in via di risoluzione. Israele chiede […]
L’articolo La revisione della politica estera della Turchia sembra essere il primo su Arabpress.
Di Bakr Sidqi. Al-Quds al-Arabi (23/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Cassata. Alcuni giornali hanno parlato del completamento degli accordi per la normalizzazione dei rapporti tra la Turchia e Israele. Fonti israeliane sostengono che i due paesi si trovano d’accordo sul 95% dei problemi, il restante 5% è ancora in via di risoluzione. Israele chiede […]
L’articolo La revisione della politica estera della Turchia sembra essere il primo su Arabpress.
Un’organizzazione umanitaria ha realizzato “Il cimitero marino” cortometraggio per aumentare la consapevolezza mondiale sui rifugiati siriani che sono morti cercando di attraversare il Mar Mediterraneo.
Un’organizzazione umanitaria ha realizzato “Il cimitero marino” cortometraggio per aumentare la consapevolezza mondiale sui rifugiati siriani che sono morti cercando di attraversare il Mar Mediterraneo.
Un’organizzazione umanitaria ha realizzato “Il cimitero marino” cortometraggio per aumentare la consapevolezza mondiale sui rifugiati siriani che sono morti cercando di attraversare il Mar Mediterraneo.
Un’organizzazione umanitaria ha realizzato “Il cimitero marino” cortometraggio per aumentare la consapevolezza mondiale sui rifugiati siriani che sono morti cercando di attraversare il Mar Mediterraneo.
Un’organizzazione umanitaria ha realizzato “Il cimitero marino” cortometraggio per aumentare la consapevolezza mondiale sui rifugiati siriani che sono morti cercando di attraversare il Mar Mediterraneo.
Campagna LasciateCIEntrare — Cona (Ve), 10 giugno 2016
Delegazione costituita da Yasmine Accardo (Ass.
Oggi, 20 giugno, si celebra la Giornata del rifugiato, per ricordare tutte le persone in fuga a causa di guerre e persecuzioni.
Salvatore Fachile (Asgi): “Faremo ricorso alla Cedu”.
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
http://ift.tt/28PPZSe ¶
Le 27 mai dernier, Orient XXI a réuni à l’université Mohamed V de Rabat une dizaine de chercheurs et…
http://ift.tt/28RzCoK ¶
“Esci alle 8 di mattina e non fai che pedalare, pedalare e pedalare.
Assemblea di Over The Fortress ¶
Sherwood Festival, sabato 2 luglio 2016 ore 14.00
Vi proponiamo la traduzione di questo articolo (link articolo originale) tratto dal blog seguirconvida.msf.es,
Si ringrazie l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione ed il commento ¶
Con la sentenza n.
Sembra che Dio si sia dimenticato dei ragazzi di Sidi Moumen e che loro in risposta siano andati a cercarlo. Le stelle di Sidi Moumen non sono solo piccoli calciatori capaci di selezionare con mano esperta il meglio da una discarica, sono anche in grado di fare molto di più, di dare la loro vita […]
L’articolo Il grande salto di Mahi Binebine sembra essere il primo su Arabpress.
Sembra che Dio si sia dimenticato dei ragazzi di Sidi Moumen e che loro in risposta siano andati a cercarlo. Le stelle di Sidi Moumen non sono solo piccoli calciatori capaci di selezionare con mano esperta il meglio da una discarica, sono anche in grado di fare molto di più, di dare la loro vita […]
L’articolo Il grande salto di Mahi Binebine sembra essere il primo su Arabpress.
Di Lina Kennouche. L’Orient Le Jour (22/06/2016). Traduzione e sintesi di Chiara Cartia. Il Consiglio di Stato egiziano ha annullato ieri la cessione all’Arabia Saudita delle due isole di Tiran e Sanafir prevista dall’accordo tra i due paesi adottato il 9 aprile scorso, ma non ancora ratificato. Questa sentenza è stata accolta positivamente da una larga […]
L’articolo Retrocessione delle isole Tiran e Sanafir: quali conseguenze? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Lina Kennouche. L’Orient Le Jour (22/06/2016). Traduzione e sintesi di Chiara Cartia. Il Consiglio di Stato egiziano ha annullato ieri la cessione all’Arabia Saudita delle due isole di Tiran e Sanafir prevista dall’accordo tra i due paesi adottato il 9 aprile scorso, ma non ancora ratificato. Questa sentenza è stata accolta positivamente da una larga […]
L’articolo Retrocessione delle isole Tiran e Sanafir: quali conseguenze? sembra essere il primo su Arabpress.
Su minima e moralia, il blog culturale di Minimum Fax, è apparsa una nuova puntata della rubrica di Mario Valentini dedicata agli scrittori arabi contemporanei. Dopo averci parlato degli autori libanesi, di Nagib Mahfuz, Habib Selmi e Ghassan Kanafani, Valentini torna in Egitto per raccontarci dei romanzi di Sonallah Ibrahim e dei tormenti dell’Egitto di … Continua a leggere L’Egitto dei suoi scrittori →![]()
Su minima e moralia, il blog culturale di Minimum Fax, è apparsa una nuova puntata della rubrica di Mario Valentini dedicata agli scrittori arabi contemporanei. Dopo averci parlato degli autori libanesi, di Nagib Mahfuz, Habib Selmi e Ghassan Kanafani, Valentini torna in Egitto per raccontarci dei romanzi di Sonallah Ibrahim e dei tormenti dell’Egitto di … Continua a leggere L’Egitto dei suoi scrittori →![]()
Su minima e moralia, il blog culturale di Minimum Fax, è apparsa una nuova puntata della rubrica di Mario Valentini dedicata agli scrittori arabi contemporanei. Dopo averci parlato degli autori libanesi, di Nagib Mahfuz, Habib Selmi e Ghassan Kanafani, Valentini torna in Egitto per raccontarci dei romanzi di Sonallah Ibrahim e dei tormenti dell’Egitto di … Continua a leggere L’Egitto dei suoi scrittori →![]()
Su minima e moralia, il blog culturale di Minimum Fax, è apparsa una nuova puntata della rubrica di Mario Valentini dedicata agli scrittori arabi contemporanei. Dopo averci parlato degli autori libanesi, di Nagib Mahfuz, Habib Selmi e Ghassan Kanafani, Valentini torna in Egitto per raccontarci dei romanzi di Sonallah Ibrahim e dei tormenti dell’Egitto di … Continua a leggere L’Egitto dei suoi scrittori →![]()
Su minima e moralia, il blog culturale di Minimum Fax, è apparsa una nuova puntata della rubrica di Mario Valentini dedicata agli scrittori arabi contemporanei. Dopo averci parlato degli autori libanesi, di Nagib Mahfuz, Habib Selmi e Ghassan Kanafani, Valentini torna in Egitto per raccontarci dei romanzi di Sonallah Ibrahim e dei tormenti dell’Egitto di … Continua a leggere L’Egitto dei suoi scrittori →![]()
Padova Accoglie, dopo il presidio e il successivo incontro, avvenuto nella Giornata Mondiale del Rifugiato, con il viceprefetto in…
Giovedì, 9 giugno 2016 ¶
In maggio Fanny Carrier, vice direttrice presso l’ufficio di Agence France-Presse di Roma, ha passato una…
In occasione della sedicesima Giornata Mondiale del Rifugiato, a Verona, un gruppo spontaneo di cittadini ha lanciato un appello che ha…
Il trio, attualmente in Grecia, sostiene che la Turchia non sia un posto sicuro per i rifugiati e la scorsa settimana se ne è lamentato…
Terrorismo e jihad sono ormai diventati termini consueti nella cronaca quotidiana dell’Occidente che ogni giorno ci racconta di nuovi attacchi terroristici in nome di una superiorità religiosa predicata da una minoranza criminale che nulla ha a che spartire con la religione in senso stretto. Ma il rapporto fra Occidente e Islam in termini di guerre […]
L’articolo “Il Califfato e l’Europa” di Franco Cardini sembra essere il primo su Arabpress.
Terrorismo e jihad sono ormai diventati termini consueti nella cronaca quotidiana dell’Occidente che ogni giorno ci racconta di nuovi attacchi terroristici in nome di una superiorità religiosa predicata da una minoranza criminale che nulla ha a che spartire con la religione in senso stretto. Ma il rapporto fra Occidente e Islam in termini di guerre […]
L’articolo “Il Califfato e l’Europa” di Franco Cardini sembra essere il primo su Arabpress.
L’assegno sociale e’ una prestazione pensionistica che viene riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici, e reddituali.
On 20 June 2016, the Council extended until 27 July 2017 the mandate of the EUNAFOR MED Operation Sophia, the EU naval operation to disrupt…
On 20 June 2016, the Council extended until 27 July 2017 the mandate of the EUNAFOR MED Operation Sophia, the EU naval operation to disrupt…
Cos’è l’invalidità civile? ¶
L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno status invalidante in base al quale il cittadino pu…
L’assegno sociale non può essere trasferito all’estero ovvero il trasferimento all’estero della persona beneficiaria dell’assegno fa…
Di Fatima Iasin. Al-Araby al-Jadeed (21/06/2016). Traduzione e sintesi di Mariacarmela Minniti. I paesi dell’Unione Europea sembrano un unico blocco omogeneo con un sistema morale, politico ed economico unificato. Il Trattato di Maastricht ha gettato le basi affinché quegli Stati traducessero in realtà giuridica questa omogeneità, ma a distanza di oltre vent’anni un membro fondamentale […]
L’articolo Unione Europea: la festa è finita? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Fatima Iasin. Al-Araby al-Jadeed (21/06/2016). Traduzione e sintesi di Mariacarmela Minniti. I paesi dell’Unione Europea sembrano un unico blocco omogeneo con un sistema morale, politico ed economico unificato. Il Trattato di Maastricht ha gettato le basi affinché quegli Stati traducessero in realtà giuridica questa omogeneità, ma a distanza di oltre vent’anni un membro fondamentale […]
L’articolo Unione Europea: la festa è finita? sembra essere il primo su Arabpress.
Lunedì 4 luglio ore 21 ¶
Accoglienza e diritto d’asilo al tempo degli hotspot ¶
Sherwood Festival 2016
Park Nord Stadio Euganeo
Second…
“Nel taxi, osservai questa bellissima terra fuori dal finestrino. Posso costruirmi un futuro qui? Mi chiesi.” saggio di un rifugiato sull’inizio della sua nuova vita.
“Nel taxi, osservai questa bellissima terra fuori dal finestrino. Posso costruirmi un futuro qui? Mi chiesi.” saggio di un rifugiato sull’inizio della sua nuova vita.
“Nel taxi, osservai questa bellissima terra fuori dal finestrino. Posso costruirmi un futuro qui? Mi chiesi.” saggio di un rifugiato sull’inizio della sua nuova vita.
“Nel taxi, osservai questa bellissima terra fuori dal finestrino. Posso costruirmi un futuro qui? Mi chiesi.” saggio di un rifugiato sull’inizio della sua nuova vita.
“Nel taxi, osservai questa bellissima terra fuori dal finestrino. Posso costruirmi un futuro qui? Mi chiesi.” saggio di un rifugiato sull’inizio della sua nuova vita.
di Elettra Repetto ¶
Isola di Samos, Grecia — Mi chiamano per mostrarmi un video.
(Agenzie). In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno, la piattaforma di corsi online americana Coursera ha messo a disposizione più di 1.000 corsi universitari online dei quali potranno usufruire i rifugiati di tutto il mondo per acquisire nuove conoscenze e competenze. L’iniziativa, chiamata Coursera for Refugeees, fornisce accesso a […]
L’articolo Piattaforma americana offre corsi per rifugiati sembra essere il primo su Arabpress.
(Agenzie). In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno, la piattaforma di corsi online americana Coursera ha messo a disposizione più di 1.000 corsi universitari online dei quali potranno usufruire i rifugiati di tutto il mondo per acquisire nuove conoscenze e competenze. L’iniziativa, chiamata Coursera for Refugeees, fornisce accesso a […]
L’articolo Piattaforma americana offre corsi per rifugiati sembra essere il primo su Arabpress.
Di Azmi Bishara. Al-Araby Al-Jadeed (20/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. Gli arabi non sono soli a fronteggiare la catastrofe che incombe su Siria e Iraq. Al loro fianco anche l’Iran che sta attraversando una vera e propria crisi. E si possono intravedere già gli sviluppi futuri nella regione. Il recente cambiamento di equilibri […]
L’articolo Arabi e Iraniani, verso quale soluzione? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Azmi Bishara. Al-Araby Al-Jadeed (20/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. Gli arabi non sono soli a fronteggiare la catastrofe che incombe su Siria e Iraq. Al loro fianco anche l’Iran che sta attraversando una vera e propria crisi. E si possono intravedere già gli sviluppi futuri nella regione. Il recente cambiamento di equilibri […]
L’articolo Arabi e Iraniani, verso quale soluzione? sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana prossima torna a Roma la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry per presentare il suo nuovo romanzo Damasco, appena uscito per Feltrinelli. Ho letto il libro e ne ho parlato per Q Code Magazine qualche giorno fa: Damasco (Feltrinelli 2016, cura e traduzione dall’inglese di M. Nadotti) è l’ultimo libro di Suad Amiry, … Continua a leggere Interno damasceno →![]()
La settimana prossima torna a Roma la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry per presentare il suo nuovo romanzo Damasco, appena uscito per Feltrinelli. Ho letto il libro e ne ho parlato per Q Code Magazine qualche giorno fa: Damasco (Feltrinelli 2016, cura e traduzione dall’inglese di M. Nadotti) è l’ultimo libro di Suad Amiry, … Continua a leggere Interno damasceno →![]()
La settimana prossima torna a Roma la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry per presentare il suo nuovo romanzo Damasco, appena uscito per Feltrinelli. Ho letto il libro e ne ho parlato per Q Code Magazine qualche giorno fa: Damasco (Feltrinelli 2016, cura e traduzione dall’inglese di M. Nadotti) è l’ultimo libro di Suad Amiry, … Continua a leggere Interno damasceno →![]()
La settimana prossima torna a Roma la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry per presentare il suo nuovo romanzo Damasco, appena uscito per Feltrinelli. Ho letto il libro e ne ho parlato per Q Code Magazine qualche giorno fa: Damasco (Feltrinelli 2016, cura e traduzione dall’inglese di M. Nadotti) è l’ultimo libro di Suad Amiry, … Continua a leggere Interno damasceno →![]()
Con il supporto dell’FNSI, dell’USIGRAI, dell’Ordine dei Giornalisti, di Art.21 e della Carta di Roma, nonché di numerose associazioni…
Si ringrazia Paola Andrisani di Lunaria per la segnalazione.
Ordinanza del Tribunale di Napoli emessa nel mese di giugno 2016 che riconosce ad un cittadino ucraino il diritto alla protezione…
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Ordinanza del Tribunale di Napoli emessa nel mese di
giugno 2016, che riconosce ad un cittadino ucraino il dritto alla
protezione…
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
(SaphirNews). Lo scorso venerdì 17 giugno, nella chiesa di San Giovanni Battista di Molenbeek, in Belgio, è stato organizzato un iftar (il pasto di rottura del digiuno durante il Ramadan) al quale hanno partecipato 600 persone, un eccezionale momento di condivisione organizzato Sarah Turine, responsabile municipale per il dialogo interreligioso. Inizialmente, l’evento doveva svolgersi nella piazza comunale (come […]
L’articolo Iftar interreligiosi in chiesa in Belgio e Canada sembra essere il primo su Arabpress.
(SaphirNews). Lo scorso venerdì 17 giugno, nella chiesa di San Giovanni Battista di Molenbeek, in Belgio, è stato organizzato un iftar (il pasto di rottura del digiuno durante il Ramadan) al quale hanno partecipato 600 persone, un eccezionale momento di condivisione organizzato Sarah Turine, responsabile municipale per il dialogo interreligioso. Inizialmente, l’evento doveva svolgersi nella piazza comunale (come […]
L’articolo Iftar interreligiosi in chiesa in Belgio e Canada sembra essere il primo su Arabpress.
Lo sgombero del campo di Idomeni in Grecia, la condizione dei rifugiati, il destino del popolo siriano e la balbuzie degli stati europei
…
Nel provvedimento emesso dal Questore di Savona, oggetto della impugnazione, si leggeva testualmente: “…. visto che il predetto in data 28…
Bloccato a Dover, frontiera sud-orientale della Gran Bretagna, su richiesta francese un convoglio composto da un tir e 250 automobili…
Dopo lo sgombero degli ultimi assembramenti non autorizzati a ridosso della frontiera, migliaia di persone sono state trasferite nei campi…
Questa incredibile storia la racconta Judith Sunderland di Human Right Watch, che ha prestato il suo telefono per permettere ad una…
Di Abdulrahman al-Rashed. Asharq al-Awsat (19/06/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. Il presidente statunitense Barack Obama pensava di essersi distinto per aver scelto di ignorare la crisi in Siria, cercando di evitare gli errori commessi in Iraq dall’amministrazione precedente. Tuttavia, molti hanno iniziato a criticare questa “neutralità negativa”, dicendo invece che è importante riconsiderare […]
L’articolo Riconsiderando l’intervento in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Una serie di brevi video che accompagnano il richiedente in ogni fase della procedura di richiesta protezione, unendo lingua parlata con…
Una serie di brevi video che accompagnano il richiedente in ogni fase della procedura di richiesta protezione, unendo lingua parlata con…
Venerdì 17 giugno, quasi un centinaio di persone sono scese in piazza Municipio per ribadire la loro assoluta contrarietà al modello…
“un’esperienza che non vorresti mai vivere, a meno che tu non sia disperato”. Il viaggio di Zozan Khaled Musa nell’Europa dell’est in cerca di asilo.
“un’esperienza che non vorresti mai vivere, a meno che tu non sia disperato”. Il viaggio di Zozan Khaled Musa nell’Europa dell’est in cerca di asilo.
“un’esperienza che non vorresti mai vivere, a meno che tu non sia disperato”. Il viaggio di Zozan Khaled Musa nell’Europa dell’est in cerca di asilo.
“un’esperienza che non vorresti mai vivere, a meno che tu non sia disperato”. Il viaggio di Zozan Khaled Musa nell’Europa dell’est in cerca di asilo.
“È un’esperienza che non vorresti mai vivere a meno che tu non sia davvero disperato,” Zozan Khaled Musa racconta del suo viaggio attraverso l’Europa dell’est in cerca di asilo
Dal 2009 Tomas Rafa documenta le nuove derive nazionaliste e neofasciste dell’Europa e dal 2015 monitora le politiche europee verso l…
“Memorie migranti” è il tema della serata inaugurale della XV Edizione del Festival Delle Letterature di Roma, apertosi qualche giorno fa nella suggestiva cornice della Basilica di Massenzio. Ospite internazionale della serata lo scrittore turco Hakan Günday che ha letto nella sua lingua un toccante inedito dal titolo “Occupato”. Il testo è una struggente lettera che […]
L’articolo A “Memorie migranti” un inedito di Hakan Günday sembra essere il primo su Arabpress.
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Questa ricetta sembra voler combinare in un unico piatto due delle pietanze più rappresentative della cucina tunisina, ossia il brik e il tajine tradizionale. Andiamo dunque a scoprire un’altra gustosa specialità del mese di Ramadan: la tajine malsouka! Ingredienti: 150gr di petto di pollo o di tonno sott’olio 10/12 folgi di pasta brik (o pasta fillo) una cipolla 100gr di formaggio grattugiato 1 […]
L’articolo Speciale Ramadan: tajine malsouka tunisina sembra essere il primo su Arabpress.
Di Samira al-Musalima. Al-Arabi al-Jadeed (15/06/2016). Traduzione e sintesi a cura di Letizia Vaglia. La Siria sta vivendo decisamente un momento di stallo: da un lato, il regime non si è dimostrato in grado di sedare la rivoluzione, nonostante il vero e proprio arsenale di armi a sua disposizione, e il sostegno militare e finanziario di Russia […]
L’articolo Siria: un destino in sospeso sembra essere il primo su Arabpress.
Ventimiglia è una città ligure della provincia di Imperia, a una decina di chilometri dalla Francia, in cui arrivano centinaia di migranti…
Una sentenza del Tar del Lazio che, nell’accogliere un ricorso contro il diniego di rilascio di visto per motivi di residenza elettiva…
La notizia battuta la Wall Street Journal sta facendo il giro del mondo.
La decisione è stata presa a seguito della lettera con la quale…
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione.
Campagna LasciateCIEntrare — Cosenza, 30 maggio 2016 ¶
Delegazione costituita da Luca Mannarino (attivista), Emilia Corea (Ass.
Quando l’architetta irlandese Grainne Hassett, nell’agosto del 2015, è arrivata per la prima volta nel campo profughi di Calais, conosciuto…
Riceviamo e pubblichiamo ringraziando le autrici. ¶
Li vediamo da lontano, per la prima volta, ci appaiono come cerchi o croci: sono le…
La notizia battuta la Wall Street Journal sta facendo il giro del mondo.
La decisione è stata presa a seguito della lettera con la quale…
Si ringrazia l’Avv.Federico Lera per la segnalazione.
 Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
(Quest’articolo è frutto di una collaborazione editoriale tra l‘Istituto Affari Internazionali e Osservatorio Balcani e Caucaso)
 Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
(Quest’articolo è frutto di una collaborazione editoriale tra l‘Istituto Affari Internazionali e Osservatorio Balcani e Caucaso)
 Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
(Quest’articolo è frutto di una collaborazione editoriale tra l‘Istituto Affari Internazionali e Osservatorio Balcani e Caucaso)
 Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
(Quest’articolo è frutto di una collaborazione editoriale tra l‘Istituto Affari Internazionali e Osservatorio Balcani e Caucaso)
 Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
Il fenomeno terrorista nel paese balcanico affonda le proprie radici nella guerra degli anni ’90, e nella presenza di gruppi che si pongono come alternativi alla comunità islamica ufficiale.
(Quest’articolo è frutto di una collaborazione editoriale tra l‘Istituto Affari Internazionali e Osservatorio Balcani e Caucaso)
Avete presente quei libri appassionanti, quelli che ripercorrono la storia di intere generazioni di una famiglia, partendo dalle origini e arrivando fino ai giorni nostri, racchiusi in quei bei tomi pesanti, che le persone che come me, che amano leggere sui mezzi o nei momenti morti della giornata, si trascinano dietro nonostante il loro peso, […]
L’articolo Consiglio di lettura: “La strega nera di Teheran” di Gina Barkhordar Nahai sembra essere il primo su Arabpress.
Di Ibrahim Sha’ban. Al-Quds (16/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Cassata. Per la prima volta dopo più di 70 anni dalla nascita dell’ONU, Israele guiderà una delle sei Commissioni dell’Assemblea Generale, la Commissione Legale. Che vergogna! La votazione si è svolta in gran segreto lunedì scorso ed hanno votato a favore più dei due terzi […]
L’articolo Israele alla guida della Commissione legale dell’ONU sembra essere il primo su Arabpress.
Anche quest’anno vi segnalo i titoli finalisti al Premio francese per la letteratura araba, che è giunto alla sua quarta edizione. Al premio possono partecipare romanzi di autori arabi (dei paesi che fanno parte della Lega araba) che scrivono in arabo, e che sono stati tradotti in francese, o che scrivono direttamente in francese. I romanzi … Continua a leggere 4° edizione per il Premio francese della letteratura araba →![]()
Anche quest’anno vi segnalo i titoli finalisti al Premio francese per la letteratura araba, che è giunto alla sua quarta edizione. Al premio possono partecipare romanzi di autori arabi (dei paesi che fanno parte della Lega araba) che scrivono in arabo, e che sono stati tradotti in francese, o che scrivono direttamente in francese. I romanzi … Continua a leggere 4° edizione per il Premio francese della letteratura araba →![]()
Anche quest’anno vi segnalo i titoli finalisti al Premio francese per la letteratura araba, che è giunto alla sua quarta edizione. Al premio possono partecipare romanzi di autori arabi (dei paesi che fanno parte della Lega araba) che scrivono in arabo, e che sono stati tradotti in francese, o che scrivono direttamente in francese. I romanzi … Continua a leggere 4° edizione per il Premio francese della letteratura araba →![]()
Anche quest’anno vi segnalo i titoli finalisti al Premio francese per la letteratura araba, che è giunto alla sua quarta edizione. Al premio possono partecipare romanzi di autori arabi (dei paesi che fanno parte della Lega araba) che scrivono in arabo, e che sono stati tradotti in francese, o che scrivono direttamente in francese. I romanzi … Continua a leggere 4° edizione per il Premio francese della letteratura araba →![]()
The consequence of the EU-Turkey Deal: We documented an
illegal push-back operation in the Aegean with Frontex present!
 C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
 C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
 C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
C’è ancora crisi e disoccupazione e cresce lo scontento. Il 4 giugno, a Douze (Governatorato di Kebili), scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, incendiata la sede municipale e la caserma della Guardia Nazionale, assalti a sedi di compagnie petrolifere. Ma nella capitale revocato il coprifuoco e si iniziano a vedere gruppi di turisti.
Nel provvedimento emesso dal Questore di Savona, oggetto della impugnazione, si leggeva testualmente: “…. visto che il predetto in data 28…
E’ accaduto a Udine dove sette volontari dell’Associazione Ospiti in Arrivo che stavano distribuendo coperte e generi di prima necessità a…
Non ci è stato possibile restare indifferenti dopo i fatti accaduti a Conegliano.
Di Ramzy Baroud. Middle East Monitor (14/06/2016). Traduzione e sintesi di Chiara Cartia “(All’alba)… resisterò.. (Perché) sopra al muro c’è ancora un foglio bianco.. E le mie dita devono ancora dissolversi (del tutto)”. Questo è un verso tradotto da “Tre muri della camera di tortura” di Mu’in Bseiso, che era – e rimane – uno degli […]
L’articolo Gaza: la poesia come strumento di resistenza sembra essere il primo su Arabpress.
Di Majed Samra’i. Al-Arab (14/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Formigari. Non c’è iracheno che non sia d’accordo nel definire Daesh (ISIS) un’organizzazione terroristica che, dal giugno 2014, ha occupato un terzo dell’Iraq e che serve gli interessi delle grandi e medie potenze. In questo contesto il governo iracheno aveva il dovere di trasformare la lotta […]
L’articolo Perché in Iraq la lotta a Daesh non si è trasformata in una guerra nazionale sembra essere il primo su Arabpress.
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Osservazioni stimolate dall’articolo di Francesca Borri “Perchè i pacifisti in Occidente non manifestano contro Assad”. Ma davvero, come ha scritto tempo fa su Internazionale Francesca Borri, i pacifisti italiani stanno con Assad? Certo, l’indifferenza mostrata dai “movimenti” e da quelle che un tempo avremmo definito “avanguardie” nei confronti del cataclisma siriano ha dell’incomprensibile. L’entità della […]![]()
Pubblichiamo ben tre ordinanze del Tribunale di Potenza che riconoscono la protezione sussidiaria ai cittadini maliani.
La struttura, chiusa nel mese di ottobre per lavori, aprirà nuovamente i suoi nuovi reparti la prossima settimana.
In maggio, Fanny Carrier, vice direttrice presso l’ufficio di Agence France-Presse di Roma, ha passato una settimana a bordo dell’Acquarius…
Specchio Straniero è una trasmissione di Amisnet.org curata dai richiedenti asilo e dai rifugiati ospitati presso i centri SPRAR del…
Di Abdallah Zaghib. As-Safir (13/06/2016). Traduzione e sintesi di Silvia Lobina. Le guerre sono sempre state cause di tragedie, con le loro trincee, il fuoco, i genocidi, e tra militari e civili, uccisori e uccisi, talvolta diviene complesso distinguere l’attentatore e le vittime, al di là delle linee designate dalla legislazione internazionale, o dei “confini morali”, che subiscono […]
L’articolo Non ci sono più bambini in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
L’UNIMED in collaborazione con Mediterraneo: fotografie tra terre e mare organizza il convegno dal titolo “Il fattore femminile come elemento essenziale nella trasmissione delle tradizioni e della cultura nel Mediterraneo”, all’interno del quale si produrranno una serie di riflessioni trasversali che vedono il coinvolgimento di varie istituzioni. In particolare, all’evento interverranno Marco Di Donato, coordinatore del Centro Studi UNIMED, Giusy […]
L’articolo Convegno: le donne e la trasmissione della cultura nel Mediterraneo sembra essere il primo su Arabpress.
Di Wael Najm. Al-Araby al-Jadeed (14/06/2016). Traduzione e sintesi di Mariacarmela Minniti. Diversamente dagli attentati che hanno colpito il Libano negli ultimi cinque anni e che rientravano nel quadro di omicidi politici o di reazioni a eventi e sviluppi a livello regionale, l’esplosione verificatasi domenica scorsa è stata differente per tempistica, messaggio, luogo e obiettivo. […]
L’articolo Il messaggio dietro l’attentato a Beirut sembra essere il primo su Arabpress.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo lo sgombero del campo di Idomeni, l’entrata scenica delle ruspe nella foresta di fronte Hotel Hara dove ancora resistono le ultime…
L’Eko Camp è stato sgomberato ieri. Dopo lo sgombero di Idomeni, il campo informale, sorto sei mesi fa nei pressi di una stazione di…
31 maggio 2016 — Arriviamo al campo governativo di Diavata intorno alle 11.00.
Allarme umanitario in Iraq, 3,6 milioni sfollati in fuga da Isis
http://ift.tt/1VXtqwN
“Abbiamo bisogno di una narrazione più complessa ed efficace del nostro paese.
Ad alcuni volontari dell’Associazione “Ospiti in Arrivo” di Udine è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari…
Le condizioni nel sistema dei nuovi campi profughi permanenti in Grecia sono state definite così squallide e carenti di servizi essenziali…
Ultimamente, se vi capita di guardare/ascoltare/leggere telegiornali o altre fonti di informazione, potreste essere portati a credere che…
Sekine Triore è rimasto ucciso da un carabiniere dopo averlo aggredito.
Padova Accoglie invita ad un presidio presso la sede della Commissione Territoriale di Valutazione delle domande di protezione…
Di Abdel Bari Atwan. Al-Arab (13/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. La scorsa domenica anche l’America sembra essere stata vittima di una delle più violenti esecuzioni terroristiche rivendicate da Daesh (ISIS), ed eseguite da uno dei suoi “militanti”, il giovane americano Omar Saddiqui Mateen, di origini afghane. Quest’ultimo, poco prima di aprire il fuoco […]
L’articolo Daesh trasferisce le sue operazioni in America sembra essere il primo su Arabpress.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
C’è lavoro. Tanto lavoro. Basta scorrere il programma del Suq Genova che tra poco apre i battenti per intuire che c’è tanto lavoro, alle spalle della tensostruttura di Renzo Piano, al Porto Antico di Genova. Io sono parziale, in questo caso. Spio di lontano il lavoro di Carla Peirolero, di tutte le amiche del Suq,Read more
http://ift.tt/1UvXlY1
Inviate due navi nella zona dopo allarme autorità libiche
migrano
news e agenzie italiane
via Ansamed — ANSA…
Alcuni volontari dell’Associazione Ospiti in Arrivo, che dal 2014 opera a Udine a scopo umanitario a favore dei migranti provenienti dalla…
 Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
 Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
 Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
 Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
Lanciato per progetti culturali da realizzare nei paesi arabi durante il biennio 2016-2017 che promuovano la libertà d’espressione e il rispetto delle diversità, e considerino la creatività artistica e il pensiero critico come elementi centrali nello sviluppo sociale e nella costruzione democratica. Le richieste di sostegno vanno inviate entro il 22 luglio.
Venerdì mattina una delegazione della Campagna LasciateCIEntrare e di Melting Pot Europa, ha avuto accesso nell’ex base militare oggi…
“Dimenticare un paese in guerra, fuggire da un’epidemia, ricongiungersi ai propri cari, iniziare una nuova vita.
Fulvio Vassallo Paleologo ¶
Elena Consiglio ¶
Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell’Università di Palermo ¶
The Central…
Di Othmane Benyahia. Al Huffington Post Maghreb (12/06/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. Ed ecco di nuovo il Ramadan, mese di felicità e di spiritualità, in cui le famiglie marocchine si ritrovano insieme quasi tutti i giorni. Il Ramadan è il mese delle azioni caritatevoli in cui si testa, al di là del nostro piccolo, di […]
L’articolo Ramadan: il mese delle contraddizioni sembra essere il primo su Arabpress.
Riceviamo e pubblichiamo. ¶
Sono ancora in corso le operazioni di sbarco dalla nave della Guardia Costiera CP 940 Dattilo di circa 640…
Padova — Si è svolto giovedì 9 giugno il dibattito “Over The Fortress.
Sentenza del Tribunale di Roma, relativa ad un ricorso avverso diniego di protezione internazionale presentato da un cittadino pakistano.
Hussein HK Ibrahim (HK sta per Hussein the King) è un ragazzo di 19 anni che abbiamo conosciuto all’Eko Camp, il campo informale…
 Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
 Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
 Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
 Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
 Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Racconta l’incredibile viaggio – 72 giorni a dorso di mulo – di Mirko Adamo e Federico Price Bruno, che hanno deciso di risalire l’Italia, da Portella della Ginestra a Roma per sensibilizzare sulla sorte e il destino assai critico delle zone rurali del Meridione d’Italia, sempre più spopolate. Regia di Christian Carmosino e Antonio Oliverio. Premio “Ambiente e società” al Festival Cinemambiente di Torino.
Di Mona Alami. Al-Monitor (13/06/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. Disillusi e disincantati in Libano e in Iraq stanno esprimendo il loro malcontento. Entrambi dominati da politiche settarie, questi due paesi stanno assistendo alla nascita di un movimento sociale trasversale: in Libano le elezioni municipali hanno rivelato che l’appoggio ai partiti tradizionali sta crollando, mentre […]
L’articolo Venti di cambiamento in Libano e Iraq sembra essere il primo su Arabpress.
Il poeta siriano e la scrittrice libanese sono tra gli ospiti del festival genovese SUQ, che si svolge dal 16 al 26 giugno al Porto Antico della capitale ligure. Potete trovare Joumana Haddad in due eventi: Lunedì 20 giugno, ore 21 / Giornata mondiale del rifugiato: Medici senza frontiere al Suq Con Loris de Filippi, … Continua a leggere Adonis e Joumana Haddad a Suq Genova 2016 →![]()
Il poeta siriano e la scrittrice libanese sono tra gli ospiti del festival genovese SUQ, che si svolge dal 16 al 26 giugno al Porto Antico della capitale ligure. Potete trovare Joumana Haddad in due eventi: Lunedì 20 giugno, ore 21 / Giornata mondiale del rifugiato: Medici senza frontiere al Suq Con Loris de Filippi, … Continua a leggere Adonis e Joumana Haddad a Suq Genova 2016 →![]()
Il poeta siriano e la scrittrice libanese sono tra gli ospiti del festival genovese SUQ, che si svolge dal 16 al 26 giugno al Porto Antico della capitale ligure. Potete trovare Joumana Haddad in due eventi: Lunedì 20 giugno, ore 21 / Giornata mondiale del rifugiato: Medici senza frontiere al Suq Con Loris de Filippi, … Continua a leggere Adonis e Joumana Haddad a Suq Genova 2016 →![]()
Di Mustafa Ünal. Yarına Bakış (09/06/2016). Traduzione e sintesi di Marta Calcaterra. Noncurante del Ramadan, il terrorismo ha mostrato il suo volto insanguinato. L’altro giorno Istanbul, poi Mardin. La situazione è molto pesante. Circoscrivere il bilancio delle vittime e dei martiri è insensato. I numeri sono inutili. È profondo il trauma che ha subito il popolo. Da […]
L’articolo Nuova ondata di terrorismo in Turchia sembra essere il primo su Arabpress.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
“Spero che, quando la guerra sarà finita, potrò realizzare i miei sogni.” afferma Nour, studente dell’Università di Damasco ora impegnato nella lotta pacifista contro Assad.
“Spero che, quando la guerra sarà finita, potrò realizzare i miei sogni.” afferma Nour, studente dell’Università di Damasco ora impegnato nella lotta pacifista contro Assad.
“Spero che, quando la guerra sarà finita, potrò realizzare i miei sogni.” afferma Nour, studente dell’Università di Damasco ora impegnato nella lotta pacifista contro Assad.
“Spero che, quando la guerra sarà finita, potrò realizzare i miei sogni.” afferma Nour, studente dell’Università di Damasco ora impegnato nella lotta pacifista contro Assad.
“Spero che, quando la guerra sarà finita, potrò realizzare i miei sogni.” afferma Nour, studente dell’Università di Damasco ora impegnato nella lotta pacifista contro Assad.
 Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
 Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
 Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
 Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
 Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Babelmed pubblica l’intervento del Presidente del dipartimento di psicologia dell’Università di Dogus, uno dei 1128 intellettuali di 89 università in Turchia e all’estero che a gennaio avevano firmato una petizione per la pace, per la soluzione della questione curda,…
Di Bouthaina Shaaban. Al-Vefagh Online (07/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Cassata. Due eventi della scorsa settimana possono essere considerati, in una certa misura, sorprendenti, oltre ad essere degli indicatori di possibili eventi futuri a livello regionale e internazionale. Il primo di essi è il riconoscimento del parlamento tedesco del massacro ottomano perpetrato contro gli […]
L’articolo Turchia e Arabia Saudia: quel che è giusto è giusto sembra essere il primo su Arabpress.
Ramadan karim! Anche quest’anno è iniziato il mese di Ramadan e con esso il digiuno rituale. Da oggi, scopriremo alcune ricette tipiche di questo periodo dell’anno in tutto il mondo arabo-islamico, cominciando con una ricetta dall’Algeria: la tbikha, giardiniera di verdure! Ingredienti: 500g di fave 500g di pisellini 5 cuori di carciofo 5 spicchi d’aglio 1 […]
L’articolo Speciale Ramadan: tbikha, giardiniera di verdure sembra essere il primo su Arabpress.
Ieri mattina una manifestazione di circa 200 braccianti ha denunciato il razzismo e il clima di terrore delle forze dell’ordine.
di questi ultimi mesi. A Palermo vengono fatti sbarcare altre centinaia di migranti, e tanti saranno minori non accompagnati, che rimangono…
Non ci è stato possibile restare indifferenti dopo i fatti accaduti a Conegliano.
Cecilia Della Negra è stata proprio brava. Cercare e mettere assieme il peggio della pubblicità sessista in Italia è stato lo sforzo giusto (uno dei numerosi) per rispondere al Buongiorno di Massimo Gramellini su Etihad, i centimetri di pelle delle hostess, la superiorità culturale occidentale eccetera. Potrei parlare della trave e delle travi. Potrei parlareRead more
Cecilia Della Negra è stata proprio brava. Cercare e mettere assieme il peggio della pubblicità sessista in Italia è stato lo sforzo giusto (uno dei numerosi) per rispondere al Buongiorno di Massimo Gramellini su Etihad, i centimetri di pelle delle hostess, la superiorità culturale occidentale eccetera. Potrei parlare della trave e delle travi. Potrei parlareRead more
Cecilia Della Negra è stata proprio brava. Cercare e mettere assieme il peggio della pubblicità sessista in Italia è stato lo sforzo giusto (uno dei numerosi) per rispondere al Buongiorno di Massimo Gramellini su Etihad, i centimetri di pelle delle hostess, la superiorità culturale occidentale eccetera. Potrei parlare della trave e delle travi. Potrei parlareRead more
Cecilia Della Negra è stata proprio brava. Cercare e mettere assieme il peggio della pubblicità sessista in Italia è stato lo sforzo giusto (uno dei numerosi) per rispondere al Buongiorno di Massimo Gramellini su Etihad, i centimetri di pelle delle hostess, la superiorità culturale occidentale eccetera. Potrei parlare della trave e delle travi. Potrei parlareRead more
La zona dei commenti, in effetti, è un po’ sacrificata. E il commento del mio “vecchio, vecchissimo” amico e sodale Attilio Scarpellini merita la sua giusta attenzione. Perché un ragionamento sulle immagini dobbiamo continuare a farlo Scrive Attilio: Cara Paola, trovo che la retorica delle immagini sia in effetti pessima. Ma ho paura che laRead more
La zona dei commenti, in effetti, è un po’ sacrificata. E il commento del mio “vecchio, vecchissimo” amico e sodale Attilio Scarpellini merita la sua giusta attenzione. Perché un ragionamento sulle immagini dobbiamo continuare a farlo Scrive Attilio: Cara Paola, trovo che la retorica delle immagini sia in effetti pessima. Ma ho paura che laRead more
La zona dei commenti, in effetti, è un po’ sacrificata. E il commento del mio “vecchio, vecchissimo” amico e sodale Attilio Scarpellini merita la sua giusta attenzione. Perché un ragionamento sulle immagini dobbiamo continuare a farlo Scrive Attilio: Cara Paola, trovo che la retorica delle immagini sia in effetti pessima. Ma ho paura che laRead more
Accogliendo la richiesta di protezione sussidiaria il giudice del Tribunale di Genova oltre ai riferimenti di legge per la concessione…
Una sentenza che allunga le ordinanze a favore di cittadini nigeriani che fanno richiesta di protezione internazionale in Italia.
Sarebbe…
riceviamo e diffondiamo In Egitto il maschio controlla la famiglia patriarcale; la Chiesa e le moschee alimentano sessismi e controlli sulle donne; lo stato, polizia o esercito che sia, esercita violenze di ogni tipo sul corpo delle donne. Qualsiasi maschio … Continue reading →
La prima a parlarmi di questa grande poetessa fu una delle mie più care amiche. Ci conoscevamo da poco, avevamo appena iniziato l’università. Mi sembra di ricordare che fosse novembre, in una delle prime uscite insieme in cui io assaporavo il gusto dolcissimo della libertà e della città. Mi ricordo anche che allora non mi […]
L’articolo Passaggi: “Seconda Origine” di Joumana Haddad sembra essere il primo su Arabpress.
Di Yassin al-Hajj Saleh. Al-Hayat (09/06/2016). Traduzione e sintesi di Irene Capiferri. Dalla vicenda del rapimento di Razan Zaitouneh, Samira al-Khalil, Wael Hammadi e Nazem Hammadi, avvenuto a Douma per mano di Jaysh al-Islam due anni e mezzo fa, emerge l’incurabile stato degli attivisti siriani democratici, di formazione laica e indipendenti. I quattro sono stati oppositori […]
L’articolo Samira, Razan, Wael e Nazem: due anni e mezzo di assenza sembra essere il primo su Arabpress.
Una importantissima sentenza a tutela dei diritti di un migrante vittima di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti.
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
Crowdfunding staffetta #overthefortress: sostieni il progetto “No Border Radio” (http://ift.tt/1YbPsfA)
Interessante sentenza, con cui il Tar ripercorre e riconferma l’orientamento del Consiglio di Stato sulla illegittimità di un rifiuto della…
Crowdfounding of solidarity relay #overthefortress: sustain “No Border Radio” project (http://ift.tt/1YbPsfA)
Di Ghissam Imam. Asharq al-Awsat (07/06/2016). Traduzione e sintesi di Laura Formigari. Non si possono comprare i curdi. Ma si possono affittare le loro milizie. E con queste ci si può gettare nella guerra in Siria e Iraq. Le guerre di oggi sono guerre per procura. Chi ha governato gli Stati Uniti, da Bush Junior […]
L’articolo Gli Stati Uniti e i curdi sembra essere il primo su Arabpress.
Di Shadi Hamid. The Atlantic (06/06/2016). Traduzione e sintesi di Chiara Cartia Per capire i conflitti in Medio Oriente, bisogna tornare al 1924, anno in cui l’ultimo califfato è stato formalmente abolito. Da quel giorno, si è assistito a una lotta per ristabilire un ordine politico legittimo, il cui problema principale era la religione e il suo […]
L’articolo L’Islam è eccezionale? sembra essere il primo su Arabpress.
“Mostrare i nostri corpi è una forma di resistenza” (cit.) Corpi abusati. Corpi soprattutto sottratti alla visione. Corpi violati. Corpi nascosti. Corpi incarcerati, e dunque rinchiusi tra muri di cinta, pareti di celle. Corpi scomparsi, e cercati e pianti di nascosto da famiglie in attesa di una notizia. Di un segno. Corpi uccisi. Corpi fattiRead more
“Mostrare i nostri corpi è una forma di resistenza” (cit.) Corpi abusati. Corpi soprattutto sottratti alla visione. Corpi violati. Corpi nascosti. Corpi incarcerati, e dunque rinchiusi tra muri di cinta, pareti di celle. Corpi scomparsi, e cercati e pianti di nascosto da famiglie in attesa di una notizia. Di un segno. Corpi uccisi. Corpi fattiRead more
“Mostrare i nostri corpi è una forma di resistenza” (cit.) Corpi abusati. Corpi soprattutto sottratti alla visione. Corpi violati. Corpi nascosti. Corpi incarcerati, e dunque rinchiusi tra muri di cinta, pareti di celle. Corpi scomparsi, e cercati e pianti di nascosto da famiglie in attesa di una notizia. Di un segno. Corpi uccisi. Corpi fattiRead more
Interessante sentenza , con cui il Tar ripercorre e riconferma l’orientamento del Consiglio di Stato sulla illegittimità di un rifiuto…
Il rapporto è stato elaborato in seguito alla visita dell’ECRI in Italia nel novembre 2015 e rispecchia la situazione fino al 10 dicembre…
L’Unione europea deve sospendere immediatamente l’applicazione dell’accordo con la Turchia che prevede il ritorno dei richiedenti asilo in…
Una riflessione intima di Raffaello Rossini della staffetta #overthefortress mentre continuano le pressioni delle autorità sui migranti…
7 giugno — Decine di migliaia di persone sono fuggite dalle loro case nel sud-est del Niger a seguito di una serie di attacchi, cominciati…
Poco prima di pubblicare questa intervista, ieri in via Cupa è stata sgomberata la tendopoli dove da giorni vivevano decine di migranti…
Si ringrazia per la segnalazione ed il commento l’Avv.
Si ribgrazia per la segnalazione ed il commento l’Avv.
 “Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
“Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
 “Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
“Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
 “Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
“Una guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia” è il libro del giornalista turco nato a Istanbul e che vive in Italia da 15 anni. Scrive sul suo Paese per diversi media. “Volevo documentare i pezzi della storia, perché non sia dimenticato nulla di un periodo storicamente difficile”.
“Vede, fintanto che le frontiere esistono bisogna rispettarle e farle rispettare. Ciò non toglie che abbiamo tutti il diritto di chiederci perché esistono. Riteniamo che siano una buona soluzione ai problemi umani? Pensiamo che tracciare dei confini sia veramente l’unico modo perché gli uomini possano vivere insieme?” Interrogativi che ormai quotidianamente ci poniamo di fronte […]
L’articolo “Ulisse da Baghdad” di Eric-Emmanuel Schmitt sembra essere il primo su Arabpress.
Di Ramez Antaki. Al-Hayat (06/06/2016). Traduzione e sintesi di Silvia Lobina. “La maggior parte dei miei amici sono partiti, e ora sono tra la Turchia, l’Europa e il Canada, ma il mio desiderio di restare qui non cambia”, dice Lina, ragazza siriana che lavora a Beirut, dove si è trasferita da circa 2 anni dopo […]
L’articolo I siriani in Libano sembra essere il primo su Arabpress.
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
Ovvero non smettete di far rinascere Roma!
via Migrano http://ift.tt/1ZwvlaP
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle […]
(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché […]
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 06095/2016 del 24 maggio, ha cancellato l’obbligo di versare da 80 a 200 euro per il rilascio o il…
La detenzione sistematica dei richiedenti asilo nel Regno Unito è arrivata al capolinea.
 Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
 Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
 Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
Un mese dopo l’irruzione delle forze di sicurezza presso la sede del sindacato dei giornalisti egiziano, cosa mai accaduta dal 1941, anno della sua fondazione, il braccio di ferro tra polizia e giornalisti continua. E mentre il sindacato prova ad abbassare i toni, il governo continua a gettare benzina sul fuoco. Sono 29 i giornalisti in carcere. (Ebticar/Mada Masr)
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito […]
Opinione di Al-Quds. Al-Quds al-Arabi (04/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. Lo scorso 3 giugno, i palestinesi hanno ritrovato quel poco di speranza quando il presidente francese, François Hollande, ha invitato la comunità internazionale a riconsiderare il conflitto israelo-palestinese. Il presidente Hollande ha rilanciato la soluzione “dei due Stati” alla presenza di ministri e […]
L’articolo La questione israelo-palestinese alla recente Conferenza di Parigi sembra essere il primo su Arabpress.
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
Da quando il fenomeno dell’ISIS è esploso mediaticamente, andare in libreria è diventata una vera e propria tortura per me. Scaffali ed espositori infatti traboccano di libri sul cosiddetto gruppo Stato islamico e sul terrorismo internazionale di matrice jihadista. Il rigurgito di titoli sull’ISIS si è ovviamente accentuato in occasione degli attentati di Parigi dello … Continua a leggere La letteratura araba è una contro-narrazione →![]()
Da quando il fenomeno dell’ISIS è esploso mediaticamente, andare in libreria è diventata una vera e propria tortura per me. Scaffali ed espositori infatti traboccano di libri sul cosiddetto gruppo Stato islamico e sul terrorismo internazionale di matrice jihadista. Il rigurgito di titoli sull’ISIS si è ovviamente accentuato in occasione degli attentati di Parigi dello … Continua a leggere La letteratura araba è una contro-narrazione →![]()
Da quando il fenomeno dell’ISIS è esploso mediaticamente, andare in libreria è diventata una vera e propria tortura per me. Scaffali ed espositori infatti traboccano di libri sul cosiddetto gruppo Stato islamico e sul terrorismo internazionale di matrice jihadista. Il rigurgito di titoli sull’ISIS si è ovviamente accentuato in occasione degli attentati di Parigi dello … Continua a leggere La letteratura araba è una contro-narrazione →![]()
Questo documento è stato scritto da un gruppo di volontari indipendenti e attivisti che dopo lo sgombero di Idomeni hanno deciso di…
Riflessioni sulla libertà di movimento al rientro di un viaggio africano
via Migrano http://ift.tt/1r9HN4r
Si ringrazia l’Avv Gabriele Bidini per la segnalazione ed il commento ¶
Con la sentenza in oggetto, il TAR ha annullato il provvedimento…
Cosa c’è di diverso stasera? Nulla. Ad affollare questa strada ci sono persone che dormiranno in un letto e persone che dormiranno su un…
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
L’ultima dal “califfato” l’abbiamo sentita qualche giorno fa: distruggere le antenne satellitari che sarebbero colpevoli di portare la propaganda nemica sul territorio controllato dal cosidetto “Stato Islamico” (ISIS, Daesh). Da Raqqa e da altre “wilayat” (le province del califfato) sono arrivati video come questo, che ricordano un pò i vecchi atti luddisti, la rage against […]![]()
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
Di Julien Bouissou. Le Monde (03/06/2016. Traduzione e sintesi di Chiara Cartia. I muri eretti nella capitale afghana per proteggere alcuni edifici dagli attentati suicidi sono sempre più alti, più larghi, più imponenti. Queste cinte murarie rinchiudono Kabul nella paura e nell’isolamento e separano i ricchi dagli altri. Un artista ha avuto l’idea di dipingere dei graffiti […]
L’articolo A Kabul si parla attraverso i muri sembra essere il primo su Arabpress.
++ Oim, forse 700 su barca Creta, centinaia dispersi ++
http://ift.tt/1t9HZm4
Di Alaa al-Aswany. Lakome (26/05/2016). Traduzione e sintesi di Rachida Razzouk. Qualunque sia la vostra nazionalità o la vostra cultura, è indubbio che voi amiate vostro padre e desideriate difenderlo se si trovasse in pericolo. Cosa succederebbe se scopriste che vostro padre abusa dei diritti altrui? Approvereste la sua ingiustizia? In realtà, l’amore per tuo padre […]
L’articolo L’adulterato patriottismo egiziano sembra essere il primo su Arabpress.
Di Ali Khaled. Al-Arabiya (04/06/2016). Traduzione e sintesi di Roberta Papaleo. Quando Muhammad Ali combatteva, il mondo si fermava a guardare. Negli anni ’70, all’apice della sua gloria, milioni di spettatori di tutto il mondo ammiravano il più grande pugile di tutti i tempi. Adorato negli Stati Uniti, è nel mondo arabo che è stato venerato come […]
L’articolo Muhammad Ali e la sua importanza per il mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
Riceviamo e pubblichiamo il racconto di un’operatrice legale che denuncia gli abusi che i migranti stanno subendo a Ventimiglia.
Migranti e turisti, a Lesbo, per incontrare vite diverse
via Migrano http://ift.tt/1VDiKU9
Di Abdulrahman al-Rashed. Arab News (02/06/2016). Traduzione e sintesi di Letizia Vaglia. Arabi e iraniani sono uniti da un comune desiderio di pace, quella pace che aveva caratterizzato gli anni ’60 e ’70, e poi persa a causa di alcuni risvolti politici. Difatti, le cose sono molto cambiate a seguito della rivolta iraniana del 1979, nel […]
L’articolo Desiderio di pace sembra essere il primo su Arabpress.
27.04.2015
Di Shafeeq Nazem Ghabra. Al-Hayat (02/06/2016). Traduzione e sintesi di Marianna Barberio. Il mondo arabo contemporaneo sta attraversando uno dei periodi più difficili, specie dopo gli avvenimenti del 2011. La forza distruttiva di Daesh (ISIS), testimoniata alcuni giorni fa da un’esplosione nelle zone costiere della Siria e ad un attacco all’aeroporto militare russo in un’area considerata […]
L’articolo Il mondo arabo tra cambiamento e distruzione sembra essere il primo su Arabpress.
di Beppe Casales attore ¶
CREDETEMI ¶
Ha 38 anni e forse ne dimostra una decina in più.
Confessate, vi mancava l’Egitto? Incredibilmente è da qualche mese che non vi parlo di un autore egiziano, nonostante l’enormità della produzione di scrittori di quel paese tradotti in italiano. Ezzat El Kamhawi fa parte di questa schiera e due libri della sua vasta produzione sono reperibili nelle librerie del Bel Paese. Prima di addentrarmi nei […]
L’articolo Torniamo in Egitto, stavolta con Ezzat El Kamhawi sembra essere il primo su Arabpress.
Di Muhammad Barhouma. Al-Hayat (02/06/2016). Traduzione e sintesi di Irene Capiferri. Tra meno di dieci giorni l’opposizione siriana dovrebbe riunirsi a Riyad per discutere la propria posizione ai negoziati di Ginevra, cercare una visione politica comune e ristrutturare la propria delegazione per includere i gruppi del Cairo e di Mosca, dopo le dimissioni di Mohammed Alloush, […]
L’articolo L’opposizione siriana ha perso la sua occasione? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Ramona Wadi. Middle East Monitor (31/05/2016) Traduzione e sintesi di Chiara Cartia. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP) sta mostrando chiaramente che ci sono alternative alla proposta coloniale manipolatrice promossa dalla Francia, dalla comunità internazionale e dall’Autorità Palestinese. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, il PFLP ha fatto un appello […]
L’articolo In Palestina, contrastare la permanenza delle colonie dovrebbe essere una priorità sembra essere il primo su Arabpress.
Mentre il sindaco di Parigi annuncia l’apertura di un campo umanitario per i migranti, a Roma la istituzioni latitano.
Di Haifa Zangana. Al-Quds al-Arabi (31/05/2016). Traduzione e sintesi di Laura Formigari. Si dice che la città di Fallujah sia sotto costante assedio da due anni. Dicono anche che chi riuscirà a entrarvi la libererà dalle mani di Daesh (ISIS), dai bombardamenti, dalla distruzione, dall’esodo delle sue donne e dei suoi bambini, salvandoli dall’assedio, dalla fame e […]
L’articolo Fallujah e le città che non muoiono sembra essere il primo su Arabpress.
Migranti: Ankara, accordo Ue è pacchetto unico con i visti
http://ift.tt/25C1kgH
Social media tornano online in Uganda ma sono offline in Iraq; nuovo strumento per russi rende gli amici degli obiettivi; sorveglianza di massa in Mozambico.
Social media tornano online in Uganda ma sono offline in Iraq; nuovo strumento per russi rende gli amici degli obiettivi; sorveglianza di massa in Mozambico.
Social media tornano online in Uganda ma sono offline in Iraq; nuovo strumento per russi rende gli amici degli obiettivi; sorveglianza di massa in Mozambico.
 Che ne è della gioventù tunisina cinque anni dopo la rivoluzione? Tra ottimismo e delusioni, la rivoluzione ha favorito nuove vocazioni, soprattutto a Tunisi, ma le ambizioni devono ancora fare i conti con ostacoli politici, culturali e giuridici.(Inkyfada)
Che ne è della gioventù tunisina cinque anni dopo la rivoluzione? Tra ottimismo e delusioni, la rivoluzione ha favorito nuove vocazioni, soprattutto a Tunisi, ma le ambizioni devono ancora fare i conti con ostacoli politici, culturali e giuridici.(Inkyfada)
 Che ne è della gioventù tunisina cinque anni dopo la rivoluzione? Tra ottimismo e delusioni, la rivoluzione ha favorito nuove vocazioni, soprattutto a Tunisi, ma le ambizioni devono ancora fare i conti con ostacoli politici, culturali e giuridici.(Inkyfada)
Che ne è della gioventù tunisina cinque anni dopo la rivoluzione? Tra ottimismo e delusioni, la rivoluzione ha favorito nuove vocazioni, soprattutto a Tunisi, ma le ambizioni devono ancora fare i conti con ostacoli politici, culturali e giuridici.(Inkyfada)
 Venerdì 10 giugno 2016, ore 18.30, a Cowall in via Libetta 15/c incontro con Annamaria Rivera,autrice del libro “La città dei gatti. Antropologia animalista di Essaouira” (edizioni Dedalo, 2016).
Venerdì 10 giugno 2016, ore 18.30, a Cowall in via Libetta 15/c incontro con Annamaria Rivera,autrice del libro “La città dei gatti. Antropologia animalista di Essaouira” (edizioni Dedalo, 2016).
Riprende il gioco dell’oca per i minori eritrei alla disperata ricerca di un’accoglienza degna in Italia ¶
Ieri pomeriggio siamo venuti a…
Si ringrazia per segnalazione ed il commento l’Avv.
Riceviamo e pubblichiamo questa interessante analisi delle leggi europee fatta da Pietro Giovanni Panico, laureando in Scienze Politiche.
Stanchi di vivere in perenne emergenza, stanchi dell’indifferenza delle istituzioni, alle quali ci sostituiamo da più di un anno, stanchi…
Si ringrazia l’Avv. Federico Vido per la segnalazione ed il commento ¶
Nello specifico il cittadino del Bangladesh ha avuto il…
Di Mohamed Abu Rumman. Al-Alaraby al-Jadeed (30/05/2016). Traduzione e sintesi di Silvia Lobina. Questo periodo vede fervere i preparativi per le azioni militari internazionali in Siria e Iraq contro Daesh (ISIS), con le quali gli Stati Uniti mirano a sottrarre al suo controllo la città siriana di Raqqa ed eliminarlo definitivamente in Iraq. I report dalla […]
L’articolo Daesh: domande del giorno dopo sembra essere il primo su Arabpress.
Di Mohamed Abu Rumman. Al-Alaraby al-Jadeed (30/05/2016). Traduzione e sintesi di Silvia Lobina. Questo periodo vede fervere i preparativi per le azioni militari internazionali in Siria e Iraq contro Daesh (ISIS), con le quali gli Stati Uniti mirano a sottrarre al suo controllo la città siriana di Raqqa ed eliminarlo definitivamente in Iraq. I report dalla […]
L’articolo Daesh: domande del giorno dopo sembra essere il primo su Arabpress.
Grafias, un bel magazine online che si occupa del mondo della letteratura e delle riviste internazionali, ha pubblicato un profilo dell’editoria francofona in Libano e ha intervistato una delle fondatrici di Tamyras, casa editrice libanese dedicata alla letteratura in francese. L’articolo menziona gli editori francofoni attivi in Libano, e il ruolo del Salone del libro … Continua a leggere L’editoria francofona in Libano →![]()
Grafias, un bel magazine online che si occupa del mondo della letteratura e delle riviste internazionali, ha pubblicato un profilo dell’editoria francofona in Libano e ha intervistato una delle fondatrici di Tamyras, casa editrice libanese dedicata alla letteratura in francese. L’articolo menziona gli editori francofoni attivi in Libano, e il ruolo del Salone del libro … Continua a leggere L’editoria francofona in Libano →![]()
Grafias, un bel magazine online che si occupa del mondo della letteratura e delle riviste internazionali, ha pubblicato un profilo dell’editoria francofona in Libano e ha intervistato una delle fondatrici di Tamyras, casa editrice libanese dedicata alla letteratura in francese. L’articolo menziona gli editori francofoni attivi in Libano, e il ruolo del Salone del libro … Continua a leggere L’editoria francofona in Libano →![]()
da
http://ift.tt/1WvA9PI
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario