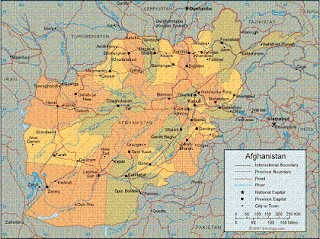|
| Asia centrale, il cuore dell’Asia |
Abstract: The countries of Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan define a human and political space strongly influenced by its bordering territories: by Russia, obviously, but also by Pakistan, Iran, and, most importantly, by Afghanistan – a country wretched by forty years of war and generally seen as a threat rather than as a resource. However, interactions between the former five soviet republics and Kabul are unavoidable: the Islamic common denominator, the porosity of borders, the presence of shared norms and practices and the existence of communities, often speaking the same language, further reinforce such belief. Furthermore, in light of future infrastructural developments of road networks, railway lines and, possibly, of energy vectors, partnerships between the five republics and Afghanistan seem the most logical solutions.
Even if each county deals with Kabul its unique way, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan all fear the contagion of war or that of the jihadi message and explain the spread of the politics of Islam within their territories through the failures of the Afghan government. A statement contested both from the inside, with the Afghan government refusing to validate the jihadi narrative, and from the outside: many observers have indeed highlighted how the ‘Afghan danger’ is better understood as a political tool used to repress possible challenges to the political establishment, rather than as an effective threat.
Nevertheless, some positive developments are on their way: negotiations regarding a seemingly difficult partnership between Kabul and the five republics is currently ongoing and further supported, in several instances, by manifestations of international cohesion fostering and financing the expansion of strengthened bilateral agreements.
Le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan formano uno spazio umano e politico fortemente influenzato dai Paesi vicini. La Russia, naturalmente, ma anche il Pakistan o l’Iran e, soprattutto, l’Afghanistan, un Paese in guerra ormai da quasi quarant’anni che è visto più come pericolo che come risorsa. Il rapporto con l’Afghanistan è però ineludibile: per il comun denominatore islamico, la porosità delle frontiere, tradizioni comuni e presenza di comunità che spesso parlano la stessa lingua. Un rapporto che ha un senso anche in ragione di un possibile futuro sviluppo di reti stradali, ferroviarie o di vettori di energia. Se ogni Paese ha nei rapporti con Kabul un atteggiamento diverso, tutte le repubbliche ex sovietiche temono il contagio della guerra o del messaggio islamista e attribuiscono all’Afghanistan la responsabilità dell’espansione dell’islam politico all’interno dei propri confini. E’ una posizione contestata sia all’interno da chi si ritene ingiustamente accusato di propaganda jihadista, sia all’esterno: molti osservatori infatti ritengono che il “pericolo afgano” venga agitato per consentire la repressione e il contenimento di qualsiasi forma di contestazione delle leadership al potere. Non di meno, alcuni progressi si vedono: è in corso un’operazione di difficile costruzione di una partnership con Kabul aiutata, in molti casi, da esperimenti di coesione internazionale che hanno dato impulso e garantito finanziamenti per l’espansione di rapporti bilaterali più saldi.
* Questo articolo è stato pubblicato su IL POLITICO (Univ. Pavia, Italy) 2016, anno LXXXI, n. 3, pp. 136-149 (le note al testo sono contenute nell’edizione cartacea)
 |
| Asia Centrale e Caucaso |
In una carta geografica dell’Asia, l’Afghanistan rappresenta una sorta di centro ideale: al confine con l’Iran a Occidente, con quello rappresentato dal subcontinente indiano a Oriente, frontiera meridionale delle repubbliche centroasiatiche ex sovietiche a Nord. Se effettivamente l’Afghanistan faccia parte dell’Asia Centrale, e cioè di quel mondo che comprende le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, è in realtà una convenzione per alcuni e non per altri. Ne fa parte in un certo senso geograficamente ma in realtà il suo centro di gravità sono i due grandi confinanti che la circondano a Est, Ovest e Sud: l’Iran e il Pakistan, la fine del Medio Oriente e l’inizio dell’Asia meridionale.. Quanto alle cinque repubbliche ex sovietiche, lo sguardo è sicuramente più centrato, seppur con forme e modalità diverse, verso Russia e Cina e Stati Uniti. Il legame col parente meridionale (sicuramente parente per motivi storici, culturali etnici e linguistici) appare oggi soprattutto o come una sorta di “dovere” (spesso suggerito da altri), o uno sguardo obbligato dalle preoccupazioni che riguardano due aspetti in particolare: la sicurezza – col corollario di un possibile contagio lungo i confini meridionali – e il narcotraffico. I legami economici sono poca caso, salvo rare eccezioni (come nel caso del progetto tapi1), il flusso transfrontaliero è limitato, le alleanze sono fragili e il sostegno alla partecipazione dell’Afghanistan a percorsi politici aggregativi (come nel caso del Processo di Istanbul)2 appare più come un aspetto di strategia politica generale – spesso su pressione di altri attori – che non un focus volto a rafforzare il parente bistrattato dalla guerra. Il quadro delle relazioni tra le cinque repubbliche e Kabul va dunque visto anche all’interno delle pressioni e delle relazioni con i grandi attori non solo regionali ma internazionali: la Russia, in primis, la Cina, soprattutto per l’aspetto economico, e gli Stati Uniti (in misura assai minore l’Unione europea). Quanto agli attori regionali, per questi Paesi contano forse più dell’Afghanistan il peso economico e la statura politica di nazioni come Iran e Pakistan.
Che la preoccupazione principale di Astana, Bishkek, Ashkabad, Tashkent, Dushanbe, sia soprattutto l’aspetto sicurezza e stabilità lo dimostra anche il fatto che nel 2014, alla vigilia delle presidenziali afgane, i riflettori delle cinque capitali si sono riaccesi – come quelli di tutti gli altri Paesi coinvolti nella guerra afgana a vario titolo – in attesa di eventi da cui ci si aspettavano grandi novità; lo dimostra anche la pubblicazione di numerose monografie e ricerche sui rapporti tra l’Afghanistan e le repubbliche (due in particolare da segnalare3), attenzione che è poi scemata pur se il quadro uscito dalle elezioni afgane è in realtà ancor più instabile del precedente e il conflitto, benché snobbato dai riflettori della cronaca, stia conoscendo una nuova accelerazione e proprio nel Nord del Paese. Che ha, nelle repubbliche frontaliere, creato un nuovo allarme specie dopo la presa di Kunduz da parte dei Talebani, anche se per pochi giorni, nell’ottobre 2015 e poi ancora nel 2016.
1 La partita regionale
Secondo diversi analisti le preoccupazioni che riguardano la sicurezza sono in realtà da leggersi, in molti casi, anche in chiave interna: più che per il timore di un contagio o per fatti reali che giustifichino una preoccupazione vera per la minaccia di un’espansione dell’islamismo armato,
i Paesi centroasiatici avrebbero cioè utilizzato e utilizzerebbero il “pericolo jihadista” anche per contenere le spinte dal basso che possono mettere in difficoltà (come già avvenuto in passato) il sistema di potere locale. Lo stesso per il narcotraffico, attività economica sotto traccia che consente il transito di oppio e oppiacei prodotti in Afghanistan. Riprendendo i due temi (sicurezza e narcotraffico) Bleuer e Kazemi scrivono che: «Il rischio in termini di sicurezza che lega l’Afghanistan alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale viene di frequente altamente esagerato e così il presunto collegamento tra narcotraffico e gruppi radicali islamisti. In realtà in tutta l’Asia Centrale i principali attori del narcotraffico sono impiegati governativi, agenti della sicurezza e personaggi legati alla mafia… ». E ancora, scrivono, non esiste « …una grave minaccia alle Repubbliche centroasitiche da parte di terroristi e insorti del Nord dell’Afghanistan che vengono normalmente reclutati tra gli afgani per agire localmente4». I Talebani afgani del resto, contrariamente ad Al Qaeda o allo Stato islamico, la cui presenza in quest’area è al momento residuale, hanno sempre sottolineato la natura nazionalistica della loro battaglia per l’instaurazione di un Emirato in Afghanistan e solo in Afghanistan. Chiarendo, al primo punto della loro agenda politica, che l’obiettivo primario è la cacciata degli stranieri dal territorio afgano5, non certo l’espansione oltreconfine del loro jihad.
Non di meno, è evidente che per i Paesi dell’Asia centrale l’Afghanistan resta un elemento importante e preoccupante in un quadro regionale complesso e da secoli al centro di interessi geostrategici, economici e politici che hanno ripreso fiato dopo la fine del dominio sovietico e un ridimensionamento della presenza russa, come provano soprattutto la politica espansiva di Cina e Stati Uniti6. L’Afghanistan resta infine particolarmente preoccupante per tre delle cinque repubbliche che ne condividono il confine, come ha provato nel 2015 la mobilitazione sia centroasiatica sia russa lungo l’Amu Darya (per via degli accordi sulla difesa delle frontiere), specie per Uzbekistan e Tagikistan a un pugno di chilometri dalla città di Kundz, presa allora per qualche giorno dalle milizie in turbante e nuovamente sotto tiro dall’ottobre del 20167.
L’Afghanistan è dunque comunque importante nel rapporto con i grandi attori dell’area centroasiatica (e più o meno direttamente legati alle vicende della guerra afgana) e il Paese, se non lo è oggi, resta d’altronde uno snodo fondamentale per il transito delle merci (anche se ora l’interscambio con le repubbliche è minimo) e soprattutto delle pipeline. Vista dalle cinque capitali dunque, Kabul è forse attualmente più motivo di cruccio che risorsa pur se lo è diventata sia per l’utilizzo in chiave interna dello spauracchio jihadista, sia perché la relazione con l’Afghanistan passa anche per il rapporto con altri attori (dalla Turchia al Pakistan, da Mosca a Washington, da Teheran a Pechino) o organismi internazionali (onu, nato alleanze regionali). Quel che va rilevato è che non essendoci in realtà una politica comune dei cinque Paesi centroasiatici, ogni nazione agisce per suo conto e percepisce, osserva e agisce in maniera diversa e a volta addirittura opposta.
Vedremo qui le grandi linee su cui si muovono i singoli Paesi e infine dedicheremo uno spazio all’attuale situazione afgana, per ora assolutamente lontana da una stabilizzazione efficace e soprattutto da una indicazione che si stia modificando lo scenario dominato dal conflitto anziché da quel negoziato politico con la guerriglia, al netto dei tentativi per ora senza successo, e da cui le repubbliche centroasiatiche sono per ora quasi totalmente escluse.
2 Tagikistan, il vicino prossimo
 |
| Il paesaggio: montagne, pianure, acque |
Il Tagikistan, teoricamente il parente più prossimo tra le cinque repubbliche – per affinità storiche, linguistiche e culturali oltre a un confine comune di oltre 1.300 chilometri – ha con l’Afghanistan scarsi rapporti economici (benché in ascesa) e un diffuso pregiudizio8 sia nei confronti dei rifugiati afgani nel Paese (circa 2.550 nel 2014) sia nei confronti di una nazione che si ritiene un pericolo costante alla frontiera, per problemi legati alla guerra, a infiltrazioni e alleanze jihadiste o al narcotraffico9. Collegate dal grande ponte sull’Amu Darya che unisce la provincia afgana di Kunduz a quella tagica di Kathion e da altri sei piccoli ponti che portano dal Tagikistan nella provincia orientale afgana del Badakshan, Dushanbe e Kabul restano lontane anche se esiste un rapporto a volte di una certa intensità sul piano culturale per iniziativa della società civile dei due Paesi.
Nonostante un interscambio commerciale ridotto, per Dushanbe l’Afghanistan rappresenta comunque un buon investimento nel settore energetico, soprattutto a partire dal 2012 quando è iniziata l’esportazione verso l’Afghanistan di energia elettrica. Kabul aveva anzi aderito al progetto noto come casa-1000, che inizialmente avrebbe dovuto portare da Tagikistan e Kirghizistan elettricità in Pakistan e Afghanistan per un totale di 1300 megawatt (1000 in Pakistan e 300 in Afghanistan). Kabul si è poi ritirata dal progetto, lanciato ufficialmente nel 2016, a un mese dalla cerimonia di avvio10 e il Pakistan usufruirà dell’intera fornitura presumibilmente entro il 2018. Ma il futuro potrebbe riservare sorprese.
Il Tagikistan, retto dal 1992 da Emomali Rahmon (che dal 1992 al 1997 ha affrontato una gravissima crisi senza risolvere i problemi alla base della guerra civile11) considera il turbolento vicino un elemento in più di destabilizzazione per un Paese, il suo, che si regge su un fragile equilibrio. Non di meno, nel giugno del 2009, il presidente tagico aveva proposto un incontro nella sua capitale tra afgani, pachistani e russi per costruire una cooperazione quadrilaterale (Dushanbe Four). Di fatto, al netto di diversi incontri, l’iniziativa non ha prodotto grandi risultati se non quello di apparire come un tassello del piano di riavvicinamento di Mosca a Kabul.
3 Uzbekistan, il vicino in allarme
L’Uzbekistan e l’Afghanistan – collegate dal tristemente famoso “Ponte dell’Amicizia” riaperto nel 2001 – hanno visto nell’ultima decade la firma di numerosi accordi per dare impulso a un interscambio economico che, sino al 2001, era praticamente inesistente. Ma gli accordi non sembrano per ora vedere un trend particolarmente significativo anche se l’interscambio è aumentato e Tashkent vende a Kabul elettricità diretta soprattutto nel Nord del Paese. Non di meno, la strategia uzbeca, più che quella di favorire il vicino – in realtà osservato con grande preoccupazione – mira a utilizzare l’Afghanistan semmai come area di passaggio in un piano di ristrutturazione delle forniture energetiche che ha come obiettivo altri Paesi. Può essere indicata come una scelta comunque significativa quella della ferrovia Hairatan-Mazar-e-Sharif, un progetto di 75 chilometri di strada ferrata, in gran parte finanziato dall’Asia Development Bank12, che collega l’importante centro afgano alla frontiera uzbeca e quindi a Termez. Inaugurata nel gennaio del 2012, la ferrovia avrebbe, secondo l’adb, trasportato in 5 anni 11,7 milioni di tonnellate di beni per un valore di oltre 115 milioni di dollari, favorendo la connessione coi mercati dell’Asia Centrale e della Cina13. Il progetto rappresenta la prima fase di un network ferroviario che include Herat e collegamenti con Tagikistan e Pakistan14.
Sul piano politico va segnalata nel 2008, durante l’incontro nel quadro dell’Euro-Atlantic Partnership Council della Nato tenutosi in Romania, la proposta dell’allora presidente Islam Karimov (morto nel settembre 2016) di istituire un ‘6+3’ Contact Group for Afghanistan sotto egida ONU che avrebbe incluso Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan accanto a NATO, Russia e Stati Uniti (escludendo sia il governo di Kabul sia la resistenza armata), con l’obiettivo di studiare l’approccio a una risoluzione del conflitto. Proposta poi rilanciata in sede ONU nel dicembre 2013 ma senza seguito.
L’Uzbekistan, assai più di altri partner regionali (con l’eccezione del Turkmenistan), si è mosso negli anni con iniziative anche autonome – spesso di segno opposto – sia col governo o con gruppi anti- talebani (noto il suo appoggio al generale Dostum, attuale vicepresidente afgano) ma anche con la guerriglia diretta allora da mullah Omar: l’obiettivo era soprattutto quello di far terra bruciata attorno al Movimentato islamico dell’Uzbekistan (mui), al punto che il governo uzbeco era arrivato a proporre ai Talebani, agli inizi del 2001, persino un riconoscimento dell’Emirato in cambio dell’espulsione dei militanti del mui15 dall’Afghanistan. Nel contempo il governo uzbeco si è distinto per una militarizzazione dei suoi confini (non solo afgani ama anche tagichi e kirghisi) considerando l’Afghanistan e i suoi movimenti islamisti una minaccia per la sicurezza del Paese, preoccupazione reiterata formalmente in più occasioni e sostenuta da una preparazione militare e di intelligence (con formazione tecnica fornita dagli Stati Uniti) che non teme confronti con le altre repubbliche.
Sul piano interno il governo uzbeco, più volte denunciato per la brutalità del trattamento riservato agli oppositori16, utilizza il “rischio afgano”, assai più che in altre repubbliche, come elemento in chiave interna volto alla repressione non solo di gruppi islamisti (aderenti al mui o all’Unione della Jihad islamica17 o supposti tali) ma in generale di oppositori al regime.
4 Turkmenistan, il vicino attivo
Durante l’epoca del governo talebano, il governo del Turkmenistan, pur non avendo ufficialmente riconosciuto il regime, aveva mantenuto rapporti stabili e, in un certo senso, cordiali con l’Emirato di mullah Omar: una scelta volta a preservare il Paese da ritorsioni o infiltrazioni talebane e confermata dalla neutralità al momento dell’invasione delle truppe straniere che nel 2001 combatterono il regime della guerriglia in turbante. Un altro buon motivo era quello di conservare buone relazioni col Pakistan (che aveva riconosciuto il regime), cliente per le forniture energetiche. Le cose sono cambiate alla morte di Niyazov nel 2006 con l’arrivo dell’attuale presidente Gurbanguly Berdimuhammedow che ha aperto agli Stati Uniti e ha autorizzato il sorvolo del Paese da parte dell’aviazione militare americana, cui ha fornito negli anni sostegno logistico e rifornimenti di carburante. Al di là delle dichiarazioni di disponibilità a sostenere ogni possibile strategia di uscita dalla crisi afgana e una discreta attività in campo diplomatico, l’iniziativa forse più rilevante del Turkmenistan è l’ospitalità offerta all’UN Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia ad Ashkabad18. Non di meno, pur non ritenendo l’Afghanistan un rischio così temibile come altre repubbliche, il Turkmenistan ha rafforzato il suo sistema di sicurezza lungo la frontiera (744 chilometri) negli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, il progetto più interessante e che prevede un investimento stimato a circa 7 miliardi di dollari è il già citato tapi19 Coinvolge Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e Unione indiana e prevede l’esportazione di oltre 33 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso circa 1800 chilometri di tubi dal Turkmenistan, via Afghanistan, al Pakistan e all’India (i lavori sono iniziati nel 2015 e dovrebbero concludersi nel 2019). L’Afghanistan dovrebbe goderne per 5 miliardi di metri cubi (lungo l’asse stradale Herat-Kandahar-Quetta) e 14 rispettivamente andrebbero a Pakistan e India. Da segnalare infine il progetto tat (Turkmenistan-Afghanistan-Tagikistan) che dovrebbe sviluppare oltre 600 chilometri di ferrovia (di cui 400 in territorio afgano) che collegherebbero Atamurat in Turkmenistan a Panji in Tagikistan passando per il Nord dell’Afghanistan e collegandosi alla linea che già porta in Uzbekistan. Il costo stimato varia tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. Il 28 novembre 2016 il presidente afgano Ghani e il suo omologo turcmeno Berdimuhamedow hanno inaugurato la tratta da Imam Nazar (Turkmenistan) ad Aqina (Afghanistan), passo in avanti sul progetto tat.
5 Kirghizistan, il vicino preoccupato
Con l’avvio del progetto casa-1000, da cui come abbiamo visto Kabul si è al momento ritirata, il Kirghizistan avrebbe assunto un ruolo rilevante nei confronti dell’Afghanistan e l’accordo avrebbe segnato una svolta in relazioni economiche il cui volume d’affari resta minimo (se si esclude quello illecito legato la narcotraffico e al contrabbando). La presenza di afgani nel Paese non ha grandi numeri limitandosi a qualche centinaia di persone, che comprendono, oltre ai rifugiati, migranti economici o studenti, molti dei quali sostenuti da borse di studio. La relazione forte con le vicende afgane si deve in realtà alla presenza della base militare americana di Manas (2001-2014) attualmente un Centro di transito dopo che è tornata nelle mani di Bishkek. La base, che serviva alle forze aeree americane come spazio logistico, è stata chiusa anche grazie alle forti pressioni in questo senso di Mosca e Pechino20. Il Kirghizistan ha comunque sempre considerato l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza definendolo addirittura il maggior pericolo esterno per il Paese, una formula reiterata nel National Security Concept. E una formula che tende a far apparire maggiore più di quanto non sia il rischio di contagio dall’Afghanistan anziché da alcune aree della Federazione russa21. Al netto delle speculazioni sull’utilizzo del “rischio Afghanistan” in chiave interna, va però menzionata un’idea lanciata per la prima volta nel 1998 per la preparazione di una Conferenza di pace internazionale sull’Afghanistan che però non ha mai fatto strada, nonostante nel 2009 il presidente Kurmanbek Bakiyev avesse riproposto l’iniziativa (chiamata appunto “Bishkek Initiative”) che intendeva costruire un centro di studi e ricerca sulla sicurezza e la stabilità in Asia centrale (anche quella senza seguito22). Il Kirghizistan aveva anche lanciato l’idea di una ristrutturazione del suo debito in cambio di forme di assistenza allo sviluppo in Afghanistan.
6 Kazakistan, il vicino lontano
Pur essendo geograficamente il Paese più lontano tra le cinque repubbliche, il Kazakistan si è comunque distinto per il sostegno all’integrazione regionale e internazionale dell’Afghanistan in più occasioni e in più organismi multilaterali. Ha investito in aiuto allo sviluppo, avviato sforzi per migliorare le relazioni commerciali, offerto sostegno per la formazione locale e nominato un rappresentante speciale per Afghanistan e Pakistan sull’onda di quanto fatto dai maggiori protagonisti stranieri nella guerra afgana. Nel 2012 ha anche lanciato un’iniziativa per la creazione di un Centro con sede in Kazakistan per facilitare una migliore cooperazione tra i Paesi dell’Asia centrale e volta a sostenere l’Afghanistan. Benché gli scettici giudichino questa politica più mirata a rafforzare all’estero l’immagine del Paese che non a immaginare un investimento strategico vero e proprio in Afghanistan, nel 2010 i kazachi hanno dichiarato in sede osce (di cui avevano la presidenza) che l’Afghanistan sarebbe stato una delle priorità della politica estera di Astana.
Il governo kazaco, a differenza di altri, non considera comunque l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza nazionale.
7 Il quadro afgano

Le elezioni presidenziali del 2014 che, come abbiamo visto hanno attirato nuovamente l’attenzione sul Paese anche se i riflettori della cronaca si sono poi andati lentamente spegnendo, si sono concluse con un accordo a tavolino che ha prodotto una bizzarra alchimia istituzionale, non prevista dalla Costituzione ma frutto di un disegno pragmatico volto a salvare almeno le apparenze di una tornata elettorale gravata da brogli e reciproche accuse tra i due principali candidati. Ashraf Ghani è diventato presidente della Repubblica e ad Abdullah Abdullah, un uomo legato alla vecchia Alleanza del Nord composta in gran parte da afgani tagichi23, è stato riservato un ruolo a metà tra il co-presidente e il primo ministro (chief executive). Il parto non è stato privo di difficoltà e il risultato sembra solo averle aumentate: questa sorta di diarchia ha di fatto paralizzato il governo per mesi sia nella nomina dei ministri, sia nell’attribuzione delle cariche secondarie, sia nella scelta dei governatori. Qualsiasi decisione, dalla più grande alla più piccola, è stata oggetto di dibattiti infiniti mal digeriti sia dal parlamento sia dal corpo elettorale che, nei sondaggi, ha visto un enorme calo di consenso verso quel governo di unità nazionale in cui tante speranze erano state riposte.
Questo preoccupante quadro politico è purtroppo sempre accompagnato da una cornice non meno angosciante: unama, la missione onu a Kabul, nel rendere noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015 ha riferito di 11.002 casi24, con un incremento del 4% rispetto al 2014 e un trend impressionante di crescita25. Anche le perdite dell’esercito afgano sono state pesanti e, tra gennaio e agosto 2016, sarebbero stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti (9.665 i feriti). Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi.
Il quadro economico resta segnato da una crisi iniziata col ritiro della maggior parte dei contingenti militari americani e Nato ed è marcato da un indebolimento della valuta, da una caduta degli investimenti e dalla fine della bolla speculativa nel settore edilizio creatasi nelle principali città26. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine dell’Onu infine, il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero mentre la produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 nel 201627.
Il vero malato è però il processo negoziale che dovrebbe por fine alla guerra. I due principali attori regionali – i governi di Kabul e Islamabad – continuano ormai dal 2015 a litigare accusandosi reciprocamente in una sorta di gara a dimostrare che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese vicino. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione con toni anche violenti: Pakistan e Afghanistan si creano inoltre vicendevolmente problemi alla frontiera per il transito delle merci e l’intelligence dei due Paesi, anziché collaborare, nasconde o mistifica le informazioni. In questo quadro, il Pakistan ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. Le espulsioni (che nel novembre 2016 avevano già raggiuntano quota 400mila) hanno messo in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani che vivono in Europa che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi. Quanto al processo negoziale, che nell’estate del 2015 era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni nel movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte ha visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader. In realtà, ma il condizionale resta d’obbligo, il processo negoziale, o quantomeno le trattative più o meno segrete, continuano sotto traccia. Mentre il governo di Kabul ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyar, fonti di stampa hanno rivelato28 che sarebbero avvenuti due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l’Ufficio politico del movimento guidato da Akhundzada. I talebani hanno smentito ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Vi avrebbe partecipato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan, ma non i pachistani il che ha fatto riemergere nuove tensioni anche se in seguito i Talebani hanno inviato una missione “informativa” nel Paese dei puri.
Conclusioni
Lungi dall’essere stato risolto, il nodo della guerra rimane il peggior nemico di un processo di integrazione sia a livello regionale in Asia Centrale sia a livello multilaterale, si tratti del Processo di Istanbul29 o di qualsivoglia iniziativa volta a migliorare la cooperazione in questo o quel campo. Al momento il Paese dell’Hindukush non può che restare una preoccupazione, più o meno agitata sia che si tratti di rischi reali sia che si tratti di propaganda a uso interno. La guerra, col suo portato di instabilità e insicurezza, non richiama investimenti, blocca il flusso delle merci ed esporta al massimo colonne di rifugiati (anche se i grandi Paesi di immigrazione restano i due confinanti Pakistan e Iran). Coinvolte spesso indirettamente nella guerra afgana (o per motivi economico-militari, come nel caso della base di Manas, o per la porosità delle frontiere o per singole iniziative negoziali come nel caso turcmeno o uzbeco), le cinque repubbliche si mantengono a debita distanza in attesa che il caso si risolva e che l’Afghanistan possa tornare ad essere un Paese di transito, cosa che lo renderebbe appetibile soprattutto per il passaggio delle pipeline, ipotesi al momento molto rischiosa. Naturalmente le relazioni esistono e si vanno lentamente rafforzando, a volte anche per spinte o suggerimenti di Paesi terzi, ma l’Afghanistan rimane un luogo da cui è bene mantenere una distanza di sicurezza. L’interesse delle repubbliche è dunque rivolto verso altri Paesi, non esclusi i grandi confinati dell’Afghanistan, Iran e Pakistan.
Risolto il nodo della guerra, una nuova stagione potrebbe cambiare percezione e visuale e andare incontro a un’attenzione che comunque, e forse più che nel recente passato, Kabul ha dimostrato verso le cinque sorelle del Nord cui comunque le unisce una Storia antica e un desiderio comune di indipendenza che per l’Afghanistan, e in parte anche per le repubbliche, resta una chimera in attesa che finisca l’eterno Great Game30 il vero comun denominatore che collega tutti e sei i Paesi.
Read more →






 La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.
La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.




 Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska
Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska