Niente più Darwin per i bambini turchi, e potrebbe essere solo l’inizio.
Anno: 2017
La posizione dell’Algeria nella crisi del Golfo
L’Algeria di Bouteflika alterna vicinanza e allontanamento dal Golfo rispettando la sua tradizionale neutralità negli affari interni dei Paesi arabi
L’articolo La posizione dell’Algeria nella crisi del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
La sera andavamo alla Martesana: l’idea e l’incipit di Viaggio all’Eden
 Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:
Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:
Mi è piaciuto l’articolo di Emanuele Giordana sul numero di giovedi 2 agosto. Ma sulla Martesana definita “fiumiciattolo maleodorante” non sono assolutamente d’accordo. Verde rigoglioso, canne, acqua abbastanza limpida con pesci e ricca vegetazione sommersa, gracidar di rane, gallinelle d’acqua, germani reali… questa è la Martesana, un pezzetto di natura quasi selvatica nei tristi quartieri Nord di Milano. Claudio Longo, 8/8/07 (lettera inviata al manifesto )
Poi, nell’estate 2013, decisi che quell’articolo poteva partorire una piccola serie rievocativa e proposi al giornale dieci puntate. Anche questa volta ci furono un mucchio di reazioni miste. Alcune davvero confortanti. Perché allora non farne un libro? Ripresi alcuni dei pezzi scritti per il Mani e gli feci acquistare dignità di capitolo ma faticavo a trovare un editore. Poi Laterza si è convinto, grazie anche al sostegno di Giovanni Carletti, la persona che poi ha seguito impianto, nuovo indice e nuova stesura. Se siete arrivati fin qui ecco allora il prologo del libro. Sperando ovviamente che poi corriate in libreria…Ce n’è giusto una all’angolo.
L’indice lo trovate qui
Sì, anche Allen Ginsberg, allora molto gettonato, era stato in India ma alla fine ci passavamo di mano soprattutto un altro classico dell’epoca, pura operazione furbescamente commerciale ma non priva di seduzione: quel raccontone letterariamente scadente ma altrettanto avvincente di Charles Duchaussois, junkiefrancese che aveva fatto il giro del mondo con un ago infilato nel braccio. Il suo Flash. Katmandu il grande viaggiodescriveva l’Old Gulhane di Istanbul e raccontava di sordidi buchi del bazar di Bombay per fumatori d’oppio, di santoni, contrabbandieri, guru e ashramdove poter allargare la coscienza a colpi di mantra e di “manali”, l’hascisc nero e profumato delle valli del Nord dell’India. Insomma la partenza si preparava così: amuchina e antibiotici per i più paranoici, pile e lamette da barba per i previdenti, Sulla stradadi Kerouac o Siddhartadi Hesse per i più raffinati, Autobiografia di uno yogidi Paramhansa Yogananda per gli spiritualisti. Inseguiti dagli anatemi di quelli che «no compagni, non si può andar via e mollare la lotta di classe», ci rodeva – sotto la pergola della Bocciofila Martesana – il tarlo della strada e non ci scalfiva quel refrain di Giorgio Gaber che cantava di una generazione che scappava «in India e in Turchia»fingendo di essere sana. Eravamo malati, come no. Bruciati dalla passione per quel treno che partiva dalla Stazione Centrale e proveniva da Parigi diretto a Istanbul, dove immigrati turchi accaldati di ritorno a casa esibivano i gilet e le coppole d’ordinanza mentre si attraversava la Iugoslavia di Tito fino alla Porta d’Oro aperta sull’Oriente.
 |
| La copertina di “Viaggio all’Eden”, la prima mitica guida al volo magico (altro titolo dell’epoca) |
Traversata la prima frontiera, i ritrovi all’occidentale cui eravamo abituati (dal piccolissimo bar Erika di zona Loreto al mitico Jamaica, già troppo caro all’epoca per le nostre tasche) finivano di colpo. C’era qualche locale a Belgrado dove potevi bere acquavite e un ultimo espresso ma già trionfava il caffè serbo, che in Grecia è caffè greco e in Turchia caffè finalmente turco. E quando ormai avevi passato anche l’ultimo confine alcolico bagnato di Retzina e Demestika ghiacciati, restava la birra turca ma si affacciava anche un primo stupore per quello splendido tè servito in bicchieri stretti stretti con la pancia sporgente e l’orlo striato da una collanina d’oro, trascinati su un vassoio rotondo di metallo martellato ai tavolini all’aperto di Sultan Ahmet. Sempre affannati a cercare il posto più economico – per mangiare e dormire, attività primigenie ed essenziali del genere umano – si finiva nei grandi stanzoni degli ostelli della Sublime Porta che, ai meno abbienti, offrivano i tetti, più per risparmiare qualche lira turca che per sfuggire all’afa distesa sul Bosforo. La mattina al Pudding Shop, luogo deputato allo scambio di informazioni sul prossimo pullman, era un’occasione per ingollare yogurt e pasticceria ottomana grassa e zuccherina, ammantata di miele e pinoli e di cui avevi già avuto qualche sentore nei Balcani. Ora il Pudding è un ritrovo alla moda con le foto degli Anni Settanta alle pareti, locale senz’anima affacciato sulla fluorescente rivisitazione modernista del grande parco di Sultan Ahmet e dei suoi gioielli architettonici.
 |
| Le foto in questa pagina sono di Guido Corradi |
Neo-registi all’opera per l’International Film School Festival di Tetouan
I giovani registi del mondo sono chiamati a partecipare all’International Film School Festival di Tetouan (Marocco) che quest’anno si terrà dal 20 al 24 Novembre 2017. Il Festival Internazionale di Scuole di Cinema (FIDEC) ha come obiettivo principale la promozione di opere di studenti e giovani creativi provenienti da scuole di cinema, università e istituti […]
L’articolo Neo-registi all’opera per l’International Film School Festival di Tetouan sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina turca: ayran, bevanda salata allo yogurt
Con la ricetta di oggi andiamo in Turchia, alla scoperta di un drink fresco e salato. Con il caldo estivo, abbiamo bisogno di rifornirci dei minerali persi e questa bevanda è un delizioso modo per ristorarci! Ecco come preparare l’ayran! Ingredienti: 500g di yogurt intero bianco 120ml di acqua fredda sale a piacere ghiaccio in […]
L’articolo Cucina turca: ayran, bevanda salata allo yogurt sembra essere il primo su Arabpress.
Viaggio all’Eden a Qui Comincia
Stamattina a Qui Comincia (Radio3) è toccato a Viaggio all’Eden finire nelle mani di Attilio Scarpellini. La puntata era dunque dedicata al libro che racconta del mio vecchio viaggio dall’Italia a Kathmandu. Sono davvero contento di questo risveglio
Qui la pagina dei podcast per riascoltare le trasmissioni del programma
Qui Comincia si avvale della regia e della consulenza musicale di Federico Vizzaccaro. Attilio Scarpellini (nella foto) è il suo conduttore storico
La scadenza del periodo di grazia pone i lavoratori etiopi in Arabia Saudita tra due fuochi
“È agghiacciante che la maggior parte degli etiopi non abbia dimostrato alcun interesse a rientrare nel proprio paese nonostante l’alto rischio di violenza”.
Viaggio all’Eden: un libro a chilometro molti zeri
 Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.
Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.Consiglio di lettura: “Gli odori di Marie Claire” di Habib Selmi
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di lettura: “Gli odori di Marie Claire” di Habib Selmi sembra essere il primo su Arabpress.
Marocco: la saggezza o il piombo?
Il Marocco come anello di congiunzione tra mondo arabo e Europa
L’articolo Marocco: la saggezza o il piombo? sembra essere il primo su Arabpress.
The Palestine Expo: il più grande evento europeo sulla Palestina
(Baraka Bits). Si inaugura domani a Londra l’evento Palestine Expo, definito il più grande evento sociale e culturale sulla Palestina realizzato in Europa. Segnando i 100 anni dalla Dichiarazione Balfour, dopo 50 anni di occupazione palestinese e a 10 anni dall’inizio dell’assedio di Gaza, la Palestine Expo esprime in maniera simbolica le potenzialità della Palestina. L’evento […]
L’articolo The Palestine Expo: il più grande evento europeo sulla Palestina sembra essere il primo su Arabpress.
A Napoli la tappa conclusiva di “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare”
È stata inaugurata a Napoli, al Castel dell’Ovo il 28 giugno alle ore 17, la tappa conclusiva della rassegna “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” edizione 2017, realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli. Nella cornice del Castel dell’Ovo, fino al 17 luglio alla Sala delle Terrazze, saranno in […]
L’articolo A Napoli la tappa conclusiva di “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” sembra essere il primo su Arabpress.
Una guerra molto speciale
Forze speciali. E’ questa la parola chiave che d’ora in poi si dovrà tenere a mente pensando
all’Afghanistan: una nuova fase della guerra affidata appunto a soldati “speciali”, coadiuvati da raid aerei per operazioni mirate. Gli operativi delle forze speciali – afgane, americane, britanniche o italiane – sono già attivi in Afghanistan e presto saranno in buona compagnia. Stando a quanto ha appena dichiarato il segretario generale della Nato a Bruxelles, promettendo l’impegno di “migliaia” di nuovi soldati dell’Alleanza con gli “stivali sul terreno”, il nuovo mantra sarà forze speciali per operazioni speciali. Di che tipo?
Una luce recente l’ha gettata il britannico Sunday Times che per ora smentite non ne ha ricevute. Secondo il giornale domenicale un’unità dello Special Air Service (Servizio Aereo Speciale), noto anche come Sas – il principale corpo speciale dell’esercito britannico – avrebbe ucciso afgani civili – innocenti e disarmati – nascondendo poi i dettagli dell’operazione per evitare una possibile accusa di crimini contro l’umanità. Sotto la lente di ingrandimento della Polizia militare britannica, che sta indagando oltre una cinquantina di casi, ci sarebbe in particolare un episodio del 2011 nel quale, durante un raid notturno, le forze speciali avrebbero ammanettato e incappucciato i membri di una famiglia dell’Helmand ritenuta talebana prima di sparare. Sparare per uccidere. L’indiscrezione, confermata poi da altri giornali del Regno unito, riferisce di un capitolo nelle carte dell’Operation Northmoor: creata nel 2014, ha il compito di redarre un rapporto classificato preparato dagli investigatori della Royal Military Police che inizialmente avrebbe iniziato a indagare su episodi controversi accaduti tra il 2010 e il 2013 anche se pare che l’indagine avrà comunque un seguito sino al 2021, pur se la maggior parte del lavoro dovrebbe essere completo entro l’estate. Grave tanto quanto la strage sarebbe proprio il fatto che le Sas avrebbero poi nascosto o artefatto lo scenario del killeraggio per farlo apparire in carico ai colleghi afgani. Un esempio perfetto di collaborazione interforze. I raid notturni furono tra l’altro tra i grandi contenziosi tra le forze occupanti e l’amministrazione Karzai.
Nella Gran Bretagna di Theresa May, che ha già promesso l’invio di nuove truppe sul terreno con la Nato, Jeremy Corbyn ha detto di tenere in “seria considerazione” la notizia augurandosi che si faccia piena luce in un caso sul quale chiede anche una commissione indipendente. Dobbiamo temere che la cosa si possa ripetere. Qualche giorno fa, a fine giugno, il segretario generale della Nato Stoltenberg – in occasione di un summit dell’Alleanza – ha confermato che Bruxelles manderà sul terreno “migliaia” di nuovi soldati. Numeri non ne ha fatti ma in compenso ha spiegato che “La Nato ha concluso le operazioni combat” ma che i suoi soldati “continueranno ad aiutare i colleghi afgani”. Come? “Rafforzando le forze speciali afgane”.
 |
| Incursori del Col Moschin. Sopra, i badge di riconocimento Usa e GB |
A metà luglio il Pentagono dirà quanto soldati manderà in Afghanistan (da 3 a 5mila). Un numero “esiguo” se paragonato ai 130mila (60mila erano Nato di cui 4mila italiani) che persero la guerra prima di ritirarsi nel 2014. E’ dunque probabile se non certo che la nuova sarà una strategia molto mirata: raid aerei – di cui è stato un assaggio anche l’ormai famosa “Madre di tutte le bombe” – e operazioni speciali con forze speciali non solo afgane. Inoltre, la nuova strategia prevede carta bianca al Pentagono e maggior autonomia dalla catena di comando nazionale afgana. Per quella data anche il governo italiano dovrà dire se e quanti uomini vuole mandare. Lo chiederà come dovrebbe al parlamento? Chiederà al Paese se siamo disposti ad “aiutare” i colleghi afgani e americani? O conterà sulla pausa estiva? E le forze speciali? Quelle italiane già ci sono da tempo e vanno per conto loro. Sono così speciali che vengono temute anche dai colleghi “ordinari”. Che, quando passano gli speciali, si devono fare da parte senza fare domande.
I giovani yemeniti e la “grande prigione”
“La grande prigione”: è così che molti giovani yemeniti descrivono il loro Paese dopo che si è spezzato il loro sogno di scappare alla ricerca di stabilità. Spostarsi diventa sempre più difficile e pericoloso e persino il percorso per ottenere l’asilo politico è pieno di ostacoli
L’articolo I giovani yemeniti e la “grande prigione” sembra essere il primo su Arabpress.
Meno uno
VIAGGIO ALL’EDENTra oggi e domani in libreriaLaterza edizioniDettagli a seguire…..
Perché non ci indignamo per lo sfruttamento dei bambini iraniani?
“Sogno ogni notte che i miei genitori, i miei fratelli e le mie sorelle mi stanno cercando. Mi sveglio piangendo ogni mattina”.
Non c’è accanimento ove non c’è terapia: Charlie Gard
mcc43 Chi ha per primo lanciato il “basta con l’accanimento terapeutico” forse non sapeva che perché esista un troppo, deve prima esserci qualcosa. Per la malattia di Charlie Gard: sindrome da deplezione del DNA mitocondriale encefalomiopatica (MDDS) non c’erano e non ci sono terapie che i medici del Great Ormond Street Hospital for Children abbiano […]![]()
Arsal: l’abitudine della vista al labirinto della brutalità
La diffusione delle immagini delle atrocità nel campo profughi di Arsal in Libano rappresenta la prassi dell’ideologia e del sistema di repressione attuato nel Levante con cui si intende intimidire e umiliare chiunque manifesti il dissenso
L’articolo Arsal: l’abitudine della vista al labirinto della brutalità sembra essere il primo su Arabpress.
Il Qatar e la membership del Consiglio di Cooperazione del Golfo
Mentre gli esiti della crisi diplomatica tra i Paesi del CCG e il Qatar rimangono incerti, quel che sembra lampante è la necessità di modificare lo Statuto stesso del Consiglio
L’articolo Il Qatar e la membership del Consiglio di Cooperazione del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Meno due
VIAGGIO ALL’
Dopo di cinque anni, la famiglia del blogger saudita Raif Badawi torna a chiederne il rilascio
10 anni di carcere e 1.000 frustate per aver scritto un blog.
“La rivoluzione e la furia”: il primo film sulla rivoluzione del 30 giugno
Il lungometraggio che racconta la rivoluzione del 30 giugno è diretto da Mohamad al-Sami, scritto da Wahid Hamid e vanta la presenza di Ahmed Al-Saqqa nel ruolo del presidente Al-Sisi
L’articolo “La rivoluzione e la furia”: il primo film sulla rivoluzione del 30 giugno sembra essere il primo su Arabpress.
Iraq: l’ultimo terrorista
L’apparente sconfitta di Daesh in Iraq non elimina i presupposti per il suo ritorno
L’articolo Iraq: l’ultimo terrorista sembra essere il primo su Arabpress.
Meno tre
VIAGGIO
Da Gerusalemme a Gaza verso una “soluzione regionale”
Riconoscere la Striscia di Gaza come Stato ed entità palestinese: è questa una parte della soluzione di pace ideata dal premier Netanyahu che non trova però alcuna corrispondenza nella legislazione internazionale
L’articolo Da Gerusalemme a Gaza verso una “soluzione regionale” sembra essere il primo su Arabpress.
T-shirt e scarpe dell’altro mondo
Non sempre la filiera tra i grandi marchi della moda e i Paesi poveri è così diretta. Un maglietta made in Bangladesh può essere tessuta con cotone uzbeco. E il cuoio di una scarpa prodotta in Cambogia può arrivare da Dacca. Viaggio nella catena nascosta di un’industria che nasconde bene anche il dolore
| Il “palazzo rosa” simbolo del potere del Nawab di Dacca Oggi è un museo. Poco più a Nord i quartieri produttivi di Kamrangirchar e Hazaribagh. Sversano nel Buriganga |
Dal cuore di Old Dakha, la capitale del Bangladesh, bisogna prendere dei piccoli battellini per attraversare il Buriganga e raggiungere l’altra sponda. Su questo largo fiume dalle acque nere come la pece si viene traghettati su piroghe sottili e dall’equilibrio apparentemente instabile. C’è un gran traffico di umanità, animali, utensili che, per qualche centesimo, si spostano dalla riva dove troneggia il palazzo rosa di Ahsan Manzil, una volta sede del “nababbo” (nawab), a un quartiere anonimo dall’altra parte del fiume che scorre verso il Golfo del Bengala. Pieno di negozi di tessuti naturalmente, una delle grandi ricchezze del Bangladesh che ogni anno porta al Paese 30 miliardi di dollari in valuta. Le fabbriche però, grandi o piccole, sono lontane dal centro città: stanno a Savar, dove si è consumato il dramma del Rana Plaza, o adAshulia, distretti suburbani industriali. Ma in pieno centro c’è invece il cuore della produzione di un altro grande bene primario del Bangladesh che se ne va tutto in esportazione: il cuoio. Decine di fabbriche dove si fa la concia delle pelli: la prima lavorazione e quella più tossica che trasforma la materia prima nel prodotto base che può poi diventare scarpa o borsetta. A un pugno di isolati dal Palazzo rosa, nel distretto di Kamrangirchar e in quello gemello di Hazaribagh, divisi dal Buriganga, si lavora in condizioni bestiali anche con l’aiuto di ragazzi di 8 anni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 90% di chi lavora in queste fabbriche di veleni che si sciolgono nel fiume non supera i cinquant’anni. Pavlo Kolovos, il responsabile di tre cliniche di Medici Senza Frontiere a Kamrangirchar, spiega che «la metà dei pazienti che viene negli ambulatori di Msf lo fa per problemi legati al lavoro: malattie della pelle, intossicazioni, insufficienze respiratorie…». Dice Deborah Lucchetti della campagna “Abiti Puliti”: «Le nostre inchieste mostrano come l’esposizione al cromo, quando viene trattato in maniera non adeguata e si trasforma in cromo esavalente, può portare anche al tumore. Senza contare che gli scarti delle lavorazioni vanno a finire in falde e terreni espandendo il danno anche oltre la fabbrica».
Il paradosso è che la materia prima – cotone o cuoio – non sempre viene dal Bangladesh che pure è un grande produttore di uno dei migliori cotoni del mondo. E non sempre i semilavorati finiscono, come avveniva una volta, nei Paesi dove hanno sede le grandi firme americane o europee che sono le vere regine del mercato dell’abbigliamento, dalla gonna allo stiletto, dalla t-shirt al mocassino. Uno dei grandi produttori mondiali di cotone ad esempio è l’Uzbekistan. E’ una produzione antica come il mondo che un tempo rese famosa la Valle di Fergana. E il cotone uzbeco va a finire in Bangladesh che non ne produce abbastanza per alimentare un’industria che vale il 90% dell’export nazionale. Quanto al cuoio, la pelle conciata, prima di andare a finire come scarpa nelle boutique di via Montenapoleone o di Bond Street, fa strade molto diverse. Magari arriva in Serbia oppure, ancora in Asia, in Indonesia, Cina, Cambogia. Due recenti inchieste ci aiutano a gettare una luce, anche se assai sinistra, su questa retrovia dei nostri abiti e delle nostre scarpe. Cominciamo dall’Uzbekistan.
Cotone uzbeco
Un rapporto di Human Rights Watch mette sotto accusa svariati milioni di dollari concessi dalla Banca Mondiale all’Uzbekistan proprio nel campo del cotone. Si chiama aiutare lo sviluppo. Ma se si va a far visita al campo di cotone vero e proprio si scoprono cose molto spiacevoli: nel dossier “We Can’t Refuse to Pick Cotton” Hrw sostiene che il cotone viene raccolto anche da minori e, in gran parte, da gente che non avrebbe nessuna voglia di raccoglierlo (per 5 euro al giorno). Hrw non è l’unica organizzazione ad aver messo sotto la lente la filiera del cotone uzbeco e soprattutto i suoi finanziamenti. Come quello per l’irrigazione – oltre 300 milioni di dollari – nei distretti di Turtkul, Beruni, Ellikkala nel Karakalpakstan dove il cotone conta per il 50% delle terre arate, in un Paese che è il quinto produttore mondiale ed esporta in Cina, Bangladesh, Turchia, Iran. In quelle zone, dice il rapporto, lavoro forzato e minorile continuano. E la Banca Mondiale lo sa perché un gruppo misto – Uzbek-German Forum for Human Rights – glielo ha già fatto sapere da un paio d’anni. Ma anziché sospendere i finanziamenti, BM li ha allargati. Per la verità anche la Banca sta attenta alle condizioni di lavoro e anzi il lavoro minorile è un mantra assoluto nella scala dei diritti da rispettare. Ma i burocrati di Washington non hanno sempre il tempo e la voglia di guardare oltre le carte e così hanno chiesto all’Ufficio internazionale del lavoro di fare accertamenti. L’Ilo l’ha fatto e ha stilato un rapporto dove si citano “progressi”. Ma gli attivisti di Hrw fanno notare che, per stessa ammissione dell’Ilo, non solo un terzo dei raccoglitori è stato obbligato a lavorare (quasi un milione di lavoratori su tre) ma le autorità avevano messo in guardia gli intervistati. Lo stesso rapporto ammette che «…molti intervistati sembravano essere stati preparati alle domande”.
Secondo Hrw la Banca Mondiale e Ifc (International Finance Corporation, un’agenzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) dovrebbero immediatamente sospendere ogni finanziamento fino a che il governo non riesca a dimostrare che non esiste più lavoro minorile e lavoro forzato.
Scarpe e tessuti in Cambogia
Passiamo alla Cambogi. Qualche giorno fa il britannico The Observer ha pubblicato un’inchiesta condotta con la Ong Danwatch sugli incidenti nelle fabbriche cambogiane di alcune delle più note marche sportive: Nike, Puma, Asics e VF Corporation. Solo nell’ultimo anno più di 500 dipendenti di quattro diverse fabbriche che lavorano per le firme occidentali sono state ricoverate in ospedale. Svenimenti di massa. Il problema è il caldo, la mancanza di ventilazione e di regole sui limiti sopportabili in giornate di lavoro anche di dieci ore. I prodotti chimici usati per la produzione fanno il resto. Insomma si lavora così. Lontano dai negozi a quattro luci che esibiscono scarpette e tailleur. Nell’ombra asfissiante del grande supermercato asiatico.
Reggiombrelli
Questa foto è stata scattata alla Fonderia Abruzzo, la due giorni all’Abbazia di Sulmona organizzata dal governatore Luciano D’Alfonso “per dare una programmazione alle idee per lo sviluppo dell’Abruzzo”, dice il quotidiano Il Centro. Tavola rotonda finale. Tutti uomini. Tavolo monogenere. Nessuno avrebbe notato l’assenza di una donna, competente come ne esistono tante. I tavoli monogenere, tuttiContinua a leggere
La divisione della Siria con la politica dello status quo
Ciò che sta avvenendo in Siria e intorno ad essa in questi giorni ci porta a riconsiderare i piani di divisione nell’ambito della corsa sfrenata tra le parti coinvolte
L’articolo La divisione della Siria con la politica dello status quo sembra essere il primo su Arabpress.
L’ascesa del Movimento di protesta Hirak in Marocco
Sei anni dopo la Primavera Araba, gli abitanti della regione del Rif, in Marocco, guidano le proteste manifestando il malcontento popolare.
Attivisti di Beirut organizzano la Giornata del Patrimonio per proteggere i siti storici a rischio
Nella capitale libanese, la deregolamentazione dei piani di privatizzazione e uno sviluppo edilizio incontrollabile hanno distrutto molti siti culturali. Gli attivisti vogliono fermare questa tendenza,
Jerusalem Without God is out!
I am glad to share with you the news that my book on Jerusalem is available in the North American bookstores. A first-hand account on the city’s political, social, human, urban situation, Jerusalem Without God highlights the political need by the international community to face the facts on the ground and change the paradigm.Continua a leggere
Cucina iraniana: bastani, gelato allo zafferano, acqua di rose e pistacchi
L’estate è ormai scoppiata e con questo caldo cosa c’è di meglio di un bel gelato? Ecco una ricetta che viene dalla Persia, dove nel 400 a.C. alcuni ingegneri inventarono una bibita rinfrescante – la sharbat – che è diventata la base di quello che oggi conosciamo come ‘gelato’. Oggi, vi proponiamo una delle ricette più […]
L’articolo Cucina iraniana: bastani, gelato allo zafferano, acqua di rose e pistacchi sembra essere il primo su Arabpress.
Più truppe in Afghanistan: la Nato risponde signorsi
Non è una novità quanto sta emergendo dal summit Nato a Bruxelles. Già sapevamo che gli Stati Uniti (che – ha detto il capo della Difesa Usa – vogliono “finire il lavoro“) stanno decidendo l’invio di 3-5mila soldati in Afghanistan. E già sapevamo che la richiesta è stata fatta anche agli alleati, in via diretta o indiretta attraverso appunto la Nato. Sappiamo anche che l’Italia avrebbe in animo di mandare 100 soldati per aumentare il secondo contingente straniero numericamente più importante. Ma oggi veniamo a conoscenza del fatto che gli americani non si accontenteranno di “centinaia” di soldatini a far da sostegno ai loro ma ne vogliono “migliaia“. Quante migliaia? Sembra di capire che la richiesta sia per un numero più o meno equivalente alle scelte americane e dunque, probabilmente, attorno ai 4mila uomini. Attualmente la Nato ha 13mila soldati da 29 nazioni (gli italiani sono 1000). Forse si arriverebbe a 17mila. Gli americano di soldati ne hanno 8500 e dunque salirebbero a circa 13mila. In totale potremmo dunque avere entro la fine dell’anno un corpo di spedizione di circa 30mila soldati. Non sono i 130mila di alcuni anni fa ma è pur sempre un bell’impegno che si profila per altro del tutto inutile. Se la Nato non ha vinto la guerra con 130mila militari come spera di farlo con un quarto di quei soldati? Anche perché, vero o falso, la Nato dice che le truppe inviate non saranno “combat”. Che ci vanno dunque a fare?
A metà luglio il Pentagono ci dirà qual è la nuova strategia e come intende vincere la battaglia persa in oltre 16 anni di guerra. A quanto sappiamo sarà una strategia aerea: più aerei e più bombe oltre a un’accordo che dia agli Usa mano libera senza dover sempre chiedere il permesso a Kabul (ammesso che ora lo faccia ma sulla carta è così). Quanto a noi, parteciperemo a questa nuova campagna. In che modo? Forse segnalando gli obiettivi, facendo cioè da sostegno a operazioni dall’aria e senza correre il rischio di riportare a casa i soldati con i piedi in avanti. Non combatteremo ma… Sono davvero pessime notizie anche perché, in Italia, il parlamento non sembra avere voce in capitolo. Tutto è già stato deciso. Altrove. E’ uno stato di vassallaggio che non ci fa onore anche perché, prima di andare in guerra (giusto o sbagliato che lo si ritenga), bisogna sapere a far cosa.
Siamo d’accordo ad appoggiare una strategia di guerra dall’aria? A colpire dal cielo guerriglieri e supposti tali? A sparare nel mucchio con tutti gli effetti collaterali stravisti? La politica dica una parola. Fughi il sospetto che stiamo aderendo all’ennesima missione suicida solo perché siamo vassalli o, peggio, per ottenere qualche poltrona a Bruxelles. Si interroghi la politica e chieda spiegazioni. Il silenzio, ancora prima di partecipare a questo nuovo surge, è già complicità.
“A Oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi” a cura di Emanuele Giordana
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “A Oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi” a cura di Emanuele Giordana sembra essere il primo su Arabpress.
Palestina, “regno degli ulivi e della cenere”
“The Kingdom of Olives and Ash” è una testimonianza collettiva occidentale dei 50 anni di discriminazione e occupazione militare
L’articolo Palestina, “regno degli ulivi e della cenere” sembra essere il primo su Arabpress.
La donna saudita che ha scatenato una bufera mettendosi al volante
Sfidare il divieto di guidare in Arabia Saudita non è un compito semplice.
Israele: checkpoint 1967
mcc43 La Guerra dei Sei Giorni del 1967 determinò uno stacco nella percezione che gli Israeliani avevano di sé, dello stato, della tradizione religiosa. L’argomento era stato affrontato qui attraverso le parole dello scrittore Benjamin Tammuz. Ora aggiungiamo un estratto dall’articolo Una strada senza uscita sulle “conseguenze che ancora oggi influenzano in maniera determinante tutta la società […]![]()
Libertà per tutti i giovani marocchini!
I numerosi arresti che hanno fatto seguito alle manifestazioni nella città del Rif Al Hoceima riportano l’attenzione sulla questione della detenzione dei giovani marocchini in prigione, simbolo della disaffezione delle autorità per la gioventù e il suo futuro nel Paese.
L’articolo Libertà per tutti i giovani marocchini! sembra essere il primo su Arabpress.
Sempre più vicini a una guerra in Medio Oriente
La situazione in Siria e nella regione del Golfo minaccia di trasformarsi in un conflitto di portata globale.
L’articolo Sempre più vicini a una guerra in Medio Oriente sembra essere il primo su Arabpress.
The U.S. calls, Italy responds with another 100 troops in Afghanistan
Commentary. The war in Afghanistan is so political that ministers and prime ministers will stay away from it, yielding policy power to the military. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. (il manifesto/global published June 21, 2017)
written by Giuliano Battiston, Emanuele Giordana
 |
| Original source here |
In Afghanistan, politics has abdicated. The military decides everything.
This applies to the United States, where President Donald Trump has delegated to the Secretary of Defense James Mattis the decision on the number of soldiers to be sent to the Central Asian country. It’s also true for Italy, where the Parliament has become an office that certifies decisions already made: paper, stamp, protocol. In an article published by La Repubblica on Saturday, we learned that “the leadership of the armed forces has prepared a plan for boosting the Afghan contingent by another 100 soldiers, who will join the 950 already deployed at the Herat base.”The decision will then be “evaluated by [Defense] Minister [Roberta] Pinotti and Prime Minister Paolo Gentiloni. If approved, Gentiloni will have to communicate it to the Chambers. The involvement of parliamentary committees is not ruled out…”
The pyramid is inverted. The political leadership is not the one — as a result of a collective consultation — to indicate what to do to the armed forces; the armed forces mark the route. There’s more and more inertia. The increase in the number of Italian soldiers deployed in Afghanistan reflects the traditional Atlantic subordination: If the U.S. calls, Italy responds at attention, if anything, claiming a place in the sun (“Italy aspires to occupy some key seats” at NATO).
And it goes back to the balance between institutional powers, with foreign policy subjugated to “defense” and the Parliament as a place of policy and conflict resolution.
But the war in Afghanistan is, first and foremost, a political war. Actually, so political that ministers and prime ministers will stay away from it. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. Their solution, then, is simple: Discuss it as little as possible, while giving carte blanche — and responsibility — to the military. Get used to saying yes.
The Italian “yes” follows that of other countries such as the U.K. and Denmark, which have already promised their support to NATO for the American surge that, so far, has been discovered through leaks to the press. Trump gave Mattis the authority to decide how and how many U.S. troops will go to swell the ranks of the 8,400 star-spangled soldiers are already operating in Afghanistan. According to Mattis, details will be clarified in mid-July.
In the meantime, the debate rages. Analysts wonder what the new American surge will accomplish in a country where the military mission has been fruitless. But the leading theoretician of the surge, retired General David Petraeus, has not only given his support to sending new soldiers but made clear in an interview some of the details of Mattis’s plan. For the surge in Iraq and Afghanistan, not only is the number of 3,000 or 5,000 soldiers “sustainable,” but the United States “should relax the remaining restrictions on the use of our air power to support our Afghan partners.”
In other words, not just more troops, but more bombs — and without restrictions that, at least in theory, require the Air Force to advise and agree with Kabul on its raid plans. However, the Afghan authorities have already experienced a surge in a way: For the last two years, the number of civilian casualties from the sky has increased.
The Pentagon may finally get a free hand without having to await permission from Kabul or orders from the president for actions that normally require the approval of the White House.
If the U.S. military is no longer mandated to present its plans in Kabul, the military would become a superpower. It already gave a sign of its intentions in April with the deployment of the so-called “Mother of All Bombs,” which dropped 11 tons of explosives in the border area with Pakistan.
Il Califfo e l’Asia a Radio Radicale
Una presentazione di A Oriente del Califfo su Radio Radicale nel programma di Francesco De Leo.Un libro di Lettera22Al minuto ’32
Qatar: la lista di “richieste impossibili” per risolvere la crisi diplomatica
Per porre fine all’assedio nei confronti del Qatar, gli ostili Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto hanno redatto una serie di richieste che il piccolo Regno dovrebbe soddisfare
L’articolo Qatar: la lista di “richieste impossibili” per risolvere la crisi diplomatica sembra essere il primo su Arabpress.
Sul ruolo della Turchia in Qatar
Nella crisi del Golfo, il presidente Erdogan fa da mediatore per il Qatar preservando così il suo ruolo nella regione
L’articolo Sul ruolo della Turchia in Qatar sembra essere il primo su Arabpress.
Intervista a C. Bertolotti (Ag. DIRE). Bertolotti: “Afghanistan, oppio e armi. Ricetta dell’Is e dei talebani/VIDEO
ROMA – C. BERTOLOTTI: “Da un lato abbiamo i Talebani, dall’altro lo Stato Islamico
(Is) nella sua variante sul continente indiano, in particolar modo in
Afghanistan e Pakistan, che sta dimostrando una forza e una capacità
organizzativa sem…
Intervista a C. Bertolotti. Afghanistan, i talebani vogliono negoziare: "inutile escluderli"
(Agenzia DIRE); Camera dei Deputati, ROMA – C. Bertolotti: "L’Afghanistan non e’ in grado di camminare con le proprie gambe,
si trova quindi in una fase di grande pericolo per il futuro dei suoi
abitanti e delle sue istituzioni. E i Talebani si stanno dimostrando
favorevoli a sedersi al tavolo negoziale con Kabul, per avere la loro
parte nella gestione del Paese. Lo ha spiegato
Novità editoriale: Sahara, deserto di mafie e jihad
Si terrà martedì 27 giugno, a Roma, Centro studi americani, la prima presentazione del nuovo libo “Sahara, deserto di mafie e jihad”, edito da Castelvecchi, uscito il 26 maggio scorso. Il libro tratta di intrecci tra le mafie nostrane e i gruppi jihadisti e i trafficanti di droga e di esseri umani della regione dalla […]
L’articolo Novità editoriale: Sahara, deserto di mafie e jihad sembra essere il primo su Arabpress.
Riaccendete le luci di Gaza
Incoraggiando Israele a tagliare la corrente a Gaza, le Autorità Palestinesi sfruttano senza vergogna i diritti fondamentali dei Palestinesi come merce di scambio nel conflitto con Hamas
L’articolo Riaccendete le luci di Gaza sembra essere il primo su Arabpress.
Speciale Ramadan: tamriyeh nablusiyeh
Per la nostra ultima ricetta di questo mese di Ramadan, ecco la ricetta di un dolce delizioso della tradizione culinaria palestinese, originario della città di Nablus: tamriyeh nablusiyeh, pane dolce ripieno di semolino! Ingredienti: Per la pasta 300g di farina 175ml di acqua un pizzico di sale olio per friggere Per il ripieno 250g di […]
L’articolo Speciale Ramadan: tamriyeh nablusiyeh sembra essere il primo su Arabpress.
L’ascesa di Mohammad bin Salman e le conseguenze per il regno saudita
Secondo la professoressa Madawi al-Rasheed, sono quattro le principali conseguenze della nomina di Mohammad bin Salman come erede alla corona saudita
L’articolo L’ascesa di Mohammad bin Salman e le conseguenze per il regno saudita sembra essere il primo su Arabpress.
Lacrime sul golfo del Bengala – Passioni del 24 e 25 giugno
 Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di
Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di
Giulia Nucci, un viaggio nel lavoro esternalizzato. E nel dolore
alle 14.30 sulle frequenze di Radio3
Diretta
Podcast
Dacca non è solo la capitale del Bangladesh ma anche la capitale della globalizzazione del lavoro, dalle nostre scarpe alle magliette. Finisce così anche per essere una capitale del dolore in un Paese che cresce a ritmi vertiginosi ma dove i profitti vanno a vantaggio di un’élite molto ristretta. Dalle macerie del Rana Plaza alle concerie del cuoio in pieno centro città, viaggio nella nazione affacciata sul Golfo del Bengala. Che sembra lontanissima ed è invece presente nella quotidianità diffusa del “Made in Bangladesh”.
Il viaggio che mi ha permesso di scrivere il capitolo sul Bangladesh di “A Oriente del Califfo”
Passaggi: “Diario di un clandestino” di Rachid Nini
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Passaggi: “Diario di un clandestino” di Rachid Nini sembra essere il primo su Arabpress.
L’affare di Tiran e Sanafir e la crisi globale egiziana
L’accordo ha messo in luce la debolezza del regime egiziano, la sua inabilità ad instaurare un dialogo ed accettare voci opposte alla convenzione
L’articolo L’affare di Tiran e Sanafir e la crisi globale egiziana sembra essere il primo su Arabpress.
La scelta di Sudabeh
E’ la traduzione del romanzo Bamdad-e khomar che in Iran è giunto alla 56^edizione vendendo milioni di copie e suscitando un acceso dibattito non solo tra i lettori iraniani ma pure tra gli studiosi di letteratura persiana. Romanzo popolare ambientato nella Tehran del 1900 esplora i temi delle differenze sociali e della condizione delle donne offrendo … Continua la lettura di La scelta di Sudabeh →
La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica
Disillusione e speranza di una generazione che ha scosso il mondo arabo, a partire dai movimenti di protesta del 2011 che hanno riportato al centro delle riflessioni il rapporto tra politica e società e la centralità del cittadino
L’articolo La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica sembra essere il primo su Arabpress.
La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica
Disillusione e speranza di una generazione che ha scosso il mondo arabo, a partire dai movimenti di protesta del 2011 che hanno riportato al centro delle riflessioni il rapporto tra politica e società e la centralità del cittadino.
L’articolo La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – È questa la vita che ci tocca?!
Una compagna scrive: “Questa è la vita che ci tocca da ora in poi? Carceri, notizie di arresti di amici e colleghi, condanne a morte ogni settimana, sparizioni forzate e torture? Anche quando cerchiamo di allontanarci, anche quando cerchiamo di … Continue reading →
Buon viaggio Americo
 |
| Una rarissima immagine (presa dal sito dell’Agenzia Italia) dello schvio Sbardella |
Due giorni fa se n’è andato Americo Sbardella. Un amico ma anche una pietra miliare della mia e di altre generazioni. L’ho conosciuto diversi anni fa a Prati, un quartiere della capitale – quando sono stato a casa di Americo, sua moglie Isabella e la figlia Angelica – per la festa dell’ultimo dell’anno. Non sapevo che Americo, un signore di poche parole e dalla conversazione assolutamente non invasiva, era stato il fondatore e l’ideatore del FilmStudio, un’esperienza che, con Annabella Miscuglio, aveva segnato profondamente la vita culturale della capitale e non solo. Quando andavamo a Roma, negli anni Settanta, il Filmstudio era una sorta di riferimento fisso. Potevi anche non andarci al cinema, ma c’era. Anche se non sapevi il nome di chi aveva inventato quell’incredibile aeroporto culturale con voli da tutto il mondo.
Per dirla con Massimiliano Studer (la sua intervista ad Americo si può sentire qui) “Su posizioni vicine al situazionismo francese e giovane cinefilo “assatanato”, Americo Sbardella nel 1966/67 sostenne la necessità di collegarsi in maniera non episodica con le cooperative di produzione e di distribuzione di cinema sperimentale e di quello politico-militante, in Italia ma soprattutto all’estero … con gli autori indipendenti europei e americani… con la prospettiva di creare e gestire uno spazio- cinema del tutto autonomo, un filmclub. Si trattava di creare una nuova forma associativa, un’associazione privata con tessera per i frequentatori, non aderente alle federazioni nazionali dei cine-club riconosciute dallo Stato, con proprie salette di proiezione, attrezzate con il 35mm, il 16mm, il super8 e il videoproiettore. Questo tipo di struttura prescindeva dal visto di censura ufficiale…”. Già, la censura ufficiale in grado di mandare al rogo le pellicole.
 Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.
Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.
Poiché un tipo come Americo detestava l’agiografia mi fermo qui. Anche perché non so nulla di cinema (anche se la mia famiglia ha prodotto un grande regista e una studiosa della materia che ne sanno ovviamente più di me) e sarei davvero di scarso aiuto per chi si avvicina allo Sbardella uomo di cinema. Lo voglio invece ricordare come uomo di mondo e non solo per esser stato quel gentiluomo che è stato (lavorammo tra l’altro assieme per presentare l’ultima grande rassegna che nel 2003 passò al Filmstudio), ma anche per essere stato quel bandito necessario che l’epoca richiedeva. Bandito? Si, un bandito disposto a bypassare, oltre alla censura, le maglie troppo strette del business legato a suoni e immagini. Una volta, e probabilmente non fu l’unica, proiettò il concerto di un importante gruppo musicale inglese che era stato piratescamente riprodotto da un amico a Londra. Lo rese disponibile a tutti nello spirito che allora ci accomunava negli anni Settanta. Che un po’ forse si è perso. Ma che Americo non deve aver credo mai perduto. Buon viaggio Americo. E un abbraccio a Isabella e Angelica.
REPORT DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 7 OTTOBRE. LUNEDI’ 3 LUGLIO MANIFESTAZIONE A ROMA PER LA LIBERTA’ E LA DEMOCRAZIA IN EGITTO.
Report della riunione del comitato promotore della manifestazione del 7 ottobre “Pace e libertà per il popolo siriano”. Si è svolta a Roma sabato 10 giugno la riunione del comitato promotore della manifestazione del 7 ottobre in solidarietà con il popolo siriano. Abbiamo discusso gli sviluppi della situazione in Siria e nell’area mediorientale: mentre continuano […]![]()
Diario persiano.Viaggio sentimentale in Iran
Il britannico che “vuole uccidere tutti i musulmani”
L’ondata crescente di islamofobia in Gran Bretagna mostra come l’estremismo di qualsiasi fattura colpisca chiunque, avallando la retorica del terrorismo e della sua matrice ideologica estremista
L’articolo Il britannico che “vuole uccidere tutti i musulmani” sembra essere il primo su Arabpress.
Raqqa: lo specchio della “rivoluzione” in Siria
A pochi giorni dalla sua ormai certa caduta, ripercorriamo la storia della capitale del sedicente Stato Islamico, storia molto simile a quella di molte altre città siriane
L’articolo Raqqa: lo specchio della “rivoluzione” in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Armiamoci e partiamo: anche i nostri stivali nel deserto afgano
 Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto
Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto
Il “si” italiano seguirebbe quello di altri Paesi che, come Regno Unito e Danimarca, hanno già promesso alla Nato il loro appoggio al surge americano, anche quello per ora affidato solo a indiscrezioni di stampa. Stando al capo del pentagono James Mattis. i dettagli della nuova missione saranno chiariti definitamente a metà luglio. Il dibattito intanto infuria. E mentre sui giornali ci si chiede a cosa serve il nuovo “surge” americano in un Paese dove la missione militare non sta ottenendo risultati, il massimo teorico del “surge”, il generale in pensione David Petraeus, non solo ha dato il suo appoggio all’invio di nuovi soldati ma ha chiarito, in un’intervista, alcuni dei dettagli che probabilmente Mattis si prepara e mettere nero su bianco: non solo, dice l’ex teorico del surge in Irak e Afghanistan, 3 o 5mila soldati sono un numero “sostenibile”, ma gli Stati Uniti devono “sciogliere le restrizioni” ancora in piedi nell’uso della forza aerea. Se non si dovesse render più conto nemmeno a Kabul di quel che si fa, quello militare diventerebbe uno strapotere che ha già comunque dato un segno nell’aprile scorso col lancio della famosa Moab da 11 tonnellate di esplosivo. Operazioni di cui, ancora una volta, stiamo diventando non solo silenti spettatori ma solerti conniventi.
A seguire per il manifesto un’analisi a 4 mani con G. Battiston
La presunta morte di Abu Bakr al-Baghdadi
Chi si aggiudicherà la vittoria della cattura di al-Baghdadi? Una riflessione di Ilias Harfoush.
L’articolo La presunta morte di Abu Bakr al-Baghdadi sembra essere il primo su Arabpress.
Dopo Oslo: il nuovo paradigma
di Mark A. LeVine e Paola Caridi (Questo articolo è stato pubblicato su minima&moralia) Ci sono luoghi ammantati di mito, a Gerusalemme. Anche quando a risuonare, nella memoria, non sono solo i suoni della sua lunga, plurimillenaria Storia, ma le parole del suo travagliato percorso contemporaneo. C’è anche una stanza d’albergo, tra questi luoghi, cheContinua a leggere
Dondero l’Africano
Da domani sino al 5 luglioLeggi qui la presentazione di Peppino Buondonno su il manifesto
Il movimento del Rif marocchino: riforme insignificanti e Benkiran a prova d’urto
L’esperienza marocchina e i fantasmi della Primavera Araba
L’articolo Il movimento del Rif marocchino: riforme insignificanti e Benkiran a prova d’urto sembra essere il primo su Arabpress.
Le conseguenze della crisi del Golfo
Le conseguenze della crisi del Golfo sono molto gravi e queste non si limitano solo ai Paesi della regione
L’articolo Le conseguenze della crisi del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Giovane palestinese documenta su Snapchat i pericoli dell’occupazione israeliana
“In tutta onestà, compatisco [le forze israeliane] più che disprezzarle”.
I siti specchio aiutano gli utenti turchi a riconnettersi a Wikipedia
Mentre la piattaforma resta bloccata, sono nati molteplici mirror, ovvero siti “specchio” progettati per riprodurre il contenuto di Wikipedia e che vengono costantemente aggiornati.
La missione di un uomo palestinese per rendere l’agricoltura urbana più sostenibile
Said Salim Abu Naser è un grande fautore dell’agricoltura sostenibile che vive e lavora a Gaza, Palestina, lungo la costa del Mediterraneo.
Obrovac, una città fantasma tra i parchi naturali di Croazia
 La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.
La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.
Perché le cause del terrorismo vanno ben oltre la religione
Sebbene l’opinione pubblica sembri vedere nell’Islam radicale la causa del terrorismo, la psicologia che porta alla violenza trova il proprio fondamento ben più in là della religione. Spetta a tutti noi soffocare il fanatismo, non solo ai musulmani
L’articolo Perché le cause del terrorismo vanno ben oltre la religione sembra essere il primo su Arabpress.
L’iraniano Alireza Pakdel vince il World Press Cartoon
Si è concluso a Caldas da Rainha, a nord di Lisbona, il World Press Cartoon, un importante concorso internazionale che premia il lavoro dei vignettisti di tutto il mondo. A vincere è stato l’iraniano Alireza Pakdel con la vignetta “Immigrants”, che ha vinto anche il primo premio nella sezione editoriale del festival stesso. La crisi migratoria globale è stata […]
L’articolo L’iraniano Alireza Pakdel vince il World Press Cartoon sembra essere il primo su Arabpress.
“Oltre le mura di Baghdad” di Marika Guerrini
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Oltre le mura di Baghdad” di Marika Guerrini sembra essere il primo su Arabpress.
I Paesi arabi e i limiti di frontiera
Ogni Paese arabo ha oltrepassato i suoi confini per intervenire negli altri e le loro terre sono diventate un campo di battaglia per varie nazioni
L’articolo I Paesi arabi e i limiti di frontiera sembra essere il primo su Arabpress.
Quanti euro vale un cittadino italiano?
(Questo mio articolo è stato pubblicato su Affari Internazionali, la newsletter dello IAI) Un cittadino italiano viene sequestrato, torturato, ucciso sul territorio italiano. La macchina investigativa e giudiziaria si mette in moto. Vengono individuati, attraverso indizi e anche prove, alcuni dei responsabili e viene definita la linea di comando che ha deciso il delitto. NonContinua a leggere
Rime dal Mediterraneo
“Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere subito già così sicuri. Non vogliamo essere subito già così senza sogni.” Le… Continue Reading →![]()
I poeti iracheni rivendicano le strade
Un’organizzazione culturale di poeti si propone di rivendicare il palcoscenico della poesia nazionale al fine di promuovere ideali e valori di progresso in evidente contrasto con il settarismo in Iraq
L’articolo I poeti iracheni rivendicano le strade sembra essere il primo su Arabpress.
La luce verde del guerrafondaio riluttante ai generali
 |
| Tre generali: Mattis, attuale capo del Pentagono. Sotto a sn Nicholson. A dx McMaster |
Alla fine la luce verde del presidente è arrivata. E benché si tratti ancora una volta di indiscrezioni giornalistiche, anche se ben verificate, Donald Trump, l’uomo che aveva promesso il disimpegno dai fronti di guerra, ha dato l’autorità al titolare della Difesa James Mattis di decidere come e quanti soldati americani andranno a ingrossare le fila degli 8.400 militari stellestrisce che operano in Afghanistan.
In un’audizione al Senate Armed Services Committee, Mattis – un generale dei marine, già a capo dell’US Central Command, responsabile del teatro afgano e mediorientale – numeri non ne ha fatti. Ma a detto che a metà luglio renderà conto della nuova strategia per battere la guerriglia talebana. Un “nemico barbaro”, come Mattis l’ha definito in altra occasione, in perfetta sintonia con le recenti aperture del governo di Kabul a quelli che Karzai chiamò persino “fratelli”. Mattis però, così come il consigliere per la sicurezza di Trump generale McMaster, alla via pacifica crede poco. E in questo è davvero in sintonia con John Nicholson, il capo delle forze Usa e Nato sul terreno (altri 5mila uomini tra cui mille italiani): è lui il principale fautore di “più stivali” in teatro, come si dice in gergo.
 La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).
La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).
Per ora gli americani hanno circa 7mila uomini nel contingente multinazionale Nato di cui hanno il comando e che ha come mandato quello di fare formazione militare e non di combattere. Ma ora le regole potrebbero cambiare: i nuovi arrivi si unirebbero probabilmente ai circa 2mila soldati Usa impegnati in operazioni “combat” e sarebbe il Pentagono, non la presidenza, a decidere regole di ingaggio e strategia locale. Che per adesso, da un paio d’anni a questa parte, si è concentrata sui bombardamenti dal cielo, l’attività dei droni e il test della GBU-Moab, la cosiddetta “Madre di tutte le bombe” che solo il Papa ha per ora avuto il coraggio di criticare. Quanto all’Italia, nemmeno una parola. Né dal governo, né dall’opposizione. La guerra in Afghanistan, nonostante le Moab, il surge e mille soldati, è dietro le spalle anche per noi.
I limiti della responsabilità per le sofferenze del popolo libico
Di Mohammed Badr Eddine Zayd. Al-Hayat (11/06/2017). Traduzione e sintesi di Gemma Baccini. È stata rapida la reazione di Mohammed al-Dairi, ministro degli Esteri libico, nell’annunciare il suo appoggio alle misure che alcuni Stati arabi hanno preso per combattere l’appoggio qatariota al terrorismo e mettere fine alla lunga sofferenza della Libia. Il popolo libico, ormai da anni, ripudia il […]
L’articolo I limiti della responsabilità per le sofferenze del popolo libico sembra essere il primo su Arabpress.
Edizione 2017: la rassegna continua a Settimo Torinese “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare”
Mediterraneo
L’articolo Edizione 2017: la rassegna continua a Settimo Torinese “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” sembra essere il primo su Arabpress.
Stivali sul terreno
 Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.
Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.
E’ ormai da un mese che se ne discute e ci si attendeva da Trump una aperta richiesta di sostegno ai partner della Nato nell’ultimo vertice dell’Alleanza dove però il presidente non ha fatto menzione di una scelta che contraddice quanto ha sempre sostenuto in campagna elettorale. La Nato ha comunque già chiesto agli alleati un possibile aumento delle loro forze nel Paese dove sono schierati in totale circa 13mila militari stranieri, 5mila dei quali in forza all’Alleanza (l’Italia con 1000 uomini).
Muslim Ban, viaggio alla scoperta delle Americhe
Tutti noi, o quasi, abbiamo acquisito durante il percorso scolastico, nozioni generali sulla storia di vari popoli. La scuola ci ha insegnato che quella delle Americhe fu una scoperta sensazionale fatta proprio dai più noti esploratori europei dell’epoca: Cristoforo Colombo… Continue Reading →![]()
Egitto, governo silenzia i media: bloccati 63 giornali online e app di messaggistica. “Stretta in vista delle presidenziali 2018”
Negli ultimi giorni sulle bacheche dei social network di molti attivisti egiziani circola una vignetta: il presidente Abdel Fattah El-Sisi tiene in mano un cavo spezzato con i fili elettrici a penzoloni ed esclama “No internet”. La caricatura è stata pubblicata da Mada Masr, uno dei 63 giornali online bloccati nelle ultime due settimane dal […]
L’articolo Egitto, governo silenzia i media: bloccati 63 giornali online e app di messaggistica. “Stretta in vista delle presidenziali 2018” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Bombe a Kabul: il giallo si infittisce
 |
| Sirajuddin Haqqani in una ricostruzione dell’Fbi |
Dopo aver preso lo stesso 31 maggio e con una solerte rapidità le distanze dalla bomba che ha ucciso a Kabul un centinaio di persone, i talebani tornano a smentire ogni coinvolgimento nell’attentato del mercoledi nero chiarendo, con un messaggio affidato al loro sito internet, che la guerriglia colpisce solo obiettivi militari e non spara mai nel mucchio. A dar più forza alla presa di distanze (la terza in pochi giorni) c’è anche un messaggio audio di Sirajuddin Haqqani, l’uomo a capo della Rete Haqqani e vice di mullah Akhundzada il leader del movimento. L’intelligence afgana è invece certa del coinvolgimento degli Haqqani che risponderebbe, dicono a Kabul, a un ordine venuto dia pachistani. E’ la prima volta non solo che i talebani reiterano una loro presa di distanze da un attentato ma che difendono con tanta alacrità la Rete Haqqani, in passato scheggia impazzita del movimento e solita agire per suo conto.
Quanto al “Processo di Kabul”, l’ultimo sasso lanciato dal governo per negoziare con la guerriglia (con l’offerta ai talebani di aprire un loro ufficio nella capitale) i guerriglieri di mullah Akhundzada ribadiscono la loro posizione con un messaggio di poche righe: “Qualsiasi conferenza venga riunita per prolungare la presenza degli occupanti è futile e viene rigettata”.
Assedio del Qatar: una lezione di geopolitica
Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti impongono un embargo al Qatar
L’articolo Assedio del Qatar: una lezione di geopolitica sembra essere il primo su Arabpress.
Ali Safar: inediti in italiano
La rivista di poesia Atelier ha pubblicato, per la prima volta in italiano, alcune poesie del poeta siriano Ali Safar, tradotte dall’arabo da Caterina Pinto. Le ripubblico qui, con il permesso di Atelier e Caterina, che ringrazio. DIARIO AUTOMATICO Diario al margine dell’incendio siriano 2012-2013 Niente sopraffà di più di ciò che ti trovi a […]![]()
L’arte contemporanea si fa nel parco. Notenere II a Roma
 Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska.
Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska.
Saif Gheddafi varie volte liberato. Era realmente “prigioniero”?
mcc43 La “cattura” del delfino di Muhammar Gheddafi nel novembre 2011, suscitava molte domande. Le ricostruzioni erano contrastanti e la versione accolta dalla maggior parte dei media – secondo la quale era stato catturato grazie al tradimento della guida del convoglio presso Oubari nel sud della Libia, caricato su un aereo e consegnato alla città […]![]()
Ernesto Pagano: Napolislam
Giornalista affermato e autore di documentari, Ernesto Pagano propone nel libro “Napolislam” un reportage sulle vite di alcuni napoletani convertitisi all’islam. L’autore ci tiene a precisare di non essere partito con l’idea di narrare storie che dimostrino che l’integrazione a… Continue Reading →![]()
“Muslim Women” and Gender Inequality in Australia’s Assimilationist-Multicultural Policies. Participation in Sport as a Case Study
Published on “About Gender” 6 (11), 2017: 324-353. Available online at: http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/383 Abstract When talking about Islam, the “religionization” of subjects – in particular female subjects – becomes the primary analytical tool to describe power relations within cultural groups and in multicultural societies. Likewise, religionization is widely employed in neoliberal western societies to discuss the […]![]()
In pericolo le relazioni tra Turchia e Germania
Sale la tensione tra i due Paesi in seguito all’annuncio del ritiro delle truppe tedesche dalla base militare turca di Incirlik. Quali saranno le conseguenze?
L’articolo In pericolo le relazioni tra Turchia e Germania sembra essere il primo su Arabpress.
I media e il Ramadan in Yemen
Mobilitazione Houthi e programmi di satira degli avversari in assenza di telespettatori
L’articolo I media e il Ramadan in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
Le parole della Luna (ai #futurimaestri)
Qui di seguito potete leggere la lettera che ho lasciato ieri sera a Bologna all’Arena del Sole ai Futuri Maestri, le centinaia di ragazzi messi insieme dal Teatro dell’Argine, protagonisti di uno spettacolo a dir poco bello, emozionante, contagioso. Mi era stato chiesto (a me così come agli altri otto ‘maestri’ che hanno letto laContinua a leggere
La parabola del pastore e il terrorismo
Santiago Alba Rico Un anno e mezzo fa scrivevo a proposito di Mabrouk Soltani, un giovane pastore tunisino del villaggio di Dauar Slatniya, ai piedi del monte Mghilla, tra Kasserine e Sidi Bouzid, la doppia culla della rivoluzione del 2011 che rovesciò Ben Ali. Il 14 novembre del 2015 Mabrouk fu assassinato dal gruppo terrorista Okba Ibn Neefa (affiliato all’AQMI) […]
L’Afghanistan visto dall’Asia Centrale*
 |
| Asia centrale, il cuore dell’Asia |
Abstract: The countries of Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan define a human and political space strongly influenced by its bordering territories: by Russia, obviously, but also by Pakistan, Iran, and, most importantly, by Afghanistan – a country wretched by forty years of war and generally seen as a threat rather than as a resource. However, interactions between the former five soviet republics and Kabul are unavoidable: the Islamic common denominator, the porosity of borders, the presence of shared norms and practices and the existence of communities, often speaking the same language, further reinforce such belief. Furthermore, in light of future infrastructural developments of road networks, railway lines and, possibly, of energy vectors, partnerships between the five republics and Afghanistan seem the most logical solutions.
Even if each county deals with Kabul its unique way, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan all fear the contagion of war or that of the jihadi message and explain the spread of the politics of Islam within their territories through the failures of the Afghan government. A statement contested both from the inside, with the Afghan government refusing to validate the jihadi narrative, and from the outside: many observers have indeed highlighted how the ‘Afghan danger’ is better understood as a political tool used to repress possible challenges to the political establishment, rather than as an effective threat.
Nevertheless, some positive developments are on their way: negotiations regarding a seemingly difficult partnership between Kabul and the five republics is currently ongoing and further supported, in several instances, by manifestations of international cohesion fostering and financing the expansion of strengthened bilateral agreements.
Le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan formano uno spazio umano e politico fortemente influenzato dai Paesi vicini. La Russia, naturalmente, ma anche il Pakistan o l’Iran e, soprattutto, l’Afghanistan, un Paese in guerra ormai da quasi quarant’anni che è visto più come pericolo che come risorsa. Il rapporto con l’Afghanistan è però ineludibile: per il comun denominatore islamico, la porosità delle frontiere, tradizioni comuni e presenza di comunità che spesso parlano la stessa lingua. Un rapporto che ha un senso anche in ragione di un possibile futuro sviluppo di reti stradali, ferroviarie o di vettori di energia. Se ogni Paese ha nei rapporti con Kabul un atteggiamento diverso, tutte le repubbliche ex sovietiche temono il contagio della guerra o del messaggio islamista e attribuiscono all’Afghanistan la responsabilità dell’espansione dell’islam politico all’interno dei propri confini. E’ una posizione contestata sia all’interno da chi si ritene ingiustamente accusato di propaganda jihadista, sia all’esterno: molti osservatori infatti ritengono che il “pericolo afgano” venga agitato per consentire la repressione e il contenimento di qualsiasi forma di contestazione delle leadership al potere. Non di meno, alcuni progressi si vedono: è in corso un’operazione di difficile costruzione di una partnership con Kabul aiutata, in molti casi, da esperimenti di coesione internazionale che hanno dato impulso e garantito finanziamenti per l’espansione di rapporti bilaterali più saldi.
* Questo articolo è stato pubblicato su IL POLITICO (Univ. Pavia, Italy) 2016, anno LXXXI, n. 3, pp. 136-149 (le note al testo sono contenute nell’edizione cartacea)
 |
| Asia Centrale e Caucaso |
In una carta geografica dell’Asia, l’Afghanistan rappresenta una sorta di centro ideale: al confine con l’Iran a Occidente, con quello rappresentato dal subcontinente indiano a Oriente, frontiera meridionale delle repubbliche centroasiatiche ex sovietiche a Nord. Se effettivamente l’Afghanistan faccia parte dell’Asia Centrale, e cioè di quel mondo che comprende le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, è in realtà una convenzione per alcuni e non per altri. Ne fa parte in un certo senso geograficamente ma in realtà il suo centro di gravità sono i due grandi confinanti che la circondano a Est, Ovest e Sud: l’Iran e il Pakistan, la fine del Medio Oriente e l’inizio dell’Asia meridionale.. Quanto alle cinque repubbliche ex sovietiche, lo sguardo è sicuramente più centrato, seppur con forme e modalità diverse, verso Russia e Cina e Stati Uniti. Il legame col parente meridionale (sicuramente parente per motivi storici, culturali etnici e linguistici) appare oggi soprattutto o come una sorta di “dovere” (spesso suggerito da altri), o uno sguardo obbligato dalle preoccupazioni che riguardano due aspetti in particolare: la sicurezza – col corollario di un possibile contagio lungo i confini meridionali – e il narcotraffico. I legami economici sono poca caso, salvo rare eccezioni (come nel caso del progetto tapi1), il flusso transfrontaliero è limitato, le alleanze sono fragili e il sostegno alla partecipazione dell’Afghanistan a percorsi politici aggregativi (come nel caso del Processo di Istanbul)2 appare più come un aspetto di strategia politica generale – spesso su pressione di altri attori – che non un focus volto a rafforzare il parente bistrattato dalla guerra. Il quadro delle relazioni tra le cinque repubbliche e Kabul va dunque visto anche all’interno delle pressioni e delle relazioni con i grandi attori non solo regionali ma internazionali: la Russia, in primis, la Cina, soprattutto per l’aspetto economico, e gli Stati Uniti (in misura assai minore l’Unione europea). Quanto agli attori regionali, per questi Paesi contano forse più dell’Afghanistan il peso economico e la statura politica di nazioni come Iran e Pakistan.
Che la preoccupazione principale di Astana, Bishkek, Ashkabad, Tashkent, Dushanbe, sia soprattutto l’aspetto sicurezza e stabilità lo dimostra anche il fatto che nel 2014, alla vigilia delle presidenziali afgane, i riflettori delle cinque capitali si sono riaccesi – come quelli di tutti gli altri Paesi coinvolti nella guerra afgana a vario titolo – in attesa di eventi da cui ci si aspettavano grandi novità; lo dimostra anche la pubblicazione di numerose monografie e ricerche sui rapporti tra l’Afghanistan e le repubbliche (due in particolare da segnalare3), attenzione che è poi scemata pur se il quadro uscito dalle elezioni afgane è in realtà ancor più instabile del precedente e il conflitto, benché snobbato dai riflettori della cronaca, stia conoscendo una nuova accelerazione e proprio nel Nord del Paese. Che ha, nelle repubbliche frontaliere, creato un nuovo allarme specie dopo la presa di Kunduz da parte dei Talebani, anche se per pochi giorni, nell’ottobre 2015 e poi ancora nel 2016.
1 La partita regionale
Secondo diversi analisti le preoccupazioni che riguardano la sicurezza sono in realtà da leggersi, in molti casi, anche in chiave interna: più che per il timore di un contagio o per fatti reali che giustifichino una preoccupazione vera per la minaccia di un’espansione dell’islamismo armato,
i Paesi centroasiatici avrebbero cioè utilizzato e utilizzerebbero il “pericolo jihadista” anche per contenere le spinte dal basso che possono mettere in difficoltà (come già avvenuto in passato) il sistema di potere locale. Lo stesso per il narcotraffico, attività economica sotto traccia che consente il transito di oppio e oppiacei prodotti in Afghanistan. Riprendendo i due temi (sicurezza e narcotraffico) Bleuer e Kazemi scrivono che: «Il rischio in termini di sicurezza che lega l’Afghanistan alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale viene di frequente altamente esagerato e così il presunto collegamento tra narcotraffico e gruppi radicali islamisti. In realtà in tutta l’Asia Centrale i principali attori del narcotraffico sono impiegati governativi, agenti della sicurezza e personaggi legati alla mafia… ». E ancora, scrivono, non esiste « …una grave minaccia alle Repubbliche centroasitiche da parte di terroristi e insorti del Nord dell’Afghanistan che vengono normalmente reclutati tra gli afgani per agire localmente4». I Talebani afgani del resto, contrariamente ad Al Qaeda o allo Stato islamico, la cui presenza in quest’area è al momento residuale, hanno sempre sottolineato la natura nazionalistica della loro battaglia per l’instaurazione di un Emirato in Afghanistan e solo in Afghanistan. Chiarendo, al primo punto della loro agenda politica, che l’obiettivo primario è la cacciata degli stranieri dal territorio afgano5, non certo l’espansione oltreconfine del loro jihad.
Non di meno, è evidente che per i Paesi dell’Asia centrale l’Afghanistan resta un elemento importante e preoccupante in un quadro regionale complesso e da secoli al centro di interessi geostrategici, economici e politici che hanno ripreso fiato dopo la fine del dominio sovietico e un ridimensionamento della presenza russa, come provano soprattutto la politica espansiva di Cina e Stati Uniti6. L’Afghanistan resta infine particolarmente preoccupante per tre delle cinque repubbliche che ne condividono il confine, come ha provato nel 2015 la mobilitazione sia centroasiatica sia russa lungo l’Amu Darya (per via degli accordi sulla difesa delle frontiere), specie per Uzbekistan e Tagikistan a un pugno di chilometri dalla città di Kundz, presa allora per qualche giorno dalle milizie in turbante e nuovamente sotto tiro dall’ottobre del 20167.
L’Afghanistan è dunque comunque importante nel rapporto con i grandi attori dell’area centroasiatica (e più o meno direttamente legati alle vicende della guerra afgana) e il Paese, se non lo è oggi, resta d’altronde uno snodo fondamentale per il transito delle merci (anche se ora l’interscambio con le repubbliche è minimo) e soprattutto delle pipeline. Vista dalle cinque capitali dunque, Kabul è forse attualmente più motivo di cruccio che risorsa pur se lo è diventata sia per l’utilizzo in chiave interna dello spauracchio jihadista, sia perché la relazione con l’Afghanistan passa anche per il rapporto con altri attori (dalla Turchia al Pakistan, da Mosca a Washington, da Teheran a Pechino) o organismi internazionali (onu, nato alleanze regionali). Quel che va rilevato è che non essendoci in realtà una politica comune dei cinque Paesi centroasiatici, ogni nazione agisce per suo conto e percepisce, osserva e agisce in maniera diversa e a volta addirittura opposta.
Vedremo qui le grandi linee su cui si muovono i singoli Paesi e infine dedicheremo uno spazio all’attuale situazione afgana, per ora assolutamente lontana da una stabilizzazione efficace e soprattutto da una indicazione che si stia modificando lo scenario dominato dal conflitto anziché da quel negoziato politico con la guerriglia, al netto dei tentativi per ora senza successo, e da cui le repubbliche centroasiatiche sono per ora quasi totalmente escluse.
2 Tagikistan, il vicino prossimo
 |
| Il paesaggio: montagne, pianure, acque |
Il Tagikistan, teoricamente il parente più prossimo tra le cinque repubbliche – per affinità storiche, linguistiche e culturali oltre a un confine comune di oltre 1.300 chilometri – ha con l’Afghanistan scarsi rapporti economici (benché in ascesa) e un diffuso pregiudizio8 sia nei confronti dei rifugiati afgani nel Paese (circa 2.550 nel 2014) sia nei confronti di una nazione che si ritiene un pericolo costante alla frontiera, per problemi legati alla guerra, a infiltrazioni e alleanze jihadiste o al narcotraffico9. Collegate dal grande ponte sull’Amu Darya che unisce la provincia afgana di Kunduz a quella tagica di Kathion e da altri sei piccoli ponti che portano dal Tagikistan nella provincia orientale afgana del Badakshan, Dushanbe e Kabul restano lontane anche se esiste un rapporto a volte di una certa intensità sul piano culturale per iniziativa della società civile dei due Paesi.
Nonostante un interscambio commerciale ridotto, per Dushanbe l’Afghanistan rappresenta comunque un buon investimento nel settore energetico, soprattutto a partire dal 2012 quando è iniziata l’esportazione verso l’Afghanistan di energia elettrica. Kabul aveva anzi aderito al progetto noto come casa-1000, che inizialmente avrebbe dovuto portare da Tagikistan e Kirghizistan elettricità in Pakistan e Afghanistan per un totale di 1300 megawatt (1000 in Pakistan e 300 in Afghanistan). Kabul si è poi ritirata dal progetto, lanciato ufficialmente nel 2016, a un mese dalla cerimonia di avvio10 e il Pakistan usufruirà dell’intera fornitura presumibilmente entro il 2018. Ma il futuro potrebbe riservare sorprese.
Il Tagikistan, retto dal 1992 da Emomali Rahmon (che dal 1992 al 1997 ha affrontato una gravissima crisi senza risolvere i problemi alla base della guerra civile11) considera il turbolento vicino un elemento in più di destabilizzazione per un Paese, il suo, che si regge su un fragile equilibrio. Non di meno, nel giugno del 2009, il presidente tagico aveva proposto un incontro nella sua capitale tra afgani, pachistani e russi per costruire una cooperazione quadrilaterale (Dushanbe Four). Di fatto, al netto di diversi incontri, l’iniziativa non ha prodotto grandi risultati se non quello di apparire come un tassello del piano di riavvicinamento di Mosca a Kabul.
3 Uzbekistan, il vicino in allarme
L’Uzbekistan e l’Afghanistan – collegate dal tristemente famoso “Ponte dell’Amicizia” riaperto nel 2001 – hanno visto nell’ultima decade la firma di numerosi accordi per dare impulso a un interscambio economico che, sino al 2001, era praticamente inesistente. Ma gli accordi non sembrano per ora vedere un trend particolarmente significativo anche se l’interscambio è aumentato e Tashkent vende a Kabul elettricità diretta soprattutto nel Nord del Paese. Non di meno, la strategia uzbeca, più che quella di favorire il vicino – in realtà osservato con grande preoccupazione – mira a utilizzare l’Afghanistan semmai come area di passaggio in un piano di ristrutturazione delle forniture energetiche che ha come obiettivo altri Paesi. Può essere indicata come una scelta comunque significativa quella della ferrovia Hairatan-Mazar-e-Sharif, un progetto di 75 chilometri di strada ferrata, in gran parte finanziato dall’Asia Development Bank12, che collega l’importante centro afgano alla frontiera uzbeca e quindi a Termez. Inaugurata nel gennaio del 2012, la ferrovia avrebbe, secondo l’adb, trasportato in 5 anni 11,7 milioni di tonnellate di beni per un valore di oltre 115 milioni di dollari, favorendo la connessione coi mercati dell’Asia Centrale e della Cina13. Il progetto rappresenta la prima fase di un network ferroviario che include Herat e collegamenti con Tagikistan e Pakistan14.
Sul piano politico va segnalata nel 2008, durante l’incontro nel quadro dell’Euro-Atlantic Partnership Council della Nato tenutosi in Romania, la proposta dell’allora presidente Islam Karimov (morto nel settembre 2016) di istituire un ‘6+3’ Contact Group for Afghanistan sotto egida ONU che avrebbe incluso Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan accanto a NATO, Russia e Stati Uniti (escludendo sia il governo di Kabul sia la resistenza armata), con l’obiettivo di studiare l’approccio a una risoluzione del conflitto. Proposta poi rilanciata in sede ONU nel dicembre 2013 ma senza seguito.
L’Uzbekistan, assai più di altri partner regionali (con l’eccezione del Turkmenistan), si è mosso negli anni con iniziative anche autonome – spesso di segno opposto – sia col governo o con gruppi anti- talebani (noto il suo appoggio al generale Dostum, attuale vicepresidente afgano) ma anche con la guerriglia diretta allora da mullah Omar: l’obiettivo era soprattutto quello di far terra bruciata attorno al Movimentato islamico dell’Uzbekistan (mui), al punto che il governo uzbeco era arrivato a proporre ai Talebani, agli inizi del 2001, persino un riconoscimento dell’Emirato in cambio dell’espulsione dei militanti del mui15 dall’Afghanistan. Nel contempo il governo uzbeco si è distinto per una militarizzazione dei suoi confini (non solo afgani ama anche tagichi e kirghisi) considerando l’Afghanistan e i suoi movimenti islamisti una minaccia per la sicurezza del Paese, preoccupazione reiterata formalmente in più occasioni e sostenuta da una preparazione militare e di intelligence (con formazione tecnica fornita dagli Stati Uniti) che non teme confronti con le altre repubbliche.
Sul piano interno il governo uzbeco, più volte denunciato per la brutalità del trattamento riservato agli oppositori16, utilizza il “rischio afgano”, assai più che in altre repubbliche, come elemento in chiave interna volto alla repressione non solo di gruppi islamisti (aderenti al mui o all’Unione della Jihad islamica17 o supposti tali) ma in generale di oppositori al regime.
4 Turkmenistan, il vicino attivo
Durante l’epoca del governo talebano, il governo del Turkmenistan, pur non avendo ufficialmente riconosciuto il regime, aveva mantenuto rapporti stabili e, in un certo senso, cordiali con l’Emirato di mullah Omar: una scelta volta a preservare il Paese da ritorsioni o infiltrazioni talebane e confermata dalla neutralità al momento dell’invasione delle truppe straniere che nel 2001 combatterono il regime della guerriglia in turbante. Un altro buon motivo era quello di conservare buone relazioni col Pakistan (che aveva riconosciuto il regime), cliente per le forniture energetiche. Le cose sono cambiate alla morte di Niyazov nel 2006 con l’arrivo dell’attuale presidente Gurbanguly Berdimuhammedow che ha aperto agli Stati Uniti e ha autorizzato il sorvolo del Paese da parte dell’aviazione militare americana, cui ha fornito negli anni sostegno logistico e rifornimenti di carburante. Al di là delle dichiarazioni di disponibilità a sostenere ogni possibile strategia di uscita dalla crisi afgana e una discreta attività in campo diplomatico, l’iniziativa forse più rilevante del Turkmenistan è l’ospitalità offerta all’UN Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia ad Ashkabad18. Non di meno, pur non ritenendo l’Afghanistan un rischio così temibile come altre repubbliche, il Turkmenistan ha rafforzato il suo sistema di sicurezza lungo la frontiera (744 chilometri) negli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, il progetto più interessante e che prevede un investimento stimato a circa 7 miliardi di dollari è il già citato tapi19 Coinvolge Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e Unione indiana e prevede l’esportazione di oltre 33 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso circa 1800 chilometri di tubi dal Turkmenistan, via Afghanistan, al Pakistan e all’India (i lavori sono iniziati nel 2015 e dovrebbero concludersi nel 2019). L’Afghanistan dovrebbe goderne per 5 miliardi di metri cubi (lungo l’asse stradale Herat-Kandahar-Quetta) e 14 rispettivamente andrebbero a Pakistan e India. Da segnalare infine il progetto tat (Turkmenistan-Afghanistan-Tagikistan) che dovrebbe sviluppare oltre 600 chilometri di ferrovia (di cui 400 in territorio afgano) che collegherebbero Atamurat in Turkmenistan a Panji in Tagikistan passando per il Nord dell’Afghanistan e collegandosi alla linea che già porta in Uzbekistan. Il costo stimato varia tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. Il 28 novembre 2016 il presidente afgano Ghani e il suo omologo turcmeno Berdimuhamedow hanno inaugurato la tratta da Imam Nazar (Turkmenistan) ad Aqina (Afghanistan), passo in avanti sul progetto tat.
5 Kirghizistan, il vicino preoccupato
Con l’avvio del progetto casa-1000, da cui come abbiamo visto Kabul si è al momento ritirata, il Kirghizistan avrebbe assunto un ruolo rilevante nei confronti dell’Afghanistan e l’accordo avrebbe segnato una svolta in relazioni economiche il cui volume d’affari resta minimo (se si esclude quello illecito legato la narcotraffico e al contrabbando). La presenza di afgani nel Paese non ha grandi numeri limitandosi a qualche centinaia di persone, che comprendono, oltre ai rifugiati, migranti economici o studenti, molti dei quali sostenuti da borse di studio. La relazione forte con le vicende afgane si deve in realtà alla presenza della base militare americana di Manas (2001-2014) attualmente un Centro di transito dopo che è tornata nelle mani di Bishkek. La base, che serviva alle forze aeree americane come spazio logistico, è stata chiusa anche grazie alle forti pressioni in questo senso di Mosca e Pechino20. Il Kirghizistan ha comunque sempre considerato l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza definendolo addirittura il maggior pericolo esterno per il Paese, una formula reiterata nel National Security Concept. E una formula che tende a far apparire maggiore più di quanto non sia il rischio di contagio dall’Afghanistan anziché da alcune aree della Federazione russa21. Al netto delle speculazioni sull’utilizzo del “rischio Afghanistan” in chiave interna, va però menzionata un’idea lanciata per la prima volta nel 1998 per la preparazione di una Conferenza di pace internazionale sull’Afghanistan che però non ha mai fatto strada, nonostante nel 2009 il presidente Kurmanbek Bakiyev avesse riproposto l’iniziativa (chiamata appunto “Bishkek Initiative”) che intendeva costruire un centro di studi e ricerca sulla sicurezza e la stabilità in Asia centrale (anche quella senza seguito22). Il Kirghizistan aveva anche lanciato l’idea di una ristrutturazione del suo debito in cambio di forme di assistenza allo sviluppo in Afghanistan.
6 Kazakistan, il vicino lontano
Pur essendo geograficamente il Paese più lontano tra le cinque repubbliche, il Kazakistan si è comunque distinto per il sostegno all’integrazione regionale e internazionale dell’Afghanistan in più occasioni e in più organismi multilaterali. Ha investito in aiuto allo sviluppo, avviato sforzi per migliorare le relazioni commerciali, offerto sostegno per la formazione locale e nominato un rappresentante speciale per Afghanistan e Pakistan sull’onda di quanto fatto dai maggiori protagonisti stranieri nella guerra afgana. Nel 2012 ha anche lanciato un’iniziativa per la creazione di un Centro con sede in Kazakistan per facilitare una migliore cooperazione tra i Paesi dell’Asia centrale e volta a sostenere l’Afghanistan. Benché gli scettici giudichino questa politica più mirata a rafforzare all’estero l’immagine del Paese che non a immaginare un investimento strategico vero e proprio in Afghanistan, nel 2010 i kazachi hanno dichiarato in sede osce (di cui avevano la presidenza) che l’Afghanistan sarebbe stato una delle priorità della politica estera di Astana.
Il governo kazaco, a differenza di altri, non considera comunque l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza nazionale.
7 Il quadro afgano
Le elezioni presidenziali del 2014 che, come abbiamo visto hanno attirato nuovamente l’attenzione sul Paese anche se i riflettori della cronaca si sono poi andati lentamente spegnendo, si sono concluse con un accordo a tavolino che ha prodotto una bizzarra alchimia istituzionale, non prevista dalla Costituzione ma frutto di un disegno pragmatico volto a salvare almeno le apparenze di una tornata elettorale gravata da brogli e reciproche accuse tra i due principali candidati. Ashraf Ghani è diventato presidente della Repubblica e ad Abdullah Abdullah, un uomo legato alla vecchia Alleanza del Nord composta in gran parte da afgani tagichi23, è stato riservato un ruolo a metà tra il co-presidente e il primo ministro (chief executive). Il parto non è stato privo di difficoltà e il risultato sembra solo averle aumentate: questa sorta di diarchia ha di fatto paralizzato il governo per mesi sia nella nomina dei ministri, sia nell’attribuzione delle cariche secondarie, sia nella scelta dei governatori. Qualsiasi decisione, dalla più grande alla più piccola, è stata oggetto di dibattiti infiniti mal digeriti sia dal parlamento sia dal corpo elettorale che, nei sondaggi, ha visto un enorme calo di consenso verso quel governo di unità nazionale in cui tante speranze erano state riposte.
Questo preoccupante quadro politico è purtroppo sempre accompagnato da una cornice non meno angosciante: unama, la missione onu a Kabul, nel rendere noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015 ha riferito di 11.002 casi24, con un incremento del 4% rispetto al 2014 e un trend impressionante di crescita25. Anche le perdite dell’esercito afgano sono state pesanti e, tra gennaio e agosto 2016, sarebbero stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti (9.665 i feriti). Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi.
Il quadro economico resta segnato da una crisi iniziata col ritiro della maggior parte dei contingenti militari americani e Nato ed è marcato da un indebolimento della valuta, da una caduta degli investimenti e dalla fine della bolla speculativa nel settore edilizio creatasi nelle principali città26. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine dell’Onu infine, il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero mentre la produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 nel 201627.
Il vero malato è però il processo negoziale che dovrebbe por fine alla guerra. I due principali attori regionali – i governi di Kabul e Islamabad – continuano ormai dal 2015 a litigare accusandosi reciprocamente in una sorta di gara a dimostrare che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese vicino. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione con toni anche violenti: Pakistan e Afghanistan si creano inoltre vicendevolmente problemi alla frontiera per il transito delle merci e l’intelligence dei due Paesi, anziché collaborare, nasconde o mistifica le informazioni. In questo quadro, il Pakistan ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. Le espulsioni (che nel novembre 2016 avevano già raggiuntano quota 400mila) hanno messo in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani che vivono in Europa che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi. Quanto al processo negoziale, che nell’estate del 2015 era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni nel movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte ha visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader. In realtà, ma il condizionale resta d’obbligo, il processo negoziale, o quantomeno le trattative più o meno segrete, continuano sotto traccia. Mentre il governo di Kabul ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyar, fonti di stampa hanno rivelato28 che sarebbero avvenuti due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l’Ufficio politico del movimento guidato da Akhundzada. I talebani hanno smentito ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Vi avrebbe partecipato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan, ma non i pachistani il che ha fatto riemergere nuove tensioni anche se in seguito i Talebani hanno inviato una missione “informativa” nel Paese dei puri.
Conclusioni
Lungi dall’essere stato risolto, il nodo della guerra rimane il peggior nemico di un processo di integrazione sia a livello regionale in Asia Centrale sia a livello multilaterale, si tratti del Processo di Istanbul29 o di qualsivoglia iniziativa volta a migliorare la cooperazione in questo o quel campo. Al momento il Paese dell’Hindukush non può che restare una preoccupazione, più o meno agitata sia che si tratti di rischi reali sia che si tratti di propaganda a uso interno. La guerra, col suo portato di instabilità e insicurezza, non richiama investimenti, blocca il flusso delle merci ed esporta al massimo colonne di rifugiati (anche se i grandi Paesi di immigrazione restano i due confinanti Pakistan e Iran). Coinvolte spesso indirettamente nella guerra afgana (o per motivi economico-militari, come nel caso della base di Manas, o per la porosità delle frontiere o per singole iniziative negoziali come nel caso turcmeno o uzbeco), le cinque repubbliche si mantengono a debita distanza in attesa che il caso si risolva e che l’Afghanistan possa tornare ad essere un Paese di transito, cosa che lo renderebbe appetibile soprattutto per il passaggio delle pipeline, ipotesi al momento molto rischiosa. Naturalmente le relazioni esistono e si vanno lentamente rafforzando, a volte anche per spinte o suggerimenti di Paesi terzi, ma l’Afghanistan rimane un luogo da cui è bene mantenere una distanza di sicurezza. L’interesse delle repubbliche è dunque rivolto verso altri Paesi, non esclusi i grandi confinati dell’Afghanistan, Iran e Pakistan.
Risolto il nodo della guerra, una nuova stagione potrebbe cambiare percezione e visuale e andare incontro a un’attenzione che comunque, e forse più che nel recente passato, Kabul ha dimostrato verso le cinque sorelle del Nord cui comunque le unisce una Storia antica e un desiderio comune di indipendenza che per l’Afghanistan, e in parte anche per le repubbliche, resta una chimera in attesa che finisca l’eterno Great Game30 il vero comun denominatore che collega tutti e sei i Paesi.
La battaglia militare e politica di Raqqa
Il volto politico della battaglia di Raqqa è quasi oscurato da quello militare e tutto ruota intorno alla seguente domanda: chi controllerà e gestirà la città dopo il ritiro di Daesh?
L’articolo La battaglia militare e politica di Raqqa sembra essere il primo su Arabpress.
Speciale Ramadan: barazek, biscotti siriani al miele con sesamo e pistacchio
Con la ricetta di oggi scopriamo uno dei tanti prodotti della deliziosa pasticceria siriana: i barazek, biscotti al miele ricoperti di sesamo e pistacchio! Ingredienti: Per la pasta: 150g di zucchero a velo 130ml di burro chiarificato 250g di farina 100ml di acqua tiepida ½ cucchiaino di lievito per dolci 200g di pistacchi pestati 400g di semi di sesamo tostati Per lo sciroppo: […]
L’articolo Speciale Ramadan: barazek, biscotti siriani al miele con sesamo e pistacchio sembra essere il primo su Arabpress.
A Oriente del Califfo al Festival della memoria di Seravezza
Al via il festival dedicato alla memoria a Seravezza (Lucca). Un fine settimana di teatro e incontri al Memofest con Ilaria Cucchi, il sindaco di Amatrice e altri. Alle 18.30 di domenica 11 giugno presentiamo “A Oriente del Califfo”Vedi il programma
Leila Slimani analizza le pieghe dell’intimo umano
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Leila Slimani analizza le pieghe dell’intimo umano sembra essere il primo su Arabpress.
Uscire, sì… ma verso dove?
La Brexit come via d’uscita al terrorismo
L’articolo Uscire, sì… ma verso dove? sembra essere il primo su Arabpress.
Ad Al-Waer, in Siria, l’incertezza dell’evacuazione pesa enormemente sui residenti
Il padre allontana la mano del figlio da quello del nonno, poi dà un bacio all’anziano dicendo: “Perdonami, padre, non sarei mai voluto partire.”
Il "week end" nero di Kabul
 |
| Sulla copertina de Il Tascabile l’ultimo attentato a Herat il 6 giugno |
Stragi senza rivendicazioni, collasso del sistema politico, lotta tra fazioni, confusione tra gli alleati internazionali. L’Afghanistan sembra attraversare un nuovo periodo buio. O un’ennesima riedizione del Grande Gioco. Un tentativo di analisi
Alle 8 e venti del mattino di mercoledi 31 aprile un’autocisterna rossa per l’acqua viene fermata all’imbocco della cosiddetta “green zone” di Kabul, un’area blindatissima dove si trovano diverse ambasciate – l’americana, la tedesca, la nostra –, il quartier generale della Nato, rimesse e caserme che ospitano soldati americani. Appena fermato e probabilmente sviato dal suo vero obiettivo, uno dei luoghi inviolabili della zona verde, l’autista si fa esplodere facendo saltare l’autobotte che contiene 1500 chili di esplosivo e che, nel creare un cratere vasto e profondo, uccide un centinaio di persone e ne ferisce circa 500, alcune delle quali in maniera semi letale. Si tratta del più grosso attentato che la capitale abbia conosciuto dal 2001, da che sono iniziati gli ormai 16 anni di guerra infinita che hanno seguito i dieci di conflitto con i sovietici dal 1979 all’89 e in seguito altri sette tra soli afgani fino alla nascita dell’emirato di mullah Omar nel settembre del 1996.
Il fatto singolare è che l’attentato non viene rivendicato…
segue su Il Tascabile
Vedi anche questo servizio della Bbc sulla vita sotto i talebani nell’Helmad
Sara Borrillo: Femminismi e Islam in Marocco
“Femminismi e Islam in Marocco: attiviste laiche, teologhe, predicatrici” è l’ultima pubblicazione di Sara Borrillo, che con linearità e accuratezza esplora il panorama femminile marocchino impegnato nella rivendicazione di una propria posizione all’interno delle istituzioni, della famiglia e della società… Continue Reading →![]()
L’Africa protagonista al Rototom Sunsplash 2017
White Helmets, Not White Collars
Source: the Independent. White Helmets, Not White Collars http://www.syriauntold.com/en/2017/06/white-helmets-not-white-collars/ By Estella Carpi. Last autumn, Max Blumenthal’s commentary on the White Helmets in Syria went viral in the international media. At the same time, the 2016 White Helmets movie and the “Hollywoodization” of civilian search and rescue operations became objects of discussion and even suspicion in […]![]()
Guerra di troni. Non più passi di danza fra Sauditi e Qatar
mcc43 Lo scorso dicembre Re Salman dell’Arabia Saudita era in visita a Doha, lo si vide danzare gongolante sul palco accanto a Tamim bin Hamad al-Thani, Emiro del Qatar. Cinque mesi dopo, esattamente il 5 giugno 2017, con una mossa che sembra improvvisa ma non lo è, quello sfoggio d’amichevole allegria si trasforma in veemente accusa […]![]()
Il Qatar tagliato fuori: come hanno reagito gli utenti di Twitter nei Paesi del Golfo?
Su Twitter non si sa se ridere o piangere
L’articolo Il Qatar tagliato fuori: come hanno reagito gli utenti di Twitter nei Paesi del Golfo? sembra essere il primo su Arabpress.
I mufti arabi: voce della religione o frusta del potere?
Da ormai un secolo la politica e lo Stato dominano e permeano tutti gli aspetti della vita quotidiana e la religione non ne è esente
L’articolo I mufti arabi: voce della religione o frusta del potere? sembra essere il primo su Arabpress.
Di Qatar, Arabia Saudita, controrivoluzioni e “sante alleanze”
5 giugno 2017. Il sole sorge, nel Mediterraneo, su un giorno a dir poco simbolico. Si dovrebbero ricordare i 50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni vinta da Israele sulle truppe (e le aviazioni) arabe. 50 anni da una guerra che ha segnato il corso della s…
5 giugno 1967 – 5 giugno 2017
Volevo ricordare i 50 anni trascorsi dall’inizio della Guerra dei Sei giorni, oggi. La guerra che ha cambiato il conflitto israelo-palestinese. Volevo e dovevo ricordare, come dovrebbe ricordare la comunità internazionale, i paesi arabi, l’Europa, gli Stati Uniti. E invece devo scrivere di un altro argomento, almeno all’apparenza. Le ennesime tensioni nella storia dei rapportiContinua a leggere
Dove si dirigono i siriani?
Con le parole della giornalista siriana, Samira al-Musalima, una riflessione sulla Siria del futuro e sui possibili scenari di risoluzione nel Paese
L’articolo Dove si dirigono i siriani? sembra essere il primo su Arabpress.
Walking the Line. 50 anni dopo, lungo il confine che non c’è
5 giugno 1967, 7.45 del mattino. L’aviazione militare israeliana si alza in volo per annientare quella egiziana, senza dargli neanche il tempo di reagire.
Mazen Maarouf: inediti in italiano
La rivista di poesia Atelier ha da poco pubblicato alcune poesie (inedite in italiano) dello scrittore e poeta palestinese-islandese Maazen Maarouf, tradotte dall’arabo da Elena Chiti. Le ripubblico qui con il permesso di Atelier e di Elena, che ringrazio. افتراض مناخي تخيلي معي طفلا يقف في نهايته طفل خلفه طفل بجانبه طفل آخر وأمامه طفل […]![]()
Si spegne a Marrakech lo scrittore spagnolo Juan Goytisolo
(Ser). Lo scrittore spagnolo Juan Goytisolo è morto oggi a Marrakech, inMarocco. Classe 1931, Goytisolo è stato uno degli scrittori contemporanei con la più vasta conoscenza della letteratura spagnola, nonché esperto critico e interlocutore tra la cultura europea e quella islamica. Le sue opere ricoprono diversi generi letterari: narrativa, reportage, letteratura di viaggio, racconti e memorie. Per […]
L’articolo Si spegne a Marrakech lo scrittore spagnolo Juan Goytisolo sembra essere il primo su Arabpress.
Rivoluzione delle idee o idea di rivoluzione?
Due concetti spesso confusi all’interno delle società
L’articolo Rivoluzione delle idee o idea di rivoluzione? sembra essere il primo su Arabpress.
Dietro le bombe senza un padrino
 |
| Babur: si vuole che la sua tomba a Kabul respingesse le pallottole durante la guerra tra mujahedin |
Sono da poco passate le tre del pomeriggio al cimitero di Khair Khana a Kabul. Un migliaio di persone sono li a rendere l’ultimo omaggio alle vittime della manifestazione antigovernativa di venerdi dove le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla. Tra questi c’è anche il cadavere di Salem Izdyar, figlio di un senatore della Repubblica e dunque sono presenti anche le alte cariche dello Stato: c’è il primo ministro Abdullah Abdullah e il ministro degli Esteri Salahuddin Rabbani. Anche perché il padre di Salem, Mohammad Alam Izdyar, non è un senatore qualsiasi ma il rappresentante alla Meshrano Jirga della Provincia del Panjshir – a maggioranza tagica e bacino elettorale fieramente antitalebano di Abdullah. La funzione religiosa viene interrotta da tre esplosioni: un ordigno e due kamikaze che si fanno saltare in aria e gettano nello scompiglio la folla che cerca salvezza nella fuga. Il bilancio è ancora incerto: decine i feriti e, secondo alcune fonti, almeno 20 morti.
Ma cosa c’è dietro questa nuova stagione del terrore con un quadro ancor più confuso dal fatto che gli attentati non vengono rivendicati e sono stati prontamente condannati dai talebani?
La pista pachistana
I servizi segreti afgani lo hanno detto sin dalle prime ore di mercoledi quando una cisterna è esplosa nel cuore ella capitale uccidendo un centinaio di civili: dietro le stragi ci sono i servizi pachistani che si servono, come in passato, della Rete Haqqani, la fazione più stragista dei talebani. E’ un’ipotesi non nuova e con diversi precedenti anche se spesso Islamabad sembra solo il colpevole più facile da indicare: una pista che raccoglie sempre il consenso dell’uomo della strada. In passato queste stragi senza paternità erano soprattutto servite a far deragliare l’avvio degli stentati tentativi di mettere in piedi un tavolo negoziale che però – almeno per quel se ne sa – in questo momento è ben lungi dall’essere apparecchiato.
Pista talebana
 |
| Abdullah e Ghani: il primo Ceo (una specie di premier, il secondo presudente. Due anime in guerra perenne |
Gli Haqqani però, anche se dotati di larga autonomia, fanno pur sempre parte della galassia talebana. Possono dunque agire del tutto fuori linea rispetto a quanto decide mullah Akhundzada, leader della guerriglia? Se fosse così ci sarebbe un motivo che spiegherebbe bene un piccolo giallo: la presa di distanze della strage di mercoledi è infatti stata riscritta sul sito ufficiale della guerriglia (smentendo il coinvolgimento di Haqqani) e non vi appare la smentita della strage al funerale. Si potrebbe dunque anche ipotizzare una lotta intestina tra fazioni e immaginare dunque che anche l’attentato di mercoledi rientri in questa logica. Le esplosioni al funerale confermerebbero le ipotesi che vogliono gli irriducibili esasperare la tensione tra le due anime del governo: quella irriducibile rappresentata da Abdullah e dai “panjshiri” e quella di Ghani, pashtun e più possibilista anche se in realtà da tempo il presidente si è spostato su posizioni di netta chiusura al Pakistan e avrebbe appena ordinato l’esecuzione di alcuni talebani prigionieri.
Pista politica interna
 |
| Il manifesto di oggi: dopo 16 anni di guerra il Paese è un “posto sicuro” solo per chi ordina i rimapatrii (forzati) |
Stando ai talebani, le stragi sono il frutto della tensione tra queste due anime: una tensione palpabile e
che si è manifestata nella manifestazione di venerdi che aveva però preso di mira entrambe le fazioni chiedendo le dimissioni di Ghani e Abdullah e quelle del capo della guarnigione di Kabul generale Gul Nabi Ahmadzai – che da due giorni invita i residenti a stare a casa e lontani da luoghi affollati – del capo dei servizi Massoum Stanekzai e del capo del National security council, Haneef Atmar, un uomo che è stato anche ministro di Karzai. A farsi portavoce della protesta c’è Asif Ashna, anche lui con un passato governativo: nel 2015 si è dimesso da vice portavoce di Abdullah. Accanto a lui anche Zia Massud, un altro panjshiri già nell’esecutivo di Karzai e poi in quello di Ghani finché il presidente non lo ha fatto fuori. Dunque, dietro la comprensibile rabbia dei parenti delle vittime c’è chi soffia sul fuoco ma da qui a immaginare che questi personaggi fabbrichino bombe da 1500 chili, come quella di venerdi, ce ne corre. Certo il quadro interno è confuso e il governo è barcollante, litigioso e senza consenso salvo l’appoggio della Nato e degli americani che non sembrano che aspettare il momento per poter aumentare il numero delle truppe straniere nel Paese, un piano che il Pentagono avrebbe già sottoposto a Trump e ai partner dell’Alleanza ma che è rimasto in stand-by. Quanto a Ghani ha già detto che non si dimetterà. Abdullah è della stessa opinione
Pista Stato islamico
Data per buona mercoledì solo da alcuni siti online (italiani) sembra da scartare completamente: il Califfato ha armi di propaganda ben affilate e quando prepara un attentato è già pronto anche il piano di comunicazione. Certo le truppe del califfo in Afghanistan sono in difficoltà ma, a maggior ragione, se dietro le stragi ci fossero loro, lo avremmo saputo con rapidità e certezza.
Egitto – Sisi incontra Trump e scatena la repressione
Ieri si sono tenuti al Cairo i funerali pubblici di giovane Yousef, 13 anni, assassinato accidentalmente da una guardia che si divertiva a sparare durante il matrimonio di sua figlia. Nonostante si conoscano i nomi dell’ufficiale e del suo complice, … Continue reading →
Restare o andarsene? Il futuro dei residenti di Al-Waer in Siria è comunque incerto
I ribelli e le loro famiglie stanno evacuando l’ultima roccaforte della città di Al-Waer soprannominata “la capitale della rivoluzione.” Nell’articolo riportiamo alcune delle loro storie.
Afghanistan: cambiano i tempi, non cambia il paese
Articolo pubblicato su L’INDRO
L’#Afghanistan è la guerra persa in cui stiamo affondando.
Quella afghana è una guerra che vede impegnata la NATO da oltre 16 anni
ed è costata più di 115 miliardi di dollari. E il risultato non è
incoraggian…
Afghanistan: 90 morti e 400 feriti- Intervista a Radio Cusano campus
Afghanistan: 90 morti e 400 feriti nel cuore di Kabul. Quale la
situazione? L’ISIS conquista terreno e alza la posta in gioco, i
talebani rispondono conquistando ampie aree del paese, gli Usa aumentano
le proprie truppe sul terreno e chiedono alla N…
Speciale Ramadan: bevanda dolce al tamarindo
Dopo tante ore di digiuno, soprattutto in estate, reidratare il corpo è fondamentale. Oggi vi proponiamo la ricetta di una delle tipiche bevande di rottura del digiuno quotidiano: bevanda dolce al tamarindo! Ingredienti: 200g di tamarindo 1 litro d’acqua 130g di zucchero acqua di rose (facoltativo) Preparazione: Prima di tutto, sminuzzare il tamarindo in piccoli pezzi. […]
L’articolo Speciale Ramadan: bevanda dolce al tamarindo sembra essere il primo su Arabpress.
Libia: situazione militare preoccupante, politica paralizzata
Tre posizioni del caleidoscopio libico
L’articolo Libia: situazione militare preoccupante, politica paralizzata sembra essere il primo su Arabpress.
Kabul spari sulla folla 5 morti
 |
| Chi non vuole vedere l’abisso afgano? |
La strage senza paternità che mercoledi ha ucciso un centinaio di cittadini di Kabul e ne ha feriti ennesimo episodio mortale. A farne le spese alcuni dimostranti uccisi dalle forze di sicurezza afgane mentre, assieme ad altri, erano convenuti sul ruolo della strage per protestare contro l’insicurezza quotidiana che circonda la vita nella capitale e in un Paese dove, nei primi tre mesi del 2017, sono state uccise oltre settecento civili e che nel 2016 ha totalizzato il bilancio più grave della guerra infinita: 3.500 morti, in aumento rispetto all’anno precedente.
oltre 400 con effetti devastanti sul centro città che si sono sentiti fino a 4 chilometri dal sito dell’esplosione, è stata seguita ieri da un
La protesta che dalle prime ore del mattino aveva raccolto un migliaio di persone si è rapidamente trasformata in una manifestazione politica con slogan che chiedevano la testa dei capi degli apparati di sicurezza ma anche le dimissioni del governo di unità nazionale. Numerosi gli slogan contro i talebani (che hanno preso le distanze dalla strage) e il Pakistan. I media locali sostengono che molti dimostranti fossero armati e che abbiano lanciato pietre contro gli agenti (alcuni dei quali sono stati feriti) ma la reazione delle forze dell’ordine, stando anche a quanto dichiarato dai responsabili di Amnesty International nella regione, sarebbe stata spropositata. L’organizzazione internazionale chiede ora un’inchiesta sull’impiego di armi da fuoco durante il corteo. Quel che è certo è che la tensione è salita alle stelle quando i dimostranti hanno cercato di spingersi verso il palazzo presidenziale, non molto distante dal luogo dell’attentato. In sostanza, quando la manifestazione, da semplice reazione di rabbia spontanea, è diventata politica, la sicurezza del governo è entrata in azione. Gas e acqua non sono stati ritenuti sufficienti e si è iniziato a sparare. I morti accertati sarebbero almeno cinque. Molti anche i feriti, con pallottole che hanno colpito alcuni dimostranti ai piedi e alle gambe.
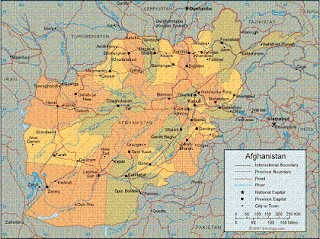 |
| Afghanistan: la guerra infinita strage dopo strage |
Alla protesta hanno partecipato anche alcuni parlamentari e anche l’ex rappresentante speciale di Ashraf Ghani per le Riforme e il Buon governo, Ahmad Zia Massud, licenziato dal presidente qualche tempo fa. Zia Massud (fratello minore del “leone del Panjshir” ed eroe nazionale Ahmad Shah), già vicepresidente con Karzai, si è unito a un sit in nel pomeriggio che chiedeva la testa di Ghani e Abdullah, i reggenti del governo “a due teste” dell’Afghanistan. La situazione resta tesa in città mentre è ancora senza paternità l’attentato che mercoledi mattina ha raggiunto il primato del più sanguinoso attacco suicida che la capitale afgana ricordi.
Il massacro senza padrini di Kabul per l’intelligence afgana una firma invece l’avrebbe: i servizi sono infatti sicuri che dietro la strage ci sia la fazione talebana della cosiddetta Rete Haqqani, sanguinaria e favorevole ad attentati stragisti con grandi numeri, che è notoriamente vicina ai servizi segreti del Pakistan. Gli afgani sono così certi della paternità pachistana della strage che il presidente Ghani avrebbe deciso, dopo l’attentato di mercoledi, di firmare l’ordine di esecuzione per undici talebani, alcuni dei quali appartengono appunto alla Rete Haqqani. Nelle stesse ore l’Afghanistan Cricket Board cancellava tutte le partite con il Pakistan fino a nuovo ordine, un segnale non certo solo sportivo in quella che spesso viene chiamata cricket-diplomacy e che lavora proprio in quei Paesi dove il vecchio gioco degli inglesi è ora sport nazionale. Latore di buoni propositi ma anche di totali chiusure.
Ghani, che ha ricevuto anche una telefonata di Trump e la solidarietà del generale Nicholson, che comanda le truppe Nato e Usa nel Paese ed è un fautore dell’aumento di soldati stranieri in Afghanistan, è comunque in seria difficoltà. Non solo potrebbe non bastargli il possibile aumento di nuove truppe straniere (anche italiane?) ma il presidente sa che l’abisso del suo Paese non fermerà comunque l’esodo forzato degli afgani venuti in Europa a chiedere asilo: nonostante lo stop alle deportazioni deciso a caldo, Angela Merkel ha fatto infatti sapere che il piano di rimpatrio andrà avanti.
Via Andegari 6
Mi ha colpito soprattutto la porta. La porta verdolina dell’ultimo piano di via Andegari 6. Il cuore della casa editrice Feltrinelli. Una porta massiccia, eppure ingentilita da quel colore così siciliano. La prima volta che l’ho attraversata, quella porta, avevo timori e allo stesso tempo molta speranza. Niente di anormale, anzi, molto di scontato quandoContinua a leggere
The day after
 |
| Guerra senza fine |
E’ ancora senza paternità l’attentato che mercoledi mattina ha raggiunto il primato del più sanguinoso attacco suicida che la capitale afgana ricordi. Fonti del ministero della Sanità di Kabul hanno contato almeno cento morti e 600 feriti ma è un bilancio che è per difetto: ci sono ancora circa una ventina di dispersi e ancora non sono stati trovati i corpi dei poliziotti che erano di guardia al check point di Zarbaq Square, nella zona “diplomatica” di Wazir Akbar Khan che si trova nel pieno centro della capitale. Un’area, non lontana dall’ospedale di Emergency, che a quell’ora, le 8 e 20 del mattino, è solitamente un ingorgo di mezzi civili guidati da chi va al lavoro. Tra i dispersi c’è ad esempio il comandante Assadullah Andarabi dell’Afghan National Police che, al comando di otto poliziotti, era di guardia al check point. Le prime ricostruzioni dicono che l’ufficiale avrebbe fermato la cisterna bloccandola nella piazza e che il conducente si sarebbe dunque fatto esplodere forse ancora lontano dal suo obiettivo reale. Il risultato dell’attentato resta comunque spaventoso: sia in termini di vite umane, mutilazioni e danni che la Camera di commercio afgana ha stimato a circa dieci milioni di dollari.
I dubbi sulla paternità si devono sia al fatto che, con una rapidità inconsueta, i talebani hanno preso le distanze dal massacro, sia che lo Stato islamico, che è invece notoriamente rapidissimo nelle rivendicazioni e incline a stragi con grandi numeri (come nel luglio dell’anno scorso), non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale né per altro ufficiosa. Uno dei suoi punti di forza è invece proprio la comunicazione, rapida ed efficace, che molto spesso si serve di lanci via twitter, pagine social o di agenzie di notizie come la famosa “Amaq” il cui fondatore, l’ideologo del Bahrein Turki al-Binali, sarebbe stato ucciso durante un raid a Raqqa. Notizia confermata proprio da fonti dello Stato islamico. Stato islamico che ha invece rivendicato un’auto bomba con autista kamikaze che si è fatto esplodere poco lontano dall’aeroporto di Jalalabad nella provincia orientale di Nangarhar – dove il 13 aprile gli americani hanno testato la super bomba GBU-43 Moab – che è ritenuta la base dei militanti della cosiddetta “Provincia del Khorasan”, come il Califfato ha rinominato l’area afgano pachistana. Avrebbe ucciso un soldato afgano – dicono fonti ufficiali – e ne avrebbe ferito un altro. Ma c’è un piccolo giallo: poco prima che Site Intelligence Group – l’organizzazione che monitora le attività jihadiste – rilanciasse la notizia data dal Califfato (secondo cui i morti sarebbero invece sette) anche il sito dei talebani riportava la notizia di un attacco a Jalalabad che aveva ferito cinque soldati americani. Ma nelle ore seguenti la notizia è sparita (è singolarmente sparita anche la presa di distanze dell’attentato di Kabul….)..
 |
| Poco spazio ormai per poeti e letterati |
Come che sia, il massacro di Kabul per ora non ha padrini anche se i servizi afgani sono sicuri che dietro la strage ci sia la fazione talebana degli Haqqani, sanguinaria e favorevole agli attentati stragisti con grandi numeri, notoriamente vicina ai servizi segreti del Pakistan. Gli afgani sono così certi della paternità pachistana della strage che, secondo indiscrezioni, il presidente Ashraf Ghani avrebbe deciso, dopo l’attentato di mercoledi, di firmare l’ordine di esecuzione per undici talebani, alcuni dei quali appartengono appunto alla Rete Haqqani (Ghani ieri ha ricevuto anche una telefonata di solidarietà di Trump mentre il generale Nicholson, che comanda le truppe Nato e Usa nel Paese ed è un fautore dell’aumento di soldati stranieri nel Paese, si è recato sul luogo della strage). Nelle stesse ore l’Afghanistan Cricket Board cancellava tutte le partite con il Pakistan fino a nuovo ordine, un segnale non certo solo sportivo in quella che spesso viene chiamata cricket-diplomacy e che lavora proprio in quei Paesi dove il vecchio gioco inglese è diventato lo sport nazionale a volte latore di buoni propositi. Oppure di totali chiusure.
Il massacro di Kabul non fermerà comunque l’esodo forzato degli afgani venuti in Europa a chiedere asilo: nonostante lo stop alle deportazioni deciso a caldo, Angela Merkel ha fatto sapere che il piano di rimpatrio andrà avanti. Bomba non bomba.
Blocco dei media in Egitto: l’audacia dell’ignoranza
A meno che le autorità non riescano a eliminare internet in Egitto, bloccare i siti di informazione è una mossa teatrale che può fare solo più male che bene
L’articolo Blocco dei media in Egitto: l’audacia dell’ignoranza sembra essere il primo su Arabpress.
Strage a maggio senza padrini
 |
| Afghanistan, la guerra infinita |
Nel Paese che l’Unione europea considera ormai sicuro e dove i migranti sono obbligati a tornare, la guerra infinita continua a mietere vittime con atrocità sempre maggiori. Una gara al rialzo dove stamattina la protagonista è stata una cisterna per l’acqua carica di esplosivo saltata in aria a Kabul nell’ora di punta, le 8 e trenta, uccidendo almeno ottantacinque persone e ferendone almeno quattro centinaia. Un bilancio che mentre scriviamo continua ad aggravarsi e che non ha ancora una paternità (illazioni, ma solo quelle, su Haqqani e Stato islamico). Paternità che i talebani, con un messaggio affidato invece in tempi rapidissimi al loro sito ufficiale, hanno sdegnosamente rifiutato chiarendo che il movimento non prende mai di mira la popolazione civile.
L’esplosione (1500 chili di esplosivo), che si è udita in tutta la città e il cui fumo ha invaso interi quartieri del centro, è avvenuta poco distante dalla porta d’ingresso della zona diplomatica dove ha sede anche l’ambasciata italiana. Sembra ricordare quella che, nel 2009, fece saltare in aria una cisterna di benzina davanti all’ambasciata tedesca che si trova appunto sull’ingresso della cosiddetta “green zone”. Da allora aumentarono sbarramenti di cemento, poliziotti privati e controlli accurati ma nessuno è ancora riuscito a trovare la ricetta per impedire atti terroristici di tale portata anche se per fare esplodere un tale quantitativo di esplosivo c’è chi lo vende e chi lo compre in un Paese dove il commercio delle armi – legali e illegali – è moneta corrente.
Le modalità della strage potrebbe far pensare a una mossa dell’autoproclamato Stato islamico che in Afghanistan ha già firmato stragi di civili con grandi numeri. Ma la memoria corre anche a episodi senza firma come il camion bomba che, senza rivendicazioni, esplose nell’agosto di due anni fa in un quartiere della capitale creando un cratere profondo dieci metri. Anche le immagini di oggi restituiscono la vista di un enorme cratere che ha inghiottito l’autocisterna e portato all’altro mondi decine di impiegati, lavoratori informali, più di un giornalista.
Intanto un gruppo di famigliari di vittime della guerra ha inviato a Unama, la missione Onu, di Kabul, una denuncia che vuole portare davanti al tribunale internazionale dell’Aja i responsabili di omicidi di gente comune. Il dito è puntato su Gulbuddin Hekmatyar, il capo mujaheddin che oggi gode dell’impunità che gli è stata garantita dal governo di Kabul in cambio della smobilitazione del suo gruppo armato (che si è però rifiutato di consegnare le armi).
Intervista ad Habib Ayeb, autore del documentario “Couscous”- les graines de la dignité”
Habib Ayeb è geografo, insegnante e ricercatore all’Università Parigi 8 in Francia, attivista e realizzatore dei documentari “Fellahin” e “Gabes Labes” Il suo nuovo lavoro “Couscous – les graines de la dignité” apparirà nei prossimi mesi in Tunisia. Intervista a cura di Patrizia Mancini Tunisia in Red: Cominciamo con la domanda più facile… Perché fare un documentario sul couscous? Habib […]
Una biologa curda protegge il leopardo persiano nell’Iraq devastato dalla guerra (Video)
In cima alle montagne del Kurdistan, la conservazionista Hana Ahmed Raza e un gruppo di ricercatori di Nature Iraq lavorano per proteggere il leopardo persiano.
Tunisia: il governo di Chahed e la guerra alla corruzione
Una manovra politica per scongiurare una nuova Rivoluzione
L’articolo Tunisia: il governo di Chahed e la guerra alla corruzione sembra essere il primo su Arabpress.
SABATO 10 GIUGNO RIUNIONE NAZIONALE DEL COMITATO PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE DEL PROSSIMO 7 OTTOBRE A ROMA
Il prossimo sabato 10 giugno, con inizio alle ore 11.00, si terrà a Roma, in Via di Porta Labicana n. 56/a, la riunione del Comitato Promotore della manifestazione nazionale prevista per il prossimo 7 ottobre. Alla riunione sono invitati a partecipare tutte le organizzazioni e le persone che hanno sottoscritto il relativo appello e […]![]()
Il Rif marocchino, cronaca e genesi di un’escalation.
Non è bastata la visita della delegazione ministeriale che si era recata nel Rif, per calmare le acque torbide in cui la regione naviga da sette mesi. Il tour di Aziz Akhenouch e i suoi colleghi- ripresi dalle telecamere in un atteggiamento dialogante, con rappresentanti della società civile e dei settori produttivi: artigiani, commercianti, e … Continua a leggere →![]()
La rivolta del Rif, spiegata bene
Continuano a crescere le tensioni nel Rif dopo le grandi manifestazioni del 18 maggio. Non è bastata, infatti, la visita della delegazione ministeriale che si era recata nel regione berbera con l’intento di capire le rivendicazioni del popolo rifi e private a calmare le acque. Il tour del Ministro dell’Agricoltura…
L’articolo La rivolta del Rif, spiegata bene sembra essere il primo su MaroccOggi.
Nell’islam qualcosa si muove
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Nell’islam qualcosa si muove sembra essere il primo su Arabpress.
Nuovi leader in Siria
Alla luce di una soluzione alla crisi siriana si fa strada la proposta americana di cambiamento della struttura politica del regime siriano. Ma quale sarà la nuova forma di potere possibile?
L’articolo Nuovi leader in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Totti spleen
..che poi per me (e per un buon pezzo della mia generazione) il calcio è finito nello stadio di Heysel. Da quel momento, l’incantesimo si è rotto, l’età dell’innocenza è finita e siamo diventati grandi. Totti, però, è un’altra storia. O meglio, lo è diventata con gli anni, con l’assommarsi degli anni, uno sopra all’altro.Continua a leggere
Theresa May e il terrorismo
L’ennesimo attacco al cuore dell’Europa apre nuove interrogativi sulla lotta e il sostegno al terrorismo da parte dell’Occidente
L’articolo Theresa May e il terrorismo sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto, attentato contro i copti: lo Stato islamico reagisce alle perdite in Siria e Iraq
Un nuovo attacco violento e militarmente ben organizzato ha colpito la minoranza cristiana in Egitto nella provincia di Minya il giorno prima dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Un attentato – senza ancora rivendicazione – che arriva poco più di un mese dopo le esplosioni della domenica delle palme e dopo il […]
L’articolo Egitto, attentato contro i copti: lo Stato islamico reagisce alle perdite in Siria e Iraq proviene da Il Fatto Quotidiano.
Speciale Ramadan: kofta bi tahini
Ramadan karim! Anche quest’anno, dedichiamo uno speciale alle ricette del mondo arabo-islamico del mese di Ramadan. Cominciamo da un piatto gustosissimo diffuso in tutto il Levante, soprattutto in Palestina, Giordania e Libano: la kofta bi tahini, carne macinata con patate in salsa di tahina! Ingredienti: Per la kofta: 500g di carne macinata (agnello o manzo) 1 cipolla […]
L’articolo Speciale Ramadan: kofta bi tahini sembra essere il primo su Arabpress.
Conferenza di Riyad: quali strategie arabe per il futuro?
La conferenza arabo-islamica americana di Riyad rappresenta un grande cambiamento nella politica degli Stati Uniti nei confronti del Medio oriente
L’articolo Conferenza di Riyad: quali strategie arabe per il futuro? sembra essere il primo su Arabpress.
Prigionieri palestinesi in sciopero della fame da un mese per le condizioni del carcere israeliano
Dopo trenta giorni, gli oltre 1500 prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri israeliane continuano il loro massiccio sciopero della fame per ottenere condizioni dignitose minime.
Consiglio di lettura: Donne di Beirut” di Iman Humaydan Younes
Dal blog “Mille e una pagina” di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di lettura: Donne di Beirut” di Iman Humaydan Younes sembra essere il primo su Arabpress.
REMIX – Cinema|Cultura|Migrazioni
 REMIX, rassegna cinematografica in collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche che coniuga racconto cinematografico e approccio scientifico sul tema delle migrazioni e della convivenza –
REMIX, rassegna cinematografica in collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche che coniuga racconto cinematografico e approccio scientifico sul tema delle migrazioni e della convivenza –
26|28 maggio 2017.
Egitto – Il regime sa solo reprimere
L’Egitto sta attraversando una settimana particolarmente dura che ha visto arresti di attivisti, figure dell’opposizione e operai in sciopero, la detenzione di Khaled Ali (figura di spicco dell’opposizione laica, possibile candidato alle prossime elezioni, in prima linea contro la cessione … Continue reading →
L’Orientale: Nabil Salameh e Simone Sibilio a Napoli
“Tarab. La poesia araba in musica”, questo il titolo del seminario tenuto martedì 23 maggio all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, introdotto da Monica Ruocco e Oriana Capezio, docenti di Lingua e letteratura araba, durante il quale sono intervenuti due… Continue Reading →![]()
Egitto: “terrorismo” eletto democraticamente?
Il regime egiziano di Abd al-Fattah al-Sisi utilizza la magistratura per raggiungere una legittimità ottenuta attraverso l’imposizione dello status quo con la forza
L’articolo Egitto: “terrorismo” eletto democraticamente? sembra essere il primo su Arabpress.
Netizen Report: Chelsea Manning e il potere della trasparenza
Questa settimana, Chelsea Manning è stata finalmente liberata dal carcere, l’Ucraina censura le piattaforme web russe e la Thailandia minaccia azioni legali contro Facebook.
Islam e prevenzione dei radicalismi violenti
Il convegno è organizzato dall’associazione culturale UVA Universolaltro, un’associazione di Promozione Sociale, composta da 16 operatori laureati in Scienze delle Religioni che si propongono di diffondere cultura ed educazione circa il loro settore di studio. L’incontro previsto per il 30 maggio 2017 alle ore 15 presso la Camera dei Deputati, sala Aldo Moro, vedrà la partecipazione di: […]
L’articolo Islam e prevenzione dei radicalismi violenti sembra essere il primo su Arabpress.
Gli interessi arabi e la politica di Trump
Primo viaggio in Medio Oriente per il presidente americano
L’articolo Gli interessi arabi e la politica di Trump sembra essere il primo su Arabpress.
Save the date! 26 maggio a Palermo
Un summit per Donald
 E’ un’agenda zeppa di impegni quella che il presidente americano Donald Trump, arrivato martedi sera a Roma, ha davanti prima del suo ritorno in Italia per l’incontro del G7 in Sicilia. Tra le due tappe italiane c’è infatti il summit della Nato a Bruxelles dove, accanto ai partner dell’Alleanza, Trump vedrà anche i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, ma anche il neo presidente francese Macron o il difficile alleato turco che Erdogan rappresenta. Non è ancora chiaro infine cosa dirà sui due temi di punta del vertice: la spesa militare della Nato – prima definita «obsoleta» poi rivalutata a struttura ineludibile – né in fatto di guerra al terrorismo. Una guerra che, dicono le indiscrezioni, si basa anche su una nuova strategia americana in Afghanistan con un aumento delle truppe di terra: statunitensi e dell’Alleanza. Sul due volte spinoso tema russo ucraino forse sorvolerà.
E’ un’agenda zeppa di impegni quella che il presidente americano Donald Trump, arrivato martedi sera a Roma, ha davanti prima del suo ritorno in Italia per l’incontro del G7 in Sicilia. Tra le due tappe italiane c’è infatti il summit della Nato a Bruxelles dove, accanto ai partner dell’Alleanza, Trump vedrà anche i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, ma anche il neo presidente francese Macron o il difficile alleato turco che Erdogan rappresenta. Non è ancora chiaro infine cosa dirà sui due temi di punta del vertice: la spesa militare della Nato – prima definita «obsoleta» poi rivalutata a struttura ineludibile – né in fatto di guerra al terrorismo. Una guerra che, dicono le indiscrezioni, si basa anche su una nuova strategia americana in Afghanistan con un aumento delle truppe di terra: statunitensi e dell’Alleanza. Sul due volte spinoso tema russo ucraino forse sorvolerà.
Prima di partire per Bruxelles Trump vedrà il papa, nelle prime ore del mattino, e poi Mattarella e Gentiloni. L’accoglienza a Roma ha già visto muoversi diverse associazioni anche di “expat” pacifisti americani che contestano la sua politica guerrafondaia di cui Trump ha dato prova coi bombardamenti in Siria e con la “madre di tutte le bombe” (Moab) sganciata il 13 aprile in Afghanistan. Una bomba che al papa non è proprio piaciuta: «….la mamma dà vita – ha detto Francesco al recente Meeting delle Scuole per la pace – le bombe danno morte». Chissà se il santo padre toccherà l’argomento.
Due settimane fa la stampa americana ha dato notizia di una nuova strategia messa a punto dal Pentagono e caldeggiata dal consigliere per la sicurezza di Trump, generale McMaster, che prevede un aumento di truppe sul terreno (da 3 a 5mila a sostegno degli 8400 già presenti in Afghanistan) ma anche un nuovo modo di condurre la guerra: le decisioni sulla sua gestione passerebbero però direttamente dal Pentagono senza bisogno della sigla del presidente e gli Usa si sgancerebbero (più di quanto non facciano ora) dalla catena di comando afgana, con più mano libera dunque, come ha dimostrato proprio il lancio della Moab. Secondo l’editorialista americano Eli Lake (Bloomberg View) il piano prevederebbe in realtà una forza di soli americani pari a 50mila uomini che però non dovrebbero essere soli. Ecco perché il segretario generale Nato Jens Stoltenberg ha lavorato in queste settimane chiedendo un aumento anche ai partner. Oltremare avrebbe guadagnato una promessa dall’Australia e un “ni” dal Canada. In Europa Londra e Copenaghen hanno già detto si. La Germania ha risposto picche. Altri tentennano, altri ancora – come la Polonia – potrebbero farci un pensierino. L’Italia ancora non si sa. E proprio rispetto alla posizione italiana, altre voci si sono intanto aggiunte a quelle della Tavola della pace e di “Afgana” che hanno chiesto al governo italiano di opporsi a un nuovo aumento di truppe in Afghanistan dove mancano – aggiunge Pangea Onlus – «politiche e finanziamenti per promuovere l’avanzamento delle donne, il contrasto alla violenza e l’applicazione di programmi sulla base delle risoluzioni Onu».
I giochi comunque dovrebbero essere già fatti anche se Trump, noto per i suoi repentini cambiamenti di idea (era contrario a impegnarsi militarmente all’estero in campagna elettorale) potrebbe spiazzare: o essere molto prudente (non facendo numeri) o molto netto chiedendo agli alleati l’impegno militare a sostegno del nuovo “surge”. Come ha detto proprio McMaster : America first didn’t mean America alone. La supremazia americana, grande totem di Trump, non si può costruire da soli.
"Afgana" su summit Nato: contro il surge di Donald Trump
 Afghanistan: Roma cambi strategia e rifiuti aumento soldati
Afghanistan: Roma cambi strategia e rifiuti aumento soldati
Alla vigilia del summit Nato a Bruxelles ancora non è nota la posizione dell’Italia
In occasione del mini-vertice della Nato del 25 maggio a Bruxelles, l’associazione italiana Afgana – impegnata da anni nel dialogo con la società civile afgana – chiede al governo italiano quali politiche intenda adottare nel Paese centroasiatico. Secondo le indiscrezioni di stampa, l’amministrazione Trump ha intenzione di annunciare l’aumento delle truppe dispiegate in Afghanistan, portandole dalle attuali 8.500 unità a oltre 11mila, e di chiedere un contestuale aumento anche ai partner dell’Alleanza atlantica, tra cui l’Italia. Nell’ambito della missione-Nato “Resolute Support”, il nostro Paese stanzia in Afghanistan il secondo contingente per numero di soldati, dopo quello degli Stati Uniti. Afgana chiede dunque di sapere se il nostro governo abbia ricevuto una richiesta formale in tal senso, se abbia intenzione di assecondarla e in quali termini.
Di fronte agli evidenti fallimenti della strategia militare adottata negli ultimi 16 anni in Afghanistan, l’associazione italiana auspica un’inversione di rotta: più cooperazione civile e un impegno maggiore nel promuovere il processo di pace e di riconciliazione. Afgana si augura inoltre che qualunque decisione passi attraverso un dibattito parlamentare trasparente e condiviso.
comunicato stampa di “Afgana”
Tataouine brucia, Tunisi risponde
Patrizia Mancini Si chiamava Anouar Sokrafi, aveva 21 anni ed è morto a Tataouine, schiacciato da un veicolo della Guardia Nazionale. Un altro manifestante è ricoverato in gravissime condizioni, colpito da lacrimogeni. E’ così che il governo ha lanciato la sua escalation in questa zona dell’estremo sud della Tunisia, in cui la popolazione da settimane è in continua mobilitazione per […]
I risultati più importanti della visita di Trump a Riyad
Nuovi accordi militari, strategici ed economici, e la scommessa della “NATO Araba” dopo l’ultimo viaggio del presidente statunitense in Arabia Saudita
L’articolo I risultati più importanti della visita di Trump a Riyad sembra essere il primo su Arabpress.
Il romanzo di Shukri al-Mabkhut racconta le lotte della Tunisia
Questa recensione del romanzo “L’italiano” (e/o, 2017, trad. dall’arabo di Barbara Teresi), è stata pubblicata su Internazionale qualche settimana fa. L’italiano è l’opera prima di Shukri al Mabkhout, noto accademico tunisino al momento direttore della fiera del libro di Tunisi, che con questo libro nel 2015 ha vinto il prestigioso premio internazionale per la narrativa araba […]![]()
Il Rif marocchino non ha smesso di “agitarsi
«Non esistono compromessi nella rivendicazione della libertà » AbdelKerim EL khettabi. È passato più di un anno da quando Mohcine Fekri, venditore ambulante di pesce, è morto accidentalmente in un compattatore della spazzatura, cercando di salvare la sua merce confiscata dalla polizia. Da allora, El Hoceima la capitale del Rif marocchino,…
L’articolo Il Rif marocchino non ha smesso di “agitarsi sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Califfo in libreria dal 25 maggio
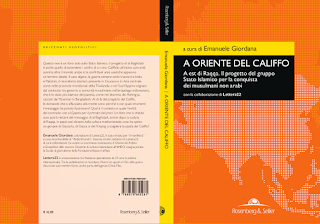 Non è un libro solo sullo Stato Islamico. Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle provincie meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei Rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, le domande che si affacciano alla mente sono: perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare? Qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad ?. Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Non è un libro solo sullo Stato Islamico. Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle provincie meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei Rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, le domande che si affacciano alla mente sono: perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare? Qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad ?. Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?A ORIENTE DEL CALIFFO
A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi
Rosenberg&Sellier
pp 188
euro 15,00
A cura di Emanuele Giordana
L’esito delle elezioni in Iran
Al suo secondo mandato presidenziale, quali saranno le sfide per il presidente Hassan Rouhani?
L’articolo L’esito delle elezioni in Iran sembra essere il primo su Arabpress.
Trump e l’ambizione di un accordo di pace tra Israele e i paesi arabi. Il piano del presidente tra scetticismo e Russiagate
La visita in Israele di Trump sembrava la parte più semplice del primo viaggio all’estero del quarantacinquesimo presidente americano. Ma dopo le rivelazioni sul caso, ormai conosciuto come Russiagate, i tre giorni a Tel Aviv e Gerusalemme saranno invece quelli più densi e difficili. A dirlo è il New York Times che sottolinea come la […]
L’articolo Trump e l’ambizione di un accordo di pace tra Israele e i paesi arabi. Il piano del presidente tra scetticismo e Russiagate proviene da Il Fatto Quotidiano.
Altre Modernità
La rivista di UNIMi 17/2017 è on line:
Proteste nel Rif marocchino: di chi è la colpa?
Le proteste del Rif e della città di El-Hoceima, da un lato, riflettono la realtà storica e tragica della relazione esistente tra il centro e il makhzen e, dall’altro, riflettono quelli che sono i maggiori problemi del Marocco, costituiti dal rapporto ambiguo tra la casa reale e il governo
L’articolo Proteste nel Rif marocchino: di chi è la colpa? sembra essere il primo su Arabpress.
Oman: le autorità bloccano l’accesso alla rivista online Mowatin
Il giornale indipendente è stato bloccato dalle autorità durante la Giornata mondiale della libertà di stampa, quando aveva ripreso a pubblicare superando altre censure statali.
Cucina del Golfo: il mashkoul
Con la ricetta di oggi andiamo a scoprire un piatto molto diffuso in tutta la regione del Golfo, utilizzato soprattutto come accompagnamento per piatti a base di carne o pesce: il mashkoul, riso basmati con cipolla! Ingredienti: 350g di riso basmati 1 cipolla grande 60g di burro o ghi Preparazione: Prima di tutto, far scaldare il […]
L’articolo Cucina del Golfo: il mashkoul sembra essere il primo su Arabpress.
La leadership saudita e Donald Trump? Due facce della stessa medaglia
Riyad si prepara ad accogliere il Presidente statunitense, con il quale condivide una visione dell’estremismo che tende ad incolpare i musulmani, assolvendo i governi da qualsiasi responsabilità
L’articolo La leadership saudita e Donald Trump? Due facce della stessa medaglia sembra essere il primo su Arabpress.
Netizen Report: un nuovo disegno di legge in Egitto potrebbe bloccare i social media
Il parlamento egiziano aumenta le restrizioni d’espressione, la Turchia blocca Wikipedia, la Russia blocca WeChat e la Gran Bretagna non smette di ficcare il naso.
Elezioni Iran -le donne
Elezioni Iran, il voto delle donne escluse
“Prima che parli il fucile. Omar Aziz e la rivoluzione siriana” a cura del Collettivo Idrisi
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Prima che parli il fucile. Omar Aziz e la rivoluzione siriana” a cura del Collettivo Idrisi sembra essere il primo su Arabpress.
Una nuova politica giordana in Siria?
Strategia militare, dichiarazioni ufficiali e operazioni sul campo lasciano presagire l’inizio di una nuova era dei rapporti siro-giordani
L’articolo Una nuova politica giordana in Siria? sembra essere il primo su Arabpress.
Yemen: ne parliamo con Laura Silvia Battaglia
Oggi in Yemen è in corso una guerra civile. Già nel 2011, però, la società civile scese in piazza. Come si è passati da rivendicazioni popolari alla lotta armata? Il 2011 è stato sicuramente un anno tellurico per lo Yemen…. Continue Reading →![]()
Tra Africa e Oriente le collezioni dell’IsIAO alla Biblioteca Nazionale
Tra Africa e Oriente le collezioni dell’IsIAO alla Biblioteca Nazionale Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 9 maggio – 30 giugno 2017 – Mostra zoom Lavorazione dell’inchiostro L’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) è stato un ente pubblico, posto sotto … Continue reading →
Novità editoriale: “Ninna nanna” di Leila Slimani
Il romanzo vincitore del premio Goncour 2016 arriva in Italia grazie alla casa editrice Rizzoli.
L’articolo Novità editoriale: “Ninna nanna” di Leila Slimani sembra essere il primo su Arabpress.
Mario Dondero alla Polveriera di Ancona
 |
| Una bellissima immagine di Mario Dondero Sarei grato se mi si volesse segnalare il suo autore |
Il 18 maggio al Primo Festival del Fotogiornalismo di Ancona, si ricorderà Mario DONDERO il grande fotografo recentemente scomparso. Ne Parleranno Paolo Marasca, Assessore del Comune di Ancona, Emanuele Giordana, giornalista amico e biografo di Mario Dondero, Marco Cruciani regista del film su Mario DONDERO “Calma e Gesso” , Valerio Bispuri fotoreporter di fama internazionale. Il Presidente della Fototeca Provinciale di Fermo Giuseppe Buondonno parlerà dell’opera di catalogazione e archiviazione dell’enorme patrimonio fotografico di Dondero in loro possesso.
LE INIZIATIVE DI SABATO 20 MAGGIO
20 maggio giornata nazionale di mobilitazione “ Pace e libertà per il popolo siriano” verso la manifestazione nazionale del 7 ottobre L’elenco delle iniziative di questo fine settimana che avviano il percorso di dibattito e mobilitazione verso la manifestazione nazionale del prossimo 7 ottobre. Venerdì’ 19 maggio : Firenze : ore 17.00 presidio in piazza […]![]()
La Detenzione Amministrativa: Israele, Palestinesi e Convenzione di Ginevra
mcc43 La Detenzione Amministrativa è una limitazione della libertà personale che si differenzia dall’arresto per natura e per applicazione secondo il dettato della Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili in tempo di guerra o occupazione territoriale (1949). Gli stessi principi sono ribaditi nel “Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici” (1966). Misura […]![]()
La spartizione del Medio Oriente
La regione è ancora soggetta all’influenza delle potenze occidentali
L’articolo La spartizione del Medio Oriente sembra essere il primo su Arabpress.
A Oriente del Califfo a Torino
Muri e frontiere. Un’umanità in fuga 2017
 Il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma – Roma Multietnica, organizza la seconda edizione di Muri e frontiere. Un’umanità in fuga, una rassegna di documentari, web-reportage, incontri con giornalisti, testimonianze di rifugiati e transitanti a Roma.
Il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma – Roma Multietnica, organizza la seconda edizione di Muri e frontiere. Un’umanità in fuga, una rassegna di documentari, web-reportage, incontri con giornalisti, testimonianze di rifugiati e transitanti a Roma.
17 maggio – 21 giugno 2017
Nuovo dizionario italiano arabo , Tresso, Hoepli
Dizionario italiano arabo In questo dizionario: 11.000 lemmi italiani selezionati mediante il criterio della frequenza d’uso, con l’aggiunta di termini relativi all’ambito culturale arabo-islamico e ai settori della scuola, della sanità, dello sport e dell’informatica; 16.600 accezioni e oltre 36.000 … Continue reading →
Vita:istruzioni per l’uso
Ahmed Nàgi, Vita: istruzioni per l’uso. Trad. di Elisabetta Rossi e Fernanda Fischione. Con illustrazioni di Ayman Al Zorqani. Il Sirente, Fagnano Alto 2014. Ho già scritto altrove che tenere in mano i libri de Il Sirente è … Continua a leggere→
Vita:istruzioni per l’uso
letturearabe di Jolanda Guardi
letturearabe di Jolanda Guardi – Ho sempre immaginato che il paradiso fosse una sorta di biblioteca (J. L. Borges)
Siamo di fronte a una nuova Guerra del Golfo?
La nuova politica americana mette il Medio Oriente contro l’Iran
L’articolo Siamo di fronte a una nuova Guerra del Golfo? sembra essere il primo su Arabpress.
Sulle elezioni in Iran
Dall’illusione democratica a quella della riforma economica: l’Iran ripete se stesso durante la campagna elettorale
L’articolo Sulle elezioni in Iran sembra essere il primo su Arabpress.
A Oriente del Califfo a Trento il 17 maggio
“Donne al buio” di Asmae Dachan è la Siria che muore ogni giorno
“Sono avvolta dal buio, la fiamma della candela si muove timida, furtiva, quasi impercettibile. Sul muro figure deformi, surreali. Basta allontanare un attimo lo sguardo da quell’innocente fuoco e sentirsi addosso il peso dell’oscurità…quel silenzio che avvolge la stanza, questo palazzo, questo quartiere, questa millenaria ed esanime città”. Così inizia Donne al buio, pièce teatrale di […]
L’articolo “Donne al buio” di Asmae Dachan è la Siria che muore ogni giorno sembra essere il primo su Arabpress.
Ibrahim Ferghali e Johnatan Wright
Tempo fa, ho pubblicato un pezzo sulla traduzione dall’arabo (qui) nel quale citavo l’intellettuale egiziano Ibrahim Ferghali (qui) e Giabir al-‘Usfur (qui) e commentavo quanto da loro affermato in ordine alla traduzione dall’arabo nelle lingue europee, affermando che dovremmo tener … Continua a leggere→
Ibrahim Ferghali e Johnatan Wright
letturearabe di Jolanda Guardi
letturearabe di Jolanda Guardi – Ho sempre immaginato che il paradiso fosse una sorta di biblioteca (J. L. Borges)
Turchia: le nuove proposte di Washington ad Ankara
La Turchia si sta dimostrando sempre più uno Stato “chiave” per il suo peso politico in Medio Oriente e gli Stati Uniti cercano di trarre vantaggio da questa situazione
L’articolo Turchia: le nuove proposte di Washington ad Ankara sembra essere il primo su Arabpress.
Passaggi: “Mi basta” di Fadwa Tuqan
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Passaggi: “Mi basta” di Fadwa Tuqan sembra essere il primo su Arabpress.
Polveriera di Ancona 18 maggio
Al-Azhar e Islam al-Behairy
La decisione presa dal grande Imam, Muhammad Ahmed Al-Tayyeb, di dimettere dal suo incarico il presidente dell’Università, Ahmed Hosni Taha, riflette pienamente lo spirito generale di Al-Azhar
L’articolo Al-Azhar e Islam al-Behairy sembra essere il primo su Arabpress.
Uno Yemen unito è necessario, ma…
Non è possibile continuare a pensare a uno Yemen unito senza prima trovare un nuovo modello su cui rifondare il Paese
L’articolo Uno Yemen unito è necessario, ma… sembra essere il primo su Arabpress.
Imparare a dire no, grazie
Qualche giorno fa, Chiara Comito ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook nel quale, commentando il festival Mediterraneo Downtown di Prato, afferma: Al Festival Mediterraneo Downtown di Prato hanno mischiato geopolitica, attivismo e cultura da Mediterraneo, Caucaso ed Europa. … Continua a leggere→
Imparare a dire no, grazie
letturearabe di Jolanda Guardi
letturearabe di Jolanda Guardi – Ho sempre immaginato che il paradiso fosse una sorta di biblioteca (J. L. Borges)
Gli accordi di Astana non avranno lunga vita
Un solo accordo, obiettivi diversi: la fragile intesa che sancisce la fine delle ostilità in Siria si basa sugli interessi divergenti dei tre principali firmatari
L’articolo Gli accordi di Astana non avranno lunga vita sembra essere il primo su Arabpress.
Gli Apocalittici e Integrati di Umberto Eco nell’epoca della democrazia rappresentata
di Anatole Pierre Fuksas
La concatenazione di accadimenti, per molti versi intricati e casuali, che ha condotto alla vittoria di Macron su Le Pen alle Presidenziali francesi, determina nei fatti la transizione ad una nuova dimensione della politica. Parrebbe infatti compiuto il processo, suggerito da molta elaborazione post-moderna, che conduce alla fine del quadro politico marcato dalla distinzione tra una destra di matrice borghese e una sinistra di matrice proletaria, variamente evolute in termini sociali, economici e culturali attraverso i grandi sconvolgimenti prodottisi dalla caduta del Muro di Berlino fino ad oggi.…
Gli Apocalittici e Integrati di Umberto Eco nell’epoca della democrazia rappresentata è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
SABATO 20 MAGGIO GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE
Verso la Manifestazione Nazionale a Roma del 7 OTTOBRE 2017 PACE E LIBERTÀ PER IL POPOLO SIRIANO E PER I POPOLI DEL MEDIO ORIENTE Muove i primi passi il percorso di mobilitazione verso la manifestazione nazionale del 7 ottobre. Da oltre sei anni la Siria è teatro di violenze e orrori indicibili. Le pacifiche manifestazioni […]![]()
Il musulmano errante di Alberto Negri, vademecum indispensabile
Gli alauiti, questi sconosciuti. Dal blog Hiwar di Giusy Regina
L’articolo Il musulmano errante di Alberto Negri, vademecum indispensabile sembra essere il primo su Arabpress.
Un Blog, tanti volti
È da sempre che desideravo scrivere ed esprimere tutto ciò che non mi stava bene, partendo dalle piccole ingiustizie che mi circondando, ma non mi sentivo ancora pronta fino a quando non ho trovato il coraggio di farlo. (Kyare) Anche… Continue Reading →![]()
Tunisia: la riconciliazione economica rinasce dalle sue ceneri
Amna Guellali, direttrice dell’organizzazione Human Rights Watch per Tunisia e Algeria Una nuova legge per consacrare l’impunità, per impedire la rivelazione della verità A sei anni dalla caduta del regime di Ben Alì, rovesciato da una rivoluzione popolare nel 2011, la giustizia di transizione sembra vivere ore difficili. Regna ancora l’impunità per le violazioni dei diritti umani, i più alti […]
Non c’è tregua
Un possibile sunto degli ultimi 50 anni nel mondo arabo ed europeo
L’articolo Non c’è tregua sembra essere il primo su Arabpress.
Odissea dei profughi dalla Siria
mcc43 Immaginate di vivere a Raqqa, la “capitale” di quello che voleva essere lo Stato Islamico di Al Baghdadi: ISIS o Daesh, come preferite. Laggiù si stanno preparando all’assedio finale, fortificano la città, scavano una rete di bunker sotterranei, tutto viene razionato o manca del tutto. Voi cosa decidete di fare? 1) Decidete di restare Allora […]![]()
Rogo Rom a Roma
 Regolamento di conti o violenza xenofoba? La domanda è aperta. Certo è che l’incendio che ha distrutto il camper in cui dormiva una famiglia Rom, genitori e 11 figli, nel parcheggio del centro commerciale Primavera a Centocelle, popoloso quartiere romano, è stato doloso. Le telecamere di sicurezza hanno inquadrato un uomo che lancia una bottiglia incendiaria contro il veicolo. Così nella notte tra il 9 e il 10 maggio hanno perso la vita una ragazza di 20 anni e due bimbe di 8 e 4 anni, Francesca, Angelica e Elisabeth Halinovic.
Regolamento di conti o violenza xenofoba? La domanda è aperta. Certo è che l’incendio che ha distrutto il camper in cui dormiva una famiglia Rom, genitori e 11 figli, nel parcheggio del centro commerciale Primavera a Centocelle, popoloso quartiere romano, è stato doloso. Le telecamere di sicurezza hanno inquadrato un uomo che lancia una bottiglia incendiaria contro il veicolo. Così nella notte tra il 9 e il 10 maggio hanno perso la vita una ragazza di 20 anni e due bimbe di 8 e 4 anni, Francesca, Angelica e Elisabeth Halinovic.
Afghanistan, cresce la voglia di "boots on the ground"
La Danimarca e la Gran Bretagna hanno detto si alla richiesta della Nato di inviare truppe fresche in Afghanistan a sostegno della decisione americana (non ancora formalizzata ufficialmente) di mandare tra 3mila e 5mila nuovi soldati nel Paese asi…
La tentazione francese
La tentazione della cultura e dei valori francesi di libertà, attraverso i candidati alla presidenza, ha assunto un sentimento opposto rispetto al passato di cui la classe dirigente libanese è un chiaro esempio
L’articolo La tentazione francese sembra essere il primo su Arabpress.
La silenziosa avanzata del land grabbing in Mozambico
ProSavana è un progetto che sottrae la terra ai piccoli agricoltori per creare grandi appezzamenti sul modello delle fazende brasiliane. Ecco chi si oppone
Una possibile svolta per la Libia
Il meeting di Abu Dhabi potrebbe essere un importante passo per la stabilizzazione della Libia
L’articolo Una possibile svolta per la Libia sembra essere il primo su Arabpress.
Surge afgano
 Ci siamo. Anzi, ci risiamo. La guerra afgana torna al centro della politica militare americana con un
Ci siamo. Anzi, ci risiamo. La guerra afgana torna al centro della politica militare americana con un
nuovo piano strategico che, una volta siglato da Trump, riporterà nel Paese asiatico migliaia di nuovi soldati: 3mila secondo il Washington Post, che per primo ha rivelato il piano, fino a 5mila secondo il New York Times e i giornali afgani. Si aggiungeranno agli 8.400 già sul posto che partecipano in parte alla missione Nato di sostegno all’esercito afgano. E proprio la prossima riunione della Nato a Bruxelles, il 25 maggio, dovrebbe vedere la conferma del nuovo “surge” americano, accompagnata da una richiesta ai partner dell’Alleanza, dunque anche all’Italia, di mettere a disposizione truppe fresche nell’ordine di “migliaia”.
La cosa era nell’aria da mesi, preceduta dalle audizioni al Congresso di alte cariche militari e in particolare del generale John Nicholson che comanda le truppe Nato in Afghanistan e che è fautore dell’aumento di “stivali sul terreno”. Poi se ne è riparlato quando Trump – in campagna elettorale favorevole al ritiro delle truppe – ha mandato a Kabul il suo consigliere per la sicurezza Herbert Raymond McMaster, un falco che viene dalle forze armate e che, durante Bush, fu uno dei padrini del “surge” – aumento consistente di truppe – in Iraq. McMaster si era fatto precedere dalla Gbu-43 – Moab (massive ordnance air blast bomb o anche mother of all bombs), un ordigno da 11 tonnellate di esplosivo sganciato alla vigilia della Conferenza di pace sull’Afghanistan organizzata a Mosca dai russi. McMaster era andato a Kabul per verificare con il presidente Ghani proprio il possibile invio di nuove truppe (cosa cui il governo di Kabul è favorevolissimo) tanto che adesso, i contrari alla nuova operazione hanno ribattezzato il piano: “McMaster’s War”, la guerra di McMaster.
L’esatto numero di soldati americani da inviare, confermano fonti dell’Amministrazione, dipenderà anche dalla disponibilità degli alleati, evidentemente già consultati in merito a un ennesimo sforzo in appoggio alla nuova strategia di Trump. Ma il piano non prevede solo l’invio di soldati. Il piano prevede che sarà il Pentagono e non la Casa Bianca a decidere sui numeri e anche ad autorizzare raid aerei che, essendo in corso ormai da mesi, aumenteranno probabilmente di numero. Autorizza anche una “mobilità” dei soldati americani che va oltre quanto Obama aveva stabilito a suo tempo quando aveva deciso una lenta uscita di scena dal teatro (salvo poi ripensarci). Le limitazioni che furono oggetto di polemiche col gabinetto Karzai (che si rifiutò di firmare l’accordo militare voluto da Obama che fu poi siglato da Ghani) dovrebbero dunque cadere e garantire agli americani maggior capacità d’azione senza troppi laccioli nella catena di comando condivisa con gli afgani.
Manca dunque solo la firma del presidente che sta probabilmente facendo i conti (la guerra afgana costa all’erario americano 23 miliardi di dollari l’anno) e sondando la disponibilità degli alleati di una Nato non più ritenuta “obsoleta”. Trump è probabilmente imbaldanzito da alcuni successi (l’uccisione un mese fa dal capo dello Stato islamico in Afghanistan Abdul Hasib o del capo talebano Akhtar Mansur nel 2016 o ancora dalla super bomba del 13 aprile scorso) ma sembra soprattutto aver dato carta bianca al Pentagono dove il capo della Difesa, Jim Mattis, è tra i fautori della nuova strategia.
L’Onu intanto ha fatto i conti di quanti afgani sono stati costretti dalla guerra a lasciare le loro case nel 2017: sono 88.841. L’anno scorso sono stati 660mila e quest’anno la stima è di 450mila.
Prigione Al Jalame, Israele: minorenni palestinesi in isolamento
mcc43 “Ci costringi ad arrestare tuo padre e tua madre; cerca di capire che io ho lo Stato d’Israele dietro di me, mentre dietro di te non c’è niente” Secondo l’ultima comunicazione ufficiale, agosto 2016, del Servizio Carcerario Israeliano (IPS), Israele ha in detenzione 350 minori Palestinesi; i dati per anno sono visibili nell’articolo dell’organizzazione […]![]()
In Tunisia, i media attaccano la società civile
I media tunisini dovrebbero sostenere il lavoro delle ONG in seno alla società, non ostacolarlo
L’articolo In Tunisia, i media attaccano la società civile sembra essere il primo su Arabpress.
Franco Cardini, un ponte fra due rive
Scardinare le griglie che occultano alla vista ciò che c’è all’esterno delle nostre idee, delle nostre convinzioni identitarie, delle griglie mentali con cui ci approcciamo agli eventi storico-politici passati e presenti, non è certo roba da tutti. Sono considerati quasi… Continue Reading →![]()
Siria: zone di sicurezza o campi di detenzione?
Pro e contro della creazione di zone di sicurezza per i rifugiati in Siria
L’articolo Siria: zone di sicurezza o campi di detenzione? sembra essere il primo su Arabpress.
Islam in Afghanistan
LE DIVERSE ANIME DELL’ISLAM
Ciclo di conferenze organizzato dal 27 aprile al 25 maggio 2017
dalla Casa della Cultura, in collaborazione con il Centro di cultura Italia-Asia
Emanuele Giordana – “L’Islam in Afghanistan”
Giovedì 11 maggio, ore 21.00
Guardato come un sorvegliato speciale, l’Islam afgano non è solo estremismo radicale, ma un pianeta diffuso e tutt’altro che omogeneo, attraversato da correnti sufi, da movimenti sciiti e ismaeliti e anche da un Islam sunnita pacifista, che si affermò, nei primi del secolo scorso, a cavallo della frontiera con l’attuale Pakistan. Uno sguardo per andare oltre una guerra di cui l’Islam non è certo l’unico responsabile.
Sede degli incontri: Casa della Cultura – Via Borgogna 3, Milano
MM1 San Babila – Ingresso libero
Per informazioni: 02 79.55.67 – 02 76.00.53.83 – [email protected]
Siti web di riferimento
Centro di cultura Italia-Asia: www.italia-asia.it
Casa della Cultura: www-casadellacultura.it
Associazione Casa della Cultura – Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MM1 – San Babila)
02 795567 – 02 76005383 – fax 02 76008247
e-mail: [email protected] – www-casadellacultura.it
C.F. 80115850150 – P.IVA 13307640154
UN PERCORSO SOLIDALE E INTERNAZIONALISTA DA COSTRUIRE
Di seguito, il report della riunione dei promotori della manifestazione in solidarietà con la Siria e i popoli del Vicino Oriente e contro il decreto “Minniti – Orlando”. Qualche considerazione preliminare è d’obbligo. Da un lato, sarebbe folle e irresponsabile promuovere una manifestazione in concomitanza con una kermesse colossale come sarà, prevedibilmente, la cosidetta “Marcia […]![]()
Elezioni in Algeria: ha vinto il “partito del boicottaggio”?
Le elezioni in Algeria sono sì state vinte ancora dal presidente Bouteflika e dai suoi alleati, ma contrassegnate da un forte astensionismo
L’articolo Elezioni in Algeria: ha vinto il “partito del boicottaggio”? sembra essere il primo su Arabpress.
La biblioteca di Abd al-Rahman Munif a Firenze
Fino al 9 giugno a “Villa Romana” a Firenze, è esposta la mostra Disappearances. Appearances. Publishing, dedicata alla biblioteca e al patrimonio culturale collezionato dallo scrittore Abd al-Rahman Munif nei suoi molteplici viaggi e spostamenti lungo la geografia dei paesi arabi. Non ne sapevo nulla (*) e mi dispiace: non capisco perché quando ci sono […]![]()
Hamas: dalla resistenza alla guerra civile
Il giornalista libanese, Nadim Qoteish, sul “nuovo” documento politico del movimento Hamas
L’articolo Hamas: dalla resistenza alla guerra civile sembra essere il primo su Arabpress.
Prigioni d’Israele: diritti negati e sciopero della fame
mcc43 E’ in corso dal 17 aprile lo sciopero della fame dei prigionieri Palestinesi in Israele. Le ragioni dello sciopero sono state annunciate da Marwan Barghouti in un articolo pubblicato dal NYT e tradotto in questo blog. E’ una protesta non violenta, ma passa quasi inosservata ai media, lasciata alle organizzazioni pro-diritti umani. B’Tselem, The Israeli Information […]![]()
La settimana di Arabpress in podcast – XXI puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XXI puntata sembra essere il primo su Arabpress.
“Peccato mortale sfruttare il lavoro ”
 Il Papa incontra i giovani studenti delle “Scuole per la pace” e prende posizione sulla guerra e le sue cause. “I governanti? Solo parole. Attenti ai terroristi delle chiacchiere”
Il Papa incontra i giovani studenti delle “Scuole per la pace” e prende posizione sulla guerra e le sue cause. “I governanti? Solo parole. Attenti ai terroristi delle chiacchiere”
Alla fine ci sta pure una battuta: “I governi e gli impegni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo? Non lo dico da papa ma lo dico con la grande Mina: parole, parole, parole”. La platea dell’Auditorium Paolo VI in Vaticano ride e si spella le mani. Sono soprattutto studenti, settemila, arrivati un po’ da tutta Italia. Fan parte di un progetto iniziato tre anni fa dalla Tavola della pace d’intesa con il Miur e promosso dal Coordinamento degli Enti Locali per la Pace, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e un altra decina di sigle tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia e i Giovani Musulmani d’Italia. I ragazzi, dalle medie al liceo, han lavorato in questi anni sul tema della guerra: informandosi, interrogandosi e anche suggerendo soluzioni. L’ultima, uscita da una media di Udine giorni fa, quella di istituire un”ora di pace” a scuola, come si fa con quella di religione.
 Bergoglio, uomo attento allo spirito ma anche al corpo degli uomini, accetta di incontrarli e di rispondere alle domande di Maria, Michele, Luca, Costanza su conflitti, violenza, discriminazione. Su quest’ultimo punto cita lo scontro tra Macron e Le Pen come pessimo esempio di “non ascolto” ma la stoccata c’è anche per i Salvini di turno, anche se il papa nomi non ne fa mai: “Ci sono persone che usano le parole per discriminare e ferire: li chiamo terroristi delle chiacchiere”. Sulla guerra, dramma del mondo, l’accusa è soprattutto al traffico d’armi, arte in cui, come ci ha appena ricordato Rete Disarmo, l’Italia eccelle. E a proposito di bombe non risparmia Trump: ”Han chiamato quell’ordigno la madre di tutte le bombe. Ma una madre dona vita, quella regala morte. Ho provato vergogna”. Ma se c’è chi traffica in armi e chi traffica in droga, avverte Bergoglio, c’è chi traffica anche in esseri umani e non solo permettendo le stragi nel Mediterraneo: “C’è chi sfrutta il lavoro altrui e non solo in luoghi lontani: lo si fa qui, in Europa, in Italia. Lo si fa pagando chi lavora in nero e con assunzioni stagionali, per evitare la continuità. Questo sfruttamento è, per noi cattolici, peccato mortale”.
Bergoglio, uomo attento allo spirito ma anche al corpo degli uomini, accetta di incontrarli e di rispondere alle domande di Maria, Michele, Luca, Costanza su conflitti, violenza, discriminazione. Su quest’ultimo punto cita lo scontro tra Macron e Le Pen come pessimo esempio di “non ascolto” ma la stoccata c’è anche per i Salvini di turno, anche se il papa nomi non ne fa mai: “Ci sono persone che usano le parole per discriminare e ferire: li chiamo terroristi delle chiacchiere”. Sulla guerra, dramma del mondo, l’accusa è soprattutto al traffico d’armi, arte in cui, come ci ha appena ricordato Rete Disarmo, l’Italia eccelle. E a proposito di bombe non risparmia Trump: ”Han chiamato quell’ordigno la madre di tutte le bombe. Ma una madre dona vita, quella regala morte. Ho provato vergogna”. Ma se c’è chi traffica in armi e chi traffica in droga, avverte Bergoglio, c’è chi traffica anche in esseri umani e non solo permettendo le stragi nel Mediterraneo: “C’è chi sfrutta il lavoro altrui e non solo in luoghi lontani: lo si fa qui, in Europa, in Italia. Lo si fa pagando chi lavora in nero e con assunzioni stagionali, per evitare la continuità. Questo sfruttamento è, per noi cattolici, peccato mortale”.
 Nessun pontefice si era spinto così lontano, difendendo, in un certo senso, anche l’ormai sepolto articolo 18. E se Bergoglio condanna ritualmente il “Dio denaro” – come ogni papa ha sempre fatto – questa volta il monito non è solo ai mercanti nel tempio. E i diritti dei lavoratori, nel giorno in cui nella stessa città si manifesta per difenderli, diventano nelle parole di Francesco un elemento che non è avulso dal discorso sulla pace. I ragazzi sono commossi e con loro sindaci, amministratori locali e professori. 162 insegnanti gli consegnano un piccolo manuale di linee guida sull’educazione alla pace. Il Papa apprezza. I ragazzi applaudono. Fuori, un timido sole scaccia la pioggia.
Nessun pontefice si era spinto così lontano, difendendo, in un certo senso, anche l’ormai sepolto articolo 18. E se Bergoglio condanna ritualmente il “Dio denaro” – come ogni papa ha sempre fatto – questa volta il monito non è solo ai mercanti nel tempio. E i diritti dei lavoratori, nel giorno in cui nella stessa città si manifesta per difenderli, diventano nelle parole di Francesco un elemento che non è avulso dal discorso sulla pace. I ragazzi sono commossi e con loro sindaci, amministratori locali e professori. 162 insegnanti gli consegnano un piccolo manuale di linee guida sull’educazione alla pace. Il Papa apprezza. I ragazzi applaudono. Fuori, un timido sole scaccia la pioggia.
A destra “Mina” Anna Maria Mazzini, cantante famosa anche in Argentina. “Parole Parole” era la sigla finale di Teatro10 con Alberto Lupo nel 1972
Sopra: la GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb (MOAB)
Il futuro del Partito Giustizia e Sviluppo in Marocco
L’autorità marocchina non perde la vecchia abitudine di intralciare l’operato dei partiti e dei governi nel momento della loro maggiore popolarità
L’articolo Il futuro del Partito Giustizia e Sviluppo in Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Quando il giornalista ha un’etica
Qualche decennio fa si usava dire che il privato è pubblico. I tempi sono cambiati, forse per fortuna. E dunque su questo blog la presenza della dimensione privata è stata rarissima. Centellinata. Ci sono, però, momenti nei quali il privato assume un significato più che pubblico. In questo caso etico e deontologico. È questo ilContinua a leggere
La vita di strada
 All’ombra della Pineta Sacchetti un gruppo di abitanti prova a ricostruire la storia e l’identità di uno scampolo di città stretto tra Primavalle, il Forte Braschi, il parco con i suoi pini. Aneddoti e ricordi condivisi dalle generazioni più anziane entrano in sinergia con le pratiche artistiche delle generazioni più giovani – dalla street art alla danza hip hop – per una rinascita che dai muri e dalle serrande decorate si espande a ricostruire una comunità viva nel progetto Pinacci Nostri.
All’ombra della Pineta Sacchetti un gruppo di abitanti prova a ricostruire la storia e l’identità di uno scampolo di città stretto tra Primavalle, il Forte Braschi, il parco con i suoi pini. Aneddoti e ricordi condivisi dalle generazioni più anziane entrano in sinergia con le pratiche artistiche delle generazioni più giovani – dalla street art alla danza hip hop – per una rinascita che dai muri e dalle serrande decorate si espande a ricostruire una comunità viva nel progetto Pinacci Nostri.
“Oltre il velo dell’Iran” di Marco Crisafulli
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Oltre il velo dell’Iran” di Marco Crisafulli sembra essere il primo su Arabpress.
La Palestina protesta, ma nessuno la ascolta
«Protestiamo perché il mondo si accorga di quello che accade oggi nelle carceri israeliane», mi spiega Bassem. Vestito bene, una cartellina sottobraccio, una laurea in diritto internazionale all’Università di Betlemme. Bassem non è l’ultimo arrivato, insomma. Una domenica normale, questa,… Continue Reading →![]()
SABATO 6 MAGGIO A ROMA RIUNIONE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 20 MAGGIO
Sabato 6 maggio, a Roma, alle 11.00, in Via di Porta Labicana n. 56/a (Scalo San Lorenzo), si terrà la riunione preparatoria della manifestazione del 20 maggio. Di seguito, il comunicato della manifestazione e le adesioni pervenute sino ad oggi. PACE E LIBERTA’ PER IL POPOLO SIRIANO Da oltre sei anni la Siria è teatro […]![]()
Egitto: Islam e Cristianesimo in dialogo alla moschea Al Azhar
mcc43 Incontro interconfessionale come opportunità di lenire ferite storiche e moderare tensioni nella società egiziana. Per gli avversari del dialogo diretto e per la politica che interferisce nella religione, un un’occasione per criticare l’ateneo Al Azhar. Numerose le intenzioni di Papa Bergoglio per la sua visita in Egitto, come somma autorità del Cattolicesimo e come […]![]()
Crisi diplomatica fra Algeria e Marocco per 50 rifugiati siriani
La tensione si innalza sulla frontiera tra i due paesi a spese di un gruppo di rifugiati
L’articolo Crisi diplomatica fra Algeria e Marocco per 50 rifugiati siriani sembra essere il primo su Arabpress.
Artista egiziano realizza copia del Corano di 700 metri
Immagine in evidenza: Saad Mohammed a Belqina, April 26, 2017. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (Agenzie). L’artista egiziano Saad Mohammed ha trascorso ben tre anni della sua vita a lavorare per realizzare quello che spera sia il Corano più grande del mondo. L’artista, che ha dipinto a mano i motivi islamici sulle pareti e sui soffitti della sua […]
L’articolo Artista egiziano realizza copia del Corano di 700 metri sembra essere il primo su Arabpress.
Avvio della rassegna a Venezia “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare”
Parte mercoledì 10 maggio a Venezia “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” edizione 2017, la rassegna che racconta attraverso la fotografia il Mediterraneo come “sperimentale” luogo di relazioni dove le culture e le arti coesistono, dialogano, si intrecciano. La prima tra le esposizioni in programma per l’edizione 2017 è ospitata nelle sale dell’Hotel Giorgione dal […]
L’articolo Avvio della rassegna a Venezia “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” sembra essere il primo su Arabpress.
USA e Turchia: matrimonio difficile, divorzio impossibile
La contraddittoria alleanza con Curdi e Turchia pone agli Stati Uniti un grosso dilemma per il futuro della guerra in Siria e in Iraq
L’articolo USA e Turchia: matrimonio difficile, divorzio impossibile sembra essere il primo su Arabpress.
Mediterraneo Downtown 2017. Dialoghi, culture e società
 Settanta ospiti internazionali, cento volontari, trentacinque ore di programmazione tra talk show, incontri, presentazioni di libri e spettacoli: è tutto pronto per la prima edizione di “Mediterraneo Downtown”, il primo festival interamente dedicato alla scena contemporanea dell’area mediterranea.
Settanta ospiti internazionali, cento volontari, trentacinque ore di programmazione tra talk show, incontri, presentazioni di libri e spettacoli: è tutto pronto per la prima edizione di “Mediterraneo Downtown”, il primo festival interamente dedicato alla scena contemporanea dell’area mediterranea.
Il Medio Oriente: dove la libertà di stampa muore
Il nuovo rapporto di Reporter Senza Frontiere mostra come la regione si è classificata come la peggio in quanto a libertà di stampa negli ultimi 12 mesi
L’articolo Il Medio Oriente: dove la libertà di stampa muore sembra essere il primo su Arabpress.
Lo sciopero dei detenuti e l’autonomia decisionale palestinese
Lo sciopero palestinese assume l’idea di autonomia decisionale nazionale chiamando le forze vitali della società a raccogliersi intorno a essa per poter uscire dalla situazione di coma politico attuale
L’articolo Lo sciopero dei detenuti e l’autonomia decisionale palestinese sembra essere il primo su Arabpress.
WEB ARTS RESISTANCES – Tre film per raccontare una Roma resistente, inclusiva, creativa – Roma, 4-6 maggio 2017
 Tre cortometraggi per raccontare una Roma insolita, dove l’arte diventa strumento di resistenza e di rinascita urbana: dal Trullo rianimato da poesia e colori di autori anonimi e conosciuti, alla Pineta Sacchetti dove rivivono le storie di un quartiere raccontate sui muri e sulle serrande, alla sfida delle ragazze della street art, che anche all’ombra del Colosseo si fanno strada in un mondo ancora prevalentemente maschile, al MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, unico museo abitato del mondo, dove una variegata comunità multiculturale e autogestita sta trasformando un ex salumificio occupato sulla Prenestina in un presidio di cultura e diritti.
Tre cortometraggi per raccontare una Roma insolita, dove l’arte diventa strumento di resistenza e di rinascita urbana: dal Trullo rianimato da poesia e colori di autori anonimi e conosciuti, alla Pineta Sacchetti dove rivivono le storie di un quartiere raccontate sui muri e sulle serrande, alla sfida delle ragazze della street art, che anche all’ombra del Colosseo si fanno strada in un mondo ancora prevalentemente maschile, al MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, unico museo abitato del mondo, dove una variegata comunità multiculturale e autogestita sta trasformando un ex salumificio occupato sulla Prenestina in un presidio di cultura e diritti.
AVVISO IMPORTANTE
La riunione preparatoria per la manifestazione del 20 maggio si terrà sabato 6 maggio, alle 11.00, a Roma, in Via di Porta Labicana n. 56/a (Scalo San Lorenzo, lungo le Mura Aureliane). Sono invitati a partecipare gli individui e le organizzazioni che hanno sottoscritto l’appello e tutti quelli che intendano contribuire alla riuscita dell’iniziativa. Le […]![]()
I GIOVANI PALESTINESI D’ITALIA ALLA MANIFESTAZIONE DEL 20 MAGGIO A ROMA
I Giovani Palestinesi d’Italia, in questo periodo impegnati nel sostegno allo sciopero della fame intrapreso dai prigionieri palestinesi, hanno comunicato la loro adesione alla manifestazione del prossimo 20 maggio a Roma. Si tratta di un contributo particolarmente significativo, in quanto rappresentativo della solidarietà che storicamente unisce il popolo palestinese a quello siriano ed agli altri […]![]()
L’attacco aereo israeliano in territorio siriano
Cosa c’è dietro l’ultimo bombardamento, da parte di Israele, alla Siria? Quali nuove alleanze si stanno delineando in quella zona?
L’articolo L’attacco aereo israeliano in territorio siriano sembra essere il primo su Arabpress.
Sulla sofferenza in Yemen
Con le parole del giornalista Al-Zurqah, una riflessione sui crimini perpetrati dagli Houthi e i suoi alleati contro il proprio Paese e i suoi abitanti
L’articolo Sulla sofferenza in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
Questa foto di profughi è stata scattata il 17 marzo al confine italo-francese?
Una foto che mostra una presunta ondata di rifugiati in marcia verso la Francia è stata condivisa sui social più di 2000 volte.
La Shura saudita contro le donne
L’insistenza di alcuni membri del Consiglio della Shura nel rigettare la richiesta da parte delle donne è un tentativo disperato di opporsi alle tendenze della società e dello Stato
L’articolo La Shura saudita contro le donne sembra essere il primo su Arabpress.
LA MOSTRA DI CAESAR A FIRENZE
Con il patrocinio del Comune di Firenze In collaborazione tra Comunità araba Siriana e Harmoon Center for Contemporary Studies Biblioteca Oblate, Firenze Via dell’ Oriuolo, 24 Primo giorno Gioverdì 04/05/2017 Ore 16.00: Apertura della mostra Nome in codice codice Caesar. Intervento della Comunità araba siriana Intervento del Comune di Firenze (da confermare) Ore 17.00-19.00: […]![]()
1 maggio sulla T-shirt
 Rana Plaza, quattro anni dopo. Il 24 aprile del 2013, una settimana prima della festa internazionale
Rana Plaza, quattro anni dopo. Il 24 aprile del 2013, una settimana prima della festa internazionale
di chi lavora, un edifico di cinque piani crollava alla periferia industriale di Dacca, Bangladesh. 1.134 morti e 2mila feriti. L’edificio ospitava cinque fabbriche di abbigliamento che producevano per marchi europei e nordamericani, alcuni dei quali fecero di tutto per non essere coinvolti nel crollo e dunque nei risarcimenti. Non è certo stato l’unico “incidente” (fu preceduto dagli incendi nella fabbrica Ali Enterprises in Pakistan e alla Tazreen Fashions in Bangladesh che uccisero più di 350 persone) ma il dossier Rana Plaza, anche se con il pagamento di un prezzo altissimo in vite umane, ha però segnato un punto di svolta. Un punto di svolta, deve essere ben chiaro, dovuto alla resistenza delle famiglie dei lavoratori di quelle fabbriche e a un’attività sindacale locale fortissima quanto rischiosa. Una resistenza e una lotta sindacale che forse non avrebbe raggiunto i loro obiettivi se non fossero state accompagnate da campagne internazionali e dalla solidarietà di altri lavoratori, attivisti, comuni cittadini.
Alcuni programmi innovativi sono stati sviluppati per evitare nuovi disastri e per garantire i risarcimenti alle famiglie. Il primo riguarda l’Accordo sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi che è un programma quinquennale, giuridicamente vincolante, col quale i firmatari si impegnano a migliorare la sicurezza delle fabbriche con cui lavorano. Lanciato dopo un mese dal crollo e non senza una forte pressione internazionale sui marchi, dopo sei mesi aveva più di 200 firmatari. L’Accordo per il risarcimento delle vittime del disastro ha terminato il suo percorso nel 2015 dopo una battaglia durata due anni per ricevere il denaro e per l’istituzione di un fondo medico fiduciario per sostenere i sopravvissuti feriti. Ma, dicono alla Campagna Abiti Puliti – la sezione italiana della Rete internazionale Clean Clothes – «Questi risultati hanno bisogno di essere costantemente difesi e sviluppati, non erosi e invertiti» perché – sostengono – le promesse di un cambiamento strutturale «non sono ancora divenute realtà: restano i problemi sistematici di una concorrenza spietata, bassi salari, repressione sindacale, un diritto del lavoro debole e l’impunità legale».
E’ anche per questo che la Campagna invita le aziende dell’abbigliamento e delle calzature che non l’hanno ancora fatto a unirsi alle 17 che già sono in linea con una nuova importante iniziativa per la trasparenza che impegna i marchi a pubblicare le informazioni che permettano a lavoratori e consumatori di scoprire dove e come vengono realizzati i loro prodotti. Un rapporto di 40 pagine (“Segui il filo”) chiede alle aziende di adottare un modello che garantisca trasparenza nella catena di fornitura dell’abbigliamento e delle calzature. «Le aziende che vi aderiscono – dicono gli attivisti di Abiti Puliti* – si impegnano a pubblicare informazioni che identifichino le fabbriche che realizzano i loro prodotti, rimuovendo un ostacolo fondamentale per sradicare pratiche di lavoro abusive e aiutando a prevenire disastri come quello del Rana Plaza». Delle 72 aziende contattate, 17 saranno perfettamente in linea con gli standard dell’iniziativa entro il 31 dicembre 2017. «La trasparenza è uno strumento molto potente per promuovere la responsabilità di impresa verso i lavoratori del tessile lungo tutta la catena di fornitura e permette alle organizzazioni e ai lavoratori di avvertire le aziende riguardo agli abusi nella fabbriche fornitrici. Facilita il ricorso più veloce a meccanismi di reclamo per abusi dei diritti umani». Ed è anche un modo per rendere più responsabili i consumatori (alcune aziende hanno dichiarato che rivelare le informazioni potrebbe svantaggiarle commercialmente…).
E perché i consumatori sappiano ecco la lista dei refrattari: American Eagle Outfitters, Canadian Tire, Carrefour, Desigual, DICK’S Sporting Goods, Foot Locker, Hugo Boss, KiK, MANGO, Morrison’s, Primark, Sainsbury’s, The Children’s Place e Walmart non si sono impegnate a pubblicare nulla. Inditex si è rifiutata di pubblicare le informazioni, ma mette a disposizione i dati. Armani, Carter’s, Forever 21, Matalan, Ralph Lauren Corporation, Rip Curl, River Island, Shop Direct, Sports Direct e Urban Outfitters non hanno risposto alla coalizione e non pubblicano alcuna informazione.
* Fa parte della coalizione composta da: Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, IndustriALL Global Union, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, International Trade Union Confederation, Maquila Solidarity Network, UNI Global Union e Worker Rights Consortium.
Un’occasione per risolvere la crisi libica
Il dialogo tra Russia e Stati Uniti potrebbe portare a una soluzione per la crisi libica
L’articolo Un’occasione per risolvere la crisi libica sembra essere il primo su Arabpress.
Novità editoriale: Oltre le mura di Baghdad
Marika Guerrini, scrittrice, indologa, storica dell’Afghanistan, studiosa di antropologia culturale e pedagogica è l’autrice del romanzo “Oltre le mura di Baghdad”, che racconta le vicende di Richard Schwan, giovane giornalista del New York Times e un inviato di guerra. Prima freelance, poi embedded, il giornalista compie un viaggio che inizia e finisce a New York e che passa per Los Angeles, Istanbul, Baghdad, […]
L’articolo Novità editoriale: Oltre le mura di Baghdad sembra essere il primo su Arabpress.
Il Regno Unito, uno dei maggiori fornitori di armi, vuole rendere illegale il boicottaggio del settore
Il Regno Unito vende armi ai paesi con una disastrosa situazione dei diritti umani; il governo vuole proibire il boicottaggio di armi provenienti da Israele.
Cucina libica: salsa di yogurt con aglio, peperoncino e coriandolo
Dalla Libia, un condimento dal sapore forte e fresco allo stesso tempo: la salsa allo yogurt con aglio, peperoncino e coriandolo! Ingredienti: 250g di yogurt intero non dolce 2-3 spicchi d’aglio 1-2 peperoncini un mazzetto di coriandolo fresco tritato sale a piacere Preparazione: Servendosi di un mixer, tritare insieme gli spicchi d’aglio e il peperoncino, […]
L’articolo Cucina libica: salsa di yogurt con aglio, peperoncino e coriandolo sembra essere il primo su Arabpress.
SOLIDARIETA’ VUOL DIRE ANCHE LOTTA CONTRO IL DECRETO MINNITI – ORLANDO
Germano Monti La manifestazione promossa per il prossimo 20 maggio a Roma in solidarietà con il popolo siriano e gli altri popoli del Vicino Oriente vittime di dittature, guerre e terrorismo vede, fra i suoi punti fondamentali, un aspetto molto particolare, vale a dire la denuncia del decreto “Minniti-Orlando”, il cui oggetto non è […]![]()
Prigionieri (in Egitto)per libertà d’espressione
Francia…focus sull’estremismo
Di Fatima Yassin. Al-Araby Al-Jadeed (25/04/2017). Traduzione e sintesi di Gemma Baccini. Il Fronte Nazionale ha un programma “nazionale” e una visione politica del governo che è un miscuglio sciovinista che si focalizza in maniera eccessiva sull’ interno e sulla protezione dei confini, e si basa sull’adozione di mezzi per espellere i migranti o per prendere […]
L’articolo Francia…focus sull’estremismo sembra essere il primo su Arabpress.
Doppio linguaggio
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Doppio linguaggio sembra essere il primo su Arabpress.
La rivoluzione di Francesco su TED
Su TED. Anche il papà ha fatto un TED Talk! È un uomo sorprendente, come la sua capacità di ‘abbassarsi con umiltà’ e usare il linguaggio della piattaforma scelta o proposta. 17 minuti da ascoltare dal primo all’ultimo. Nel tempo della guerra mondiale a pezzi, papa Francesco parla di futuro, di tu e noi.Continua a leggere
Mohammed Hassan Alwan, vincitore dell’Arabic Booker 2017
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Mohammed Hassan Alwan, vincitore dell’Arabic Booker 2017 sembra essere il primo su Arabpress.
I bombardamenti turchi in Siria e Iraq
Un’azione di forza per fare in modo che inizi un nuovo capitolo della politica USA?
L’articolo I bombardamenti turchi in Siria e Iraq sembra essere il primo su Arabpress.
Paese che vai, accuse di brogli che trovi: ora tocca alla Turchia
mcc43 Prima della consultazione è un brontolio, a urne chiuse un tuono che sale dalle file dei perdenti negli articoli dei giornali e nei post dei social media con accuse di irregolarità, frodi, brogli. Il caso più eclatante fu il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Austria. In maggio 2016 vince Alexander Van Der Bellen; il […]![]()
ATTENZIONE: ERRATA CORRIGE
LA MAIL PER INVIARE LE ADESIONI ALLA MANIFESTAZIONE DEL 20 MAGGIO E’ [email protected]. ![]()
Tunisia, il difficile equilibrio tra tradizione e modernità al tempo dei social
 Nelle ultime settimane sui social tunisini si sono scatenati infiammati dibattiti fra tradizionalisti e modernisti, islamisti e laici. Omosessualità, scienza, libertà di espressione, anche quando ci si riferisce ai precetti religiosi. Un segnale di vitalità dall’esito non scontato, tra radicalizzazione islamica e resistenza in nome della modernità. Chi non si lascia distrarre dalle battaglie per i propri diritti sono e continuano a essere le donne.
Nelle ultime settimane sui social tunisini si sono scatenati infiammati dibattiti fra tradizionalisti e modernisti, islamisti e laici. Omosessualità, scienza, libertà di espressione, anche quando ci si riferisce ai precetti religiosi. Un segnale di vitalità dall’esito non scontato, tra radicalizzazione islamica e resistenza in nome della modernità. Chi non si lascia distrarre dalle battaglie per i propri diritti sono e continuano a essere le donne.
Tunisia: le riforme economiche non placano le rivolte sociali
Clara Capelli Cooperation and Development Network – Pavia Come altre economie della regione, la Tunisia continua a muoversi su due sentieri che solo raramente si incontrano e quasi mai comunicano. Da una parte il governo guidato da Youssef Chahed cerca di consolidare i conti pubblici e stabilizzare i dati macroeconomici, programma sostenuto da diverse organizzazioni internazionali quali l’Unione europea, la Banca […]
Referendum in Kurdistan
In caso di esito positivo a cambiare non sarà soltanto la cartina geografica, ma l’intero sistema di influenze nella regione
L’articolo Referendum in Kurdistan sembra essere il primo su Arabpress.
L’ascesa dell’estrema destra in Europa
Al momento l’Europa è divisa tra una parte anti-immigrati, nazionalista, conservatrice e anti-Islam, e un’altra una che sostiene il pluralismo culturale e religioso
L’articolo L’ascesa dell’estrema destra in Europa sembra essere il primo su Arabpress.
Mohammed Hasan Alwan vince il Premio internazionale per la narrativa araba 2017
Lo scrittore saudita Mohammed Hasan Alwan ha vinto la decima edizione del Premio internazionale per la narrativa araba 2017 (IPAF) con il suo romanzo Una morte piccola, pubblicato dall’editore libanese Dar al-Saqi. Alwan, nato nel 1979 a Riyadh ma che vive a Toronto, in Canada, è autore di altri quattro romanzi e di un saggio […]![]()
Al Museo Salinas
SABATO 20 MAGGIO A ROMA PER LA PACE, LA DEMOCRAZIA E LA GIUSTIZIA IN SIRIA E IN TUTTO IL VICINO ORIENTE, PER L’ACCOGLIENZA A MIGRANTI E RIFUGIATI, CONTRO IL DECRETO MINNITI-ORLANDO
Sabato 22 aprile si è riunito il comitato promotore della manifestazione in solidarietà con il popolo siriano. La riunione ha affrontato essenzialmente alcuni aspetti organizzativi e logistici, a partire dalla consapevolezza dei tempi molto stretti, ma anche due nodi politici di fondo, quali quello relativo alla chiarezza in merito alle responsabilità della tragedia siriana e […]![]()
La Tunisia e la democrazia “emozionale”
Se la Tunisia vuole uscire dalla crisi sociale ed economica, dovrà compiere un ulteriore passo verso una democrazia più razionale
L’articolo La Tunisia e la democrazia “emozionale” sembra essere il primo su Arabpress.
Anime dell’Islam
LE DIVERSE ANIME DELL’ISLAM
Ciclo di conferenze organizzato dal 27 aprile al 25 maggio 2017
dalla Casa della Cultura, in collaborazione con il Centro di cultura Italia-Asia
“L’Islam in Afghanistan”
Giovedì 11 maggio, ore 21.00
Relatore: Emanuele Giordana
curatore del volume “A Oriente del Califfo: la conquista dello Stato islamico dell’islam non arabo”, collettanea di Lettera22 per Rosenberg&Sellier in libreria a maggio
“L’Islam in Indonesia”
Martedì 16 maggio, ore 21.00
Relatore: Antonio Cuciniello
“Sufismo e confraternite in Turchia nel XX secolo”
Giovedì 25 maggio, ore 18.00
Relatrice: Anna Maria Martelli
Sede degli incontri: Casa della Cultura – Via Borgogna 3, Milano
MM1 San Babila – Ingresso libero
Per informazioni: 02 79.55.67 – 02 76.00.53.83 – [email protected]
Siti web di riferimento
Centro di cultura Italia-Asia: www.italia-asia.it
Casa della Cultura: www-casadellacultura.it
Associazione Casa della Cultura – Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MM1 – San Babila)
02 795567 – 02 76005383 – fax 02 76008247
e-mail: [email protected] – www-casadellacultura.it
C.F. 80115850150 – P.IVA 13307640154
Referendum in Turchia e il destino di Assad
Cosa accomuna il popolo siriano a quello turco chiamati entrambi a decidere del proprio destino?
L’articolo Referendum in Turchia e il destino di Assad sembra essere il primo su Arabpress.
Khaled Khalifa, Faiza Guène, Doaa el-Adl e Samir Harb a Mediterraneo Downtown a Prato
Quindi a Prato dal 5 al 7 maggio c’è un Festival dedicato alle arti, alle società e alla cultura del Mediterraneo (e non solo, perché in realtà ci saranno anche ospiti da alcuni Paesi del Caucaso), che quest’anno è giunto alla sua seconda edizione. Tra i numerosi ospiti giornalisti, ricercatori, politologi, analisti, ci sono anche […]![]()
I segreti della bomba
 Dopo una settimana ora anche i militari afgani possono visitare il sito dove è esplosa Moab. Mentre i talebani assaltano una base dell’esercito e fanno strage di soldati. Viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Dopo una settimana ora anche i militari afgani possono visitare il sito dove è esplosa Moab. Mentre i talebani assaltano una base dell’esercito e fanno strage di soldati. Viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Soltanto venerdi l’esercito afgano ha potuto entrare nell’area dove, giovedi scorso, è stata sganciata la bomba da 11 tonnellate di esplosivo che gli americani hanno sganciato nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangarhar. Ma alcuni video girati nei dintorni a due giorni dallo scoppio e i primi che ora cominciano a girare dopo che gli americani hanno tolto i sigilli dall’area del bombardamento, mostrano le prime distruzioni e gli effetti di un ordigno considerato secondo solo alla bomba atomica: il più potente ordigno non nucleare i cui effetti sono ancora segreti e probabilmente tali rimarranno. Conditi da dichiarazioni, dati e simil certezze – tra cui le “scuse” di un alto comandante americano per possibili vittime civili – che conviene continuare a prendere con le molle. Ma mentre i primi soldati afgani ricevevano il permesso di vistare l’aera, cinquecento chilometri più a Nord, nella provincia di Balkh, i talebani mettevano a segno il più sanguinoso attacco contro un obiettivo militare nazionale. Lasciando sul terreno oltre cento soldati morti.
La dinamica che ricostruisce l’attacco di venerdi alla base militare dove si trova il 209 Shaheen Corps nella provincia di Balkh, città circondata da una cintura della guerriglia in turbante ormai da diversi anni, è ancora oggetto di ricostruzione. Quel che è certo è che la guerriglia, che ha rivendicato l’attacco condotto con kamikaze e un commando armato (una decina tra loro sono stai uccisi), ha atteso che i militari fossero alla preghiera del venerdi e dunque in un momento di riposo alla una e mezza mentre altri commilitoni erano in pausa pranzo. Sono riusciti a passare i check point, probabilmente aiutati da spie interne, e hanno fatto strage a colpi di kalashnikov sparati da mezzi militari che hanno forse indotto in errore i controlli dell’ingresso. I morti ufficialmente sarebbero un centinaio ma diverse fonti fissano il bilancio tra i 130 e i 140 morti con almeno una sessantina di feriti. Nelle prime ore le cifre erano molto più basse: una decina si era detto all’inizio, forse stimando che nascondere la verità avrebbe ridotto l’effetto dell’azione.
Mezze bugie, aperte falsità e propaganda di guerra
Le mezze bugie, quando non le aperte falsità, sono una costante della propaganda di guerra e l’Afghanistan non fa eccezione. E eccezione non fa la vicenda della GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Moab), la madre di tutte le bombe. Il refrain, in attesa di un rapporto ufficiale definitivo sugli effetti della bomba, è stato fin dall’inizio che l’ordigno non ha causato vittime civili, dato certificato anche dal ministero della Sanità. Ma alcuni video girati fuori dall’area recintata dagli americani e immediatamente vicini alla zona della deflagrazione, mostrano cadaveri con segni evidenti di ustioni, case distrutte e un terreno violentato dal calore e da uno spostamento d’aria che, dicono le cronache di quella bomba, può uccidere anche a grande distanza. Venerdi scorso però, a poche ore dall’esplosione, gli americani hanno sentito il bisogno di un’excusatio anticipata nel caso di “possibili vittime civili”. Lo racconta Luca Lo Presti, presidente della Onlus Pangea, una delle poche organizzazioni italiane (con Emergency) rimaste ad operare in Afghanistan e che, a Kabul, ha progetti di microcredito e protezione di bambini e donne. “La notizia della bomba l’ho avuta dall’Italia la sera di giovedi – dice Lo Presti – nonostante fossi a Kabul dove quella sera ho dormito da una famiglia afgana. Sentivo una pena incredibile a vedere i fragili corpi di quei bambini riposare ignari nei loro letti. Poi, il giorno dopo, vedo in televisione un alto grado dell’esercito americano chiedere scusa nel caso la bomba avesse prodotto effetti collaterali sui civili…”. Ma di civili morti non si parla e dall’area blindata escono notizie col contagocce mentre l’ex presidente Karzai – l’unico ad alzare la voce – accusa il governo (che ora dice addirittura che la bomba è stata sganciata sotto la sua supervisione) di aver rinunciato alla sua sovranità territoriale per consentire a Trump di testare nuovi ordigni.
Ma quel che più appare comico, se non del tutto tragico, è che le autorità hanno fatto nomi, cognomi, origine etnica e ruolo nelle organizzazioni eversive (tra cui i talebani pachistani) di alcuni tra i novanta cadaveri di appartenenti allo Stato islamico rimasti sotto la bomba sganciata sul villaggio fantasma di Assadkhil nell’area conosciuta come Mohmand Dara. Come abbiano ritrovato corpi o anche solo ossa, e dunque il Dna, di queste vittime è un vero mistero che gli effetti della bomba, da quel poco che si vede nei primi video che circolano, rendono ancora più che tragicomico.
E mentre la guerra infuria viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Corsa al rialzo
In Afghanistan c’è una corsa al rialzo: a chi, si potrebbe dire, la spara più grossa. Con la differenza che qui non sono battute e boutade ma proiettili veri che uccidono e feriscono in una terra dove il “Nuovo Grande Gioco” sembra non solo ritornato prepotentemente alla ribalta ma vicino al punto più basso della sua tragica storia. Una storia centenaria se il Grande Gioco tra lo Zar di tutte le russie e la Corona britannica iniziò nell’800 per poi proseguire, nel secolo scorso, con la Guerra Fredda e adesso con un nuovo episodio il cui terreno di conquista è sempre quello: l’Afghanistan e la porta maledetta tra l’Asia centrale, il Medio oriente e il subcontinente indiano. La riedizione di un gioco condotto con l’usuale brutalità e meschinità che l’ha sempre contraddistinto.
La corsa al rialzo ha come protagonisti diversi attori: l’azione di venerdi a Balkh da parte dei talebani sembra indicare il tentativo non solo di affermare la superiorità militare nei confronti del governo e dell’esercito nazionali, ma anche di dimostrare agli affiliati al Califfato di Al-Bagdadi (che sei settimane fa hanno ucciso 50 soldati nell’ospedale militare di Kabul a due passi dall’ambasciata americana) che il jihad contro l’invasore stranieri e i suoi alleati afgani è roba loro e non di questi nuovi guerriglieri in parte stranieri, in parti desunti da ex talebani spesso espulsi dalle file del movimento che fa capo a mullah Akhundzada.
 Ma i due veri protagonisti sembrano al momento ancora i vecchi attori della Guerra Fredda che, cambiati di poco gli abiti di allora, si contendono la scena centroasiatica e dunque l’Afghanistan, il suo boccone più succulento. La bomba sganciata giovedi, prima ancora dei militanti del Califfato, è sembrata in realtà diretta altrove per affermare la supremazia degli Stati Uniti nei confronti della Russia di Putin che, in quelle ore, stava preparando il punto di arrivo di una maratona diplomatica durata almeno quattro anni. Venerdì mattina infatti, i delegati di Cina, India, Pakistan, Afghanistan e delle cinque repubbliche centroasitiche dell’ex Urss dovevano incontrarsi per una conferenza internazionale proprio sul futuro dell’Afghanistan cui anche Washington era stata inviata e a cui aveva sdegnosamente rifiutato di partecipare. Questa offensiva russa, iniziata negli ultimi anni dell’era Karzai e proseguita pur con molte difficoltà, nell’era Ghani-Abdullah (i due “copresidenti” attuali), ha molto infastidito gli americani. La bomba non sembra dunque una coincidenza ma, come l’attacco ieri dei talebani per mostrare i pugni a Daesh, la sottolineatura di una primogenitura sul Paese dell’Hindukush. “Roba nostra, sembra aver detto la GBU-43/B Moabc on i suoi 11mila chili di esplosivo.
Ma i due veri protagonisti sembrano al momento ancora i vecchi attori della Guerra Fredda che, cambiati di poco gli abiti di allora, si contendono la scena centroasiatica e dunque l’Afghanistan, il suo boccone più succulento. La bomba sganciata giovedi, prima ancora dei militanti del Califfato, è sembrata in realtà diretta altrove per affermare la supremazia degli Stati Uniti nei confronti della Russia di Putin che, in quelle ore, stava preparando il punto di arrivo di una maratona diplomatica durata almeno quattro anni. Venerdì mattina infatti, i delegati di Cina, India, Pakistan, Afghanistan e delle cinque repubbliche centroasitiche dell’ex Urss dovevano incontrarsi per una conferenza internazionale proprio sul futuro dell’Afghanistan cui anche Washington era stata inviata e a cui aveva sdegnosamente rifiutato di partecipare. Questa offensiva russa, iniziata negli ultimi anni dell’era Karzai e proseguita pur con molte difficoltà, nell’era Ghani-Abdullah (i due “copresidenti” attuali), ha molto infastidito gli americani. La bomba non sembra dunque una coincidenza ma, come l’attacco ieri dei talebani per mostrare i pugni a Daesh, la sottolineatura di una primogenitura sul Paese dell’Hindukush. “Roba nostra, sembra aver detto la GBU-43/B Moabc on i suoi 11mila chili di esplosivo.
Pachistani afgani, i tradizionali protagonisti di questa guerra locale, sembrano invece, in questo momento, del tutto in sordina. Al netto dei litigi tra le due capitali, all’ordine del giorno con vigore ormai da due anni, entrambi sembrano aver ormai perso del tutto il controllo della situazione. Islamabad è stata bypassata da russi e americani che trattano, più o meno segretamente direttamente con la guerriglia, e Kabul è ormai così schiacciata sulle posizioni di Washington (da cui spera di ricevere altro denaro e nuove forze militari) che sembra ormai davvero solo una marionetta in mani altrui. Quanto alla Nato, anche l’Alleanza di volenterosi (tra cui mille soldati italiani di stanza a Herat) sembra aver ormai totalmente lasciato agli americani ogni strategia senza nemmeno salvare le apparenze, come ai tempi della missione Isaf. Ora la missione Resolute Support sembra solo la misera foglia di fico su decisioni che si prendono a Washington e assai poco a Bruxelles. Dove al massimo è richiesto di rispondere soltanto “Signorsì”.
Referedum costituzionale : la Turchia ad un bivio
Erdoğan, ancora una volta, è uscito vincitore dalle urne. Ma il 16 Aprile, allo stesso tempo, è stata una giornata che ha messo a nudo la fragilità del suo potere che, nonostante la vittoria, appare in bilico come non mai…. Continue Reading →![]()
I laici turchi dovrebbero smetterla di nascondersi dietro Ataturk
All’indomani del referendum, l’élite laica in Turchia è più preoccupata della fine del lascito tirannico di Ataturk che dell’indebolimento della democrazia
L’articolo I laici turchi dovrebbero smetterla di nascondersi dietro Ataturk sembra essere il primo su Arabpress.
In Turchia non c’è più alcuna possibilità di opposizione
Per un soffio, Erdogan ha ottenuto quello che voleva e non è in vena di compromessi. Tanto meno lo sono le opposizioni.
La settimana di Arabpress in podcast – XX puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XX puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina libanese: sfiha, fagottini ripieni di carne speziata
Con la ricetta di oggi andiamo in Libano, a scoprire un’altra delle tante pietanze dello street food mediorientale: gli sfiha, fagottini ripieni di carne speziata! Ingredienti: Per la pasta: 500g di farina 230ml di acqua tiepida 2 cucchiai di zucchero 1 cucchiaio di latte in polvere 2 cucchiaio di lievito istantaneo 1 pizzico di bicarbonato 1 pizzico […]
L’articolo Cucina libanese: sfiha, fagottini ripieni di carne speziata sembra essere il primo su Arabpress.
Trump vs Putin via Kabul
La bomba americana GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Moab), sganciata giovedì 13 aprile, ha colpito sì il distretto di Achin della provincia orientale afgana del Nangarhar, ma lo sguardo degli osservatori vi ha colto un messaggio rivolto ad altri. In particolare, alla Corea del Nord, uno dei punti di tensione più elevati del continente asiatico.
Una serie di apparenti coincidenze invita però a una riflessione d’altro tipo che forse può essere utile considerare. E che fa dell’Afghanistan, ancora una volta, non solo uno dei maggiori terreni di scontro col terrorismo di matrice islamica – obiettivo dell’azione – ma anche il teatro di un confronto tra due potenze in contrapposizione su varie caselle dello scacchiere geopolitico internazionale: gli Stati Uniti e la Russia.
Il 13 aprile non era infatti un giorno come un altro, ma la vigilia della terza Conferenza sul futuro dell’Afghanistan organizzata dal Cremlino nella capitale russa. Nelle due tornate precedenti la diplomazia di Vladimir Putin aveva convocato solo alcuni attori regionali ed era assente il protagonista principale – l’Afghanistan. Il 14 aprile doveva invece segnare il vero e proprio rientro sulla scena afgana della Russia – dopo l’uscita dell’URSS da quel Paese nel 1989, dieci anni dopo l’invasione e nel momento in cui l’impero sovietico si avviava alla disintegrazione.
Per diversi anni i russi hanno tenuto un profilo molto basso sull’Afghanistan, limitandosi a criticare in qualche intervista l’intervento della Nato e, soprattutto, a mettere in guardia l’Occidente sui rischi insiti nella “tomba degli imperi”, come l’Afghanistan è stato più volte soprannominato per la capacità di infliggere sconfitte militari agli eserciti più forti. Ma negli ultimi tre-quattro anni Mosca ha tentato, con qualche successo, di riaffaccciarsi sulla scena: promesse d’aiuto e regali di armamenti hanno accompagnato una morbida e sottile offensiva diplomatica con le autorità di Kabul….(segue)
Questo articolo prosegue su Aspeniaonline
Radicalismo, violenza e islamisti
L’analisi dei movimenti radicali richiede lo studio del contesto storico in cui essi emergono, delle trasformazioni interne che li hanno formati e delle variabili esterne che li governano
L’articolo Radicalismo, violenza e islamisti sembra essere il primo su Arabpress.
“I movimenti delle donne in Nord Africa e Medio Oriente: percorsi e generazioni femministe a confronto”
A cura di Renata Pepicelli e Anna Vanzan
L’articolo “I movimenti delle donne in Nord Africa e Medio Oriente: percorsi e generazioni femministe a confronto” sembra essere il primo su Arabpress.
Gli arabi cristiani: cittadini come gli altri
Un’eguaglianza reale rispecchia tanto la storia quanto le speranze per un futuro migliore
L’articolo Gli arabi cristiani: cittadini come gli altri sembra essere il primo su Arabpress.
2° edizione del concorso JJEM (Giovani Giornalisti Nel Mediterraneo)
Per la sua seconda edizione, il concorso JJEM, Giovani giornalisti nel Mediterraneo, allarga i propri orizzonti, e invita i giovani video reporter che vivono in Algeria, Egitto, Francia, Italia, Libano, Marocco e Tunisia a postare sulla piattaforma Web…
Intervista a Shukri Al-Mabkhout #LibriCome
Nella cornice dell’Auditorium di Roma, per il Festival di letteratura #LibriCome 2017, intervistiamo lo scrittore tunisino Shukri al-Mabkhout, autore del romanzo L’Italiano, vincitore dell’International Prize for Arabic Fiction (edizioni e/o).
L’articolo Intervista a Shukri Al-Mabkhout #LibriCome sembra essere il primo su Arabpress.
Il conflitto internazionale getta le basi per la spartizione della Siria
Nessuna risoluzione unitaria sembra realmente all’orizzonte, e si concretizza sempre di più l’ipotesi di una divisione territoriale
L’articolo Il conflitto internazionale getta le basi per la spartizione della Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Marwan Barghouti al NYT: Perché 1200 Prigionieri Palestinesi in sciopero della fame
mcc43 Perché siamo in sciopero della fame nelle carceri israeliane Di Marwan BARGHOUTI NYT 16 Aprile 2017 Prigione di Hadarim, Israele – Dopo aver trascorso gli ultimi 15 anni in una prigione israeliana, sono stato sia un testimone sia vittima del sistema illegale di Israele che pratica arbitrari arresti di massa e maltrattamento dei prigionieri […]![]()
Siria: una guerra (anche) di simboli
Il 17 aprile ricorre l’anniversario dell’ indipendenza della Siria, ottenuta dai francesi nel 1946 proprio in questa data. La bandiera adottata allora dalla neonata repubblica siriana era il tricolore verde,bianco e nero con le tre stelle rosse sulla banda centrale. Oggi,… Continue Reading →![]()
Tehran fuori cliché
https://ilmanifesto.it/teheran-fuori-cliche/
Effetti della bomba: off limits anche per gli afgani
 A quasi una settimana dal lancio della “madre di tutte le bombe”, sganciata il 13 aprile nel distretto Achin – provincia orientale del Nangarhar -, l’area resta completamente sigillata sia per i giornalisti
A quasi una settimana dal lancio della “madre di tutte le bombe”, sganciata il 13 aprile nel distretto Achin – provincia orientale del Nangarhar -, l’area resta completamente sigillata sia per i giornalisti
ficcanaso sia per lo stesso esercito afgano, escluso da un perimetro guardato a vista dalle forze americane di stanza in Afghanistan.
Nonostante l’acquiescenza generalizzata con cui la bomba è stata accolta sia dal governo (che l’ha anzi definita una giusta azione in appoggio agli operativi dell’esercito afgano) sia dalla stampa locale, qualche sospetto si è fatto strada ad esempio tra i giornalisti di ToloNews, un’emittente privata a larga diffusione, che ha tentato di andar oltre la versione ufficiale che a oggi attesta un successo con 99 cadaveri di membri dello Stato islamico spazzati via dalla bomba sganciata sul villaggio di Assadkhil nell’area conosciuta come Mohmand Dara. Il giornalista Karim Amini, che ha pubblicato anche una foto della “frontiera” attorno al cratere causato da un ordigno da 11 tonnellate di esplosivo, sostiene che lo Stato islamico è ancora attivo nella zona da cui spara razzi sull’esercito afgano che, in mancanza di una presa di visione di quanto è successo nella zona colpita, deve accontentarsi della reazione rabbiosa dei jihadisti.
Ma la domanda vera cui per ora non c’è risposta riguarda le vittime civili. Il raid puntava a una serie di tunnel costruiti dai mujaheddin con soldi della Cia durante gli anni dell’invasione sovietica e poi diventati alloggio dei jihadisti d’importazione del Califfato, attivi soprattutto nella provincia del Nangarhar, al confine col Pakistan. E qualche sospetto arriva dalle parole di un membro del Consiglio provinciale che dice al giornalista che dovrebbe esserci libero accesso alle organizzazioni umanitarie per consentire alle popolazioni sfollate di far ritorno nei loro villaggi. Amini non approfondisce così che non è chiaro se si tratti solo delle famiglie sfollate per la presenza dello Stato islamico, noto per la sua brutalità, o anche per gli effetti della guerra: sia per gli operativi militari afgani e americani nell’area, sia anche per effetto della bomba. La versione ufficiale è che non ci sono state vittime civili ma si sono trovati solo militanti jihadisti tra i cadaveri rinvenuti (resta da capire come si è arrivati al conteggio e al riconoscimento visto che la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast è in grado di uccidere un uomo col solo spostamento d’aria ed è in grado di perforare cemento armato sino a 100 metri di profondità). La versione ufficiale sosteneva anche che nell’aera bombardata viveva una sola famiglia, evacuata prima del raid. E’ però inevitabile far mente locale non solo sulle vittime civili di questa guerra (in aumento rispetto agli anni precedenti da quando, dal 2009, la missione Onu a Kabul ha iniziato a tenerne il bilancio): tra i tanti episodi c’è quello dell’ottobre 2016 quando un drone ha bombardato alle tre del mattino una guest house nel villaggio di Shadal Bazar, distretto di Achin, uccidendo almeno 15 persone convenute per celebrare un anziano di ritorno dalla Mecca. Allora l’Onu disse che erano civili mentre le autorità locali li avevano bollati come islamisti tra cui non c’erano né donne né bambini anche se un giornalista del Guardian, che aveva fatto vista ai feriti dell’ospedale di Jalalabad, trovò tra loro un ragazzino di 12 anni e due anziani.
Le attività dei droni sono segrete e anche sui bombardamenti in atto nel Sud del Paese da mesi c’è una cortina di silenzio. Identico a quello che ora circonda gli effetti della prima bomba di Donald Trump.
Tre ragazze palestinesi di Tel Aviv: In between
mcc43 Capita di fidarsi della critica positiva e del titolo di un film. Leggendo che l’opera prima “Libere disobbedienti innamorate”della regista palestinese Maysaloun Hamoudi narra di tre ragazze arabo-israeliane di Tel Aviv le mie aspettative sono schizzate in alto. I Palestinesi cittadini dello stato di Israele sono un argomento negletto. Come vivono l’estraneità che loro attribuisce lo “stato […]![]()
Novità editoriale: “La sposa yemenita” dal 4 maggio in libreria
Una graphic novel di Laura Silvia Battaglia e Paola Cannatella
L’articolo Novità editoriale: “La sposa yemenita” dal 4 maggio in libreria sembra essere il primo su Arabpress.
Matrimonio siriano, il progetto editoriale di Laura Tangherlini
Un progetto benefico per i profughi siriani
L’articolo Matrimonio siriano, il progetto editoriale di Laura Tangherlini sembra essere il primo su Arabpress.
Iraq: a 14 anni dalla liberazione, dove va il Paese?
A pochi giorni dal quattordicesimo anniversario della caduta di Saddam Hussein, è il momento per l’Iraq di tirare le somme
L’articolo Iraq: a 14 anni dalla liberazione, dove va il Paese? sembra essere il primo su Arabpress.
Playing on the Move: Understanding Play, Care and Migration through Inter-relationality
Photo taken by: Right to Play, Ethiopia. Call for Abstracts, WOCMES 2018 Playing on the Move: Understanding Play, Care and Migration through Inter-relationality In the wake of the latest migration flows from the Middle Eastern region, mostly the result of economic hardships and protracted political failures, humanitarian and development organisations have increasingly been relying on […]![]()
Libia: il progetto di divisione di Gorka
Quale spiegazione dietro il progetto di Sebastian Gorka in Libia?
L’articolo Libia: il progetto di divisione di Gorka sembra essere il primo su Arabpress.
Dopo la vittoria del “Sì”, cosa succederà in Turchia?
Anche se il referendum è legittimo e il risultato è chiaro, resta da vedere se esso garantirà alla Turchia un futuro di stabilità e prosperità
L’articolo Dopo la vittoria del “Sì”, cosa succederà in Turchia? sembra essere il primo su Arabpress.
Veramente è risorto
Quando si cucina si pensa, ci si prende cura, si usano le mani assieme al cervello. Con il cuore a Gerusalemme, oggi raramente unita nelle Pasque e allo stesso tempo come sempre complicata. Ecco il mio modo di festeggiare la Pasqua e di rilassarmi, come spesso facevo quando vivevo bella Città Tre Volte Santa. Con gliContinua a leggere
Pasqua, in Egitto senza festeggiamenti dei copti dopo gli attentati: “Pregare è diventato pericoloso”
Il ritorno in chiesa dei cristiani, a una settimana dagli attacchi delle domenica della Palme, avviene in una Cairo blindata da polizia e esercito con lo stato di emergenza che, come deciso dal presidente Sisi, andrà avanti provvisoriamente per tre mesi. “Sono stati annullati tutti i festeggiamenti, ad eccezione della sola celebrazione della Santa Messa di […]
L’articolo Pasqua, in Egitto senza festeggiamenti dei copti dopo gli attentati: “Pregare è diventato pericoloso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il Marocco ha finalmente un nuovo governo, ma a che prezzo?
L’annuncio della creazione di un nuovo governo in Marocco è segno che il Partito islamista per la Giustizia e lo Sviluppo potrebbe aver pagato un prezzo molto alto per scendere a compromessi
L’articolo Il Marocco ha finalmente un nuovo governo, ma a che prezzo? sembra essere il primo su Arabpress.
Il successo di Mosca
 |
| Il mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa. L’Orso russo torna in scena |
Se la cosa farà strada si vedrà ma intanto Mosca, la bestia nera dell’Afghanistan, incassa un successo. E offre, durante la terza conferenza sull’Afghanistan organizzata dai russi nella loro capitale, di fare di Mosca la sede di un possibile negoziato tra talebani e governo afgano. Incassa anche toni amichevoli dagli afgani stessi (pur se la strategia dei due Paesi è assai diversa), tanto che la bomba americana sganciata giovedi scorso sull’Afghanistan orientale – se doveva essere una dimostrazione di forza anche contro l’Orso russo – non sembra aver portato a casa risultati politici soddisfacenti. Le note ufficiali dicono che quasi cento affiliati allo Stato islamico sono stati uccisi dall’ordigno ma il risultato definitivo è che intanto Mosca rientra in scena proprio sul territorio nel quale si pensava non avrebbe mai rimesso piedi. Una notizia che oscura il colpaccio contro il Califfato ammesso che venga confermato che la bomba non ha fatto danno ai civili (al di là della distruzione di pascoli, terreni e probabilmente abitazioni).
Musulmani in Europa: questioni identitarie e dibattito fallito
I musulmani e l’Islam sono parte del tessuto sociale europeo oppure no?
L’articolo Musulmani in Europa: questioni identitarie e dibattito fallito sembra essere il primo su Arabpress.
Sofian : vittima dell’islamofobia
SIRIA: NON C’E’ PACE SENZA GIUSTIZIA
I firmatari di questo appello intendono sollecitare le forze civili e politiche del nostro Paese a mobilitarsi in solidarietà del popolo siriano e degli altri popoli che dal 2011 sono in lotta per diritti universali ed inalienabili quali dignità, libertà, autodeterminazione e giustizia sociale e che per questo si trovano ad affrontare guerra, repressione, le […]![]()
Tunisia, il calvario delle donne sotto la dittatura
Thierry Brésillon Dal novembre 2016 e dall’inizio delle audizioni pubbliche organizzate dall’Instance Verité et Dignité, ritrasmesse in diretta alla televisione, la società tunisina esamina i suoi decenni di dittatura. Creata per fare luce sui soprusi di Stato perpetratisi per oltre mezzo secolo, questa Istanza raccoglie le testimonianze di donne e uomini che hanno subito i peggiori abusi. Grazie a questi […]
Consiglio di lettura: “Il Ritorno” di Hisham Matar
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di lettura: “Il Ritorno” di Hisham Matar sembra essere il primo su Arabpress.
In Egitto di carcere si muore!
In Egitto migliaia e migliaia di prigionier* soffrono chius* nelle loro celle a causa del sovraffollamento, della scarsa igiene, della mancanza di cibo e di acqua potabile, di ogni sorta di privazione, abusi e torture. In molt*, poi, sono mort* … Continue reading →
Cambio delle regole del gioco politico in Iran
A poche settimane dalle elezioni, l’entrata in scena di nuovi candidati impone cambiamenti strategici
L’articolo Cambio delle regole del gioco politico in Iran sembra essere il primo su Arabpress.
Usa/Urss/Afghanistan. Messaggio da undici tonnellate di esplosivo
 |
| Moab Gbu-43, il più potente ordigno convenzionale. Sganciato giovedi in Afghanistan |
Il giorno dopo la “madre di tutte le bombe” elicotteri da combattimento americani continuano l’operazione di pulizia iniziata nella provincia di Nangarhar giovedi sera nel distretto di Achin, dove tunnel costruiti dai mujaheddin durante la guerra contro i sovietici (con soldi americani ha denunciato ieri con un tweet Edward Snowden) sarebbero adesso i rifugi tattici dello Stato islamico in Afghanistan. Il distretto è abbastanza disabitato e, stando alle dichiarazioni del governo, nella zona del bombardamento (il villaggio di Mohmand Dara) viveva una sola famiglia afgana evacuata per tempo. Secondo Kabul infatti non ci sarebbero state vittime civili nell’attacco dell’altro ieri ma solo militanti del Califfato. I morti sarebbero quasi una quarantina su settanta (il Califfato smentisce) possibili obiettivi ma il bilancio è probabilmente provvisorio come provvisorie potrebbero essere le notizie sulle vittime civili che, male che vada, devono aver perso raccolti e abitazioni nell’operazione che ha visto il lancio di una bomba da 11 tonnellate di esplosivo costata al contribuente americano 15 milioni di dollari.
Le reazioni all’operazione, avvenuta alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan voluta dalla Russia e che si sta svolgendo a Mosca, sono di tipo diverso: il governo è compatto e compiaciuto. E’ ormai da tempo schiacciato sulle scelte americane e del resto appoggia l’escalation di raid aerei in corso da oltre un anno tanto che dal palazzo presidenziale si è appreso che la bomba americana serviva come appoggio alle operazioni dell’esercito nazionale. Infine non è un mistero che l’esecutivo a due teste di Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah stia aspettando l’arrivo del consigliere per la sicurezza di Trump con la speranza che gli americani (che hanno ora in Afghanistan 8.500 soldati accanto a poco meno di 5mila militari Nato di cui 1000 italiani) decidano, in controtendenza con Obama, di aumentare il contingente militare. Per Ghani sarebbe un sollievo, più che per la guerra, per l’iniezione di denaro fresco che l’arrivo di un nuovo contingente verrebbe a significare in un’economia sempre più asfittica dopo che la Nato se n’è andata lasciando solo il ricordo dei bei tempi in cui nel Paese stazionavano oltre 100mila soldati stranieri.
L’opposizione più violenta al raid viene dal vecchio presidente Hamid Karzai che ha usato parole durissime sostenendo che per gli americani l’Afghanistan è solo un territorio dove testare nuove armi. Gli ha fatto eco l’inviato speciale per il Pakistan Umar Zakehlwal che ha bocciato la bomba come “riprovevole e controproducente”.
Le reazioni della gente della strada infine – raccolte dalla stampa locale – sono diverse: chi è d’accordo, chi pensa che in realtà gli americani abbiano bombardato per i loro fini e non per aiutare gli afgani, chi invece pensa – ha detto uno studente di Kabul – che la bomba fosse diretta a Mosca. Quella del giovane studente sembra in effetti la lettura più interessante: alla Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta oggi a Mosca gli americani avevano opposto un secco diniego all’invito russo in un clima di nervosismo per le avance dei russi verso il vecchio Paese occupato nel 1979. Mosca di conferenze ne ha già organizzate altre due ma questa, a differenza delle altre più in sordina, è una cosa seria: ci sono tutti, dall’Iran alla Cina, dall’India al Pakistan passando per le cinque repubbliche dell’ex Urss in Asia centrale. E c’è naturalmente Kabul che, pur se sostiene Washington e la sua politica, ha accettato di buon grado alcune iniziative di sostegno da parte russa. Questa parte del mondo sembra dunque tornare a essere, come ai tempi del “Great Game” e della Guerra Fredda, la pedina da giocare tra due giganti. Se Washington e i suoi militari sono preoccupati dal ritorno sula scena dell’Orso russo, Mosca è allarmata dall’accerchiamento sul suo lato Sud che gli americani, dopo aver preso il controllo dell’Afghanistan, hanno allargato corteggiando le repubbliche dell’Asia centrale, tradizionali alleate di Mosca.
Lo schiaffo di Trump all’Afghanistan (e a Mosca)
 Gli avieri statunitensi delle Forze speciali, impegnati da mesi in una campagna di bombardamenti aerei in Afghanistan, hanno sganciato ieri un ordigno da undici tonnellate di esplosivo nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangharhar al confine col Pakistan e considerata la base dello Stato islamico nel Paese.
Gli avieri statunitensi delle Forze speciali, impegnati da mesi in una campagna di bombardamenti aerei in Afghanistan, hanno sganciato ieri un ordigno da undici tonnellate di esplosivo nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangharhar al confine col Pakistan e considerata la base dello Stato islamico nel Paese.
La bomba Gbu-43, nota anche come “Moab” ( massive ordnance air blast bomb ma in gergo mother of all bombs) è la più grande bomba non nucleare mai sganciata. Il primo test dell’ordigno è del marzo e poi nel novembre del 2003 e, a parte i test, non si aveva mai avuto notizia di altri lanci. Quello di eri, alle sette di sera, è dunque un duplice messaggio. Allo Stato Islamico ma indirettamente anche a Mosca che, proprio in queste ore, sta ultimando i preparativi di una conferenza sull’Afghanistan in agenda da mesi. Al meeting, cui saranno presenti oltre agli afgani i delegati di Cina, India, Pakistan, Iran e delle repubbliche centroasiatiche dell’ex Urss, era stata invitata anche Washington che aveva però opposto un diniego. Convitato di pietra, Trump si è invece auto invitato ieri mettendo a segno un colpo clamoroso proprio nel Paese di cui si sta per discutere a Mosca. E non è l’unica notizia di un rinnovato attivismo americano in Afghanistan (da cui a breve sapremo l’entità del danno provocato dall’ordigno). Sempre alla vigilia del meeting organizzato da Putin, Trump ha annunciato l’arrivo imminente a Kabul del suo National Security Adviser, il generale McMaster. Il presidente ha annunciato il suo invio – è il funzionario di Stato più alto in grado a visitare Kabul da che Trump si è insediato – durante una conferenza stampa ma si è limitato a dire che il viaggio – di cui per ora non si conoscono né la data né altri dettagli – servirà a capire “che progressi si potranno fare con i nostri partner afgani e i nostri alleati della Nato”. Nel giro di boa che Trump sta facendo rispetto alle sue promesse elettorali (tra cui quella di lasciare l’Afghanistan) non c’è solo la nuova apertura nei confronti di una Nato “non più obsoleta” ma anche la possibilità, sostengono gli osservatori, che la Casa Bianca decida per un aumento delle sue truppe, come peraltro richiesto dal generale John Nicholson, comandante delle forze straniere nel Paese. La bomba sembra esserne il biglietto da visita.
L’Afghanistan conosce dunque una nuova escalation anche se di fatto una campagna di bombardamenti aerei nel Sud del Paese è in atto da mesi. Ancora non si conoscono gli effetti di questa massiccia operazione ma i dati del solo anno trascorso parlano chiaro: l’anno passato le vittime civili sono state oltre 11mila: 3512 morti (tra cui 923 bambini) e 7.920 feriti (di cui 2.589 bambini), con un aumento del 24% rispetto al periodo precedente. Ma il rapporto di Unama, la missione Onu a Kabul, spiegava anche che i bombardamenti aerei – afgani e internazionali – pur se responsabili “solo” del 5% delle vittime nel 2016, rispetto al 2015 hanno raddoppiato il loro bilancio: 250 morti e 340 feriti, i numeri più elevati dal 2009. Forse per difetto, perché – ad esempio – i bombardamenti coi droni non sono calcolati in quanto operazioni secretate. Le manifestazioni di protesta si susseguono e anche se spesso si manifesta contro la guerriglia, non meno spesso gli afgani manifestano contro le bombe che da un anno a questa parte cadono sempre più frequentemente.
Storie all’ombra di Gerusalemme – Palermo 19 aprile ore 18
Mercoledì 19 aprile ultimo appuntamento con il caffè letterario del Rouge et Noir. Alle 18:00 “Articolo Femminile” – conversazione con Paola Caridi su “Storie all’ombra di Gerusalemme”. Si può dare spazio ai dettagli quando incombe, su di noi, la Grande Storia? Ci si può innamorare di un caffè al cardamomo, quando la violenza quotidiana èContinua a leggere
L’ultimo tweet di Trump
Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017 Santiago Alba Rico Chi scambia bombe scambia anche segni, messaggi. Nel caso di Trump, una persona dipendente dai social network che ha vinto le elezioni a colpi di tweets, quasi […]
Letteratura persiana femminile alla Fiera del Libro di Milano 20 aprile
Lavori in corso per il referendum a Istanbul
Con il referendum ormai alle porte, la città sul Bosforo è teatro di una campagna che mostra forti disequilibri fra gli attori in campo, per l’imponente dispiegamento di forze di Erdogan e del suo partito
L’articolo Lavori in corso per il referendum a Istanbul sembra essere il primo su Arabpress.
Il giorno della terra palestinese
La comunità palestinese celebra ogni 30 marzo il Giorno della Terra, commemorazione di un evento drammatico nella sua storia
L’articolo Il giorno della terra palestinese sembra essere il primo su Arabpress.
Il lato oscuro delle nostre scarpe
«L’etichetta Made in Italy o Made in EU ha sempre suggerito qualità del lavoro e degli standard ma se le scarpe sono solo progettate nella UE e poi prodotte in Serbia, Albania, Birmania o Indonesia da lavoratori stranieri in condizioni miserabili, oppure in Italia da parte di terzisti che pagano salari contrattati al di sotto del salario vivibile, dove sta il valore aggiunto del Made in EU o Made in Italy?». Se lo chiede un’inchiesta della Campagna Abiti Puliti e di Change your Shoes – progetto di 15 organizzazioni europee e 3 asiatiche – che è un viaggio nel lato oscuro delle nostre scarpe. Proprio “nostre” perché Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive di tre marchi globali delle calzature, studio realizzata dal Centro Nuovo Modello Di Sviluppo e FAIR, racconta il percorso compiuto lungo le filiere produttive di tre grandi marchi italiani (Tod’s, Geox, Prada), mostrando quanto si sia ancora lontani dal rispettare i diritti umani e sindacali di chi confeziona le loro-nostre scarpe.
 Nel mondo si fabbricano ogni anno circa 23 milioni di paia di scarpe e qualche barlume di consapevolezza sulle condizioni di lavoro in cui vengono assemblate attraverso una filiera che agisce su diversi Paesi (prodotto base, tomaia, design, distribuzione etc) ci aveva mostrato processi ad alta intensità di manodopera sottoposti a rapidi tempi di consegna e prezzi ridotti all’osso soprattutto in Cina, India, Bangladesh, Pakistan e Indonesia. Ma oggi – spiega il rapporto – dopo la delocalizzazione si assiste alla rilocalizzazione o reshoring, ossia al trasferimento in direzione contraria delle attività produttive precedentemente delocalizzate in Asia grazie al basso costo del lavoro. «L’aumento di produttività, unito a una politica di moderazione salariale, maggiore flessibilità del lavoro, maggior libertà di licenziamento, relazioni industriali soft affiancate da incentivi e sussidi per attrarre gli investimenti – dice l’inchiesta – sta rendendo di nuovo appetibile anche la vecchia Europa che presenta il vantaggio di una mano d’opera ad alta tradizione manifatturiera. Ad essere più interessati al fenomeno sono i Paesi dell’Europa dell’Est con salari a volte più bassi di quelli asiatici». Spesso anche grazie a incentivi locali.
Nel mondo si fabbricano ogni anno circa 23 milioni di paia di scarpe e qualche barlume di consapevolezza sulle condizioni di lavoro in cui vengono assemblate attraverso una filiera che agisce su diversi Paesi (prodotto base, tomaia, design, distribuzione etc) ci aveva mostrato processi ad alta intensità di manodopera sottoposti a rapidi tempi di consegna e prezzi ridotti all’osso soprattutto in Cina, India, Bangladesh, Pakistan e Indonesia. Ma oggi – spiega il rapporto – dopo la delocalizzazione si assiste alla rilocalizzazione o reshoring, ossia al trasferimento in direzione contraria delle attività produttive precedentemente delocalizzate in Asia grazie al basso costo del lavoro. «L’aumento di produttività, unito a una politica di moderazione salariale, maggiore flessibilità del lavoro, maggior libertà di licenziamento, relazioni industriali soft affiancate da incentivi e sussidi per attrarre gli investimenti – dice l’inchiesta – sta rendendo di nuovo appetibile anche la vecchia Europa che presenta il vantaggio di una mano d’opera ad alta tradizione manifatturiera. Ad essere più interessati al fenomeno sono i Paesi dell’Europa dell’Est con salari a volte più bassi di quelli asiatici». Spesso anche grazie a incentivi locali.
Uno tra gli esempi citati dal rapporto riguarda ad esempio 11 milioni di euro messi a disposizione da
Belgrado nel gennaio 2016 grazie ai quali Geox ha aperto un impianto a Vranje, in Serbia. L’estate seguente, il marchio è stato oggetto di contestazioni sulla stampa locale per diverse irregolarità: condizioni sanitarie e di sicurezza insoddisfacenti, offese verbali ai lavoratori, forme di assunzione non regolari, straordinari eccessivi e altre violazioni. Anche se le denunce, la pressione dei media e l’attività sindacale e degli attivisti hanno migliorato le cose, le preoccupazioni non sono cessate.
La pratica del “terzismo” è comune: «I terzisti capofiliera utilizzati da Geox si trovano tutti all’estero, prevalentemente in Estremo Oriente, anche se non manca l’Europa dell’Est. Tod’s, invece – scrive il rapporto – li ha prevalentemente in Italia distribuiti fra Marche, Abruzzo e Puglia. Tuttavia dispone di terzisti capofiliera anche in Romania per la produzione di scarpe a marchio Hogan Rebel. Quanto a Prada, fino al 2015 intratteneva rapporti produttivi anche col gruppo cinese Stella International Holding, che dispone di stabilimenti calzaturieri in Cina, Vietnam, Indonesia e Bangladesh, ma vista la progressiva perdita di competitività dell’Asia, oggi la politica di Prada è di abbandonare l’Asia per tornare a produrre in Italia e Paesi dell’Europa dell’Est, principalmente Romania, Serbia, Bosnia Erzegovina, oltre alla Turchia». Questa diversificazione consente ai marchi di pagare prezzi differenti ai loro fornitori in base all’area geografica.
Ciò fa si che il “mercato del lusso” metta in evidenza una crescente sproporzione tra prezzi e valore reale dei beni. Un surplus di valore che però «non è distribuito equamente fra coloro che partecipano alla sua produzione ed è assorbito per la maggior parte da due fasi della catena:la distribuzione e il marchio, che si appropriano di circa il 60% del prezzo finale. Con questo meccanismo si attiva una spirale crescente per cui chi detiene più ricchezza e potere nella catena del valore finirà per detenerne sempre di più, potendo accrescere a dismisura il proprio potere di vendita attraverso il marketing e così mantenere il proprio controllo sui fornitori che denunciano prezzi troppo bassi e tempi di consegna troppo rapidi».
La presenza di consumatori informati e reti di solidarietà internazionali, secondo Abiti Puliti e Change your Shoes, sono le condizioni per ottenere dalle imprese comportamenti conformi alle tutele previste dalle leggi nazionali, dalle convenzioni internazionali e dai principi guida dell’Onu. Le Campagne chiedono ai marchi (compresi Tod’s, Prada e Geox) di garantire trasparenza sulla catena di fornitura e il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui un salario dignitoso; ai governi nazionali e alla UE chiedono di rafforzare i controlli sull’applicazione delle leggi sul lavoro. Il 14 aprile Abiti Puliti organizza a Genova al Teatro Altrove l’evento 13600HZ Concerto per macchine da cucire, progetto dell’artista concettuale Sara Conforti. Verrà proiettato anche il video-documentario “In My Shoes” dopo un dibattito pubblico sui temi dell’inchiesta.
Islam e pensiero scientifico, incontro ad Altamura
Il 4 aprile, all’interno dell’Infopoint di Altamura, ha avuto luogo una conferenza sull’Islam e il pensiero scientifico, che si inserisce all’interno del ciclo di incontri “Epicentro”, organizzato dall’associazione culturale “Spiragli”. La rassegna affronta le tematiche più varie, spaziando dall’architettura, al… Continue Reading →![]()
Leader egiziano alla Casa Bianca per la prima volta dopo il 2011
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Leader egiziano alla Casa Bianca per la prima volta dopo il 2011 sembra essere il primo su Arabpress.
Libano, patria dei rifugiati
Su 4 milioni di abitanti locali, sono 2 milioni i rifugiati e profughi.
L’articolo Libano, patria dei rifugiati sembra essere il primo su Arabpress.
USA-Egitto: forte intesa tra Trump e Al-Sisi
Il presidente egiziano torna da Washington investito del ruolo di alleato strategico per gli Stati Uniti nella regione
L’articolo USA-Egitto: forte intesa tra Trump e Al-Sisi sembra essere il primo su Arabpress.
Siria, il discorso del miliardario
 Da un compound superprotetto, circondato da lastroni di cemento incastrati in modo identico a quello del Muro di segregazione israeliano, e serrato da cancelli di ferro e sbarre pesanti quanto un fuoristrada, a Kabul, questa mattina, ascoltavo l’intervento del presidente Trump sull’attacco all’aeroporto militare siriano.
Da un compound superprotetto, circondato da lastroni di cemento incastrati in modo identico a quello del Muro di segregazione israeliano, e serrato da cancelli di ferro e sbarre pesanti quanto un fuoristrada, a Kabul, questa mattina, ascoltavo l’intervento del presidente Trump sull’attacco all’aeroporto militare siriano.
A Torino torna la TOMidEast Summer School
Dal 3 al 7 Luglio 2017 il Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) dell’Università di Torino organizza la quarta edizione della scuola estiva TOMidEast con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con Osservatorio Iraq come media partner.
Guerre di religione? A Cesare quel che è degli uomini
A Cesare quel che è di Cesare. A Dio quel che è di Dio. E’ singolare che un verso del vangelo di Marco serva, oggi, a rispondere a chi – in maniera sconsiderata – continua a parlare di “guerra di religione”. Di chi contro chi? Di quale fede contro quale altra fede? Darei agli uominiContinua a leggere
….
Ci sono momenti, e in questo periodo sono lunghi momenti, in cui vorrei sottrarmi. Rispondere con l’assenza alle parole altisonanti che ascolto e leggo. Parole abusate e pericolose. Mi sa che mi tocca tornare dall’esilio virtuale.
Cosa può e non può fare al-Sisi sotto lo stato di emergenza
Quali sono i limiti al potere presidenziale nello stato di emergenza imposti dalla Costituzione del 2014 e dalla sentenza della Corte Suprema Costituzionale.
L’articolo Cosa può e non può fare al-Sisi sotto lo stato di emergenza sembra essere il primo su Arabpress.
La propaganda anti-americana
Se l’attacco del presidente americano Trump in Siria è stato acclamato dalla maggioranza degli arabi, Mosca, Teheran e Damasco non hanno tardato a rispondere, cambiando più volte versione
L’articolo La propaganda anti-americana sembra essere il primo su Arabpress.
Il governo di Othmani in Marocco… una vendetta?
La formazione della maggioranza di Othmani è avvenuta in un contesto di “vendetta collettiva” nei confronti del governo Benkirane, leader del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, a causa delle sue “critiche” al sistema politico e amministrativo e il rifiuto di piegarsi alle condizioni impostegli.
L’articolo Il governo di Othmani in Marocco… una vendetta? sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – XIX puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XIX puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina irachena: kubba Mosul
Oggi scopriamo uno dei piatti più tipici della cucina irachena, diffusa soprattutto nel nord del Paese, in particolare nella città di Mosul, dalla quale prende il nome, e che tristemente oggi ci evoca solo immagini di guerra e desolazione. Rendiamo un omaggio a questa città e prepariamo insieme la kubba Mosul! Ingredienti: Per la parte esterna: […]
L’articolo Cucina irachena: kubba Mosul sembra essere il primo su Arabpress.
Il mondo arabo deve ammettere di essere razzista
A lungo vittime di razzismo e imperialismo, gli arabi dovrebbero difendere i diritti degli altri popoli tanto quanto difendono i propri
L’articolo Il mondo arabo deve ammettere di essere razzista sembra essere il primo su Arabpress.
Usa/Russia: Afghanistan, il fronte nascosto
C’è un altro fronte di scontro tra russi e americani in Asia. Un fronte nascosto e dimenticato ma
dove la guerra infuria con continuità e, per numero di decessi, più di prima. E’ il fronte afgano, la porta che dal Medio oriente e dall’Asia centrale arriva al subcontinente indiano. Un fronte di guerra che l’anno scorso ha contato 11mila vittime civili e dove si sta assistendo a un’escalation dei bombardamenti americani nel Sud e alla possibilità che Trump, in campagna elettorale favorevole al ritiro, aumenti le truppe nel Paese. Come anche il governo di Ashraf Ghani gli chiede.
L’Afghanistan fu terreno di scontro durante il “Grande Gioco” tra Impero zarista e Inghilterra nell’800 e divenne il confine della guerra guerreggiata durante la Guerra Fredda quando l’Urss invase l’Afghanistan e gli Usa armarono, con sauditi e pachistani, l’armata mujaheddin: i primi “combattenti della fede” manovrati anche dall’Occidente come da lì a poco sarebbe avvenuto anche per la guerra in Bosnia.
I sovietici lasciarono l’Afghanistan con le ossa rotte nel 1989, dopo dieci anni e migliaia di morti, poco prima che la Perestrojka desse il colpo di grazia all’Unione delle Repubbliche socialiste. L’Afghanistan fu il detonatore di una crisi profonda e la carta che Washington aveva giocato, assieme a molte altre, per combattere i comunisti nel mondo. Poi fu la volta degli americani. Dopo l’attacco alle Torri gemelle del 2001, prima gli Stati Uniti e poi la Nato (quindi ancora gli Stati Uniti), presero il controllo del Paese per far presto i conti con le tribù afgane adesso col turbante nero dei talebani. Mosca intanto si era ritirata dalla scena, alle prese con la ricomposizione di un impero ormai spezzettato. Se aveva perso l’Afghanistan, Mosca stava soprattutto perdendo influenza in Asia centrale e nel Caucaso dove, oltre alla protesta islamista, c’era da far i conti con la perdita di giacimenti di gas e petrolio, cotone, minerali.
Ma da qualche tempo a questa parte ecco che Mosca ricomincia a occuparsi del piccolo Paese crocevia perché le preoccupazioni crescono. Sul fronte afgano ci sono almeno tre grossi problemi: la presenza di truppe Nato e soprattutto il controllo delle basi aeree afgane da parte degli Usa, una cintura pericolosa sul suo lato sudorientale. Il narcotraffico, che porta in Russia vagoni di eroina. Lo Stato Islamico, che ha creato una testa di ponte sui porosi confini tra Afghanistan e Pakistan. Gli americani e la Nato hanno deciso di lasciare? Bene, è il momento di farsi avanti. A Kabul c’è ancora Karzai e Mosca fa le prime avance. Regali, offerte di training militare, aiuti economici. E’ un avvicinamento lento portato avanti dall’ambasciata a Kabul e dall’inviato speciale Zamir Kabulov. Kabulov conosce il Paese: ci ha lavorato dal 1983 all’87 come secondo segretario d’ambasciata (e, per gli americana, come spia del Kgb) e poi è stato ambasciatore a Kabul sino al 2009. E’ un uomo che ha conosciuto mullah Omar e ha trattato con lui, nel 1995, per il rilascio di prigionieri russi. La carta da giocare è diplomatica. Mosca organizza un incontro in Russia sul futuro dell’Afghanistan ma non invita né Kabul né Washington. Intanto tratta coi talebani. E mentre i comandanti americani e afgani cominciano ad accusare Mosca di vendere armi alla guerriglia, la Russia organizza per il prossimo 14 aprile una nuova conferenza internazionale cui invita Kabul, Teheran, Islamabad, Pechino, Delhi e le repubbliche centroasiatiche. Fa la sua offerta anche a Washington che declina l’invito. I nervi sono tesi anche se quel fronte sembra apparentemente ininfluente e lontano. La conferenza si svolgerà proprio mentre il segretario di Stato Usa Tillerson sarà Mosca.
Tunisia: inizia la corsa alla presidenza
In vista delle prossime elezioni previste nel 2019, i partiti tunisini si stanno già muovendo per proporre i loro candidati
L’articolo Tunisia: inizia la corsa alla presidenza sembra essere il primo su Arabpress.
“I rohingya possono tornare”
Per la prima volta la Nobel birmana si difende ma prende posizione: “Non è pulizia etnica. Se
rientrano sono i benvenuti”
 Nella prima dichiarazione pubblica da che il dramma dei rohingya birmani si è trasformato in un
Nella prima dichiarazione pubblica da che il dramma dei rohingya birmani si è trasformato in un
esodo di massa verso il Bangladesh dopo gli incidenti alla frontiera nell’ottobre scorso, Aung San Suu Kyi, in un’intervista alla Bbc, nega la “pulizia etnica” e non prende posizione sulla campagna militare ma sostiene però che il suo Paese è pronto ad accogliere chi vorrà tornare e che gli sarà garantita la sicurezza necessaria. “Chi torna è il benvenuto”, dice la signora in giallo, che questa volta sfoggia un elegante abito verde (il colore dell’islam per paradosso): riceve il giornalista della Bbc Fergal Keane con cui affronta le difficoltà della transizione, il processo di pace e, dopo qualche minuto, le vicenda rohingya. Suu Kyi si difende dall’accusa di aver taciuto sostenendo al contrario di aver preso misure incaricando Kofi Annan di una missione specifica e di avere, col suo governo, iniziato un percorso di verifica sulla cittadinanza. Nega che si possa usare il termine “pulizia etnica” (che lo stesso Annan si è rifiutato di utilizzare) e, non condannandoli, la Nobel finisce per giustificare l’operato dei militari (accusati di stupri, violenze, uccisioni e incendi di villaggi) ma, in più di un passaggio, torna sul concetto di cittadinanza. Non dice direttamente che spetti ai rohingya ma insistere su questo punto diventa rilevante: qualche giorno fa infatti, i militari hanno preso posizione proprio sul tasto più controverso: la nazionalità dei musulmani rohingya in Myanamr.
Dopo che la missione di Kofi Annan, voluta da Aung San Suu Kyi per metter fine alle polemiche sull’espulsione dei rohingya, è stata resa pubblica con la richiesta di svuotare i campi profughi nello stato del Rakhine, un’indispettita casta militare che, benché al governo ci siano i civili pare aver sempre l’ultima parola, ha detto la sua. In risposta al rapporto dell’ex segretario generale il capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing, ha sottolineato con parole chiare che i rohingya in Myanmar non ci sono e che quelli che ci sono, restano degli “immigrati bangladesi” senza diritto di cittadinanza birmana. E’ la parola fine cui segue il silenzio di sempre a cominciare dalla leadership civile nel Paese, oppressa dal timore di un colpo di coda degli uomini in divisa. Nonostante le prese di posizione forti alle Nazioni Unite (il rapporto di Annan è piuttosto blando ma le denunce dell’Onu non sono mancate specie dalla Commissione diritti umani e dall’Unhcr), le parole del generale sembrano chiudere il capitolo in modo definitivo. Ma ecco che, a distanza di una settimana Suu Kyi puntualizza. Lo fa in punta di coltello, attenta a non dire una parola di troppo ma sottolinea il ruolo del governo civile e, seppur senza attaccarli direttamente, risponde ai militari. Si difende ma apre: “Pulizia etnica – dice – è una parola troppo forte… è una questione di persone su diversi lati dello spartiacque e questo divario stiamo cercando di chiuderlo… saremo felici se faranno ritorno”. C’è da capire se da cittadini o no.
“I baroni di Aleppo” di Flavia Amabile e Marco Tosatti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “I baroni di Aleppo” di Flavia Amabile e Marco Tosatti sembra essere il primo su Arabpress.
Ankara e la bandiera curda issata a Kirkuk
L’attesa non sempre paga: la Turchia alle prese con la valutazione errata della geopolitica irachena
L’articolo Ankara e la bandiera curda issata a Kirkuk sembra essere il primo su Arabpress.
Radicalizzazione e movimenti sociali: stesso contesto, battaglie diverse
. Henda Chennaoui Nonostante la repressione, i movimenti sociali sono in continuo aumento in tutte le regioni della Tunisia. Mentre i sit-in degli operai della fabbrica di cavi al Kef proseguono da una decina di giorni, gli abitanti di Tataouine sono al loro tredicesimo giorno di contestazione e non sembrano pronti a rinunciare al diritto allo sviluppo regionale, al lavoro […]
Novità editoriale: la graphic novel “Orientalia, mille e una notte a Venezia”
“Orientalia, mille e una notte a Venezia” di Alberto Toso Fei e Marco Tagliapietra ed edita da Round Robin, è candidata al Premio Strega 2017.
L’articolo Novità editoriale: la graphic novel “Orientalia, mille e una notte a Venezia” sembra essere il primo su Arabpress.
Space of Refuge Symposium Report
Originally posted on Refugee Hosts :
On Wednesday 15 March 2017, Samar Maqusi, Prof. Murray Fraser (both of UCL-Bartlett School of Architecture) and Dr Elena Fiddian-Qasmiyeh (UCL-Geography and Refugee Hosts PI) convened a symposium on Space of Refuge. The symposium drew heavily on Maqusi’s PhD research in Jordan and Lebanon, enabling a conversation around the roles that space and scale play…![]()
The True Cost
Terra Equa Bologna (vedi il programma intero)
Terra Equa quest’anno ha dedicato il suo Festival del Commercio Equo e dell’Economia Solidale al tema della moda, del tessile, dell’abbigliamento, degli accessori.
Per toccare con mano che cosa significa Made in Dignity, Fashion Revolution, Slow Fashion, Abiti Puliti.
Ore 18 Sala cinema e parole
The True Cost
“Uno dei più bei film che ho avuto occasione di guardare al Festival di Cannes 2015” – Huffington Post / “Questo film sconvolgerà tutto il mondo della moda” – The Guardian
Proiezione del documentario The True Cost (versione originale, sottotitoli in italiano), presentato al Festival di Cannes nel 2015, che racconta le storie delle persone che producono i nostri vestiti, l’impatto dell’industria della moda sul nostro mondo e qual è il vero costo della maglietta da 10 € che indosso.
Intervengono:
Linda Triggiani (C’è un mondo – Terra Equa)
David Cambioli (altraQualità)
Deborah Lucchetti (Fair Coop. Soc. – Campagna Abiti Puliti)
Emanuele Giordana (giornalista, saggista e direttore di Lettera22)
In collaborazione con “Tutti nello stesso piatto”, Festival Internazionale di cinema e videodiversità
Per l’occasione saranno presentate le campagne internazionali in corso per la difesa dei diritti dei lavoratori del settore.
La battaglia di Raqqa e le porte dell’inferno
Alle porte della roccaforte del sedicente Stato Islamico si giocano gli interessi di tutte le forze in campo della guerra siriana: chi potrà riconquistarla?
L’articolo La battaglia di Raqqa e le porte dell’inferno sembra essere il primo su Arabpress.
Le mire di Mosca e l’islam radicale in Asia Centrale
| Samarcanda, piazza Registan. Sotto una mappa dell’Uzbekistan |
L’ondata di arresti seguita ai fatti di San Pietroburgo porta dritta a una pista che dalla tradizionale rotta ceceno-daghestana arriva in Asia Centrale, la nuova frontiera da cui Mosca teme adesso un’ondata di violenze dirette o meno che siano dal Califfato di Raqqa. Un progetto che peraltro non ha fatto molta strada nell’Azerbaijan o nelle cinque repubbliche dell’ex Urss ai confini orientali di quel che fu l’Impero zarista e poi l’Unione sovietica. Eppure, se un timore islamista esiste, sono proprio le turbolente aree caucasiche ancora sotto diretto dominio russo a impaurire gli Stati orientali che temono un contagio dal Daghestan o dalla Cecenia anche se pubblicamente non lo ammettono. La bestia nera delle cinque repubbliche dell’Asia centrale è invece, pubblicamente, l’Afghanistan, la terra dei talebani, agitata come uno spauracchio per reprimere il dissenso islamista e non. Per Mosca l’Asia centrale resta comunque una preoccupazione perché il controllo di quelle terre gli è ormai in gran parte sfuggito di mano anche se gli accordi con la Russia prevedono la difesa militare dei confini in caso di conflitto. Lo si è visto con la presa di Kunduz in Afghanistan per alcuni giorni nel 2015. Sui confini è scattata l’allerta e una massiccia presenza di militari russi.
I Paesi dell’Asia centrale hanno un’antica tradizione islamica ma è solo l’Uzbekistan il Paese che potrebbe temere, a ragione, la pressione dei gruppi radicali armati. Naturalmente, come altrove, i conflitti in Afghanistan/Pakistan e nel vicino Caucaso settentrionale – e così la più recente guerra siriana e, a suo tempo, la guerra in Iraq – sono stati il motore di un revivalismo radicale che sembra aver assecondato la diffusione di movimenti salafiti e wahabiti e infine la partenza di foreign fighter verso l’estero per aderire alle brigate islamiche internazionali in vari Paesi. A volte i numeri hanno una certa rilevanza ma il fenomeno sembra abbastanza ridotto. L’Uzbekistan è un caso a parte: l’obiettivo del governo è sempre stato quello di far terra bruciata attorno al Movimento islamico dell’Uzbekistan (Mui), al punto che si era arrivati a proporre ai talebani, agli inizi del 2001, persino un riconoscimento dell’Emirato in cambio dell’espulsione dei militanti Mui dall’Afghanistan. Creato nel 1998 con l’obiettivo di rovesciare il regime e instaurare una forma di governo conforme alle leggi islamiche, il Mui si è alleato con i Talebani e Al Qaeda. Nel 2015 ha espresso fedeltà al Califfato di Al-Bagdadi creando una spaccatura tra i suoi membri, molti dei quali non hanno aderito alla svolta. I suoi combattenti sono attivi soprattutto in Pakistan. Oltre 1500 uzbechi militerebbero all’estero in gruppi come il Mui o la Jamaat Imam Bukhari. Lontano però dai confini russi.
Se all’epoca sovietica il controllo su moschee e madrase era ferreo, le cose cambiano con la “liberazione” dal tallone di Mosca ma l’enfasi sul nazionalismo e un ambiguo atteggiamento verso la religione intesa soprattutto come stampella del potere, hanno finito per rivitalizzare l’islam centroasiatico favorendo la nascita di sezioni locali anche di movimenti transnazionali islamici. La risposta dei governi è stata soprattutto repressiva e con la tendenza a fare di ogni erba un fascio senza grandi distinzioni. Secondo diversi analisti le preoccupazioni che riguardano la sicurezza sono in realtà da leggersi, in molti casi, in chiave interna: preoccupazioni insomma che derivano più da un timore per la stabilità dei governi – in una situazione di povertà crescente per la crisi del greggio e del rublo e per l’incertezza nella successione interna delle leve di potere – che non per la paura reale di un contagio o di un’espansione dell’islamismo esogeno armato. In sostanza i Paesi centroasiatici avrebbero cioè utilizzato e utilizzerebbero il “pericolo jihadista” anche per contenere le spinte dal basso che possano mettere in difficoltà (come già avvenuto in passato) il sistema di potere locale. Lo stesso per il narcotraffico, attività economica sotto traccia che consente il transito di oppio e oppiacei prodotti in Afghanistan anche se, scrivono i due ricercatori C. Bleuer e S. Kazemi, «Il rischio in termini di sicurezza che lega l’Afghanistan alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale viene di frequente altamente esagerato e così il presunto collegamento tra narcotraffico e gruppi radicali islamisti. In realtà in tutta l’Asia Centrale i principali attori del narcotraffico sono impiegati governativi, agenti della sicurezza e personaggi legati alla mafia…». Anche qui c’è ovviamente uno zampino dei russi, destinatari dell’eroina afgana. Naturalmente un rischio islamista, benché sovrastimato, esiste ma, avvertono gli studiosi, in quest’area si fa più affidamento alla repressione che al dialogo. Un metodo che in Asia Centrale hanno imparato da Mosca.
Wikimedia Levante pubblica il libro della storia di Wikipedia in lingua araba
E’ stato pubblicato il primo libro in lingua araba che racconta la storia dell’enciclopedia Wikipedia. Uno dei pochi testi al mondo a trattare dell’argomento.
La questione curda in Turchia: cenni storici e fase attuale
La questione curda, oggi, ha raggiunto una centralità che probabilmente non ha precedenti nella storia recente. Per delimitare il campo e permettere una comprensione di essa, nel contesto turco, è necessario chiarire alcuni aspetti che credo siano imprescindibili. Con la… Continue Reading →![]()
Workshop di Calligrafia Araba a Cassino(FR)
أموت ويبقى كل ما قد كتبته فياليت من يقرأ مقالي دعا ليا Morirò……ma rimarrà tutto ciò che ho scritto, spero che tutti coloro che leggeranno i miei scritti pregheranno per me La calligrafia è l’arte della scrittura bella, stilizzata ed … Continue reading →
Non è tutto bianco o nero
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini.
L’articolo Non è tutto bianco o nero sembra essere il primo su Arabpress.
Siria: l’attacco su Idlib sfida il mondo intero
Un presunto attacco chimico sul villaggio di Khan Sheikhoun, nel governatorato di Idlib, ha provocato decine di morti e feriti
L’articolo Siria: l’attacco su Idlib sfida il mondo intero sembra essere il primo su Arabpress.
I “vertici arabi” di Trump e le nuove trattative israelo-palestinesi
In questi giorni il governo statunitense sta incontrando alcuni leader arabi, tra le questioni discusse c’è senz’altro quella palestinese
L’articolo I “vertici arabi” di Trump e le nuove trattative israelo-palestinesi sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – Lettere di prigionieri della dittatura
Alaa Abdel Fattah è entrato nel suo quarto anno di carcere nella prigione di Tora, al Cairo. Scrive dal carcere: “Questa settimana ho iniziato il mio quarto anno di prigione. Potrei essere rilasciato a ottobre, qualora il mio appello venga … Continue reading →
Novità editoriale: “Prima che parli il fucile”
Questa è la storia di un siriano qualunque, figlio della buona borghesia damascena, che scrive un vero e proprio manifesto teorico-pratico sulla rivoluzione dal basso, nello specifico quella siriana. Emigrato all’estero e poco interessato al clima repressivo del suo Paese, agli inizi della rivolta siriana della primavera del 2011 torna a Damasco per restare. Dalla sua […]
L’articolo Novità editoriale: “Prima che parli il fucile” sembra essere il primo su Arabpress.
Saranno i siriani a decidere il futuro del presidente Assad?
Dalle recenti dichiarazioni americane, il presidente siriano riesce a mantenere il potere nel suo Paese
L’articolo Saranno i siriani a decidere il futuro del presidente Assad? sembra essere il primo su Arabpress.
In un campo profughi in Grecia: Il diario di una volontaria
“Come volontari, veniamo trattati come se non fossimo parte della storia… quando in realtà siamo parte di essa e la influenziamo in maniera significativa.”
Quando la letteratura araba incontra quella occidentale: parla il Prof. egiziano Salah Fadl
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Quando la letteratura araba incontra quella occidentale: parla il Prof. egiziano Salah Fadl sembra essere il primo su Arabpress.
Una lingua politica e civile per completare l’identità araba
Gli arabi hanno bisogno di rivalutare la propria lingua in chiave politica per evitare che il potere dominante abbia il monopolio delle parole e del loro significato
L’articolo Una lingua politica e civile per completare l’identità araba sembra essere il primo su Arabpress.
Vertice arabo di Amman: un tentativo di far rivivere il Mar Morto
I leader della Lega araba si sono riuniti sul Mar Morto per discutere delle guerre e dei principali problemi che dilaniano il Mondo arabo
L’articolo Vertice arabo di Amman: un tentativo di far rivivere il Mar Morto sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina marocchina: insalata di cipolle, arance e olive
Oggi voliamo in Marocco alla scoperta di un piatto fresco, semplice e molto saporito: l’insalata di cipolle, arance e olive! Ingredienti: 500g di cipolle dolci 4 cucchiai di aceto di vino 3 arance 1 cucchiaino di zucchero 4 cucchiai di olio d’oliva 1 pizzico di cannella in polvere 1 pizzico di pepe bianco macinato 100g di […]
L’articolo Cucina marocchina: insalata di cipolle, arance e olive sembra essere il primo su Arabpress.
Passaggi: “Come fili di seta” di Rabee Jaber
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Passaggi: “Come fili di seta” di Rabee Jaber sembra essere il primo su Arabpress.
Yemen: due anni di caos e delusioni
È vergognoso e inumano definire la guerra portatrice di speranza per gli yemeniti
L’articolo Yemen: due anni di caos e delusioni sembra essere il primo su Arabpress.
La nuova Guerra Fredda nel Nuovo Grande Gioco
Amici o non amici, Trump e Putin se la devono forse vedere con una nuova Guerra Fredda tra Usa ed ex Urss che manco a dirlo passa per Kabul. Il generale Joseph Votel – generale a 4 stelle e già a capo del Comando centrale – ha detto all’ Armed Services Committee del Congresso che suppone che Mosca fornisca i talebani di armi. Accusa grave e senza prove, come lui stesso ammette, ma che esce dalla bocca di un top general benché uscente dalla sua posizione di comandante in capo. Votel (classe 1958, nella foto a sinistra) è un four stars general che è stato comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti dal marzo 2016 e che ha già prestato servizio come comandante degli Stati Uniti Special Operations Command. Non una voce qualsiasi. Gli Stati Uniti sono preoccupati dall’attivismo diplomatico di Mosca che cerca di recuperare posizioni e che sta tenendo nella capitale russa colloqui multilaterali sull’Afghanistan cui non ha mai invitato Washington. Troppo impegnati a seguire le vicende dei collegamenti russi di Trump rischiamo di prendere lucciole per lanterne. Più che un’alleanza tra i due colossi (vedi Siria apparentemente) sta montando una nuova Guerra Fredda, vedi un po’, nel Nuovo Grande Gioco in Asia centrale.
La rivoluzione secondo l’Arab Opinion Index
La primavera araba dal 2011 al 2016: delusioni e aspettative
L’articolo La rivoluzione secondo l’Arab Opinion Index sembra essere il primo su Arabpress.
Rohingya: la parola fine
 |
| L’Onu condanna Myanmar ma nessuno pensa a prendere provvedimenti |
Dopo che la missione di Kofi Annan, voluta da Aung San Suu Kyi per metter fine alle polemiche sull’espulsione dei rohingya birmani, un’indispettita casta militare che, benché al governo ci siano i civili, pare aver sempre l’ultima parola, ha detto la sua. Tombale.
In risposta al rapporto dell’ex segretario generale che chiedeva la chiusura dei campi profughi nello stato birmano del Rakhine, il capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing, ha detto con parole chiare che i Rohingya in Myanmar non ci sono e che quelli che ci sono, restano degli immigrati bangladesi senza diritto di cittadinanza birmana. E’ la parola fine cui segue il silenzio di sempre a cominciare dalla leadership civile nel Paese, oppressa dal timore di un colpo di coda degli uomini in divisa.
Ci sono state alcune prese di posizione forti alle Nazioni Unite (il rapporto di Annan è piuttosto blando ma le denunce dell’Onu non sono mancate) ma sembra di capire che non ci sarà alcun seguito. Il caso è chiuso.
Another One Bites the Dust: Major arms depot falls to Islamic State
By Stijn Mitzer and Joost Oliemans
Just over a year after capturing Deir ez-Zor’s Ayyash weapon depot in the largest arms haul of the Syrian Civil War, the Islamic State has once again got its hands on massive quantities of ammunition captured from a storage depot in Deir ez-Zor. This arms haul joins the list of other major instances where vast amounts of weaponry and munitions traded owners such as the capture of the aforementioned Ayyash weapon depot, Regiment 121, Brigade 93 and the Mahin arms depot, all but the last of which were at the hands of the Islamic State. Each of these depots provided its capturers with a wide array of weaponry, vehicles and ammunition that could immediately be used against their former owners, a major blow to other factions fighting for control over Syria.
A propaganda video released by the Islamic State, showing its fighters on the offensive in Deir ez-Zor, was the only footage released of the capture of the depot. The video, على أبواب الملاحم – ‘At the Doors of Epics [Battles]’, details the Islamic State’s efforts towards splitting the regime-held territory in two, which they succeeded in doing so in February 2017. This means that the airbase and Brigade 137 are now completely isolated, further complicating efforts to supply both pockets and drastically increasing the vulnerability of the airbase. Despite the growing threat, it remains unlikely that the Islamic State will be able to capture either pocket. The capture of significant quantities of ammunition, including up to three million rounds of small arms rounds will surely allow the Islamic State to prolong its fight for survival.
This is an estimate of the ammunition captured, the real figures are believed to be higher. The contents of at least 652 crates could not be identified. Small arms are not included due to the small quantities captured.
Ammunition:
˜ 3,320,600* rounds of 7.62×39, 7.62x54R, 12.7mm and 14.5mm ammunition.
– 2,310 rounds of 85mm ammunition.
– 693 rounds of 100mm ammunition.
– 13 rounds of 125mm ammunition.
– 120 rounds of 120mm ammunition.
– 68 rounds of 122mm rocket ammunition.
– 15 TM-62 anti-tank mines.
Vehicles:
– 1 T-72M1 TURMS-T.
– 3 T-72M1s.
– 1 AMB-S.
– 1 Tatra 148.
– 1 UAZ-469.
– 5 cars.
Although assessing the exact contents of each spam can of small arms munition is impossible, by volume the total amount would equal roughly 3.32 million rounds of 7.62x39mm, or a slightly smaller numer distributed of larger calibres such as 12.7mm and 14.5mm. Regardless, truly a tremendous amount of small arms ammunition was captured indeed.
An immense quantity of 85mm UBR-365P AP rounds was also discovered in the arms depot. While certainly an impressive sight, these rounds are completely useless to the Islamic State. The 85mm D-44 anti-tank cannon currently is the only weapon in the Syrian arsenal capable of firing these rounds, but only a small number of these are active on the battlefield. In fact, the D-44 is so rare the Islamic State is currently believed to be in the possession of just one.
At least 693 rounds of 100mm tank ammunition were also found stored in two seperate rooms. This quantity far exceeds the need of the Islamic State in the city of Deir ez-Zor as it only operates several T-55 tanks that use these shells here. It is thus extremely likely that at least a part was transported to Raqqa for further distribution among Islamic State units elsewhere.
The presence of Iranian ammunition crates dated the 5th of May 2015 is notable, dating back to shortly before the encirclement of the city. These crates likely arrived onboard of one of the SyAAF’s Il-76s that frequently visisted Deir ez-Zor when it was still possible for these aircraft to land at the airbase. This has meanwhile become impossible due to the close proximity of the Islamic State to the runway from the Eastern and Southern side, a fact that was made painfully clear by the destruction of two L-39s in their Hardened Aircraft Shelter (HAS).
Much of the ammunition was quickly loaded onto trucks and cars, and was likely distributed among Islamic State units located throughout Syria. The targeting of these stockpiles before would prevent this from happening, and limit the Islamic State’s ability to continue replenishing its stocks. Nonetheless, such action has time and again not been undertaken by either the SyAAF or Russian Air Force, which combined with the lack of timely evacuation or sabotage of such depots by ground units in the first place has been a major boon to opposing parties during the Syrian War.
The Islamic State also captured two airdrops destined for regime forces in the city, one of which was already believed to have been emptied of its contents before the Islamic State arrived. However, it is extremely likely that the ammunition from these crates was later encountered in one of the depots captured. Several airdrops have so far ended up in the wrong hands after landing in Islamic State controlled territory, which includes the two pallets below.
While a less than ideal situation, these airdrops are meanwhile the only way to supply the city and its inhabitants after the complete encirclement of Deir ez-Zor in May 2015. Both the United Nations and Russian Air Force have actively participated in dropping humanitarian aid to the starving population living in regime-held parts of the city, while Il-76s of the SyAAF are mostly active for the purpose of supplying weaponry, ammunition and fuel to the remaining regime forces held up in the city.
In addition to capturing huge amounts of ammunition, the offensive also provided the Islamic State with four T-72M1s, more than doubling the size of the T-72 fleet the Islamic State currently operates in and around Deir ez-Zor. This arms haul also included a single T-72M1 equipped with the Italian TURMS-T (Tank Universal Reconfiguration Modular System T-series) fire-control system, amounting the first T-72 TURMS-T to have been captured by the Islamic State.
Interestingly, two of the T-72M1s feature protective covers around their TPN-1-49 gunner sights, a modification that is slowly being applied across what remains of Syria’s battered T-72 fleet. A single Czechoslovak AMB-S armoured utility vehicle was also captured, which will likely end up employed as a VBIED similar to the two BREM-2 armoured recovery vehicles captured near the Ayyash weapon depots.
Article written in collaboration with MENA_Conflict.
Recommended Articles
Islamic State captures Ayyash weapons depots in largest arms haul of Syrian Civil War
Armour in the Islamic State, the DIY works of Wilayat al-Khayr
ancora sul velo?
L’Iraq dice OK all’America!
La politica irachena sembra accondiscendente e subordinata agli interessi americani
L’articolo L’Iraq dice OK all’America! sembra essere il primo su Arabpress.
Elezioni iraniane 2017
Rohani bis o virata conservatrice?
L’articolo Elezioni iraniane 2017 sembra essere il primo su Arabpress.
La religione può dividere ma la fede unisce: a Tor Pignattara cristiani e musulmani si incontrano
Dal blog Hiwar di Giusy Regina
L’articolo La religione può dividere ma la fede unisce: a Tor Pignattara cristiani e musulmani si incontrano sembra essere il primo su Arabpress.
Into the Badlands S02E02 Sub ITA (2×02)
..:: Episodio 02 “Force of Eagle’s Claw” ::..
Download Sub ITA]
Streaming Sub ITA]
http://vidto.me/4bu2rjspq2fd.html
Dai colonialismi al “diritto di avere diritti”
Perché scrivere di un seminario pensato da docenti universitari per studenti universitari? Bella domanda.. Spero che i lettori di questo blog sappiano perfettamente che tra gli obiettivi della sua esistenza c’è anche la volontà di trasmettere ai “non addetti ai lavori” contenuti e… Continue Reading →![]()
Mubarak libero ed innocente
Si chiude tragicamente l’ultimo capitolo di una delle rivoluzioni più spettacolari degli ultimi anni
L’articolo Mubarak libero ed innocente sembra essere il primo su Arabpress.
A Firenze il convegno “L’esperienza del Marocco: la sfida delle riforme”
COMUNICATO STAMPA Venerdì 31 Marzo 2017, presso l’Auditorium di Palazzo del Pegaso del Consiglio Regionale della Toscana, in Via Cavour 4 a Firenze, si svolgerà dalle 14 alle 19 il convegno L’ESPERIENZA DEL MAROCCO – LA SFIDA DELLE RIFORME, organizzato da POLICOM (Società di Consulenza politica e di Comunicazione politica), che presenterà la propria attività. […]
L’articolo A Firenze il convegno “L’esperienza del Marocco: la sfida delle riforme” sembra essere il primo su Arabpress.
Il Marocco ha un governo
Dopo cinque mesi di travaglio e un parto doloroso – con il siluramento di Benkirane – alla fine è nata la coalizione di governo che guiderà il Marocco per i prossimi cinque anni. Ci è voluto uno psichiatra per mettere tutti d’accordo, e porre fine a quello che stava diventando un…
L’articolo Il Marocco ha un governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
La Siria e “Ginevra 5”
Quale sarà l’esito dei negoziati di Ginevra fra potenze internazionali, russi e potenze lealiste o d’opposizione per giungere ad una soluzione alla crisi siriana?
L’articolo La Siria e “Ginevra 5” sembra essere il primo su Arabpress.
Come sopravvivere ai ricordi
Ad un certo punto di Tutto quello che non ricordo (Iperborea 2017, nell’ottima traduzione dallo svedese di Alessandro Bassini), romanzo dello scrittore e drammaturgo svedese-tunisino Jonas Hassen Khemiri, il protagonista si chiede: “Quanto deve essere forte uno schianto perché si senta fin nel futuro? A che velocità bisogna andare per sopravvivere nella memoria di qualcuno?”. L’autore […]![]()
Egitto – Chiudete il carcere di Wadi Natrun!
Chiudete il carcere di Wadi Natrun è l’appello che gira su internet dopo che Ahmad al-Khatib, uno studente universitario di 22 anni, da due anni e mezzo dentro, è stato affetto dalla Leishmaniosi. Ahmad ha contratto questa infezione dietro le … Continue reading →
Haftar e i suoi affiliati : dalla profanazione delle tombe alle esecuzioni pubbliche
Le ultime notizie mostrano un’immagine dei seguaci di Haftar molto simile a quella delle organizzazioni terroristiche che affermano di combattere e li mettono in una posizione delicata per i futuri negoziati
L’articolo Haftar e i suoi affiliati : dalla profanazione delle tombe alle esecuzioni pubbliche sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – XVIII puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XVIII puntata sembra essere il primo su Arabpress.
If Yemen’s Houthis weren’t Iranian proxies before, they could be soon
Leaders in Riyadh, Saudi Arabia and Washington, DC long argued, without much evidence, that Yemen’s Houthi rebels are puppets of Tehran. Those arguments, which many saw as exaggerated, are now beginning to ring true.
The notion of a proxy war in Yemen is not new. Saudi Arabia and the US State Department cited the Iran/Houthi connection to justify the launch of a massive military operation designed to drive the group from power. They argued that Iran would turn Yemen into a Shiite stronghold on Saudi Arabia’s southern border, enabling Tehran to exert influence there as it does in Lebanon, Syria and Iraq.

Supporters of the Houthi movement demonstrate in Sanaa, Yemen July 1, 2016. The banner reads: “Allah is the greatest. Death to America. Death to Israel. A curse on the Jews. Victory to Islam.”
Credit:
Reuters/Khaled Abdullah
The Houthis, known in Yemen as Ansar Allah, use the “Death to America” slogan which originated in Iran and is frequently invoked by the Iranian-backed Hezbollah in Lebanon. But beyond the shared rhetoric, there is scant evidence that the Houthis aim to project Iranian power on the Arabian Peninsula.
The Houthis are homegrown. Their name comes from the Houthi family, who launched a religious revival in northern Yemen. In the 1990s, when Salafists began preaching the Saudi brand of Wahhabi Islam on what was essentially Houthi turf, the head of the family, Hussein al-Houthi, led a movement to reaffirm Zaidi Shiite traditions that had guided Yemeni culture for centuries.
Yemen’s central government saw Houthi’s growing influence as a security threat. Under the leadership of then-President Ali Abdullah Saleh, Yemeni armed forces launched a series of wars to beat back the Houthis. In 2009, Saudi Arabia sent its own troops to join in the fight to subdue the Houthis.
By 2011, as populist fervor was coursing through the Arab world, the Houthis had joined with other anti-government groups in Yemen to hasten the downfall of President Saleh. They argued that his leadership had become corrupt, and they called for his ouster.
In 2012, Saleh was forced to transfer executive power to his vice president, Abdo Monsuer Hadi. The same year, the Houthis came to the negotiating table to help draft a power-sharing agreement with other Yemeni factions through a UN-sponsored National Dialogue Conference.
But the NDC came up with recommendations that would have provided the Houthis with less than complete control of their historic lands in the north.
The Houthis were having none of that, and in a political move that continues to confuse observers, they formed a political alliance with their longtime nemesis, the deposed Saleh, who was already seeking to regain power in 2013.
Reporter Iona Craig, who was then living in Sanaa, recalls that the Houthis, with Saleh’s formidable political and military connections, were able in 2014 to gain control of northern Yemeni cities including the capital, Sanaa. “Certainly at the beginning of this war it was Saleh who was really the driving force behind the Houthis and, yes, they were politically aligned to Iran but there was very little evidence, really, of the Iranians supporting the Houthis.”
There was no need for Iranian weapons in 2014. Saleh may have been out of office, but he still controlled much of the well-stocked, American-supplied Yemeni arsenal.
By March 2015, the Houthi/Saleh forces had conquered most of Yemen’s major cities and driven out the caretaker government of President Hadi, thoroughly alarming the Saudi government that supported him.
On March 26, 2015, Saudi Arabia led a bombing campaign to take out the Houthi military and its weapons. The Saudis also instituted a naval blockade aimed at preventing Iranian weapons from entering Yemen. Both the air and sea operations continue as of this writing.
And while claims of Iranian weapons deliveries were seen to be groundless in the opening months of the Yemen war, there is evidence now that the Iranians are assisting the Houthis militarily.
#Report: #Yemen army announces restoring balance of #missile deterrence#yemenpresshttps://t.co/ZJuzlAlOkb pic.twitter.com/YKhtfOdtXP
— yemenpress (@Yemenpress_org) March 4, 2017
“In the last few months — as you know we’re going into the third year of war now in Yemen — there has been growing evidence of Iranian involvement on the weapons front,” says reporter Craig. “Ballistic missiles … have clearly been modified, and new missiles have been built in Yemen to fire over the Saudi border — long-range missiles that did not exist in the Yemeni arsenal before this war have been used.”
Zionist Saud’s Military Base Destroyed in Yemen’s Zalzal-2 Missile Attack. @RiseUp75 #Trump #UN #US #Yemen #resistance #Zionism #Saudi pic.twitter.com/GhYzmPzcJB
— Asma Ahmad (@_asma_ahmad_) March 4, 2017
#Yemen Missile #Strikes Base In #Riyadh Again#yemenpresshttps://t.co/8EfKzE3WIS pic.twitter.com/wQfVdXXwJL
— yemenpress (@Yemenpress_org) March 18, 2017
If Iran’s influence in Yemen was hard to detect before, it is unmistakeable now. In the first months of 2017, the Houthis — and Tehran — have boasted of a newfound ability to attack Saudi Arabia. And as the war drags on, Iranian influence may grow.
“This is the risk and this is the danger,” says Craig. “The longer this war goes on, the likelihood is of more Iranian involvement rather than less.” That, says Craig, could drive Washington to step up its already significant material and logistical support of the Saudi-led military coalition.
And, Craig adds, it might even inspire the US to assume a more active role in Yemen. “The Trump Administration [could start] their own proxy war with Iran by bombing the Houthis,” she says, “and that’s the real danger now.”
Hello Psychaleppo: l’elettronica come evasione da una realtà sempre più surreale
Intervista a Samer Saer el-Dahr, nome originale del produttore musicale siriano conosciuto come Hello Psychaleppo
L’articolo Hello Psychaleppo: l’elettronica come evasione da una realtà sempre più surreale sembra essere il primo su Arabpress.
La democrazia e le sue nuove sfide
Le trasformazioni in atto nelle società attuali impongono una revisione del sistema democratico e dei suoi strumenti di azione
L’articolo La democrazia e le sue nuove sfide sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina palestinese: maramieh, tè alla salvia
Il tè alla salvia, è molto diffuso in tutti i villaggi della Palestina, spesso offerto a parenti e amici in visita. Il suo nome proviene dal racconto secondo il quale un florido cespuglio di salva avrebbe protetto il neonato Gesù e la vergine Maria (Mariam in arabo) dai soldati romani. Inoltre, questo infuso ha delle potenti […]
L’articolo Cucina palestinese: maramieh, tè alla salvia sembra essere il primo su Arabpress.
La tempesta di Erdogan
La Turchia volta le spalle all’Europa per guardare ai suoi interessi in Medio Oriente
L’articolo La tempesta di Erdogan sembra essere il primo su Arabpress.
Avviso agli studenti (di Palermo)
“Niente sarà più come prima”. Niente sarebbe stato più come prima, non solo nelle due Germanie, ma anche in Europa e nel mondo. Il significato profondo non sta in una frase che oggi, a quasi 28 anni di distanza dal giorno in cui fu pronunciata, può apparire lapalissiana, banale. Il significato è nell’uomo che l’haContinua a leggere
“Via dei ladri” di Mathias Enard
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Via dei ladri” di Mathias Enard sembra essere il primo su Arabpress.
#FreeAya
La foto di Aya Hegazy e di suo marito Mohammed Hassanein è stata scattata oggi in un tribunale del Cairo da Sherif Abdel Quddous, giornalista indipendente, il reporter che più di ogni altro segue i processi ai detenuti politici egiziani. Aya e Mohammed aspettano la sentenza. Possono incontrarsi solo bella gabbia riservata agli imputati, in tribunale. AllaContinua a leggere
Gli attentati di Damasco sono solo l’inizio
L’opposizione siriana e l’arma del terrorismo come lotta al regime
L’articolo Gli attentati di Damasco sono solo l’inizio sembra essere il primo su Arabpress.
Eni, Milano: ‘Il giacimento in Egitto emblema del nostro modello’
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Eni, Milano: ‘Il giacimento in Egitto emblema del nostro modello’ sembra essere il primo su Arabpress.
L’islam politico e la democrazia: una contraddizione in cerca di una soluzione
In questo periodo sorge più che mai spontanea la domanda: è possibile una coesistenza tra questi due sistemi?
L’articolo L’islam politico e la democrazia: una contraddizione in cerca di una soluzione sembra essere il primo su Arabpress.
Giustizia di transizione : Sami Braham, o della funzione terapeutica della sua audizione pubblica.
Frédéric Bobin Rasserenato dalla sua sconvolgente confessione fatta in diretta televisiva, questo ex prigioniero politico si preoccupa che la giustizia di transizione abbia un esito positivo in Tunisia. Bisognava rivederlo, Sami Braham, bisognava incontrare di nuovo colui il quale ha sconvolto l’intera Tunisia (e anche ben al di là) durante un’intera serata di confessioni in televisione, un’immersione nella profondità dell’orrore. […]
Lo schiaffo di Rima Khalaf
Le dimissioni della segretaria esecutiva dell’ESCWA e i rapporti stilati dall’ente negli ultimi due mesi rappresentano uno schiaffo alla censura e all’oppressione
L’articolo Lo schiaffo di Rima Khalaf sembra essere il primo su Arabpress.
I giovani jihadisti raccontati dai romanzi arabi
La scorsa settimana su Internazionale vi ho raccontato di come, tra i tanti tempi esplorati dal romanzo arabo contemporaneo, vi sia anche quello del jihad. Dal settembre del 2001 i romanzieri arabi hanno più volte tentato di raccontare la “guerra santa” globale dichiarata dai terroristi fondamentalisti contro l’occidente e i nemici dell’islam. È quello che […]![]()
#LibriCome: Intervista a Parisa Reza
Parisa Reza racconta la trasformazione dell’Iran tra gli anni ’20 e ’50 del secolo scorso, affrontato soprattutto grazie alla forza dell’amore che lega i protagonisti Talla e Sardar.
L’articolo #LibriCome: Intervista a Parisa Reza sembra essere il primo su Arabpress.
L’ossessione del “velo islamico” contagia anche la Corte di Giustizia europea
 Chi si occupi sistematicamente e da lungo tempo dei ricorrenti “affaire del velo” (cui di recente si è aggiunto quello del burkini) lo sa bene: nessuna argomentazione, per quanto razionale e raffinata sia, può far cambiare idea a chi assolutizza l’hijâb – null’altro che un foulard – quale minaccia “ai nostri valori” e simbolo di oppressione e oscurantismo, senza neppure preoccuparsi di distinguere tra “veli” imposti e “veli” liberamente scelti.
Chi si occupi sistematicamente e da lungo tempo dei ricorrenti “affaire del velo” (cui di recente si è aggiunto quello del burkini) lo sa bene: nessuna argomentazione, per quanto razionale e raffinata sia, può far cambiare idea a chi assolutizza l’hijâb – null’altro che un foulard – quale minaccia “ai nostri valori” e simbolo di oppressione e oscurantismo, senza neppure preoccuparsi di distinguere tra “veli” imposti e “veli” liberamente scelti.
Libano: no alle tasse!
Dopo la crisi dei rifiuti dell’estate 2015, i libanesi tornano in piazza per opporsi alla nuova legge di bilancio
L’articolo Libano: no alle tasse! sembra essere il primo su Arabpress.
More 70 websites counting : Online Censorship does not want to stop in Egypt
Whoever runs this ongoing online censorship latest crackdown does not want to stop !!
Now the number of blocked websites in Egypt jumped from 65 in the past 48 hours to 77 according to the Human rights law firm “Association for Freedom of Thought and Expression on Friday.
The new blocked websites in Egypt are :
- Al-Manassa News and Citizen Journalism website
- Noon Post
- Nooun feminist webzine
- Ida2at.com
- Madaad.net
- 6 April Youth Movement official website.
- Muslim Brotherhood affiliated-Mekameleen TV channel’s official website
- Muslim Brotherhood’s disbanded political army Freedom and Justice’s news portal.
- Turkey’s Hurriyet Daily News website
- Muslim Brotherhood affiliated Marsad Press
- Open Whisper System official website
I feel that sad that Al-Manassa news and citizen journalism platform has been blocked.
I think that website founded by veteran blogger and journalist Nora Younis joined the blocked websites list for its distinguished for its parliament’s coverage.
The website had an excellent parliamentary correspondent who used to reveal the tiniest thing happening the in the House of Representatives.
It was among that the few websites that followed minute by minute on Wednesday how the Tiran and Sanafir islands deal passed.
Turkey-based Noon Post is similar to Sasa Post. The Islamic leaning website used to have very interesting news reports and investigative reports from time to time.
Now, I think Nooun Feminist webzine is paying the price of having a similar name to Noon Post because other than that I cannot find a reason on why this blog webzine dedicate to women’s affairs and issues would be blocked now !!!!
Newly launched Madaad has joined the list. It is not a big surprise to me or others. Since day one , there was an expectation that the Nasserite news website affiliated with former presidential candidate Hamdeen Sabhi and his Popular Current Movement would be blocked because of its Tiran and Sanafir coverage.
Earlier this month , the new website made an interview with the commander of paratroops division in the Egyptian arm in 1967 , former Major General Abdel Moneim Khalil who spoke about the Tiran Island Egyptian POWs for the first time.
The website also made an excellent historical investigative report “which I envy” about the Egyptian POWs captured on that island and two of them were killed proved the current regime wrong. The current regime claims that we did not the price of blood on those two islands. I know this cliché but pardon me because I get emotional here.
I did not visit Cairo-based Ida2at.com or even know its true affiliation which I assume Islamist but I found out that the website published a news report about the documents proving the Egypianhood of that two islands of Tiran and Sanafir.
Once again we are back with Signal Messaging app and the Egyptian government.
Now , its official website “Open Whisper Systems” was reportedly blocked Friday night. Interestingly , the Signal service is still working. You do not need its official website to download it ironically. You can download it easily from App store whether on iOS or on Android !!
Interestingly earlier Friday , all the websites that have been blocked since May were unblocked for few hours.
It seemed that whoever runs that show decided to test some new setting or chose some option and unblocked the websites accidently in that expensive blocking software.
Again and again , there is a huge fear that the next move will be the social media networks especially Facebook as many of those blocked websites began to use it to publish its reports and article like Mada Masr.
Personally, I believe now the regime won’t block the social media especially Facebook because it is a major instrument to spread its propaganda and fake news.
By the way , the weekly issued of El-Sabah newspaper which is owned by businessman Ahmed Bahget was not printed on Friday because the Front Page of the newspaper had one word “Egyptian” in reference to the two islands with photo of legendary actor Mahmoud El-Milgy in his iconic role “Abu Swelam” in 1970-film “The land”
“I tuffatori di Casablanca”
Attraverso i taccuini e le fotografie della giornalista Rosita Ferrato e il tratto elegante delle illustrazioni di Paolo Galletto scorrono le “cartoline” di un viaggio in otto tappe, da Rabat a Tangeri, passando per Casablanca, El Jadida, Essauoira, Ma…
Gli USA sorprendono l’opposizione siriana
Dal comunicato Ratney “un’accusa” all’opposizione siriana che ha favorito il fronte Al-Nusra con il suo silenzio
L’articolo Gli USA sorprendono l’opposizione siriana sembra essere il primo su Arabpress.
Turchia: demistificazione di cinque miti della disinformazione
mcc43 Steven A. Cook Council on Foreign Relations Washington Post Five myths about Turkey No, its president isn’t a dictator, and the country isn’t secular. Cinque stereotipi sulla Turchia No, il presidente non è un dittatore e il paese non è laico La Turchia è stata a lungo un importante alleato dell’Occidente, ma, nonostante tutti […]![]()
La Libreria Griot di Roma incontra Hisham Matar
Lunedì 20 marzo evento speciale alla Libreria Griot (a Roma), di cui la vostra blogger è fedele e affezionata amica: alle 19.30 si terrà un incontro specialissimo con lo scrittore anglo-libico Hisham Matar, che converserà con Gennaro Gervasio, Università di Roma Tre. Hisham Matar in questi giorni si trova in Italia per un tour promozionale: […]![]()
Start-up a impatto sociale in Marocco, Tunisia ed Egitto
In questi tre Paesi stanno fiorendo una quantità di start-up che costituiscono l’avanguardia dell’imprenditoria sociale
L’articolo Start-up a impatto sociale in Marocco, Tunisia ed Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
L’Europa saprà arginare la corrente anti-islamica?
La mancata vittoria del partito di Geert Wilders in Olanda non implica la fine dell’ostilità per i musulmani d’Europa
L’articolo L’Europa saprà arginare la corrente anti-islamica? sembra essere il primo su Arabpress.
Sarà El Othmani l’uomo giusto?
Saad Eddine El Othmani è l’uomo giusto per formare il nuovo governo, in panchina da cinque mesi dopo il risultato delle elezioni. Un fallimento da parte del precedente leader del Pjd, Benkirane, nel trovare un compromesso con altri partiti per una maggioranza governativa. Ma se i cinque mesi sono stati…
L’articolo Sarà El Othmani l’uomo giusto? sembra essere il primo su MaroccOggi.
La rivoluzione egiziana tra speranze perse e apatia crescente
Il dittatore egiziano Mubarak è stato assolto dall’accusa di omicidio di massa e molti egiziani iniziano a perdere la speranza per il cambiamento del paese.
Cucina iraniana: koloocheh, dolci per il Capodanno persiano
In vista del Nawruz, il Capodanno persiano che si celebra ogni anno il 20 marzo, ecco la ricetta della cucina iraniana di una delle pietanze preparate per l’occasione: il koloocheh! Ingredienti: Per la pasta: 500g di farina 200g di zucchero ½ cucchiaino di lievito ½ cucchiaino di bicarbonato 2 cucchiai di olio 200g di burro non salato […]
L’articolo Cucina iraniana: koloocheh, dolci per il Capodanno persiano sembra essere il primo su Arabpress.
Marocco: crisi politica e soluzione costituzionale
Benkirane, rimosso dall’incarico di primo ministro, per legge viene sostituito da un membro del Partito Giustizia e Sviluppo (PJD)
L’articolo Marocco: crisi politica e soluzione costituzionale sembra essere il primo su Arabpress.
Quale futuro per le relazioni tra Egitto e Iran?
Mentre le relazioni del Cairo con Riyad si raffreddano, si intravede un’apertura con Teheran?
L’articolo Quale futuro per le relazioni tra Egitto e Iran? sembra essere il primo su Arabpress.
Le leggi crudeli, parte terza: Israele e attivisti israeliani per i diritti
mcc43 “Non puoi far pace con il nemico se non sei giusto con i tuoi cittadini.” L’informazione italiana si occupa diffusamente della politica estera di Israele, talvolta dei rapporti con l’Autorità Palestinese, ma trascura del tutto le narrazioni circa gli avvenimenti sociali, le proteste e le tensioni. Gli articoli pubblicati in precedenza hanno avuto per […]![]()
La settimana di Arabpress in podcast – XVII puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XVII puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Erdogan e l’indifferenza verso il destino dei musulmani in Europa
La facilità con cui espressioni iperboliche ed estreme vengono usate è un chiaro segno dell’allontanamento dallo spirito della democrazia
L’articolo Erdogan e l’indifferenza verso il destino dei musulmani in Europa sembra essere il primo su Arabpress.
Elezioni Olanda numeri vs opinioni
mcc43 “Ma la realtà è che gli olandesi hanno respinto la politica economica della coalizione, l’hanno sanzionata, di conseguenza significa che il paese non sta così bene come suggerirebbe un tasso di crescita gonfiato dalle ri-esportazioni [*nota] da Rotterdam e dagli effetti relativi alle agevolazioni fiscali per le multinazionali.” Questa l’estrema sintesi di La Tribune dello […]![]()
Benkirane silurato, si riapre la partita del governo
Il Re Mohamed VI ha rotto gli indugi. Ieri in un comunicato ufficiale, il monarca marocchino ha sollevato il leader del partito PJD dall’incarico di costituire una maggioranza governativa.Dopo cinque mesi di blocco e di braccio di ferro fra Abdelillah Benkirane e gli altri partiti con cui era in trattativa,…
L’articolo Benkirane silurato, si riapre la partita del governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Il Marocchino
Il leader populista olandese Geert Wilders aveva lanciato la sua campagna elettorale usando toni forti nei confronti degli immigrati marocchini, definiti “feccia” e promettendo di fare “di nuovo nostra” l’Olanda. Ora, la comunità marocchina ha una percentuale altissima e rappresentano l’islam nel paese. Ma è anche una comunità integrata che…
L’articolo Il Marocchino sembra essere il primo su MaroccOggi.
Cooperazione dolce
 |
| Un’ape “carica” dell’apicoltore Hatem Ait Ali |
In Algeria c’è un’associazione di produttori di miele di qualità che sfrutta tutte le sfumature climatiche producendo anche nel Sahara. E che lavora con gli standard proposti dalla “Carta dei mieli del Mediterraneo”. Un progetto europeo che ha un’anima umbra. Un reportage dalle nuove frontiere della biodiversità.
Si racconta che negli anni Sessanta, subito dopo l’indipendenza dalla Francia, il tunisino Bourghiba e l’algerino Boumedienne avessero qualche preoccupazione sulle mire espansionistiche dell’Egitto. Per evitare scomode ingerenze Bourghiba propose che la dizione Maghreb riguardasse solo i tre Paesi che avevano in comune… il cous cous, piatto tipico di Marocco, Algeria e Tunisia. Vero o non vero, questi tre Paesi hanno in comune anche l’apis mellifera intermissa o ape nera, un insetto prezioso e diffuso soprattutto in Algeria e Tunisia con colonie in Marocco e qualche puntata in Libia e nel Sud della Spagna. Ignorata per molti anni e con la fama (ingiustificata) di essere molto aggressiva, l’ape nera sta conoscendo un momento di splendore. Le università locali ne studiano le peculiarità e lavorano alla selezione e alla salvaguardia della specie. Ma questo lavoro è soprattutto diffuso in una nuova generazione di apicultori che, abbandonato il sistema tradizionale di allevamento, si è rapidamente messa al passo con le tecniche più recenti di selezione e cura delle api con l’obiettivo di trasformare l’apicoltura magrebina in un segmento produttivo che mira alla qualità del miele e che contribuisce alla biodiversità. E sì perché le api non producono solo miele, propoli, polline e pappa reale. Stimolano, con l’impollinazione, nuove colonizzazioni agricole che possono rendere verde anche il deserto.
 |
| Tahar Souna al lavoro |
Il viaggio comincia nei dintorni di Algeri nell’azienda famigliare dei Souna dove Tahar, che ha solo 36 anni, ci accoglie con grande cordialità. Tahar, il cui padre è morto l’anno scorso in un incidente, ha ereditato coi suoi tre fratelli, l’azienda paterna figlia di una grande ambizione. Per inseguire le fioriture naturali infatti, Tahar, come quasi tutti gli apicultori algerini, a maggio si sposterà nel Sahara dove suo padre aveva acquistato ben 400 ettari. Il sogno del vecchio Souna era rendere fertile una porzione di quelle terre aridi dove, se c’è acqua, cresce benissimo una specie della famiglia delle Ramnacee, lo jujubier che noi chiamiamo giuggiolo (Zizyphus vulgaris). Quest’albero da frutto è coltivato nella regione mediterranea per il frutto carnoso e dolce che può essere consumato crudo o essiccato. Ma adesso vien messo a dimora soprattutto per i suoi fiori gialli di cui le api sono ghiotte. Tahar ha scavato un pozzo a 400 metri di profondità e ha iniziato a trapiantare le pianticelle che ora crescono alla periferia di Algeri in una serra che mostra con orgoglio. “I semi – dice – li ha presi mio padre in Yemen” dove la tradizione vuole che lo jujubier raggiunga il massimo splendore. Tra qualche anno il nomadismo sahariano di Tahar si rivolgerà alle sue terre dove le pianticelle già iniziano a fruttificare. Niente discussioni dunque con altri apicultori, ghiotti, come le loro api, di questo fiore che dà un miele dolcissimo e ricercatissimo soprattutto sui mercati arabi e nel Golfo.
 |
| Giuggiolo o jujubier |
“Effettivamente – spiega Mohammed Hamzaoui, un apicoltore di Blida, alle porte di Algeri – c’è ormai molta concorrenza nelle regioni sahariane dove fioriscono diverse specie quando nella zona costiera, quella dove risiedono i produttori, i fiori sono caduti. Anche per questo abbiamo creato Anap, l’Associazione degli apicoltori professionisti, in modo tale che ci si possa mettere d’accordo”. Ma non è solo una questione di posti al sole: l’Anap ha sposato l’idea che il miele algerino possa essere alla pari con quelli prodotti in Europa dove gli standard sono elevati e richiedono un’apicoltura tecnicamente avanzata con prodotti garantiti. “Per ora siamo circa 200 soci ma non è il numero che ci preoccupa. Anzi. Chi vuole aderire deve infatti garantire gli standard che applichiamo: una difesa della qualità dei nostri prodotti”. L’evoluzione è recente e la racconta Hocine Difallah mentre ci accompagna nella sua azienda: “Durante l’epoca del terrorismo (gli anni Novanta ndr) l’apicoltura tradizionale ha visto un crollo: la gente scappava dalle campagne e abbandonava sia l’agricoltura sia le api. Ma dal Duemila in avanti, quando le cose hanno iniziato a cambiare, qualcosa si è mosso. Molti giovani hanno visto che col miele si poteva vivere ma anche che bisognava cambiare metodi e mentalità”. Hocine vive del miele e con lui altre tre famiglie. Ma si è “modernizzato”: nella sua azienda si prepara il polline, la pappa reale e si selezionano le “regine” che altri produttori vengono a comprare. C’è una filiera che comprende macchine per smielare ma anche un piccolo laboratorio dove il prodotto viene monitorato con attenzione. Se ne occupa Hassan, suo fratello, che tiene un libro mastro dove ogni arnia (son più di 700) ha un numero, una storia, una funzione. E il risultato si sente.
Hocine, Mohammed, Tahar – così come Jamal Bouazria che sta nella piana di Mitidja o Lounis Touati in Cabilia o ancora Hatem Ait Ali alle porte di Algeri – sono dunque una generazione di apicoltori che sta inaugurando una nuova stagione. Hanno aderito a un progetto promosso da APIMED, un’associazione che rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e che ha promosso la “Carta dei mieli del Mediterraneo” con standard in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiane. Il progetto si chiama Mediterranean CooBEEration ed è finanziato dall’Unione europea in partnership con altri soggetti tra cui il programma Art di Undp. Ma il suo cuore è in Umbria. E’ un’idea nata diversi anni fa nella testa di un apicultore, Vincenzo Panettieri, e che ha trovato il sostegno di Felcos Umbria, un fondo di Enti locali per la cooperazione decentrata. Attraverso quel progetto gli apicoltori algerini hanno avuto accesso a corsi di formazione e a una coscienza del loro lavoro che si è formata con la collaborazione di università e centri di ricerca sia in Europa (l’Università di Torino ad esempio) sia in altri Paesi del Mediterraneo (la Tunisia o la Grecia). Chissà che il miele di jujubier algerino non arrivi un giorno anche sulle nostre tavole.
Questo articolo è uscito su Repubblica Online.
A Homs, i russi sgombrano l’ultimo bastione dei ribelli anti-Assad
I russi svuotano al-Waar, cade l’ultimo bastione anti-regime a Homs Homs (al-Hayat, Fonti locali a SiriaLibano). A est del fiume Oronte, nella Siria centrale, sorgeva un borgo abitato da beduini sedentarizzatisi ai margini di Homs, un tempo la terza città siriana. Con il passare del tempo quel borgo è diventato sobborgo, diviso dalla città solo dal […]
Finanza Halal, un nuovo traguardo per il Marocco
Grande attesa per il lancio della finanza islamica in Marocco. A maggio di quest’anno il sistema bancario marocchino si doterà di prodotti finanziari Halal. In ritardo rispetto a tutti gli altri paesi musulmani, il Regno del Marocco ha autorizzato cinque banche islamiche ad entrare nel tessuto bancario del paese. Si tratta…
L’articolo Finanza Halal, un nuovo traguardo per il Marocco sembra essere il primo su MaroccOggi.
Rohingya: espulsione senza ritorno
 |
| Un’immagine di Mahmud Hossain dal servizio realizzato per Al Jazeera a Cox Bazar (Bangladesh) che si può vedere qui |
Chi ha dovuto lasciare le proprie case in Myanmar per cercare fortuna (e sopravvivenza) altrove potrebbe non poter mai più far ritorno a casa. Lo sostiene Yanghee Lee, UN special rapporteur on human rights in Myanmar, davanti all’UN rights Council di Ginevra. Quella dei Rohingya non è dunque una punizione temporanea ma un’espulsione totale o almeno un tentativo di farla. Lee chiede un intervento urgente e vorrebbe l’istituzione di una Commissione d’inchiesta ma il suo allarme sembra cadere nel vuoto. Le reazioni al suo rapporto, ha detto lei stessa ai cornisti, ha ricevuto reazioni tiepide per il difficile equilibrio tra potere militare e civile in Myanmar e per l’effetto destabilizzante che i risultati di un’inchiesta potrebbe avere.
Intervista a Khalid Ait Khardi: attivista per i diritti del popolo berbero
Se dovessi definirti in una sola frase, chi è Khalid? Sono un ragazzo normale, attivista per i diritti umani e ricercatore berbero originario del Marocco. Chi sono i berberi? I berberi sono il popolo indigeno del Nord-Africa. Le popolazioni berbere… Continue Reading →![]()
Un business dal cuore umano
 Il dibattito sul modello di sviluppo sta conoscendo una crescita febbrile. In America impazza inclusive capitalism, che ad alcuni sembra un nuovo modo di intendere la responsabilità d’impresa e ad altri sembra il belletto su un sistema in crisi specie dopo che, da produttore di merci, ha iniziato a fabbricare spazzatura finanziaria tossica. L’Ocse ci ha provato, sin dagli anni Settanta, che normative e regole che però sono appunto regole: non cambiano né il sistema di produrre, né la logica del profitto, anima e bestia nera del capitalismo. Un gruppo di ricercatori del Global Forum on Law Justice and Development, un organismo che fa capo alla Banca Mondiale, ha messo a punto qualcosa di diverso. Un progetto solo teorico per ora ma il cui nome già ne racconta l’essenza: “Human-Centered Business Model” è infatti un modello d’impresa centrato sull’essere umano e non (solo) sul profitto. E’ stato presentato alla World Bank a porte chiuse nel dicembre scorso e poi a Roma, in febbraio, al pubblico internazionale. Nella bella cornice di Palazzo Aldobrandini, sede di Unidroit uno dei partner dell’iniziativa.
Il dibattito sul modello di sviluppo sta conoscendo una crescita febbrile. In America impazza inclusive capitalism, che ad alcuni sembra un nuovo modo di intendere la responsabilità d’impresa e ad altri sembra il belletto su un sistema in crisi specie dopo che, da produttore di merci, ha iniziato a fabbricare spazzatura finanziaria tossica. L’Ocse ci ha provato, sin dagli anni Settanta, che normative e regole che però sono appunto regole: non cambiano né il sistema di produrre, né la logica del profitto, anima e bestia nera del capitalismo. Un gruppo di ricercatori del Global Forum on Law Justice and Development, un organismo che fa capo alla Banca Mondiale, ha messo a punto qualcosa di diverso. Un progetto solo teorico per ora ma il cui nome già ne racconta l’essenza: “Human-Centered Business Model” è infatti un modello d’impresa centrato sull’essere umano e non (solo) sul profitto. E’ stato presentato alla World Bank a porte chiuse nel dicembre scorso e poi a Roma, in febbraio, al pubblico internazionale. Nella bella cornice di Palazzo Aldobrandini, sede di Unidroit uno dei partner dell’iniziativa.
Il Progetto. Lo spiega Marco Nicoli, uno dei suoi ideatori: il progetto intende contribuire a sviluppare, per poi sperimentare sul campo, un nuovo modello d’impresa economicamente sostenibile, rispettoso dei diritti umani, dell’ambiente e delle comunità locali in cui s’inserisce. L’idea è quella di fornire una risposta concreta a quegli imprenditori che vogliano lavorare in modo etico e sostenibile e che non trovano risposta nei modelli economico/giuridici e nei meccanismi di mercato esistenti. Il nuovo modello d’impresa che il progetto vuol definire – a differenza di altre soluzioni unicamente “profit” – comprende caratteristiche comuni sia al settore profit sia a quello non-profit. Rispetto al modello profit, continua Nicoli, aggiunge obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Rispetto al non-profit prevede invece una forte identità attraverso un insieme comune di obiettivi d’impresa e misuratori di risultato. Ma la grande differenza tra le regole e le regolette per rendere più etiche le aziende sta nel fatto che il Progetto propone un nuovo modo di essere impresa sin dalla nascita. Una nascita non sotto il segno del profitto ma dove il profitto e’ solo una parte del tutto.
Un ecosistema d’impresa. Dal punto di vista operativo, intende identificare – in un ecosistema d’impresa – nuovi obiettivi e strumenti ossia nuove forme di governance, sistemi di finanziamento specifici o l’adattamento di quelli esistenti. Ma anche particolari strutture di tassazion
Il progetto in sei pilastri
Il Progetto si struttura attorno a sei pilastri (“Pillars”) che ne costituiscono le linee guida, una specie di statuto per queste nuove imprese
1 – “Guiding Principles” si occuperà dei principi, nel campo del funzionamento delle imprese centrate sull’essere umano, per guidare le imprese che vogliano produrre nel rispetto degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile.
2 – “Legal Framework and Corporate Governance” si occuperà di delineare (proponendone una disciplina) nuove forme giuridiche e di governo delle imprese.
3 – “Financial” elaborerà modalità innovative di finanziamento che possano sostenere le imprese che adottano questo modello.
4 – “Fiscal” proporrà soluzioni fiscali che riconoscano i costi aggiuntivi sostenuti da tali imprese virtuose ed incentivino il loro funzionamento socialmente e ambientalmente responsabile.
5 – “Procurement” presenterà politiche d’impresa e forme agevolate di acquisti pubblici, nel rispetto della concorrenza, premiando le imprese rispettose della legalità, e degli standard ambientali ed etici.
6 – “Capacity Building and Mentoring Support” si occuperà infine di iniziative formative e sistemi di sostegno tecnico specializzati.
Ascolta la trasmissione di oggi su Radio Vaticana
Egitto, Hosni Mubarak torna in libertà: l’ultimo colpo di coda della restaurazione
Il ritorno del regime militare del presidente Abdel Fattah El-Sisi aveva già abbondantemente fatto ripiombare l’Egitto negli anni bui della dittatura prerivoluzionaria. Ma l’ultimo colpo di coda della restaurazione è arrivato oggi, l’ultimo tassello che riabilita persino la famiglia Mubarak nello scenario politico del Paese. La Procura generale del Cairo ha disposto infatti il rilascio […]
L’articolo Egitto, Hosni Mubarak torna in libertà: l’ultimo colpo di coda della restaurazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
Syrie: Fatah al-Cham revendique les attaques anti-chiites de Damas
Le front Fatah al-Cham, ex-al-Qaïda en Syrie, a revendiqué dimanche 12 mars le double attentat qui a fait samedi 74 morts, dont de nombreux pèlerins chiites irakiens, dans la vieille ville de Damas. Le communiqué du groupe jihadiste indique que les attaques ont été menées par deux kamikazes.
Jonas Hassen Khemiri e Hisham Matar a Incroci di civiltà a Venezia
A fine marzo torna a Venezia il bel festival Incroci di civiltà, dedicato alla letteratura internazionale. Due sono gli autori che “ci” interessano e di cui vi avevo già parlato in questo altro post. Jonas Hassen Khemiri, scrittore svedese-tunisino, sarà a Venezia sabato 1 aprile, ore 11.30 @Auditorium Santa Margherita Ca’ Foscari, in conversazione con […]![]()
Tutti da Banksy sabato sera
E così Banksy ha deciso di investire i suoi soldi in una delle città più strangolate del mondo, di quelle che non è per niente facile raggiungere, per i turisti di tutto il mondo. Banksy, però, è un artista che riesce sempre a stupire, e dunque l’apertura del suo Walled Off Hotel è riuscita aContinua a leggere
Indonesians Gleefully Welcome Saudi King, But Activists Are Wary of Riyadh’s Influence

Saudi Arabian King Salman bin Abdulaziz Al Saud. Source: Flickr / Jim Mattis / United States government work
After a 47-year lapse, a Saudi King has visited Indonesia again. The visit was welcomed by many in Indonesia which is the world’s most populous Muslim-majority nation, but others expressed dismay the government didn’t raise the plight of Indonesian migrants suffering abuses in Saudi Arabia.
King Salman bin Abdulaziz Al Saud arrived in Indonesia on March 1 as part of his month-long Asian tour which also includes Malaysia, Brunei Darussalam, China, Japan, and the Maldives. The king was accompanied by 1,500 delegates, including 25 princes and 10 ministers.
The last visit by a Saudi ruler to Indonesia was made during the reign of Faisal bin Abdulaziz Al Saud.
King Salman was welcomed by Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) as the guardian of the two Islamic holy cities of Mecca and Medina.
A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Mar 1, 2017 at 7:23am PST
Jokowi also featured the Saudi king in his video blog. He emphasized that the historic visit of the king would lead to closer relations between Indonesia and Saudi Arabia.
Protection of Indonesian workers in Saudi Arabia
During the visit of the Saudi king, 11 agreements on cultural collaboration, trade and investment, science, crime fighting, and Islamic affairs were signed by Indonesia and Saudi Arabia.
Labor groups questioned why the Indonesian government failed to raise the issue of protecting Indonesian workers in Saudi Arabia, however.
Indonesia stopped sending workers to Saudi Arabia in 2011 because of the abuses suffered by migrants at the hands of their employers. But despite the ban, Indonesians continued to enter the kingdom to work as domestic helpers illegally, making them even more vulnerable to various forms of abuse.
According to the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, there are more than 630,000 Indonesians working in the Middle East, including in Saudi Arabia. But that number would be higher with the inclusion of undocumented workers and victims of illegal trafficking.
A peaceful protest in front of the Saudi embassy was organized by activists during the visit of the Saudi king. They demanded better human rights protection for Indonesian workers in Saudi Arabia where domestic workers are still considered by some abusive employers as kaffallah (property).
Presiden Jokowi Dinilai Tak Peduli Perlindungan TKI https://t.co/q8dROf72IM pic.twitter.com/G5H36qgOS8
— FSPMI KSPI (@FSPMI_KSPI) March 3, 2017
(President) Jokowi doesn’t focus enough on protecting of Indonesian migrant workers.
In response, the Indonesian government claimed that during a dialogue between Jokowi and the king, the issue of Indonesian migrant workers was discussed. King Salman reportedly assured Jokowi that he will treat the Indonesian workers as his own people.
Saudi Arabia and Indonesia must follow up Salman and Jokowi’s talk with technicalities on migrant workers protection https://t.co/RugOOvFNWt
— Andreas Harsono (@andreasharsono) March 2, 2017
Wahhabism in Indonesia
Rising extremism in Indonesia was also discussed by netizens during the visit of the Saudi king. Indonesia is generally known for its inter-religious tolerance, although Muslim hardliners have become more active in recent years through their vocal opposition to the current government, which they accuse of being weak in defending Islam. They have also issued calls to establish an Islamic caliphate in the region.
During his speech in front of Indonesian senators and legislators, King Salman encouraged closer collaboration to combat terrorism and extremism.
#RajaSalman mengajak Dunia bersatu & bertekad memerangi ekstremisme & terorisme, itu sebabnya meng-Haji-kan keluarga dari Densus88 yg gugur
— Hans P Siagian (HPS) (@HansPSiagian) March 2, 2017
#RajaSalman (King Salman) calls for global unity and commitment to fight extremism and terrorism, therefore he’s going to send family members of the fallen Densus88 (Indonesian counter-terrorism special forces) to the Haj pilgrimage.
7. Oleh karenanya, segala bentuk radikalisme dan ekstremisme disebut @KingSalman sangat penting untuk ditanggulangi #RajaSalman pic.twitter.com/5yoMTwTjG9
— Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) March 4, 2017
Therefore, it’s important to address radicalism and extremism, as mentioned by the king.
The king and his entourage also held a meeting with Indonesia’s religious leaders.
Saudi belajar pluralisme dari Indonesia. Kita belajar Wahabisme dari Saudi. Impas.
https://t.co/t1TOFFaRTh
— Berbagi Cerita (@idetopia) March 4, 2017
Saudi learns pluralism from Indonesia. We learn wahabism from Saudi. We’re even.
Despite the positive reception which greeted the Saudi king, some are still wary about the rise of Wahhabism in Indonesia.
Historically, the advent of Wahhabism in Indonesia occurred during the Dutch colonial era when Muslim leaders took arms to fight the Dutch colonial government.
But the strict interpretation of Wahhabism only gained momentum in the 1980s with the introduction of Saudi-funded language and cultural schools. Today, moderate Muslims in Indonesia are uniting to fight against the spread of extreme Wahhabi and Salafist interpretations of the religion.
Wahabi bukanlah wajah Islam yg kita inginkan. Dengannya Islam tampak tdk kompatibel dg kemanusiaan dan peradaban abad 21.
— savic ali (@savicali) March 5, 2017
Wahabi is not the face of Islam that we (Indonesians) want. With it, Islam seems incompatible with humanity and 21st century civilisation.
Written by Juke Carolina Rumuat · comments (1)
Donate
· Share this: twitter facebook reddit googleplus
Mario Dondero, semplicemente fotografo
 |
| Algeria 1986 “Il lettore”, una delle mie immagini preferite |
Essenziale e schiva come il personaggio di cui parla, la copertina del catalogo della mostra che si è aperta ieri a Bergamo alla Galleria Ceribelli, racchiude un volume prezioso e anche alcuni inediti di Mario Dondero, scomparso un anno fa – ça va sans dire – troppo presto. Lo dico perché le mostre fotografiche mi distraggono o meglio, mi distrae la gente, i commenti, i saluti che vi si fanno intorno. Anzi, direi che alle inaugurazioni vado per quello: incontrare e rivedere le persone che conosco e conoscerne di nuove, l’attività umana più fertile che esista, come Mario sapeva assai bene. Distratto dal vocio, dai pasticcini o dagli affetti – o ancora da qualche viso che suscita un’immediata curiosità o da un’assenza che segna un vuoto – ho visto più che guardato le immagini di Mario, molte delle quali conosco già. Ma a casa, con calma, caffè e toscano e la silente compagnia del mio amatissimo cane, ecco che il catalogo restituisce il lavoro e l’essenza della mostra: il lavoro di Mario ovviamente – ben stampato in Francia e tecnicamente organizzato da Philippe Bretelle per SilvanaEditoriale – ma anche di tutte le persone che hanno contribuito alla scelta e alle chiavi di lettura: la figlia Maddalena, Tatiana Agliani, Walter Guadagnini per non dire di Arialdo Ceribelli, uomo generoso e attento, di una squisita eleganza umana che molto piaceva a Mario (che me lo fece conoscere) e che è lo schivo architetto di questa operazione.
La scelta delle foto ripercorre la vita fotografica di Mario con ripescaggi attenti e singolari: molte cose si conoscono, altre meno, altre ancora si eran mai viste. Lavoro che si deve alle scelte di Maddalena e Tatiana, alla Fototeca di Altidona e all’inesauribile passione di Pacifico D’Ercoli e del suo staff (stiamo parlando di 350-400mila scatti!!!!). Rubo qui e là qualche brano dalle introduzioni che mi ha colpito: “Mario – scrive Maddalena Fossati Dondero – è stato un padre difficile, assente, luminoso, leggendario e itinerante e non sono sicura che questi aggettivi siano nell’ordine giusto”.
“E’ per questo – scrive Guadagnini – che Dondero è potuto apparire a tratti come un fotografo senza stile, mentre forse è stato, proprio come voleva il manifesto di alcuni suoi colleghi, contro lo stile“.
“Dai fotogrammi 35mm dei provini a contatto – suggerisce Agliani – dalle campiture nere e bianche di negativi ancora non provinati, osservati in trasparenza davanti alla luce di una finestra, si delineano gli orizzonti etici, morali, politici, la sensibilità e la poetica di un uomo che è stato un irriducibile esponente e interprete di quell’impegno civile, di quella tensione morale che ha segnato il pensiero del secondo Novecento”. Fa vedere, guardare, leggere.
Alcune immagini della mostra e un bell’articolo di Marco Belpoliti potete vedere e leggere qui
Un oggetto vintage
Questo è un oggetto vintage, che in questi giorni di marzo compie esattamente la bellezza di 10 anni. Dieci anni. Ha dato il nome a questo blog, nato l’anno successivo, nel 2008. Eppure, oggi soprattutto, mi sembra non sia passato un giorno. Gli arabi sono ancora invisibili, i loro luoghi anche. Arabi e città arabeContinua a leggere
La Knesset approva i progetti di legge contro l’inquinamento acustico delle moschee
Due le proposte di legge. Protestano i membri del partito a maggioranza araba. Il leader Ayman Odeh espulso dall’aula per averne strappato una…
2.600-year-old palace discovered under shrine demolished by ISIS (video)
… city of Palmyra in Syria – one of the Middle East’s most famous Roman sites. … Management Programme at the British Museum, told The Guardian.
Mario Dondero a Bergamo (sabato 11 marzo)
I’m migrant di Luca Negrini
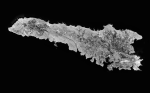
I materiali vengono pubblicati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione — Non commerciale CC BY-NC
Interpreting the matter of constant transition for the different actors inhabiting Lampedusa (Italy) and gathering their common needs together with what the island is lacking.
“Sleep, dear Chevalley, the Sicilians
want Sleep and they always hate
the one who wants to wake them,
even if he would bring them
the most beautiful presents; the
Sicilians never want to improve for
the simple reason that they think
themselves perfect; their vanity is
stronger than their misery; every
invasion by outsiders, whether
so by origin or, if Sicilian, by
independence of spirit, upsets their
illusion of achieved perfection, risks
disturbing their satisfied waiting for
nothing”
da “Il Gattopardo” , Tomasi di Lampedusa
The island of Lampedusa has for many years seen a constant flow of newcomers and tourists, staying only for a short period of time and then leaving. This has brought significant changes to the Lampedusian society that is slowly abandoning local traditions and methods in order to prioritize tourism. Through the creation of a meeting space, the project aims to exploit the big flow of people in a positive way to create different opportunities among the people inhabiting the island.
The project aims to fill up what the Island and its people are lacking and, at the same time, have a symbolic value as landmark and memory of what Lampedusa has been going through in the last years.
My reaction to the reality of this small Mediterranean Island, full of contradictions and potential, is a “bridge building” which wants to connect the main town street to the sea and be a clear response to the actual stillness of the government and local authorities in front of the current situation.

Papers: I’m migrant di Luca Negrini
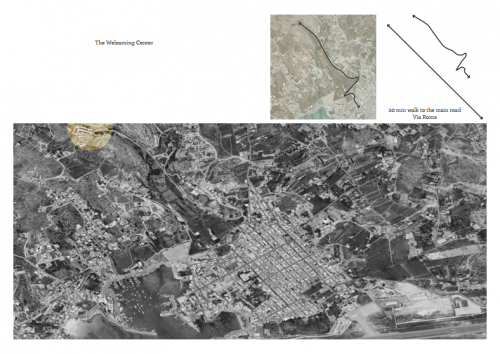
via Migrano http://ift.tt/2maLXaI
L’ esperienza di due attivisti siriani prigionieri dell’ISIS a Al Bab
“Il tempo trascorreva, ed io non mi sarei mai aspettato di tornare nel luogo in cui fui umiliato, né mi sarei mai aspettato di uscire.”
Protezione sussidiaria ad un cittadino Pakistano proveniente dalla regione del Punjab.

Si ringrazia l’Avv. Carlo Tramonte per la segnalazione ed il commento.
Il Giudice, evidenziando che nella regione pakistana del Punjab “… si registra una situazione di gravissima insicurezza in conseguenza dell’attività terrotistica posta in essere da parte di alcuni gruppi armati dell’estremismo islamico …”, ha riconosciuto al ricorrente, proveniente da tale regione, la protezione sussidiaria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 14, lett. c), D.lgs 251/07.
Scarica l’ordinanza:

Ordinanza Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2017


Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
via Migrano http://ift.tt/2nmbPAM
Si ringrazia l’AVV. Chiara Maiorano per la segnalazione ed il commento.

Si ringrazia l’AVV. Chiara Maiorano per la segnalazione ed il commento.
Il Ricorrente aveva dichiarato durante l’audizione in commissione territoriale di aver lasciato il proprio paese per cercare un lavoro in europa, in quanto in Senegal viveva in stato di povertà.
ll giudice, esaminato il ricorso, ha concesso al ricorrente la protezione umanitaria fondando la propria decisione unicamente sulla valutazione positiva dell’impegno profuso dal ricorrente durante il periodo dell’accoglienza: “ Si deve evidenziare che il ricorrente si sia positivamente impegnato nell’apprendimento della lingua italiana e che lo stesso si è impegnato in attivi.
Scarica l’ordinanza:

Ordinanza Tribunale di L’Aquila del 01 dicembre 2016


Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
via Migrano http://ift.tt/2n436H8
Egitto – Gli accordi con la Germania sui flussi migratori e il conflitto nel nord del Sinai
Nel giorno in cui Mubarak, i suoi figli e tutto il suo entourage vengono scagionati dall’accusa di aver ucciso più di 800 persone durante la rivoluzione del 2011, la cancelliera Merkel è al Cairo per rafforzare i rapporti tra Germania … Continue reading →
I VIP tornano al Cairo
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo I VIP tornano al Cairo sembra essere il primo su Arabpress.
Gli Arabi e l’Europa: intrecci di lingue e culture. A Milano il Festival
Al via nelle aule della Cattolica di Milano la terza edizione del Festival internazionale della lingua e della cultura araba
L’articolo Gli Arabi e l’Europa: intrecci di lingue e culture. A Milano il Festival sembra essere il primo su Arabpress.
Attacco al “nemico vicino”
 Lo Stato islamico in Afghanistan cambia strategia. Per scippare la scena ai talebani. Trenta morti all’ospedale militare di Kabul ( a dx in un’immagine di Tolonews)
Lo Stato islamico in Afghanistan cambia strategia. Per scippare la scena ai talebani. Trenta morti all’ospedale militare di Kabul ( a dx in un’immagine di Tolonews)
Sono le nove del mattino davanti all’ospedale militare Daud Khan, uno dei nosocomi più grandi della capitale con 400 posti letto e una sede nel cuore di Kabul, poco distante dal quartiere generale Nato e dall’ambasciata Usa. Un uomo si fa esplodere e consente così ad altri tre del commando di farsi strada nell’ospedale. Sono vestiti da paramedici e dunque, fino a quel momento, non hanno dato nell’occhio. Appena entrati iniziano a sparare su dottori, pazienti, tecnici e su chiunque si aggiri nei corridoi: oltre 40 vittime e decine di feriti. La gente cerca rifugio sul tetto e c’è chi salta dai piani alti per salvarsi. Alla fine, e sono ormai oltre le tre del pomeriggio, le forze di sicurezza hanno ragione del commando che si è ritirato sul tetto. Ma non sono talebani. Questa volta, con un’azione militare eclatante e in un edifico simbolico, la rivendicazione – sul sito di Amaq – è dello Stato islamico. E’ un salto di qualità. Uno schiaffo alla Nato e all’esercito afgano, al presidente Ghani ma anche alla guerriglia talebana cui ora il Califfato cerca di levare il primato nella guerra. La Croce rossa internazionale – già entrata nel mirino del Califfato anche in Afghanistan – denuncia l’ennesimo crimine contro l’umanità e la violazione di ogni regola umanitaria che impedisce di colpire gli ospedali.
C’è una scelta strategica nuova. Non più – o non solo – sparare nel mucchio di “takfir”, dei musulmani devianti come sono per Al Bagdadi sciiti, sufi o minoranze: è un’azione di guerra militare che si accoppia alle stragi finora condotte soprattutto contro chi non segue la corretta via delle scritture così come i salafiti le interpretano. I talebani sono costretti a prender subito le distanze: la guerriglia in turbante di mullah Akhundzada, dove c’è chi guarda anche al negoziato politico, viene spinta tra i “revisionisti”, tra gli incapaci non solo di seguire correttamente il Corano ma nemmeno più di avere la supremazia nella guerra di liberazione. Che per i talebani è guerra all’invasore e per Al Bagdadi guerra ai “crociati”.
La tecnica è quella del terrore puro come raccontano i resoconti di medici e pazienti. Una tecnica che lo Stato islamico associa alle stragi di sciiti di cui ha già nel carniere un buon numero. Ma questa è però la prima grossa azione militare “pura” dove il nemico è lo stesso che combattono i talebani per i quali, invece, gli sciiti sono sì dei devianti ma non devono essere colpiti. Fu proprio sull’atteggiamento da tenere con gli sciiti che maturarono le prime divisioni tra l’allora giovanissimo militante giordano al Zarkawi e Osama bin Laden che guardava con sospetto questa brillante recluta di Al Qaeda che però stava già maturando un progetto diverso. Progetto che applicherà poi in Medio Oriente preparando la strada al suo allievo più capace: Abu Bakr Al Bagdadi. Ora che il Califfo è in difficoltà sulle strade mediorientali e nelle città di cui perde i pezzi ecco che la guerra si sposta altrove e con altri metodi. Attaccando comunque (e anche questa è una delle linee guida di Al Bagdad) il “nemico vicino” ossia l‘esercito afgano, ancor più colpevole dei suoi alleati crociati.
Come reagiranno adesso governo e alleati è difficile dire. I talebani serreranno i ranghi perché non possono consentire che il vessillo della liberazione del Paese venga scippato dagli “stranieri” del Califfo. E forse gli americani manterranno la promessa di un aumento consistente delle truppe come vorrebbe, e Trump potrebbe ascoltarlo, il generale Nicholson che comanda Usa e Nato nel Paese. Ma i bombardamenti continui, che sono la nuova tattica americana, non hanno per ora prodotto che più vittime civili né hanno allontanato la sfida del Califfo che intanto – nemico comune di governo, alleati, talebani e qaedisti – dimostra di avere la forza per colpire.
Turchia, referendum e Occidente
Qualsiasi sarà il risultato delle votazioni, in assenza di una campagna elettorale democratica ci si chiede come sia possibile che la nazione sia libera di decidere
L’articolo Turchia, referendum e Occidente sembra essere il primo su Arabpress.
Scrittori e incontri al Festival della cultura araba di Milano
Si apre oggi a Milano il terzo appuntamento con il Festival internazionale della lingua e della cultura araba organizzato dall’Università Cattolica di Milano, che durerà fino all’11 marzo. Molti gli incontri e gli eventi di questo festival, che si caratterizza per essere un punto di incontro tra accademia e divulgazione. Tema di questa terza edizione […]![]()
Si ringrazia l’Avv. Stefano Maiorano per le segnalazioni. Il commento è della redazione.

Si ringrazia l’Avv. Stefano Maiorano per le segnalazioni. Il commento è della redazione.
Il Tribunale di Lecce con queste due ordinanze fornisce una ulteriore conferma dell’orientamento della giurisprudenza italiana nel ritenere i richiedenti asilo provenienti dal Mali aventi diritto perlomeno ad una protezione umanitaria.
Entrambe le sentenze ribaltano il parere della Commissione territoriale ed attraverso un’analisi geopolitica approfondita considerano il Paese, ed in particolare la regione di Kayes nel sud, in una situazione non ancora del tutto stabilizzata e caratterizzata da episodi di violenza localizzata. Una situazione “comunque grave che si è deteriorata nell’ultimo anno”, a tal punto da ritenere che “sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente”.
Alla luce di queste considerazioni ci domandiamo come l’Ue e soprattutto l’Italia possano stringere “patti su misura” con il Mali e, citando l’Alto rappresentante UE per gli Affari esteri Federica Mogherini, “impegnarsi in modo così specifico con un paese africano sul rientro dei richiedenti asilo respinti”, quando invece non solo le condizioni oggettive non lo permettono, ma avrebbero tutto il diritto a vedersi riconosciuta una tutela umanitaria. (ndr)

Scarica le ordinanze

Tribunale di Lecce, ordinanza del 18 gennaio 2017

Tribunale di Lecce, ordinanza dell’8 febbraio 2017


Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
via Migrano http://ift.tt/2mmcIM4
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione.
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione.
Una pronuncia molto interessante del Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittimo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa asilo politico (invece del permesso di soggiorno per motivi umanitari) da parte della Questura di Roma per un richiedente asilo a cui la commissione aveva accordato la protezione umanitaria e che di conseguenza aveva impugnato il provvedimento per ottenere il riconoscimento di una protezione internazionale.
Il Tribunale civile di Roma ribadisce che la Questura non ha alcun potere decisionale in questa fase in ordine alla tipologia di permesso da rilasciare e ricorda che l’art. 19 del Dlgs 150/2011, in caso di impugnazione ex art. 35, nel sancire l’effetto sospensivo si riferisce “all’efficacia esecutiva del provvedimento negativo dell’Autorità Amministrativa, vale a dire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione”, e non anche al provvedimento che riconosce una protezione umanitaria.

Scarica l’ordinanza

Tribunale di Roma, ordinanza del 6 febbraio 2017
via Migrano http://ift.tt/2nf7Aa4
ROSSOBRUNI ALLA CIOCIARA
La collusione fra estrema destra ed elementi “di sinistra” o “pacifisti” nel sostegno al dittatore siriano Bashar Assad non è una novità, ma si arricchisce costantemente di nuove conferme. Il prossimo 26 marzo, in provincia di Frosinone, si terrà un incontro sulla Siria cui parteciperà, in qualità di relatore, Ouday Ramadan, instancabile propagandista del […]![]()
Leila Alaoui, “Je te pardonne” alla Galleria Continua
La Galleria Continua di San Gimignano ospita dal 18 Febbraio al 23 aprile la personale postuma di Leila Alaoui, fotografa e video artist franco- marocchina. La mostra presenta un insieme di scatti fotografici provenienti da varie serie di lavori dell’artista, realizzati in diversi paesi del mondo: “Les marocains” realizzato in…
L’articolo Leila Alaoui, “Je te pardonne” alla Galleria Continua sembra essere il primo su MaroccOggi.
A Rosarno tra parole e lotta

La Calabria è così, passi una volta, ti fermi e poi sei costretto a tornarci.
Rosarno non si può definire una località di villeggiatura, “spostata” dalla tratta di un’autostrada infinita, adagiata, come nel volere degli antichi greci, in una collina che guarda il mare.
La terra della Piana (di Gioia Tauro) oggi, e Rosarno in particolare, è stata stuprata da un abusivismo selvaggio, un inquinamento visibile ad occhio nudo, un continuo di opere mia finite. La stessa terra in cui, per più di cinquant’anni, si sono combattute le ‘ndrine e lo sfruttamento lavorativo (vedi articolo di Terrelibere.org).
Tra connivenze istituzionali, vecchie e nuove lotte politiche e povertà dilagante
Siamo tornati a Rosarno, e lo facciamo oramai da più di un anno, per continuare a dar voce, in ogni senso, a coloro che, ultimi tra gli ultimi, dimenticati e sfruttati, raccolgono la nostra frutta per pochi euro al giorno nella terra dove la disoccupazione ha fatto scappare i giovani e intristito i vecchi.
Siamo tornati a Rosarno perché oggi più di ieri siamo convinti che la parola, in questo caso la parola italiana, sia fondamentale per l’acquisizione di diritti e dignità dei tanti braccianti africani che, come fantasmi, in una sorta di “prostituzione lavorativa”, vagano tra le campagne della Piana alla ricerca di un “lavoro”, eufemismo contemporaneo per definire la nuova, capillare, schiavitù.
Siamo tornati a Rosarno e per più di una settimana abbiamo portato avanti dei corsi di prima alfabetizzazione all’interno e all’esterno del ghetto, tra capre squartate, roghi di plastica bruciata, cumuli di spazzatura puzzolente, baracche in costruzione e prostitute scosciate a bordo strada.
San Ferdinando è proprio questo! Una grande zona industriale, per lo più abbandonata, a sinistra una tendopoli istituita nel 2010, subito dopo la famosa Rivolta, con annesso ghetto in espansione, a destra una grande fabbrica occupata. Tra ghetto e fabbrica vivono oggi più di 2500 braccianti in condizioni disumane e in attesa di spostarsi verso altre località del Sud per l’avvio di altre raccolte agricole. E questo è solo un piccolo lembo di un territorio, quello della Piana, che “ospita” migliaia di braccianti, per lo più rumeni, bulgari e africani, che spuntano la mattina in concomitanza di qualche incrocio per farsi accompagnare al campo dal caporale di turno. Caporale che è l’anello debole della catena o meglio “l’ultima ruota del carro”.
Pensare di debellare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura attraverso l’arresto di qualche caporale o qualche mafioso è pura follia.
Un po’ come scrive Roberto Saviano sulle pagine di Repubblica in un editoriale uscito proprio ieri dal titolo “Uomini e caporali nella Puglia che brucia” dimenticandosi (sic!) di menzionare la Grande Distribuzione organizzata che, imponendo prezzi dei prodotti e bocciando politiche legate ad esempio all’etichetta narrante, diventa la burattinaia di un Sistema voluto e ben rodato!
Dopo lo sgombero del ghetto di Boreano la scorsa estate e di quello di Rignano qualche giorno fa, quello di Rosarno resta il ghetto per antonomasia e, probabilmente, sarà così per molto altro tempo ancora. Un po’ perché simbolo di una Rivolta mai del tutto metabolizzata, un po’ perché frutto di strategie politiche che, in terra di ‘ndrangheta, profumano molto di connivenza.
L’ultima trovata delle istituzioni locali sarebbe quella di costruire, sempre all’interno della zona industriale, una nuova tendopoli, recintata e sorvegliata, dove inserire circa 500 braccianti, scelti non si sa in base a quali elementi, in un contesto che potrebbe tranquillamente riprodurre un regime simile a quello detentivo. Costo della trovata tra 600 e 700 mila euro.
Noi abbiamo risposto, e risponderemo, continuando i corsi di italiano all’interno del ghetto e del campo containers e con la costruzione di una struttura polifunzionale, Rosarno Hospital(ity) school, che, per la prossima stagione agrumicola, diventerà uno spazio condiviso all’interno di un ghetto marginalizzato.
Siamo tornati a Rosarno convinti che la parola sia l’unica arma per difendere i propri diritti ed affermare i propri bisogni.
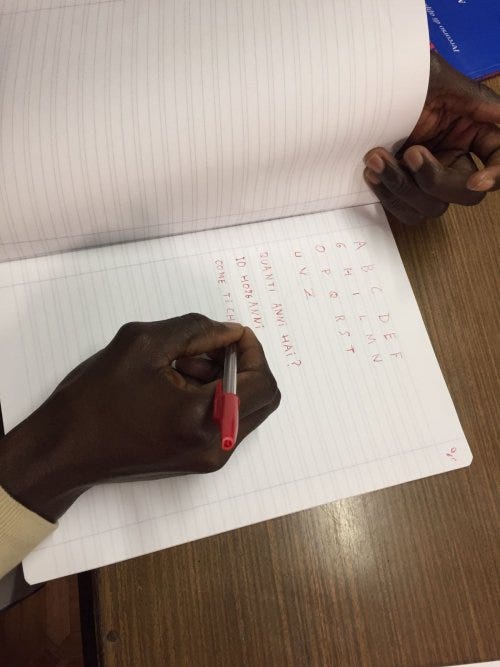
Links utili:

Collettivo Mamadou su FB — [email protected]
via Migrano http://ift.tt/2mB6lom
Ecco le donne più potenti del mondo arabo
Le top 5 tra le 25 donne presenti nella classifica dei 100 arabi più potenti del mondo arabo
L’articolo Ecco le donne più potenti del mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
La lingua perduta delle gru
Echoes un film di Gabriele Cipolla

La prima proiezione del film il 7 marzo al Respect Belfast Human Rights Film Festival.

Sinossi
Con l’acuirsi della crisi migratoria causata dalla guerra in Siria, Ungheria, Serbia e Macedonia chiudono i loro confini a migliaia di persone in fuga, interrompendo un’antichissima via migratoria: la rotta balcanica. In Grecia, lungo il filo spinato del confine macedone, uomini, donne e bambini si riuniscono nei campi profughi, immense tendopoli autogestite, dove NGO, volontari e attivisti sfidano il gioco delle mafie dei trafficanti di esseri umani.
Echoes ritrae un limbo nel quale alla disperazione di un futuro sospeso si contrappone una resistenza vitale e ostinata, concentrando il suo sguardo sul giorno precedente allo sgombero di Eko Station, l’ultimo campo informale rimasto nel nord della Grecia.
Attraverso le frequenze di una radio pirata parole e canti ribelli riecheggiano nel silenzio imposto dalla fortezza Europa.
ECHOES trailer (eng) from ECHOES FILM on Vimeo.
“Sono arrivato ad Eko camp a maggio del 2016”, scrive Gabriele, “insieme ad un gruppo di attivisti con cui collaboravo ormai da qualche mese. Stavamo portando nei campi autogestiti ed informali ai confini dell’Europa una radio pirata, Radio Noborder, uno strumento di aggregazione, ma anche una possibilità di racconto, un modo per le persone di darsi voce.
Fin dal primo ingresso nel campo mi sono reso conto che la presenza di macchine fotografiche, camere e cellulari era davvero diffusa: il campo aveva una copertura mediatica intensissima ogni giorno.
L’atto di filmare per me nasce quasi come una necessità, ma in quel momento mi chiesi se aggiungere l’ennesimo punto di vista, l’ennesimo sguardo, fosse davvero la cosa giusta da fare.
Così rimasi qualche giorno alla radio, senza utilizzare la camera se non per brevi filmati, partecipando alle trasmissioni e osservando come in realtà il nostro appuntamento quotidiano stesse diventando un punto di riferimento nel campo.
Ogni pomeriggio, centinaia di persone si ritrovavano intorno al gazebo che avevamo montato e condividevano storie, musiche e racconti al nostro microfono.
Fu così che conobbi prima Hussein, un giovanissimo rapper siriano rifugiato con il quale girai il videoclip di una sua canzone e poi iniziai a frequentare quotidianamente Mohammed e la sua famiglia allargata.
Ogni film comincia principalmente da un incontro, il processo di avvicinamento con i personaggi, che può durare anche mesi, è per me il momento fondamentale. Il tempo necessario alla conoscenza reciproca, mi fa capire quale sia la giusta distanza tra me, il soggetto e la camera, e inizia a creare l’orizzonte visivo entro il quale le nostre esperienze si incontreranno e diventeranno una narrazione anche per gli altri.
Quando ho intuito che era il momento di girare, io e Mohammed eravamo diventati amici. Seguirlo nei suoi spostamenti all’interno del campo ci sembrava naturale. Decisi così di concentrarmi sul racconto della sua quotidianità, evitando di spettacolizzare le loro vite o di approfondire esplicitamente il contesto socio politico di larga scala.
Vivendo per settimane insieme agli abitanti di Eko camp, ho sentito la necessità di riportare le persone al centro del discorso, facendole diventare i soggetti attivi delle loro narrazioni, per abbracciare la complessità di ciò che ci fa continuamente sperare, nonostante tutto e nei modi più impensati, ad un domani diverso”.

Un film di
Gabriele Cipolla
con
Davide Agnolazza
e Mohammed JJO
produzione:
Radio Noborder
Radio Noborder è una radio web e pirata itinerante, che tratta il tema dell’immigrazione dando voce a migranti ed attivisti di tutto il mondo.
#overthefortress
#Overthefortress è una campagna lanciata dal progetto Melting Pot Europa che mira al monitoraggio ed alla solidarietà attiva nei confronti dei migranti.
Macao
Macao è un centro indipendente per l’arte, la cultura e la ricerca.
Ha sede in una palazzina liberty, nel mezzo di una enorme area abbandonata vicina al centro di Milano. Propone un programma multi settoriale che ospita progetti, eventi e residenze nei più svariati campi dell’arte e della ricerca: arti visive e performative, cinema, fotografia, letteratura, musica, design, hacking, new media. È coordinato da una assemblea aperta di artisti e attivisti.
Durata: 76 min.
Lingua: Arabo, Curdo Siriano, Inglese
Sottotitoli: Inglese, Italiano
Formato di ripresa: digital 4k
Formati disponibili per la riproduzione: 4k DCP, HD file
Fotografia/montaggio/postproduzione:
Gabriele Cipolla
Mix audio:
Marc Brunelli
Musiche:
Eko camp
MZKY
Traduzione:
Kovan Direj
Sottotitoli:
Davide Agnolazza
Bio del regista:
Gabriele Cipolla, classe 1984, vive e lavora a Milano. Dopo aver frequentato la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, perfeziona il suo percorso come film maker studiando ripresa e direzione della fotografia presso la scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’. Il suo campo di ricerca spazia tra la cinematografia e le arti visive, lavorando parallelamente nel settore commerciale e nella sperimentazione, con progetti audiovisivi indipendenti. Dal 2012, Gabriele Cipolla è docente di post produzione cinematografica e di tecniche di regia presso la Scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’ e l’università NABA.

[Confini]
Grecia, lungo il confine della fortezza Europa.
L’ingente flusso di profughi causato dal prolungarsi del conflitto siriano ha portato alcuni paesi europei a prendere decisioni drastiche in materia di immigrazione. Paesi come l’Ungheria, la Serbia e la Macedonia, spinti da interessi politici xenofobi e populisti, ed in assenza di una presa di posizione chiara da parte dell’Europa, chiudono i loro confini ai migranti, portando di conseguenza all’interruzione di una delle vie migratorie storiche, la cosiddetta ‘rotta Balcanica’. Nel giro di pochissimo tempo migliaia di persone in transito ed in fuga si sono trovate bloccate lungo il confine settentrionale greco, separate dai familiari che li hanno preceduti, anche solo di qualche giorno. Si tratta soprattutto di persone provenienti dalla Siria, ma non solo: Afgani, Pachistani, uomini e donne provenienti dall’Africa centrale e settentrionale. In tutto, 60.000 tra rifugiati e migranti, politici o economici, ammassati lungo una linea ufficialmente invalicabile, dove si muove il più sordido dei poteri, quello delle mafie che trafficano essere umani.
Lungo gli snodi del territorio greco si formano spontaneamente numerosi campi profughi, tra i quali il più grande è quello di Idomeni, proprio a ridosso del confine Macedone, dove 13.000 persone, in un’immensa tendopoli, premono per oltrepassare la linea immaginaria che li divide dalla prossima tappa del loro viaggio. Il confine, tracciato perpendicolarmente ai binari arrugginiti di uno scalo merci, è difeso dalla polizia greca e macedone in assetto anti sommossa; scoppiano quasi quotidianamente dei disordini. All’interno del campo, la situazione igienico sanitaria è precaria, solo alcune NGO e soprattutto centinaia di attivisti da tutta Europa cercano di portare conforto e sostegno ai migranti in difficoltà. I campi autogestiti con le loro manifestazioni di protesta attirano su di sé molta attenzione mediatica e il governo greco, nel maggio 2016, è costretto a fare la sua mossa. In aree industriali dismesse e precarie, vengono costruiti dal nulla decine di campi governativi, gestiti esclusivamente dall’esercito greco. Le strutture risultano subito inefficienti e impreparate all’accoglienza, ma le operazioni di sgombero dei campi informali partono immediatamente. L’imperativo imposto dai militari è l’assoluto controllo delle presenze nei campi: alle organizzazioni di supporto è permesso entrare, gli attivisti e le piccole associazioni vengono bandite.
Le operazioni di sgombero di Idomeni e degli altri campi informali fanno parte di un processo inarrestabile, ma, per quanto sia ingente il dispiegamento di forze in campo, che necessita di tempo. Migliaia di migranti continuano ad accamparsi lungo il confine, anche per l’iniqua politica che divide i richiedenti asilo dai migranti definiti ‘economici’. Mentre da una parte, per far abbassare la tensione e facilitare le operazioni, viene paventata una rapida soluzione per i Siriano-Iracheni, in fuga dalla guerra, attraverso il Programma di Ricollocamento Europeo, dall’altra, grazie all’accordo tra Europa e Turchia, si aprono scenari di espulsione e rimpatrio obbligatorio per tutti gli altri. Nei campi di Hotel Hara e BP, tra gli ultimi informali rimasti a pochi chilometri da Idomeni, ogni notte centinaia di persone disperate tentano un’ultima carta affidando la vita e gli ultimi risparmi ai trafficanti.
Nel frattempo, dai campi governativi trapelano i racconti delle persone deportate al loro interno. Racconti di una situazione di totale abbandono, ancora più precaria che nei campi ribelli, dove ancora possono lavorare volontari ed attivisti.

[Eko Camp]
Alla campagna di sgomberi nei confronti dei campi informali sopravvive solo Eko Station, ultima realtà non governativa dove i migranti continuano a vivere o transitare.
Il campo sorge all’interno di un’area di rifornimento, lungo l’autostrada che collega il confine macedone a Salonicco. Si tratta di un campo popolato in maggioranza da curdi siriani, sorto quasi in contemporanea ad Idomeni, e che nel periodo di massima portata arriva ad ospitare circa 4.000 persone, delle quali oltre la metà bambini. Il campo è autogestito dai migranti, un avamposto di Medici Senza Frontiere fornisce supporto medico e generi di sussistenza, mentre associazioni, volontari ed attivisti si occupano della distribuzione alimentare e dell’allestimento di strutture educative e ricreative. Tra le tende, che si ammassano anche tra le pompe di benzina in disuso, quotidianamente svolgono le loro attività una scuola, uno spazio donne, un centro mobile di assistenza legale e una radio, Radio NoBorder.
Nonostante le minacce di uno sgombero forzato e le lusinghe della millantata e imminente partenza del Programma di Ricollocamento Europeo, Eko camp rimane fino alla fine popolato della sua gente. La resistenza verso le deportazioni nei campi governativi trae la sua convinzione dai racconti che in gran quantità arrivano al campo, attraverso le voci e le testimonianze delle persone che quotidianamente ne fuggono e grazie ai report degli attivisti, che sfidano capillarmente le imposizioni dell’esercito, violando le recinzioni e i divieti.
Eko camp respira e resiste, fino all’intervento della polizia in una triste mattina di giugno 2016, all’interno di una contraddizione che inspira l’intera esperienza del campo: da una parte le condizioni estreme alle quali i migranti sono costretti, l’umiliazione continua di una situazione precaria e inumana, dall’altra l’ultimo spazio di libertà rimasto, il solo punto di incontro con una Europa diversa, quella dei volontari e degli attivisti, che non impone un controllo ed un assistenzialismo fine a sé stesso, ma un processo di condivisione esperienziale e di costruzione.
Fino all’ultima lunga notte, da Eko camp, attraverso Radio NoBorder, risuonano insistentemente le voci e i canti di uomini e donne — prima che migranti o rifugiati, persone libere.

[Radio NoBorder]
Radio NoBorder trasmette ogni giorno da Eko camp in FM, attraverso un ripetitore e una lunga canna da pesca usata come antenna, e in streaming internet, attraverso una parabola satellitare. La programmazione della radio si crea ogni giorno a partire dalle esigenze del campo: racconti di esodo e di denuncia si susseguono intervallati dalla musica suonata live dai musicisti o proveniente dai telefoni dei migranti. La piccola redazione della radio, situata in quella che potrebbe essere definita la piazza principale di Eko, diventa da subito un punto di riferimento per tutti gli abitanti della tendopoli, scandisce le attività quotidiane educative e di distribuzione, trasmette la preghiera che segna la fine del digiuno del Ramadan, offre la possibilità di raccontare le vicende individuali, che si trasformano in questo modo in storie di tutti.
Non è la prima volta che Radio Noborder si trova in un campo: è una radio pirata itinerante, che tratta il tema dell’immigrazione dando voce a migranti ed attivisti di tutto il mondo.
L’idea nasce nella primavera del 2016 da un gruppo di attivisti indipendenti durante la loro permanenza all’interno del campo informale di Idomeni, sul confine greco-macedone. NoBorder, una stazione radio FM, viene installata all’interno del campo e gestita per alcune settimane da una redazione composta sia da attivisti che da migranti.
Lo sgombero forzato del campo di Idomeni, avvenuto nelle prime settimane di maggio 2016, non segna la fine del progetto: si decide di trasferire la radio all’interno dell’altro grande campo informale della zona, EKO camp, ancora immune dall’ondata di sgomberi, e dove molti abitanti di Idomeni si erano rifugiati per sfuggire alle deportazioni.
La prima trasmissione da EKO è datata 31 Maggio 2016, sulla frequenza FM 95.00, e viene realizzata utilizzando un vecchio trasmettitore di Radio Popolare Milano e un’antenna autocostruita. Si inizia anche a trasmettere in streaming attraverso un’antenna satellitare risparmiata dalla furia delle ruspe ad Idomeni, installata in precedenza da #overthefortress per il progetto noborderWiFi.
La radio diventa subito il più importante luogo di aggregazione all’interno del campo e intorno ad essa si costruisce una comunità di persone che si alterneranno ai microfoni e alle conduzioni per circa un mese.
Rimane nel campo fino al giorno dello sgombero, la mattina del 13 giugno, quando la polizia fa irruzione all’interno dell’area obbligando i rifugiati a salire sui bus per essere deportati nei campi governativi e arrestando gli attivisti, compresi i conduttori della radio che stavano monitorando e documentando la situazione.
Dopo l’esperienza in Grecia, tutto il materiale tecnico viene portato in Italia in attesa di essere riutilizzato. L’occasione per riaccendere le trasmissioni non tarda: nel luglio del 2016, a Como, sul confine italo-svizzero, centinaia di migranti africani rimangono bloccati nel parco della stazione dei treni, a seguito di un importante giro di vite da parte della Svizzera in merito al passaggio dei migranti attraverso il proprio territorio. La radio seguirà per tutta l’estate le vicende di Como, portando le testimonianze dei migranti e dei tanti attivisti e volontari presenti.
In Italia le cose non vanno diversamente che in Grecia. Il campo di Como viene sgomberato e Radio Noborder, dopo qualche mese di pausa, si riorganizza per aggregarsi, nei primi gorni di novembre, alla carovana in viaggio per il sud Italia di #overthefortress, un’azione di inchiesta e comunicazione indipendente al fianco dei migranti e delle realtà che li sostengono. La Radio trasmette, per tutta la carovana, ogni settimana da un luogo diverso, coinvolgendo attivisti e migranti conosciuti durante il percorso.

[Mohammad]
Intrecciando l’esperienza degli attivisti della Radio con le vite delle persone incontrate nel campo di EKO, nasce Echoes, un film che racconta la vita all’interno del campo attraverso le trasmissioni di Radio Noborder effettuate in Grecia.
Il film racconta l’ultimo giorno di vita del campo, prima dello sgombero, seguendo col suo sguardo Mohammad, uno dei più attivi conduttori e frequentatori della Radio.
La storia di Mohammad, incontrato tra uno streaming e una registrazione e diventato amico degli attivisti di Radio NoBorder, è in tutto e per tutto simile a quella delle migliaia di persone strappate alla loro casa dal conflitto siriano: una epopea durata anni, un viaggio intrapreso con la moglie Slava — attraversando montagne, fiumi e il mare assassino in condizioni estreme e dietro il ricatto dei trafficanti.
Il ricordo dei pericoli affrontati per arrivare in Europa e l’attesa infinita e sterile, è vivido nel cuore di Mohammed quando invia ai suoi amici europei della Radio un lungo messaggio vocale, dopo alcuni mesi dal loro rientro in Italia. Il messaggio arriva ad inizio settembre, e la scelta non è casuale: il messaggio che accompagna la sua voce è fin troppo chiaro.
“Tra poche ore partirò, io e Slava non possiamo più stare qui, abbiamo perso il figlio che aspettavamo, è ora di tornare a casa, in Iraq”.
È l’ultima notizia che abbiamo di lui.

Citazioni
“We thought we could start to think about a better life, but they closed the border in front of us.
We have just crossed over the deadly sea, we witnessed the death, but for the people the situation got worse. Beeing dead or alive, at this point, doesn’t make a difference for us,it became the same”.
(Mohammad, opening message)
“Pensavamo potessimo iniziare a pensare ad una nuova vita, ma ci hanno chiuso il confine in faccia.
Abbiamo attraversato il mare assassino, abbiamo sfiorato la morte, ma per noi la situazione peggiora.
Essere vivi o morti, a questo punto, non fa differenza, è diventata la stessa cosa”.
(Mohammad, messaggio d’apertura)
“My name is Israa, I’m seventeen years old and I’m Syrian, from Aleppo. My destination was Germany, where my father is. I wanted to accomplish my studies there as a pediatrician, but we lost everything”.
(Israa, syrian refugee, seventeen years old, interview at Noborder Radio)
“Il mio nome è Israa, ho diciassette anni e sono siriana, di Aleppo. La mia destinazione era la Germania, dove vive mio padre. Volevo finire li miei studi come pediatra, ma abbiamo perso tutto”.
(Israa, rifugiata siriana di diciassette anni, intervista a Radio Noborder)
“- Do you have any message to give to people from their same age living in Europe?
— I would like them to demonstrate for us, to do something for us, to make us live like them and study. Living in this tent destroyed our life”.
(Tolin Xelil, syrian refugee from Rojava, eighteen years old, interview at Noborder Radio)
“- Hai qualche messaggio per la gente della tua stessa età che vive in Europa?
— Vorrei che manifestassero per noi, per fare qualcosa per noi, per farci vivere come loro e per farci studiare. La vita in queste tende ci sta distruggendo”.
(Tolin Xelil, rifugiata Siriana del Rojava, diciotto anni, intervista a Radio Noborder)
via Migrano http://ift.tt/2lY0shP
Scorribande dei Corsari Barbareschi in Liguria
mcc43 La Guerra di Corsa differiva dalla pirateria poiché quest’ultima era, e tuttora è in alcuni mari, esercitata per conto proprio, mentre le navi corsare inalberavano la bandiera di un sovrano. Le coste della Liguria per secoli furono assaltate dai Corsari Barbareschi che combattevano per l’Impero Ottomano. Gli effetti concreti delle spedizioni di questi corsari, […]![]()
L’immigrato italiano

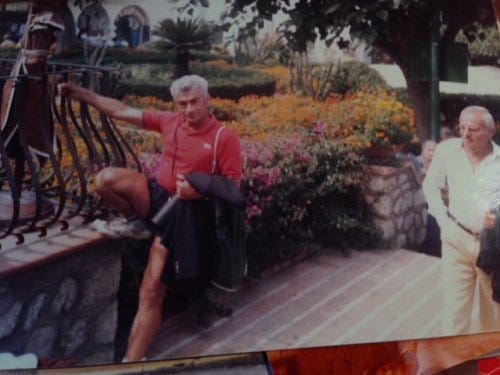
Questa fotografia ritrae mio nonno. Saranno stati gli anni 70 e non so bene dove sia stata scattata. Sicuramente stava facendo una gita. Ha scarpe da ginnastica usate, un binocolo, porta una giacca troppo elegante ed indossa una polo. Lo vedete l’altro uomo? Quello che cammina ben vestito con la mano in tasca? Quello è sicuramente un cittadino svizzero, dove i miei nonni sono emigrati, e sta guardando mio nonno. Sta guardano quello spaccone che si mette in posa per farsi una foto, con indosso dei cenci e pure accoppiati male. Parliamo degli anni dell’iniziativa Schwarzenbach culminata con il referendum del 7 giugno 1970 contro l’inforestierimento, soprattutto degli italiani.
Mio nonno è stato un grandissimo lavoratore; ha contribuito a costruire la via ferrata, ha lavorato in ristoranti, in ospedali come tutto fare, e faceva quanto più non posso. E’ partito da una terra e da una guerra che non poteva offrirgli più nulla, nonostante lavorasse da quando aveva 7 anni, giorno e notte.
In Svizzera non è andata meglio. Il costante razzismo nei confronti degli italiani era dilaniante e rendeva quasi impossibile integrarsi; dai loro racconti, infatti, le loro compagnie non erano composte da persone Svizzere. Mia mamma poi, è nata in Svizzera. Ha vissuto per 34 anni in Svizzera e ha partorito sua figlia in Svizzera. Ma non è mai stata cittadina Svizzera. Siamo sempre stati italiani.
E’ arrivata in Italia a 34 anni senza quasi sapere una parola nella nostra lingua e per me è stato lo stesso. Ricorda con terrore e con molto dolore le iniziative Schwarzenbach che l’hanno accompagnata durante la sua infanzia, adolescenza ed il resto della sua vita in quel paese.
Riguardare questa foto mi ha fatto sorridere. Oggi puntano tutti il dito contro i richiedenti protezione internazionale perché posseggono un cellulare, vestiti nuovi e non sono deperiti.
Vero, la differenza sta nell’assistenzialismo, i nostri nonni non lo hanno ricevuto: ma a quale prezzo? Quante sofferenze e vicissitudini hanno dovuto affrontare? Vogliamo essere quel mondo? Quel tipo di mondo?
Non si possono fare dei veri e propri paragoni, tuttavia il meccanismo rimane perlopiù invariato. Chissà cosa pensavano i vicini della mia famiglia? Chissà quante brutte parole sono state rivolte loro per mera ignoranza e xenofobia?
Riguardo quel binocolo e sorrido. Nonno, che ci dovevi fare con quel pesantissimo binocolo, custodito così tanto gelosamente? Quel binocolo che sopravvive ancora oggi.
Quel binocolo è uno status. E’ una voce che grida: “Ce l’ho fatta anche io! Sono qui in mezzo a voi e vivo!”.
Eppure quel binocolo, quel telefonino, quei cappelli curati, quelle scarpe nuove danno fastidio; fanno credere che le persone che ci stanno chiedendo aiuto non ne abbiano davvero bisogno, che sia tutta una messinscena.
Spesso, quando le persone si rivolgono a noi operatori dell’accoglienza, ci rimproverano queste cose e spesso non sappiamo cosa rispondere loro. La dignità, questa sperduta.
E’ difficile rispondere al mondo che un orologio non significa nulla, è solo un modo per appartenere ad un nuovo mondo. E’ difficile far comprendere che quando non hai nulla, perché nel tuo paese ormai globalizzato non hai soldi per vestire e mangiare, l’unica cosa che vorresti fare, seppure in un primo momento, è omologarti a tutti gli altri senza sentirti necessariamente diverso, escluso. Allora sì che potremmo comprendere che la prima cosa che fanno alcuni beneficiari, con il loro primo pocket, è comprare un cappello, delle scarpe, una qualsiasi cosa che non lo faccia sentire maggiormente diverso e discriminato. Non possiamo fingere di non sapere che essere povero, non possedere nulla, non sia pregiudicante. Essere un richiedente protezione internazionale lo è, essere povero anche. Se sei entrambe le cose sei doppiamente discriminato. Le persone, gli esseri umani, spesso non vogliono essere compatiti, vogliono che siano loro riconosciute abilità e dignità e molto spesso, questo, non lo facciamo.
E’ per questo che nei percorsi di accoglienza, quelli buoni, quelli dignitosi, sono di vitale importanza i percorsi individuali. Puoi fare percorsi individuali quando hai tre operatori e accogli 100 persone? No. Molto semplice.
Quanto ancora dovrà durare questa enorme differenza tra CAS e SPRAR? Per quanto ancora dovremo vedere migliaia di persone finire nelle grinfie di “lavoratori” (perché non posso chiamarli operatori) incompetenti o, comunque, messi in condizione di non poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro, permettendo ai propri capi di arricchirsi a dismisura?
Quanto ancora?
Nel frattempo guardo il binocolo di mio nonno e penso a quanto sia stato fiero di poterlo sfoggiare. A quanto avrà riflettuto prima di comprarlo (contadino che non spendeva soldi “inutilmente; gli sfizi e le vacanze non si sono mai visti nella loro umile vita) e a quanto ci teneva per non permettere a nessuno di toccarlo.
Penso a quel binocolo e a mio nonno l’immigrato.
Sabrina Yousfi, cooperaia Alternata SI.Lo.S
via Migrano http://ift.tt/2mTtl30
Campagna OverTheFortress: report assemblea nazionale

Report Assemblea Nazionale
CSA TNT — Jesi, 3 marzo 2017
Sabato 3 marzo si è tenuta la seconda Assemblea Nazionale della Campagna #Overthefortress. Alle presenze fisiche presso lo Spazio Comune Autogestito TNT di Jesi vanno aggiunte le partecipazioni in remoto on line. La discussione ha quindi avuto contributi di decine di realtà dislocate su tutto il territorio nazionale.
La campagna, iniziata nell’estate 2015 con viaggi di osservazione e narrazione attorno alle frontiere d’Europa, giunge ora ad uno snodo importante del proprio percorso. L’analisi politica che ci ha suggerito il nome resta valida, ed anzi oggi si rafforza: incontriamo frontiere militarizzate e muri non solo laddove corrono i confini tra Stati, ma nuovi dispositivi di separazione ed esclusione compaiono dislocati nei territori. L’operato del governo Gentiloni, che dà attuazione al Migration Compact proposto da Renzi ed adottato dall’UE, traccia il quadro dentro cui si situano l’istituzione dei nuovi centri per il rimpatrio (CPR), gli accordi bilaterali con Paesi retti da dittature, l’esternalizzazione e il controllo delle frontiere esterne finanziati attraverso un uso distorto della cooperazione internazionale. L’accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016 ha aperto una fase nuova nelle relazioni internazionali che condiziona il dibattito attorno alla revisione dell’Accordo di Dublino, il cosiddetto “Dublino IV”.
Fermando l’attenzione a quanto accade in Italia, il fatto storico costituito dall’ingresso forzatamente illegale (frutto di un’assenza di politiche di ingresso regolare e di canali umanitari) di centinaia di migliaia di persone non solo non incontra soluzioni politiche, anzi: a suon di disposizioni amministrative vengono tracciate nuove linee di separazione tra soggetti inclusi ed esclusi dalla sfera dei diritti. Le frontiere da indagare e narrare e lungo cui sviluppare interventi solidali sono dunque riterritorializzate e diffuse in ogni territorio.
La discussione si è sviluppata lungo tre assi: una migliore strutturazione dei viaggi di inchiesta e supporto, l’analisi della situazione migratoria nel quadro mutato dal decreto Minniti-Orlando e una proposta di agenda di mobilitazioni.
Viaggi di inchiesta e di supporto solidale
La cifra qualificante di #OverTheFortress è il continuo viaggiare, che consente di conoscere direttamente le condizioni materiali tanto dei dispositivi di frontiera quanto delle situazioni di vita dei migranti, e di confrontarsi con realtà sociali resistenti e solidali. Gli interventi lungo la rotta balcanica, nelle isole greche e la prolungata presenza nel campo di Idomeni, da ultimo il viaggio attraverso il Sud Italia e il muoversi, nuovamente, sulla Balkan Route hanno consentito di sviluppare elementi di analisi privilegiati. Se da una parte grazie alla semplice osservazione diretta dell’esistente possiamo già intravedere quali forme concrete assumeranno i dispositivi di respingimento o di rastrellamento, reclusione e rimpatrio che gli apparati repressivi stanno organizzando, riteniamo necessario un salto di qualità tanto nell’identificazione delle potenziali destinazioni quanto nel contributo progettuale da apportare, identificando come confine ogni luogo dove avvengono atti discriminatori su base etnica o razziale ed ovviamente di repressione della libertà di movimento. Il livello minimo di intervento è lo spazio europeo nella sua interezza, che va letto ed agito anche come ambito di costruzione di relazioni e di organizzazione. La discussione fa emergere la necessità e volontà di organizzare interventi progettuali qualificati e che si sviluppino attraverso la concreta cooperazione con le soggettività migranti. Particolare attenzione è stata posta sui cosiddetti “ghetti”, luoghi di esclusione e contigui all’iper-sfruttamento agricolo, ma al tempo stesso espressione di autorganizzazione dei migranti, di cooperazione sociale dal basso e di rivendicazione di diritti di cittadinanza.
La situazione migratoria ed i nuovi provvedimenti governativi: una campagna politica contro i CPR e per il diritto di soggiorno.
L’azione legislativa italiana si sta sviluppando in piena continuità con l’agenda europea sulle migrazioni del 2015 e il Migration Compact, ribadendo come l’Italia sia ora laboratorio europeo “all’avanguardia” nell’innovazione normativa.
La circolare Gabrielli del 30 dicembre 2016 ed i rastrellamenti dei cittadini nigeriani del mese scorso sono state le premesse al pacchetto securitario del decreto Minniti-Orlando, che di fatto smonta completamente le procedure di inclusione dei richiedenti protezione internazionale e dei migranti nella sfera del diritto. Se da una parte il decreto legge del 17 febbraio, che deve essere convertito in legge nazionale, introduce i CPR sottraendo risorse all’inclusione, indebolisce il diritto di difesa dei richiedenti asilo ed abolisce il ricorso in Corte d’Appello contro i dinieghi delle Commissioni territoriali, dall’altra i dispositivi di disciplinamento dei richiedenti asilo nel fallimentare sistema di accoglienza emergenziale sono volti a smorzare sul nascere qualsiasi forma di protesta. Uno sguardo più largo a livello continentale restituisce il montare delle pratiche di criminalizzazione e repressione verso i migranti, confinati dalle nuove cortine di ferro ed azzannati dai cani delle guardie di frontiera, bollati come clandestini e quindi costretti ad una esistenza da invisibili. L’Ue ha in serbo di attuare nel prossimo periodo 1 milione di deportazioni di migranti.
L’analisi delle modalità di applicazione delle leggi rende evidente come il diritto sia applicato in forma differenziale, creando sistemi di perimetrazione ed esclusione non solo delle soggettività migranti ma più in generale di ogni categoria sociale non compatibile con un sistema socio-economico informato dai principi del neoliberismo.
Migliaia di migranti che risiedono oramai da anni in Italia vengono costretti alla clandestinità e alienati da ogni diritto a causa dei dinieghi deliberati dalle Commissioni, della perdita del reddito o della casa e degli altri dispositivi di legge pensati per produrre la decadenza del titolo di soggiorno. Opporsi a questa situazione significa rivendicare il diritto all’emersione dal “soggiorno in nero” e la promozione di una campagna finalizzata al riconoscimento della condizione di soggiornante come fonte del diritto di restare e di regolarizzare la propria posizione con il conseguimento del permesso di soggiorno. La lotta per il riconoscimento del diritto di restare deve costituire il fulcro della nostra risposta alle logiche di deportazione e di confino perseguite dal governo Gentiloni e rilanciate dalla UE.
Agenda e mobilitazioni
Dall’assemblea è emersa la necessità di sviluppare azioni, progetti e connessioni organizzative che siano in grado di contrapporre alla “cooperazione internazionale” del Migration Compact, che legittima e finanzia governi corrotti e Paesi non sicuri in cambio di un controllo da parte di essi dei loro confini e dell’accettazione degli espulsi, la reale cooperazione sociale che cresce nella solidarietà, nelle lotte e nelle mobilitazioni.
Per quanto riguarda le mobilitazioni un primo passaggio è stato individuato nei percorsi territoriali che si stanno organizzando a partire dall’appello del City Plaza Hotel di Atene. Nei giorni del 18 e 19 marzo molte realtà rappresenteranno i loro percorsi di cooperazione locale e di rifiuto della guerra ai migranti in corso; oltre all’appuntamento di Venezia con la marcia regionale, altre iniziative a Milano, Torino, Firenze, Brescia, Ancona chiederanno diritti e dignità per i/le migranti. Dall’assemblea si invita alla partecipazione alle iniziative già in costruzione e all’organizzazione di ulteriori piazze.
L’opposizione all’operato politico dell’Unione Europea saccheggiatrice di risorse, promotrice di guerre e sconvolgimenti climatici che forzano a migrare intere popolazioni, e che poi produce dispositivi di chiusura, blocco della mobilità ed espulsioni di massa, deve trovare nella giornata del 25 marzo un momento di forte e significativa espressione. Nel giorno in cui i rappresentanti delle leadership europee si troveranno a Roma per celebrare i 60 anni dalla firma dei Trattati UE, è necessario portare nelle mobilitazioni dei movimenti che attraverseranno quella giornata la tematica delle migrazioni, dei diritti negati, delle deportazioni, della necessità di rovesciare dal basso le politiche europee delle frontiere, che non sono solo quelle dei confini geografici, ma anche quelle in cui vengono confinati i diritti, le povertà, il bisogno sempre più diffuso di protezione dalle conseguenze devastanti e multiformi prodotte dagli attuali assetti economici, politici e finanziari.
Per le stesse ragioni e per dare continuità ad una nuova stagione di protagonismo sociale sulle tematiche trattate l’assemblea ha individuato nelle mobilitazioni previste in occasione del G7 che si terrà a Taormina il 26–27 maggio un altro percorso all’interno del quale è necessario essere presenti e partecipare attivamente.
Info: [email protected]
via Migrano http://ift.tt/2lT36Vr
Buone notizie
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Buone notizie sembra essere il primo su Arabpress.
“International Women’s Film Festival”: Il Cairo festeggia il gentil sesso
Al-Bawaba. Per il suo 10° anniversario, il “Cairo International Women Film Festival” ha reso noto il suo programma 2017 poco prima dell’inizio ufficiale dell’evento, che si sta svolgendo e si concluderà il 9 marzo prossimo. Il Festival, lanciato nel 2008, prevede quest’anno ben 59 film provenienti da più di 23 paesi. Secondo gli organizzatori, esso include i più importanti film realizzati da registe donne, provenienti […]
L’articolo “International Women’s Film Festival”: Il Cairo festeggia il gentil sesso sembra essere il primo su Arabpress.
L’indipendenza del potere giudiziario in Tunisia
Quando in un paese democratico e avanzato i tre poteri dello stato cooperano tra di loro senza prevalere gli uni sugli altri ne deriva sicurezza e pace sociale
L’articolo L’indipendenza del potere giudiziario in Tunisia sembra essere il primo su Arabpress.
Occidentali’s Islam, come l’Occidente ha costruito il suo Islam
L’Occidente cristiano ha in qualche misura stigmatizzato la figura del musulmano e più in generale dell’orientale, identificandolo di volta in volta con una serie di caratteristiche finalizzate a sottolineare l’alterità, piuttosto che la somiglianza tra i due mondi. Di questo processo si… Continue Reading →![]()
Ciò che resta della primavera marocchina
Il Marocco commemora il sesto anniversario del Movimento 20 Febbraio
L’articolo Ciò che resta della primavera marocchina sembra essere il primo su Arabpress.
Ghana. Protezione umanitaria a seguito della situazione di fragilità e d’insicurezza del…
Si ringrazia l’Avv. Laura Mistichelli per la segnalazione ed il commento.
Con ordinanza pubblicata il 10.01.17 il Tribunale di L’Aquila, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Salari, ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino proveniente dal Ghana, fuggito dal suo paese nel timore di essere arrestato per l’incendio divampato il 17 luglio di quell’anno presso il mercato di Kumasi ove egli svolgeva il lavoro di guardiano notturno.
Il ricorrente produceva una serie di documenti che radicavano la sua buona fede soggettiva secondo l’insegnamento di Cass. 16201/2015 nel senso della credibilità del racconto e dei riscontri concreti (articoli giornali sia sull’incendio alla data riferita, sia le notizia di stampa circa il concreto pericolo di un incendio al mercato in questione, sia la ricerca diramata dalla polizia nei suoi confronti e della fuga come narrata dalla moglie).
Il giudice ha ritenuto che la situazione di fragilità e la situazione d’insicurezza del ricorrente — “esposto ad un’accusa poco verosimile quale quella di avere incendiato il più grande mercato dell’Africa Occidentale con una candela- mentre sembra possibile che l’incendio si sia sviluppato per effetto di un corto circuito, tant’è che il ricorrente narra dell’avvenuto black out (frequente) che lo ha spinto ad accendere una candela per segnalare la propria presenza all’interno del mercato” meritassero considerazione nella forma della protezione umanitaria.

Scarica l’ordinanza:

Tribunale di L’ Aquila, ordinanza del 10 gennaio 2017


Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
via Migrano http://ift.tt/2mX74OB
Si ringrazia l’Avv. Laura Mistichelli per la segnalazione ed il commento.
Con ordinanza dell’11.01.17 il Tribunale di L’Aquila, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Salari, ha riconosciuto la protezione…
We are goods
La merce siamo noi
Decreto legge Minniti-Orlando: dov’è la giustizia?
Venezia incontra il fumetto e la letteratura araba per l’infanzia
Il Master MIM (Mediazione Inter-Mediterranea) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nel mese di marzo ha in programma tre bellissimi incontri attorno al fumetto arabo e alla letteratura araba per l’infanzia. Lunedì 6 marzo, ore 16,30 (Ca’ Bernardo): Leggere a fumetti l’Egitto di oggi: trasposizione fumettistica di Thomas Azuélos del romanzo di Sonallah Ibrahim. Incontro con l’autore […]![]()
Merkel in Tunisia ed Egitto: tra promesse di investimenti e pressioni diplomatiche
Le ragioni della visita da parte della Cancelliera tedesca ai due Paesi nordafricani sono molte, così come le questioni discusse
L’articolo Merkel in Tunisia ed Egitto: tra promesse di investimenti e pressioni diplomatiche sembra essere il primo su Arabpress.
“La Mecca-Phuket” di Saphia Azzeddine
 Un racconto lungo che cerca di narrare le contraddizioni e il dilemma vissuto da una ragazza di origini marocchine cresciuta in una banlieue povera di Parigi. La protagonista del racconto è la primogenita di una coppia di marocchini arrivati in Francia con tanta voglia di “integrarsi” e vivere come i francesi.
Un racconto lungo che cerca di narrare le contraddizioni e il dilemma vissuto da una ragazza di origini marocchine cresciuta in una banlieue povera di Parigi. La protagonista del racconto è la primogenita di una coppia di marocchini arrivati in Francia con tanta voglia di “integrarsi” e vivere come i francesi.
Putin e Trump: fine della luna di miele
L’idillio tra Mosca e Washington sembra giunto al termine dopo le prime divergenze sulla Siria
L’articolo Putin e Trump: fine della luna di miele sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – XVI puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XVI puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Cucina yemenita: jabeez di Aden
La ricetta di oggi viene dallo Yemen, in particolare dalla città di Aden: il jabeez di fagioli! Ingredienti: 150g di fagioli dall’occhio 70g di farina 1 cipollotto tritato 1 cipolla tritata 1 uovo 1 cucchiaio di lievito spezie: curcuma, pepe nero, cumino in polvere, coriandolo tritato 450ml d’acqua sale e olio (d’oliva o di semi) Preparazione: […]
L’articolo Cucina yemenita: jabeez di Aden sembra essere il primo su Arabpress.
L’innocenza di Mubarak agli occhi della storia
L’ex presidente egiziano Hosni Mubarak è stato assolto dalle accuse che lo vedevano coinvolto nell’uccisione di manifestanti durante le rivolte che nel 2011 hanno portato alla caduta del suo regime
L’articolo L’innocenza di Mubarak agli occhi della storia sembra essere il primo su Arabpress.
Sgombero al Gran Ghetto di Rignano: dopo il corteo i morti di stato
Dimanche 19 mars à Venezia/ Venise : Side by side en marche pour l’humanité
“We need doctors”. Ma a Belgrado prestare soccorso ai migranti è illegale
Si ringrazia l’Avv. Cristian Valle per la segnalazione ed il commento.
Una recentissima ordinanza del Tribunale di Napoli che riconosce ad un cittadino ivoriano il diritto alla protezione sussidiaria.
Il…
Bolzano — Cosa sta succedendo in strada?
Donderiana: a Bergamo l’11 marzo
 A poco più di un anno dalla scomparsa di Mario Dondero, la mostra propone un viaggio nella
A poco più di un anno dalla scomparsa di Mario Dondero, la mostra propone un viaggio nella
poetica e nell’universo di storie raccontate da questo fotografo, inguaribile freelance che ha da sempre rifiutato il legame stabile con un giornale per viaggiare e raccontare il mondo in totale libertà.
La mostra – spiegano alla Galleria di Arialdo Ceribelli, grande amico e sostenitore di Mario – intreccia momenti e aspetti del suo suo lungo percorso di vita: l’appassionante ritratto costruito negli anni sul mondo della cultura europea del secondo Novecento, con la sua ricchezza di idee, il fermento di sperimentazioni e la tensione morale che lo attraversa, a Roma, a Milano, a Parigi, come a Londra; le immagini di importanti momenti storici come il maggio francese, la caduta del muro di Berlino, i conflitti del Medio Oriente, ma soprattutto il racconto della “storia minuta”, della vita quotidiana della gente comune. , la vita che scorre per tutti”, come scriveva Dondero. Ecco allora le fotografie dei villaggi del Mali, del Senegal, del Niger, dove Dondero torna ripetutamente soprattutto nel corso degli anni settanta, delle famiglie contadine in Portogallo, Italia, Spagna, di Cuba, negli anni più duri dell’embargo, della vita nella Russia di Putin. Volti, ritratti di uo mini e donne, frammenti di vite che ci guardano e ci parlano attraverso l’obiettivo del fotografo, coinvolgendoci nel dialogo appassionato che Mario Dondero ha intessuto per tutta la sua vita con il mondo e la realtà.
GALLERIA CERIBELLI
MARIO DONDERO
un uomo, un racconto
11 MARZO – 13 MAGGIO 2017
Catalogo in galleria, testi di Walter Guadagnini, Tatiana Agliani Lucas.
Galleria Ceribelli – Via San Tomaso 86 – 24121 Bergamo tel.035 231332
Orario 10.00-12.30 – 16.00 19.30 chiuso domenica e lunedì
www.galleriaceribelli.com – [email protected]
Una biblioteca in inglese per Gaza
Quanto può essere difficile avviare una biblioteca pubblica con libri in inglese? Non troppo, no? A meno che non vi troviate in un posto come Gaza, dove gli accessi al mondo esterno sono bloccati, dove la censura interna è onnipresente e dove l’ultima guerra di Israele ha distrutto (anche) gran parte del patrimonio librario e […]![]()
L’Iran in una fase delicata
Oltre alla politica estera, il Paese si trova a dover affrontare ad un possibile cambiamento al suo interno
L’articolo L’Iran in una fase delicata sembra essere il primo su Arabpress.
La Tunisia, un paese sempre più “europeo”
Santiago Alba Rico Lo scorso 15 febbraio il Primo Ministro tunisino Youssef Chahed, in visita in Germania, ha partecipato a un tesa riunione con la sua omologa Angela Merkel. Il motivo della discordia? La scarsa diligenza delle Autorità tunisine nel rimpatriare 1.500 immigrati clandestini che l’attentato di Berlino del dicembre 2016 -il cui autore veniva dalla Tunisia- ha reso […]
Appuntamenti jihadisti il 1 marzo (a Milano)

————— Milano ore 18 ——
Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda
domani a 1 marzo, 2017@18:00–19:30
un libro di i Giuliano Battiston
Quartiere Isola, in via Carmagnola 4 angolo via Pepe.
con Andrea Carati, Università degli Studi di Milano
Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore freelance
Emanuele Giordana, giornalista e saggista
ed Elisa Giunchi, Università degli Studi di Milano
Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore freelance, scrive per quotidiani e periodici tra cui “l’Espresso”, “il manifesto”, “pagina99” e “Lo straniero”. Esperto di Afghanistan, si occupa di islamismo armato, politica internazionale e globalizzazione. Per le edizioni dell’Asino ha pubblicato i libri-intervista Zygmunt Bauman. Modernità e globalizzazione (2009) e Per un’altra globalizzazione (2010).
—————– …più tardi a Seregno ————-
Incontro “Dentro il Jihadistan”
Perchè l’islam, non è il nemico
1 marzo 2017
Sala Minoretti
Circolo Culturale San Giuseppe
Via Cavour 25, Seregno
L’incontro verrà introdotto da Alberto Rossi (Pres. Il Caffè Geopolitico), e moderato in maniera
attiva da Lorenzo Nannetti (Resp. Scientifico Il Caffè Geopolitico).
Relatori: Emanuele Giordana (Giornalista e scrittore) e Arturo Varvelli (Analista, ISPI)
Gli orari verranno gestiti in maniera flessibile dai relatori e dal moderatore
21.00 – 21.15 Presentazioni e introduzione ospiti (A. Rossi)
21.15 – 22.15 interventi (circa 25 minuti totali per relatore)
Moderatore della serata sarà Alberto Rossi
La sala dove si svolge l’incontro è all’interno di una zona chiusa al traffico, è possibile parcheggiare
comunque nei pressi di via Cavour, nei pressi dell’incrocio con Corso Matteotti.
La Giordania e l’illusione della pace
Il silenzio incomprensibile del governo giordano rispetto all’incontro Trump-Netanyahu
L’articolo La Giordania e l’illusione della pace sembra essere il primo su Arabpress.
Appesi a quel forse
A New York, un salone di bellezza “hijab-friendly”
Le’Jemalik di Huda Quhshi ha aperto i battenti alla fine di gennaio ed è già un santuario per le donne, musulmane e non, della Grande Mela
L’articolo A New York, un salone di bellezza “hijab-friendly” sembra essere il primo su Arabpress.
L’Egitto tra Obama e Trump
Da Obama a Trump, quale sarà la natura delle relazioni tra Egitto e Stati Uniti?
L’articolo L’Egitto tra Obama e Trump sembra essere il primo su Arabpress.
Shukri al-Mabkhout e Hisham Matar al festival Libri Come di Roma
A Libri Come, festival di letteratura dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, diretto da Marino Sinibaldi, ci saranno anche lo scrittore tunisino Shukri al-Mabkhout e lo scrittore anglo-libico Hisham Matar. Tema dell’edizione di quest’anno sono i “confini”, e sia il tema che il logo scelto dagli organizzatori trovano un particolare – quanto, immagino, casuale– parallelismo […]![]()
“Side by side, in marcia per l’umanità — Domenica 19 marzo — Manifestazione regionale del Veneto…
Una giornata per dare corpo e parola a chi non accetta in Veneto e ovunque un presente di odio e barbarie
Appello di overthefortress. Apriamo una stagione dei diritti contro il piano Gentiloni-Minniti
Sulla conferenza dei curdi a Mosca
Verso quale direzione si muoverà la questione curda in Medio Oriente?
L’articolo Sulla conferenza dei curdi a Mosca sembra essere il primo su Arabpress.
Talebani confermano: ucciso il "liberatore" di Kunduz
Un lungo comunicato ufficiale dei talebani ha confermato oggi la morte di Al-Haj Mullah Abdul Salam Akhund, ucciso da un drone il 26 febbraio scorso nel distretto di Dasht-e-Archi (Kunduz). Otto guerriglieri sono stati uccisi con llui.
Il sito della guerriglia dedica ampio spazio, numerosi elogi e un’immagine (a destra) al martirio dell’uomo che i talebani chiamano il “liberatore di Kunduz”. Governatore ombra della provincia del Nord, si deve infatti a lui la presa per due volte della città. Per il governo e i suoi alleati (la paternità dell’azione è americana) è un colpo importante che potrebbe riflettersi sul morale della truppa in turbante.
Oscar: la Siria e l’Iran premiati nell’America di Trump
(The New Arab). Hollywood ha lanciato un messaggio forte all’America di Donald Trump, premiando il documentario siriano “The White Helmets” e il film iraniano “Il Cliente”. Il primo, è un documentario sull’omonimo gruppo di Difesa Civile siriano, un team di soccorritori che cercano di salvare le vite dei cittadini colpiti dalla guerra in Siria. Molti dei […]
L’articolo Oscar: la Siria e l’Iran premiati nell’America di Trump sembra essere il primo su Arabpress.
I funzionari dell’Unione Europea non hanno esitato a condannare i decreti esecutivi recentemente…
Tuttavia, non bisogna perdere di vista le azioni che l’UE e i suoi stati membri stanno realmente mettendo in pratica sul campo. Ingenti…
Domenica 19 marzo a Venezia: in marcia per l’umanità
Algeria: viva la stabilità, viva il presidente Bouteflika!
Il capo di gabinetto conferma che il presidente Bouteflika svolgerà il suo quarto mandato senza impedimenti e lo terminerà, come previsto dalla legge, nel 2019
L’articolo Algeria: viva la stabilità, viva il presidente Bouteflika! sembra essere il primo su Arabpress.
La donna che scambiava le persone per bulloni
CNI Firenze 2017: un resoconto
Si è tenuto a Firenze tra il 22 ed il 24 Febbraio 2017 il Coordinamento Nazionale Immigrazione, organizzato dalla Caritas Italiana. Obiettivo di questo momento di formazione e condivisione è stato quello di coinvolgere operatori Caritas impegnati sul territorio italiano in… Continue Reading →![]()
Turismo halal: un buon affare o un dovere religioso?
Il turismo ‘muslim-friendly’ è sempre più diffuso in tutto il mondo e ci si chiede se non si tratti solo di una trovata commerciale
L’articolo Turismo halal: un buon affare o un dovere religioso? sembra essere il primo su Arabpress.
Le testimonianze che avevamo raccolto e raccontato nell’articolo uscito il 12 febbraio, “La libert…
L’inchiesta giornalistica sulla gestione del CAS di Nuvolera ha generato degli effetti positivi. Quando c’è un territorio ricettivo e…
Cos’ha fatto davvero la Lega Araba per gli arabi?
Ci sono timori di un probabile scioglimento dell’organizzazione, che di fatto però ha da tempo perso il suo ruolo.
L’articolo Cos’ha fatto davvero la Lega Araba per gli arabi? sembra essere il primo su Arabpress.
In Libano, una moschea all’avanguardia che predica tolleranza
Un design innovativo per riflettere su religione e modernità, su diversità e coesistenza
L’articolo In Libano, una moschea all’avanguardia che predica tolleranza sembra essere il primo su Arabpress.
Nigeria — Protezione sussidiaria alla richiedente vittima di violenza di genere
Mali — Status di rifugiato al richiedente fuggito dalle ritorsioni jihadiste
La Corte europea per i diritti dell’uomo ordina al Governo di trasferire i minori da Cona
I bambini congelati della Grecia: cosa succederà ai giovani rifugiati?
La mappa degli accordi contro i migranti
In Libia la tratta dei migranti sta prosperando. Perché il mondo sta ignorando il fenomeno?
Report redatto da Yasmine Accardo, Francesca Mazzuzi, Maria Grazia Krawzyck, Daniele Pulino
Una delegazione della Campagna LasciateCIEntrare ha visitato in data 18 febbraio il CAS sito in Sassari, via Planagia 14, gestito da SDP…
#overthefortress: operatori sanitari e attivisti in partenza per Belgrado
Photo credit: Luca Zanon
Gli attivisti della Judend Rettet e di #OverTheFortress sono entrati in azione questa mattina sul Ponte di Rialto, dove hanno aperto uno…
Un’interessante sentenza emessa proprio nei giorni in cui perfino il governo Gentiloni “sdogana” il…
Il Tribunale di Milano afferma il carattere discriminatorio dell’espressione “clandestini” riferita a 32 richiedenti asilo che dovevano…
Cittadinanze dirompenti: per un Febbraio di cittadinanza per un futuro civile
Walking on Death Along the Iraqi Border
The smuggler told us to continue our journey on foot and to be careful to follow the footprints that barely show in the dark. I realized then that we were walking on death, because we were in the middle of a mine field
The post Walking on Death Along the Iraqi Border appeared first on SyriaUntold | حكاية ما انحكت.
A Response to Roy Gutman’s “Have the Syrian Kurds Committed War Crimes?”
By Aymenn Jawad Al-Tamimi
A recent article in The Nation by Roy Gutman has generated considerable controversy, as the article attempts to highlight what it portrays as the more unsavoury and neglected aspects of the Democratic Union Party (PYD)- the main Kurdish faction operating in Syria and linked to the Kurdistan Workers’ Party (PKK)- and its armed wing the People’s Protection Units (YPG), which constitute the majority of the Syrian Democratic Forces (SDF) coalition.
The article does raise some valid points for discussion. In general, there is a tendency to romanticise Kurdish forces in both Iraq and Syria- a trend exemplified in a piece by Michael Totten, in which he urges Trump to “back the Kurds to the hilt and give them the green light to declare independence.” Such a simplistic assertion overlooks complications like the sharp political division between the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq led by Masoud Barzani’s Kurdistan Democratic Party and the PYD-administered areas in Syria, the financial crisis afflicting the KRG and its inability to become economically independent, and the lack of a vision for real independence in the PYD’s approach to governance that is heavily influenced by the thinking of PKK luminary Abdullah Ocalan. Besides, there are real problems concerning the behaviour of Kurdish forces towards Arab populations in both Iraq and Syria, with cases of destruction of homes and villages documented by human rights monitors (cf. here). Political authoritarianism in the Kurdish entities should also be a major concern: Masoud Barzani still clings to the KRG presidency despite the fact that his mandate expired long ago, and the PYD’s harsh behaviour towards its political opponents cannot be ignored.
However, acknowledging these issues should not blind the reader to the clear problem with Gutman’s work: namely, the author’s biases for the Syrian opposition and Turkey that have been evident for years. As such, he uncritically relays dubious testimony that a serious and fair-minded journalist would have subjected to appropriate scrutiny. This fault becomes most apparent in Gutman’s claim that the YPG and the Islamic State (IS) “have often worked in tandem against moderate rebel groups,” which I will focus on in particular here. Elaborating on this claim, Gutman asserts that “again and again, in towns where the YPG lacked the manpower or weapons to dislodge the rebels, IS forces arrived unexpectedly with their corps of suicide bombers, seized the territory and later handed it over to the YPG without a fight.”
Gutman attempts to support this narrative with cases such as Tel Hamis and Husseiniya in Hasakah province. What he completely omits is that on numerous occasions in 2013 and January 2014, rebel groups worked with what was then called the Islamic State in Iraq and al-Sham (ISIS) against the YPG. For example, Ahrar al-Sham, ISIS and other rebel militias worked together to expel the YPG from the important northern border town of Tel Abyad in August 2013, only for ISIS to take over the area in January 2014. It is rather strange that Gutman cites Tel Hamis and Husseiniya in a bid to support his narrative, since video evidence that explicitly mentions ISIS-Ahrar al-Sham coordination against the “PKK dogs” in Husseiniya can be found from early January 2014. The coordination eventually fell apart later that month as ISIS proceeded to subjugate all other rebel groups in Hasakah province amid wider infighting with rebel forces across northern and eastern Syria. As for the notion that Tel Hamis was yielded to the YPG without a fight, that claim can only be described as a travesty of the truth. The YPG lost numerous fighters in the extended campaigns to take Tel Hamis, with abundant ‘martyrdom’ commemorations to be found on social media.
The notion that the YPG and IS are in collusion with the latter supposedly yielding territory to the former without a fight is a recurring trope. For instance, it is repeated on multiple occasions in Anne Speckhard and Ahmet Yayla’s book that consists of interviews with IS defectors. The fact that this notion is repeated so many times does not make it any more true. The biases of the sources making these claims as well as the wider tendencies in the region towards conspiracy theories have not been sufficiently taken into account. On the wider level, even when we do suppose or note a withdrawal without a real fight, there are simpler and more logical explanations that need not entail a conspiracy, such as manpower issues, the assessment of a particular location’s strategic importance or lack thereof, and the like. For example, IS yielded the border town of Jarabulus to the Syrian rebels backed by Turkish forces in August 2016 without a real fight: the reason for this withdrawal is that IS probably determined that the town was not worth defending and that better defensive positions needed to be taken up further south within Aleppo province. As it so happens, the recent fight for the IS stronghold of al-Bab has proven to be protracted and difficult for the rebels participating in Turkey’s “Euphrates Shield” operation. In a similar vein, the YPG’s relatively swift capture of Tel Abyad in 2015 was not the result of a joint YPG-IS conspiracy against the rebels: rather IS’ fighting lines in the area had largely collapsed on account of devoting so much manpower and resources to the fight for Kobani in a wasteful attempt to show defiance in the face of so many coalition airstrikes.
The question of the U.S. relationship with the SDF going forward is an important one as the issue of who takes the key IS-held areas in Syria of Raqqa city and Deir az-Zor continues to be discussed. American attempts to deny SDF links with the PKK are not only absurd but also harmful in handling relations with Turkey. However, debates need to be held on serious grounds rooted in facts and credible evidence. Gutman’s work here has fallen far short of those standards. Unfortunately, similar problems in his reporting with regards to the PKK can be traced in his earlier work. In an October 2012 article for McClatchy purporting to offer an inside account of the PKK, Gutman relayed in an almost entirely uncritical manner the testimony of a supposed PKK defector to Turkish authorities, including claims that the PKK prohibits Islamic practices like daily prayers for its fighters and tells them that the Kurds’ religion is Zoroastrianism and that they should worship fire. The latter two claims are particularly absurd because the association of Zoroastrianism with fire worship is in fact a calumny against the Zoroastrian religion.
It is apparent that Gutman’s opinion biases have had and still have a problematic impact on his reporting. This matter needs to be highlighted rather than showing uncritical deference simply because Gutman once won a Pulitzer Prize, just as we should not show uncritical deference to Seymour Hersh’s claims of rebel responsibility for the Ghouta chemical weapons attacks in 2013 simply because he also once won a Pulitzer Prize.
The post A Response to Roy Gutman’s “Have the Syrian Kurds Committed War Crimes?” appeared first on Syria Comment.
Di sommersi e di salvati (riflessioni siriane)
di Daud al-Ahmar*
Si sbaglia a credere che le nazioni vittime della storia (e sono la maggioranza) vivano col pensiero fisso della rivoluzione, vedendovi la soluzione più semplice. Una rivoluzione è sempre un dramma (…). La rivoluzione è l’ultima risorsa e se un popolo ha deciso di ricorrervi è perché ha imparato per lunga esperienza, che non gli resta altra via d’uscita.
…
Di sommersi e di salvati (riflessioni siriane) è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Logiche di mercato: scatti con velo cercasi
 Spesso si pensa che non ci sia nulla di più vero di una fotografia, lo scatto che immortala un momento e che fa della cronaca realtà. Più della parola scritta, che immagini tutt’al più suggerisce, e meglio della televisione che ormai, lo sanno anche i bambini, è quanto di più artefatto esista. Ho fatto questa prima riflessione in Bangladesh sul confine birmano. Mi aveva colpito l’immenso numero di donne velate che affollano le campagna bangladese ma, arrivato ai campi profughi dei rohyngya, immaginavo di vederne senza velo perché tutte le foto che avevo guardato le dipingevano così, come mostra l’immagine postata sopra a sinistra. Donne svelate però non ne vedo nemmeno nel centro sanitario di Msf. Chiedo lumi: come posso riconoscere una donna o un uomo rohingya? In nessun modo, mi risponde uno del team. Nemmeno noi del Bangladesh, mi dice, le distinguiamo poiché sono del tutto simili a noialtri. Dal che discendono due cose: la prima è l’affinità strettissima tra le due comunità divise, solo per convenzione, da una frontiera. La seconda è che le donne son velate. Come le loro colleghe del Bangladesh.
Spesso si pensa che non ci sia nulla di più vero di una fotografia, lo scatto che immortala un momento e che fa della cronaca realtà. Più della parola scritta, che immagini tutt’al più suggerisce, e meglio della televisione che ormai, lo sanno anche i bambini, è quanto di più artefatto esista. Ho fatto questa prima riflessione in Bangladesh sul confine birmano. Mi aveva colpito l’immenso numero di donne velate che affollano le campagna bangladese ma, arrivato ai campi profughi dei rohyngya, immaginavo di vederne senza velo perché tutte le foto che avevo guardato le dipingevano così, come mostra l’immagine postata sopra a sinistra. Donne svelate però non ne vedo nemmeno nel centro sanitario di Msf. Chiedo lumi: come posso riconoscere una donna o un uomo rohingya? In nessun modo, mi risponde uno del team. Nemmeno noi del Bangladesh, mi dice, le distinguiamo poiché sono del tutto simili a noialtri. Dal che discendono due cose: la prima è l’affinità strettissima tra le due comunità divise, solo per convenzione, da una frontiera. La seconda è che le donne son velate. Come le loro colleghe del Bangladesh.
Ed ecco (foto a destra) che vedo pubblicata un’immagine di rohingya col velo. La prima! E perché ? L‘articolo che la ospita è dedicato all’estremismo radicale islamico tra i rohingya del Myanmar e dunque il velo è di rigore. In poche parole, se serve svelata (commuove di più, appare più simile a noi) eccola senza velo. Se serve invece a farci paura (anche li, tra quei poveretti, c’è la terribile spada vendicatrice dell’islam) eccola velata. E con tanto di niqab (diffusissimo per latro nelle campagne del Bangladesh che ho visto).
Dove sta la verità? Non lo so ma non certo negli scatti che ho visto. O meglio, è una verità parziale, tanto quanto quello che scrivo io. E segue la logica di mercato. Come per altro faccio anch’io cannando in pieno, visto che ho i miei pezzi nel cassetto: a gran parte della stampa del mio Paese non interessano. Forse però con una bella immagine di donna col niqab e un articolo un tantino allarmista… chissà. Scatti con velo cercasi.
La solidarietà reciproca tra i cittadini di Iran e America diventa virale #LoveBeyondFlags
Per contrastare la retorica dell’odio tra governi e per ringraziare gli americani schieratisi contro il bando di Trump, gli iraniani lanciano l’hashtag divenuto virale #LoveBeyondFlag.



























































