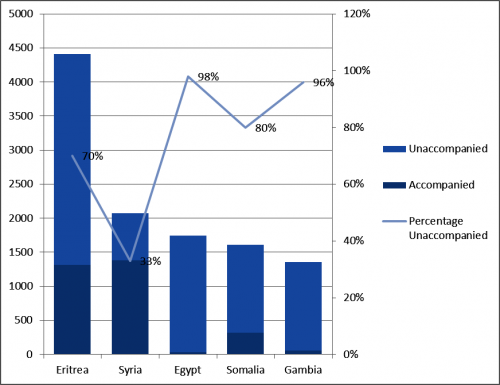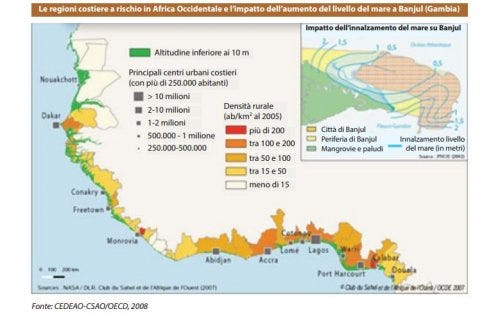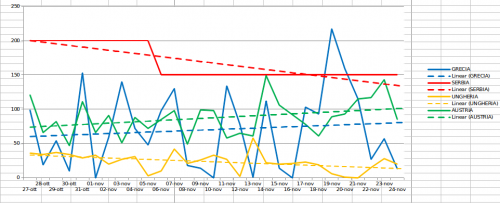Anno: 2016
Chronicle Keepers The Dreaming Garden
Spy Bugs
Loot Hero DX
Redemption Eternal Quest
Street Arena
Wave of Darkness
Victor Vran
Gryphon Knight Epic
Grey Goo
Legend of Kay Anniversary
Dream
Industry giant II
Mos Speedrun 2
Airscape The Fall of the Gravity
Klaus Ps4
Professional Farmer 2017
Internet e mondo arabo
LEGO Dimensions disponibile in Italia!
CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX
Buon anno a Dacca
 Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.
Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.
Ti assale – in questi luoghi tentacolari – un panico sconfortante a metà tra l’idea che non si riuscirà a combinare nulla e l’idea che le ore passeranno inesorabili nello sconforto di una città senza volto. Ma quel volto c’è. C’è un’identità e persino un carisma.C’è un fascino. Perdersi è l’unica strada. Mi metto in tasca la Lonely Planet (davvero ben fatta per quel che ho visto e scritta da un viaggiatore attento e profondo) e mi aiuto con le mappe, percorsi consigliati, qualche buona dritta. Poi mi lascio trascinare. Prendo la barca sul fiume che attraversa Old Dhaka e poi, dopo un tè, la riprendo all’indietro. Dietro la puzza c’è un profumo. Dietro un’umanità che appare disperata c’è un sorriso e una curiosità che si riflette in gentilezza. Una gentilezza delicata e mai invasiva. Un modo di fare che a tutta prima sembra chiuso e scortese e invece è rispetto per gli estranei. Immaginavo una città violenta e oscura. E’ solare e gentile. Inquinata, certo, e sporca e con una densità tale che si ha sempre l’impressione di essere sul filobus che va in stazione nelle ore di punta. Eppure nessuno si tocca. Tutti e tutto ti sfiorano.
 |
| In città ci sono pochissimi semafori e, soprattutto, sono spenti. Come facciano a guidare senza scontrarsi di continuo resta un mistero glorioso |
Questo fascino nascosto della città forse più caotica al mondo non si può spiegare. Né si può spiegare perché io preferisca il caos del centro città ai quartieri di Banani o Gulsham dove una piccola Londra, passando per l’India, è sbarcata anche qui: viali ordinati, alberi e negozi come li vedi ovunque. Capisco chi ci vive perché lavora qui, ma per un viaggiatore sono non luoghi senza senso. Ma che senso abbia il resto, il quartiere di Shantinagar dove sto io, non saprei dire. Non c’è un palazzo antico, un parco pubblico, un ristorante degno di questo nome. Eppure passano queste seducenti ragazze con la carnagione scura e gli occhi a mandorla nei loro abiti eleganti e piccole taverne di strada offrono succulenti banchetti. Mi spiace solo non poter bere quell’intruglio di una specie di scorzonera mescolata con foglie di agave che deve fare benissimo ma è condita con acqua di dubbia provenienza. Guardo il maestro di tanta pozione prepararla con cura accovacciato all’incrocio dove sfrecciano autobus sfregiati e tutt’intorno sfrigolano fritture di pasta e patate. Più in là, venditori di ogni bendiddio in una città che è un bazar perenne di oggetti e rumori. Baccano che diventa colonna sonora di sottofondo. Diamine, ecco perché sono venuto. Ecco la sorpresa. Anche se non posso bere la tua acqua magica, maestro, potrò ben raccontare di averla vista preparare.
Intervista di Hibai Arbide a Mikelon e Bego dopo la liberazione
Begoña Huarte e Mikelon Zuloaga parlano con il giornalista Hibai Arbide Aza e Pikara Magazine dopo essere stati liberati per aver tentato…
Mimmo Lucano va avanti. Il ritiro delle dimissioni dopo la seduta di consiglio comunale aperto
“Sono obbligato a continuare”, ha detto emozionato e commosso il sindaco di Riace che aveva rimesso il suo mandato nelle mani del consiglio…
Arrestate due attiviste basche mentre tentavano di trasferire un gruppo di rifugiati
Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, due attiviste basche sono state arrestate nel porto di Igoumenitsa (nord della Grecia) mentre…
Le Scarpe dei Caporali
Uno spettacolo teatrale di Salvatore Cutrì con la regia di Paolo Grossi
Da un’inchiesta di Matteo De Checchi e Valentina Benvenuti
Rosarno: lasciate ogni speranza voi ch’entrate
Photo credit: Mattero De Checchi
Quello che stiamo vivendo in questi giorni rasenta così da vicino il dramma che a fatica riusciamo ad…
La grande adunata per Lucano
Il consiglio comunale di Riace conferma all’unanimità fiducia al sindaco che aveva manifestato la volontà di lasciare dopo alcuni attacchi…
L’indignazione per i minori non accompagnati mette in evidenza le gravi carenze nei dati dell’UE
Anche se le notizie dei “bambini scomparsi” suscitano indignazione morale, la realtà è che i dati dell’UE sui minori non accompagnati sono…
Frutta sporca. Un reportage di Matteo De Checci e Valentina Benvenuti (febbraio/luglio 2016)
Orange juice — Reportage da Rosarno (9 Febbraio 2016) continua »
Factory as home.
La guerra in Siria è la più documentata di sempre eppure ne sappiamo ancora poco.
Con la fine del devastante assedio ad Aleppo est, il mondo guarda, analizza e discute sul significato dei messaggi condivisi dalle persone rimaste lì intrappolate.
Ragazze siriane ringraziano i soldati russi nel calendario sexy finanziato dal Cremlino
Grazie alle sovvenzioni del Cremlino, ora abbiamo un calendario con belle ragazze siriane che posano accanto a citazioni che elogiano l’intervento russo in Medio Oriente.
L’anno che ha mostrato al mondo la tragedia siriana
Il 2016 non ha solo mostrato al mondo la tragedia siriana, ma ha rivelato anche il ruolo che ha svolto Obama nel cambiare la natura profonda della politica estera americana
L’articolo L’anno che ha mostrato al mondo la tragedia siriana sembra essere il primo su Arabpress.
Tornando a casa
…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere
Tornando a casa
…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere
Tornando a casa
…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere
Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta

Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.
Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta.
 |
| 500 Tk:Il costo di un pranzo in un ristorante di lusso. Ma con dieci volte questa cifra una famiglia operaia deve vivere un mese |
Comincia tutto il 12 dicembre ad Ashulia, una zona suburbana di Dacca a una ventina di chilometri a Nord dal centro città. Tra gli operai delle fabbriche girano volantini che rivendicano un nuovo minimo sindacale. L’ultimo, è stato fissato tre anni fa e ammonta a 5300 Taka ossia circa 65 euro al mese. Visto che un terzo del salario se ne va in affitto, un chilo di riso costa 50 tk e il trasporto pubblico è quasi inesistente, la rivendicazione – un aggiustamento al triplo – sembra una richiesta più che legittima. Alla Windy cominciano le prime agitazioni spontanee che in pochi giorni si estendono a macchia d’olio: o ci date l’aumento o incrociamo le braccia. Il 14 la patata e già bollente e la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea), l’associazione di settore degli imprenditori, va in fibrillazione. Ci sono i primi incontri con le associazioni dei lavoratori ma la linea rossa, ribadita nei giorni a seguire, è che il salario minimo non è in discussione. La Bgmea, il cui obiettivo è arrivare a fatturare – dagli attuali 30 – 50 miliardi di dollari l’anno con l’export del tessile, non ne vuole sapere. Col passare dei giorni la tensione aumenta: il 21 dicembre l’agitazione coinvolge 59 fabbriche e centinaia di lavoratori. E mentre viene decisa la serrata (terminata il 26 su richiesta della premier Sheikh Hasina) si accende la macchina della repressione. Uno per tutti, il caso di Ibrahim, della Bangladesh Garments and Industrial Workesr Fderation. Il sindacalista viene arrestato con tre altri leader sindacali e per tre giorni sparisce. Quando finalmente colleghi e famiglia sanno qualcosa di lui, il caso è passato alla magistratura con cinque capi di imputazione e per adesso nessuna cauzione possibile per farlo uscire. Non lo hanno picchiato – spiega un suo collega – ma «è stato sottoposto a minacce e avvertimenti», pressioni psicologiche esercitate, come le foto del loro licenziamento, anche verso gli operai. Se i leader sindacali sono in manette almeno altre duecento denunce pendono sul capo di altrettanti lavoratori. La legge usata per arrestarli o accusarli è un vecchio residuo legislativo del 1974, la Special Law, varata (dopo l’indipendenza del Bangladesh dal Pakistan (1971) e mai emendata o abolita.
 |
| Una pubblicità di Benetton. Fu coinvolta nella vicenda del Rana Plaza e fece una pessima figura. Ora che farà? |
Parliamo con uno dei leader sindacali di cui è meglio, in queste ore, non fare il nome. Spiega che i sindacati stanno offrendo a governo e padroni un ramoscello d’olivo. «Ma – dice – devono accettare di sedersi al tavolo e negoziare e non vogliono farlo». Il problema, aggiunge un altro sindacalista, è che «il governo non è un mediatore terzo. In parlamento non ci sono lavoratori e così alla fine l’esecutivo fa quel che dicono i padroni». Questi ultimi hanno lamentato perdite in questi giorni di agitazione per oltre un miliardo di euro e non ne vogliono sapere di discutere del minimo anche se deve essere rinegoziato, per legge, ogni cinque anni. I diversi sindacati di categoria invece, hanno eletto un Comitato proprio per definire correttamente il valore del salario garantito: un paniere che contenga calorie, bisogni sanitari, costo degli alimenti. «Una cifra dignitosa – dice una collega – dovrebbe essere almeno 200 dollari al mese». Ma da questo orecchio nessuno ci sente.
 |
| Un Paese ignorato dai media e anche dall’Accademia, salvo rare eccezioni. Eppure vestiamo tutti…. Made in Bangladesh |
I lavoratori però ci sentono eccome anche se la loro provenienza è extra urbana, mancano di istruzione e hanno il terrore di perdere il posto di lavoro. Un esercito solitamente di fantasmi silenziosi il cui unico vantaggio rispetto al lavoro informale, è che in fabbrica si lavora otto ore, anche se ti vengono scalati i minuti per andare in bagno. Chi è questo lavoratore del tessile lo spiega David Lewis, docente della London School che al Bangladesh ha dedicato nel 2011 uno dei rari libri* su questo Paese: “E’ una giovane donna appena arrivata da un villaggio, che vive in affitto negli slum vicino a una fabbrica o un’area speciale (Export Processing Zone) dove lavora a macchina per circa un dollaro e mezzo al giorno…la fabbrica la mette faccia a faccia con le contraddizioni e la complessità di un’economia globalizzata: può esser di proprietà coreana, con tessuto di Taiwan, filo indiano e imballaggi cinesi. Ma ma i capi prodotti portano tutti l’etichetta Made in Bangladesh».
Il prodotto finito arriva a Seul o a Taipei ma anche a Londra, Parigi, Milano. E’ il motivo per cui è nata la Campagna Clean Clothes (Abiti Puliti in Italia) che dopo il Rana Plaza – quando il mondo ha cominciato ad accorgersi del Bangladesh – è riuscita a far fare qualche passo avanti sul piano della sicurezza. Ora denuncia gli arresti e le intimidazioni. Deborah Lucchetti di Abiti Puliti si unisce al coro: «Chiediamo alle imprese italiane che operano nel Paese di chiedere immediatamente al governo del Bangladesh il rilascio dei sindacalisti arrestati, di comunicare dove sono detenuti, di ritirare le accuse infondate nei loro confronti e di cessare ogni ulteriore forma di repressione nei confronti di chi legittimamente esercita il diritto fondamentale di espressione e organizzazione».
 |
| Dieci Taka: nemmeno 15 centesimi di euro Ci si beve un tè con una pastella fritta ripiena di patate. C’è chi sopravvive così |
Il clima a Dacca è di paura. I sindacalisti con cui parliamo sono stati intimiditi, minacciati, avvertiti che non devono organizzare riunioni né muoversi dai loro uffici. Ma, chiediamo, è una questione di prezzi troppo bassi sul mercato internazionale? «No – sorride il sindacalista – se il prezzo delle merci fosse più alto il guadagno non verrebbe redistribuito. Ci sarebbe solo più profitto per i proprietari».
Nel piccolo ristorante su una strada iperaffollata, alcuni minorenni servono ai tavoli. Guadagnano 230 tk al giorno che, al mese, fa circa 6mila tk, più del salario di un tessile. Ma, anziché andare a scuola, lavorano 16 ore al giorno e per sette giorni su sette. Lavoro informale e senza le garanzie di una fabbrica. Garanzie? La “sospensione temporanea” è solo un modo per dire che d’ora in poi la fabbrica non ha più bisogno di te.
* Lewis D., Bangladesh Politics, Economy and Civil Society, Cambridge University Press, 2011
Questo reportage è uscito oggi su il manifesto
I 10 piatti più cucinati nel 2016!
L’articolo I 10 piatti più cucinati nel 2016! sembra essere il primo su Arabpress.
Al confine Libano-Siria nel campo di Tel Abbas: intervista ad una volontaria dell’Operazione…
Leggi anche: Altra frontiera: il campo di Tel Abbas
Al confine tra la Siria e il Libano, a soli 4 chilometri dal confine, c’è il campo…
Sabra e Shatila versione Guernica, l’opera di Dia Al-Azzawi
Il Ministro della Cultura spagnolo ha chiesto che l’arazzo raffigurante il massacro di Sabra e Shatila sia appeso accanto all’icona di Picasso.
L’articolo Sabra e Shatila versione Guernica, l’opera di Dia Al-Azzawi sembra essere il primo su Arabpress.
Bulgaria — Più di 2.000 rifugiati hanno lasciato i campi profughi nell’ultimo mese e mezzo
Quasi 600 persone hanno lasciato i campi profughi in Bulgaria nelle prime due settimane di dicembre e la polizia bulgara non sa dove si…
Caso Emmanuel: il volto della provincia italiana sfigurato dall’intolleranza
Ci sono voluti solo cinque mesi per svelare definitivamente il volto sfigurato dall’odio e dall’intolleranza della piccola provincia…
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Il giudice di Pace di Savona accoglie il ricorso avverso l’espulsione del richiedente poichè come descritto nell’art. 19 del D.Lgs. n.268…
Gambia. Rischio effettivo di subire un danno nel caso di rientro nel paese interessato.
Si ringrazia l’Avv. Elisa Elia per la segnalazione.
Passaggi: “Mio Caro Kawabata” di Rachid Daif
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Passaggi: “Mio Caro Kawabata” di Rachid Daif sembra essere il primo su Arabpress.
Le paure per il 2017
Non previsioni, ma suggerimenti critici in attesa degli sviluppi dello scenario attuale
L’articolo Le paure per il 2017 sembra essere il primo su Arabpress.
Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta
 Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto
Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto
Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.
Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta…
(continua. In edicola domani su il manifesto)
Com’è dura rompere il silenzio
 Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.
Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.
Ma anche una lettera – un’autorevole lettera – è rompere il silenzio. Anche un articolo, nel suo piccolo, può farlo anche se oggi un settimanale italiano mi ha risposto che no, grazie, non interessa. E tanti auguri di buon anno. Due righe per dire che questi 34mila disperati che solo negli ultimi tre mesi son stati spinti via dalla loro terra non sono un pane appetibile per te, lettore italiano. La Raggi vale di più. Bersani pure. Non mi stupisco. Nessun giornale del mio Paese si è scandalizzato per l’espulsione annunciata di 80mila afgani dalla sacra terra europea. Né fa scalpore quel milione di afgani che, a centinaia per volta, il Pakistan sta espellendo dalla sua terra, che la geopolitica val più della solidarietà. Dunque 34mila rohingya possano soffrire in silenzio. Non meritano la tua attenzione, lettore italiano.
Varcano il fiume che separa le due frontiere e che diventa un braccio di mare. Ma è riparato e dunque tranquillo e la stagione è buona. Cento, duecento, cinquecento al giorno. Dicono che ora il loro arrivo si è stabilizzato. Non cresce più. Ma non sappiamo, non possiamo saperlo, quanti vorrebbero fuggire e non possono farlo. In Myanmar, su quel confine non si può andare. Anche in Bangladesh il confine è off limits. Ma si può venire qui a Ukhia, trenta chilometri da Cox Bazar, la Rimini del Paese, a vedere dove vive questa gente. Teloni neri di plastica appoggiati su aste di bambù. E la solidarietà quotidiana di chi non è molto più povero di loro ma condivide un pasto, un posto per la tenda. Durerà? La pressione è forte anche se i rohingya son del tutto simili ai bengali. Pare siano circa 300mila i rohingya in Bangladesh, un terzo della loro popolazione totale. Dispersi qui e là, su fino a Chittagong e forse anche a Dacca. Lavori stagionali e, immagino, un senso di ingiustizia, di precarietà, una sofferenza che non valgono questo silenzio. Grazie, non interessa. Abbiamo altro cui pensare.
Il bilancio di competenze all’interno di un progetto SPRAR
Il punto di vista dell’operatore (Racconti, conflitti, limiti, potenzialità degli operatori dell’accoglienza) è una nuova rubrica che…
Sul “Dossier Caritas 2016: Africa occidentale — Divieto di accesso”
Diteci dove sono
E’ partita un’iniziativa rivolta al Presidente della Repubblica affinché, dopo un’incomprensibile attesa di cinque anni, le famiglie…
La liberazione di Mosul si fa attendere
Tra la ripresa dell’ISIS e i ritardi dell’operazione militare iracheno-statunitense, la liberazione di Mosul sembra ancora lontana.
L’articolo La liberazione di Mosul si fa attendere sembra essere il primo su Arabpress.
Bibbia e politica
Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere
Bibbia e politica
Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere
Bibbia e politica
Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere
Egitto: nuovi accordi con BP, Total e Eni
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Egitto: nuovi accordi con BP, Total e Eni sembra essere il primo su Arabpress.
Maggio 2016
Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag
via Migrano http://ift.tt/2hyzAqA
In Turchia è riuscito “l’altro” colpo di Stato
Il tentativo di rovesciare Erdoğan con un colpo di Stato è fallito, ma vincente è stato invece “il golpe” dello stesso presidente contro i propri nemici che ha ridisegnato la posizione della Turchia nello scacchiere internazionale
L’articolo In Turchia è riuscito “l’altro” colpo di Stato sembra essere il primo su Arabpress.
Linverno è arrivato
L’Ue ha bloccato la Balkan Route, scaricando sulla Grecia i rifugiati in fuga dalla guerra.
Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici
Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()
Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici
Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()
Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici
Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()
L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere
mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()
L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere
mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()
L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere
mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()
Piana di Gioia Tauro: 2.000 persone nelle baraccopoli di San Ferdinando. Si torna indietro di anni
Nella zona industriale di San Ferdinando sono più di 2mila i migranti accampati tra tende, baracche e stabili abbandonati in condizioni di…
Entre Ionio et Tirreno peu d’espace pour les migrants en Calabria
5 € pour 10 km : soutenez le camper de Overthefortress
Un voyage de deux mois de la Sicile à Rome dedans et au-delà de la route de la M…
I 10 articoli più CLICCATI nel 2016!
L’articolo I 10 articoli più CLICCATI nel 2016! sembra essere il primo su Arabpress.
Le quattro biblioteche più antiche del Medio Oriente e Nord Africa
Di Asmaa Abu Latifa. Barakabits (18/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina. L’odore dei libri e la consistenza morbida delle pagine sono due cose che ogni amante dei libri adora. Le biblioteche variano per dimensioni e scopi e in base ai paesi e alla cultura: non sono solo un viaggio attraverso la storia, ma anche un promemoria […]
L’articolo Le quattro biblioteche più antiche del Medio Oriente e Nord Africa sembra essere il primo su Arabpress.
Salutando il 2016
Si sta per chiudere un anno turbolento per il Medio Oriente
L’articolo Salutando il 2016 sembra essere il primo su Arabpress.
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione.
Il Tribunale di Genova attraverso un’analisi geopolitica approfondita nega la protezione sussidiaria e l’asilo politico per il richiedente…
Si ringrazia l’Avv.Federico Lera per la segnalazione.
Il tribunale di Genova attraverso un’analisi geopolitica approfondita nega la protezione sussidiaria e l’asilo politico per il richiedente…
Rivoluzioni violate, presentazione a Napoli
Leggere un quotidiano o guardare il tg spesso significa imbattersi in notizie di cronaca estera raccontate in modo non sempre imparziale e oggettivo. Questo dimostra scarso interesse e volontà di informare e, più semplicemente, chiarisce quanto si punti piuttosto a catturare… Continue Reading →![]()
Il controllo dei confini e la vita precaria dei migranti in Italia
Post di Simon McMahon, ricercatore presso il Centre for Trust, Peace and Social Relations della Coventry University.
Gli Stati non arabi “capiscono meglio” la causa palestinese
I Paesi più lontani geograficamente sono più vicini a livello umano alla causa palestinese rispetto ai regimi sunniti arabi
L’articolo Gli Stati non arabi “capiscono meglio” la causa palestinese sembra essere il primo su Arabpress.
Marzo 2016
Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag
via Migrano http://ift.tt/2icknew
Un messaggio da Ahmed Naji
Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()
Un messaggio da Ahmed Naji
Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()
Un messaggio da Ahmed Naji
Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()
Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia
Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere
Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia
Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere
Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia
Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere
L’identità dell’individuo nel nome: اِسْم ism, كنية kunya, نِسْبَة nisba, لَقَب laqab
Etimologie del termine coranico اِسْم ism, “nome”. Gli elementi del nome: اِسْم ism, كنية kunya, نِسْبَة nisba, لَقَب laqab. Nomi arabi maschili e femminili.![]()
Il Cara di Mineo va chiuso subito
Durante il viaggio della campagna #overthefortress al sud Italia avevamo fatto visita al Cara di Mineo.
Visti da dentro. 12 storie che raccontano 12 vite limite. Da dentro appunto.
Riceviamo e pubblichiamo questo articolo scritto per noi da Michela Belli, Responsabile delle attività culturali dell’Associazione Homo…
Febbraio 2016
Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag
via Migrano http://ift.tt/2hYCTGz
Labour exploitation and caporalato’ in Sicilian countryside
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
L’Europa abbandona la politica del ricongiungimento familiare per i rifugiati dalla Grecia
Un nuovo aspetto della solidarietà europea mostra un crollo brutale.
Welcome to the jungle
Dal 26 dicembre al 3 gennaio il Collettivo Mamadou di Bolzano torna alla tendopoli di Rosarno, Piana di Gioia Tauro, per far partire un…
Il Natale della 2334
Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere
Il Natale della 2334
Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere
Il Natale della 2334
Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere
How much does this emergency cost?
Watch the video of the press conference
5 € for 10 km: support Overthefortress’ campervan
A two-month trip from Sicily to Rome inside and…
Nel 2016 il Messico ha deportato 9.222 minori migranti in Honduras
Tra febbraio e novembre di questo anno, circa 9.222 bambini e adolescenti provenienti dall’Honduras che emigravano verso gli Stati Uniti…
Palermo — Espulsioni di gruppo nel centro di accoglienza straordinaria di Isnello
Tredici ragazzi gambiani sono stati espulsi dal CAS per presunta condotta irregolare e per il loro presunto ruolo nelle proteste contro le…
Formazione ASGI su Protezione internazionale: corso intensivo per operatori
Aperte le iscrizioni all’iniziativa formativa ASGI che si terrà a Roma dal 18 al 21 gennaio 2017.
Natale ad Aleppo: la trappola del confessionalismo
La guerra in Siria si sta combattendo non solo tra fazioni opposte ma anche tra narrazioni discordanti. Da cristiano che si pone domande, mi viene spontaneo chiedermi:come stanno guardando agli ultimi sanguinosi avvenimenti della città di Aleppo i cristiani, in… Continue Reading →![]()
Il fronte caldo del Bangladesh (e del Myanmar)
Il corpo decapitato di un contadino senza vita è stato trovato in un fosso nello Stato di Rakhine, in Birmania. Ma questa volta non c’entrerebbe la polizia, accusata di aver messo a ferro e fuoco quest’aera abitata da musulmani rohingya, la piccola minoranza senza diritti del Myanmar in fuga vero il Bangladesh.
Non si sa chi l’abbia ucciso ma si sa che l’uomo – un rohingya di nome Shu Nar Myar – aveva parlato il giovedi con alcuni giornalisti birmani invitati dal governo a visitare i luoghi ora sotto i riflettori (si fa per dire) della cronaca. L’uomo aveva negato – riporta Al Jazeera – che nella zona si fossero verificati arresti indiscriminati, incendi e stupri, cosa di cui sono accusati i militari birmani (finora un’ottantina di morti). Dunque potrebbe essere stato ucciso da chi lo ha bollato probabilmente come “informatore collaborazionista”. Le ipotesi corrono al gruppo radicale islamista Harakah al-Yaqin (che il governo chiama genericamente Aqa Mul Mujahidin o comunità di combattenti), che secondo International Crisis Group, sarebbe all’origine della strage di appartenenti alle forze di sicurezza di inizio ottobre che dato la stura alla repressione dei rohingya nella zona Nord del Rakhine dove il gruppo è attivo (il governo birmano aveva invece fatto riferimento al gruppo qadista Aqa Mul Mujahidin). Intanto il numero “ufficiale” di coloro che sono già fuggiti qui in Bangladesh, nella zona di Cox Bazar, è salito a circa 34mila.
Anche a Dacca il fronte è caldo. Dalle due di stamattina era in corso un’operazione di polizia che aveva già portato all’arresto di appartenenti al gruppo Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb), gruppo che pare affiliato allo Stato islamico e che è stato accusato di essere dietro alla strage di luglio quando furono uccisi una ventina di ostaggi (tra cui 9 italiani) in un bar di Gulsham, la zona “bene” della città. Nel primo pomeriggio poi, una donna si è fatta esplodere ma senza far vittime oltre a se stessa mentre altre con bambini si sono arrese. Un ragazzo di 14 anni è stato falciato: la polizia sostiene che fosse armato e pericoloso… Il raid si è concluso.
Il sogno di Nour
Quattro anni fa Nour studiava legge a Damasco. Era il suo ultimo anno: altri quattro esami e poi la laurea.
Speciale Natale: petto di agnello ripieno
Ormai il Natale è alle porte e non potevamo mancare con una ricetta per la cena della Vigilia, anche stavolta di origine libanese: il petto di agnello ripieno di riso, frutta secca e spezie! Ingredienti: 300g di carne di agnello tritata un petto di agnello (tagliato a tasca) 400g di riso 100g di pinoli 100g […]
L’articolo Speciale Natale: petto di agnello ripieno sembra essere il primo su Arabpress.
Chi spegne il fuoco in Medio Oriente?
Quando l’incendio divampa c’è sempre qualcuno che ha il compito di domarlo: chi è pronto a farlo nel mondo arabo? E, soprattutto, chi ha appiccato il fuoco?
L’articolo Chi spegne il fuoco in Medio Oriente? sembra essere il primo su Arabpress.
Poly Bridge
Chronicle Keepers The Dreaming Garden
Spy Bugs
Loot Hero DX
Redemption Eternal Quest
Street Arena
Wave of Darkness
Victor Vran
Gryphon Knight Epic
Grey Goo
Legend of Kay Anniversary
Dream
Industry giant II
Mos Speedrun 2
Airscape The Fall of the Gravity
Klaus Ps4
Professional Farmer 2017
Internet e mondo arabo
LEGO Dimensions disponibile in Italia!
CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX
Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Quale Cristo sta nascendo tra noi oggi?
“Sì, siamo cristiani, ma non vogliamo un Cristo che non ci assomigli.”
A Napoli incontro con Antonio Musella (reporter di Fanpage.it),
Metà dicembre, si avvicina il freddo del Natale e anche la fine di questo viaggio.
Tra le sue ultime tappe il camper di #overthefortress…
A Napoli incontro con Antonio Musella (reporter di Fanpage.it),
Metà dicembre, si avvicina il freddo del Natale e anche la fine di questo viaggio.
Tra le sue ultime tappe il camper di #overthefortress…
Emersione del rapporto di lavoro irregolare e permesso di soggiorno per attesa occupazione
Si ringrazia l’Avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e la sua assistente dott.ssa
Emersione del rapporto di lavoro irregolare e permesso di soggiorno per attesa occupazione
Si ringrazia l’Avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e la sua assistente dott.ssa
La Missione Impossibile dell’Ethan Hunt Tunisino, la Verità di Transito e la Bizona Minniti
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Giusto il tempo di far emergere i dettagli circa l’identità dell’attentatore e saltano naturalmente fuori i famosi amici del jihadista, secondo il copione che avevamo tracciato nella puntata precedente. Subito si dimostra che il Califfone è ramificato dappertutto (mi perdonerai l’omaggio al coattissimo cinquantino da motocross della nostra giovinezza) e tutti gli amici degli attentatori sono il brodo di coltura nel quale il radicalismo sguazza, eccetera (ma poi non vale se la stessa cosa accade in North Carolina, chissà perché, chissà percome).…
La Missione Impossibile dell’Ethan Hunt Tunisino, la Verità di Transito e la Bizona Minniti è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Senegal. Nel Casamance perdura una situazione di diffusa pericolosità.
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione.
Senegal. Nel Casamance perdura una situazione di diffusa pericolosità.
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione.
Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione.
Attraverso una descrizione dettagliata degli avvenimenti politici che funestano la Nigeria, il giudice del tribunale di L’Aquila riconosce…
Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione.
Attraverso una descrizione dettagliata degli avvenimenti politici che funestano la Nigeria, il giudice del tribunale di L’Aquila riconosce…
Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo sembra essere il primo su Arabpress.
Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo sembra essere il primo su Arabpress.
La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani
Twitter, Facebook, Apple, Google e Uber hanno dichiarato che non sosterranno in alcun modo la creazione di un registro di musulmani americani se richiesta dall’amministrazione Trump.
L’articolo La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani sembra essere il primo su Arabpress.
La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani
Twitter, Facebook, Apple, Google e Uber hanno dichiarato che non sosterranno in alcun modo la creazione di un registro di musulmani americani se richiesta dall’amministrazione Trump.
L’articolo La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani sembra essere il primo su Arabpress.
Ode ai sognatori caduti: i giovani rivoluzionari siriani
Budour Hassan, rivoluzionaria palestinese, ricorda la Gioventù Rivoluzionaria Siriana che intonava slogan per pane, libertà e giustizia sociale.
Gerusalemme com’era
Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.
Gerusalemme com’era
Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.
Gerusalemme com’era
Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.
Palestina….sfide e libertà
A Roma Palestina….sfide e libertà
Palestina….sfide e libertà
A Roma Palestina….sfide e libertà
Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara?
Fonti di sicurezza analizzano gli eventi e la figura di Altıntaş, il killer dell’ambasciatore russo ad Ankara ucciso il 19 dicembre
L’articolo Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara? sembra essere il primo su Arabpress.
Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara?
Fonti di sicurezza analizzano gli eventi e la figura di Altıntaş, il killer dell’ambasciatore russo ad Ankara ucciso il 19 dicembre.
L’articolo Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara? sembra essere il primo su Arabpress.
L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo
Il riflesso della crisi siriana sull’attacco in Giordania
L’articolo L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.
L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo
Il riflesso della crisi siriana sull’attacco in Giordania
L’articolo L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione
In diversi passaggi il giudice del Tribunale di Genova ricorda come nel paese africano, vi siano gravissime violazioni dei diritti umani e…
Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione
In diversi passaggi il giudice del Tribunale di Genova ricorda come nel paese africano, vi siano gravissime violazioni dei diritti umani e…
Si ringrzia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione ed il commento.
Ordinanza del Tribunale di Roma in cui viene riconosciuta la protezione Internazionale ad una cittadina camerunense omosessuale, atteso che…
Si ringrzia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione ed il commento.
Ordinanza del Tribunale di Roma in cui viene riconosciuta la protezione Internazionale ad una cittadina camerunense omosessuale, atteso che…
Dacca. Annusare una città
La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.
Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.
Dacca. Annusare una città
La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.
Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.
Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze
Il “matrimonio” tra Ennahda e Nidaa Tounes, non abbastanza maturo, ha messo a nudo i suoi punti deboli al cambiare degli eventi
L’articolo Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze sembra essere il primo su Arabpress.
Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze
Il “matrimonio” tra Ennahda e Nidaa Tounes, non abbastanza maturo, ha messo a nudo i suoi punti deboli al cambiare degli eventi
L’articolo Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze sembra essere il primo su Arabpress.
Il qualcunismo omicida dei lupi solitari e la sindrome di Lee Oswald
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Una conversazione sul Pizzagate ed il pistolero del Comet, il Fantasma del Camion di Berlino e la performance del poliziotto turco
Anatole. È molto difficile uscire dalla spirale del complottismo, nella quale ci siamo avvitati inevitabilmente da più di un mese, ma sapevamo che sarebbe stato così e proprio per questo abbiamo evitato di tuffarci in questo argomento sublime quanto inquietante finché ci è stato possibile.…
Il qualcunismo omicida dei lupi solitari e la sindrome di Lee Oswald è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Osservatorio Balkan Route — Novembre 2016
Rispetto all’ultimo rapporto, che analizzava i dispositivi d’accoglienza in tutti gli stati interessati dalla rotta, in novembre l…
Osservatorio Balkan Route — Novembre 2016
Rispetto all’ultimo rapporto, che analizzava i dispositivi d’accoglienza in tutti gli stati interessati dalla rotta, in novembre l…
C’era una volta un principe…
C’era una volta un principe…
Libia: una crisi già dimenticata?
La prima visita di Haftar dall’inizio della crisi libica è stata ad Algeri. Crisi che da qualche tempo è scomparsa dalle cronache. La situazione è ancora bloccata con il governo al Sarraj che, nonostante il riconoscimento internazionale e la riconquista di Sirte dalle mani dell’Isis, non riesce a imporre la sua volontà davanti al potere […]
L’articolo Libia: una crisi già dimenticata? sembra essere il primo su MaroccOggi.
Libia: una crisi già dimenticata?
La prima visita di Haftar dall’inizio della crisi libica è stata ad Algeri. Crisi che da qualche tempo è scomparsa dalle cronache. La situazione è ancora bloccata con il governo al Sarraj che, nonostante il riconoscimento internazionale e la riconquista di Sirte dalle mani dell’Isis, non riesce a imporre la sua volontà davanti al potere […]
L’articolo Libia: una crisi già dimenticata? sembra essere il primo su MaroccOggi.
Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad
Il 17 dicembre sono riprese le audizioni dell’Istanza di Verità e Dignità per ascoltare le vittime del regime di Benali. Questa seconda tornata avviene in un momento difficile. La situazione economica é disastrosa. La sicurezza è ancora fragile. L’ultimo episodio a scuotere la Tunisia è l’uccisione dello scienziato tunisino Mohamed Zouari, omicidio che porta alla […]
L’articolo Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad sembra essere il primo su MaroccOggi.
Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad
Il 17 dicembre sono riprese le audizioni dell’Istanza di Verità e Dignità per ascoltare le vittime del regime di Benali. Questa seconda tornata avviene in un momento difficile. La situazione economica é disastrosa. La sicurezza è ancora fragile. L’ultimo episodio a scuotere la Tunisia è l’uccisione dello scienziato tunisino Mohamed Zouari, omicidio che porta alla […]
L’articolo Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad sembra essere il primo su MaroccOggi.
Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo
Non è solo la crisi economica a mettere in difficoltà il governo algerino. Ci si mette anche un sedicente scienziato, Taoufik Zaibat, 51 anni. La storia ha dell’incredibile. Zaibat tecnico di laboratorio residente da tempo in Svizzera, si presentava come un ricercatore in medicina, titolare a Costantino di un laboratorio farmaceutico dove produce medicinali . […]
L’articolo Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo
Non è solo la crisi economica a mettere in difficoltà il governo algerino. Ci si mette anche un sedicente scienziato, Taoufik Zaibat, 51 anni. La storia ha dell’incredibile. Zaibat tecnico di laboratorio residente da tempo in Svizzera, si presentava come un ricercatore in medicina, titolare a Costantino di un laboratorio farmaceutico dove produce medicinali . […]
L’articolo Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis
L’opinione pubblica araba continua a seguire l’assurda parabola della pop star marocchino Saad Lamjarred. Dalle stelle alle stalle. Anzi dalle stelle, alle celle buie delle galere parigine. Saad Lamjarred, 31 anni, star della musica araba giovanile, figlio d’arte, madre attrice di teatro e padre cantante di successo, era diventato negli ultimi anni un’icona della musica […]
L’articolo Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis sembra essere il primo su MaroccOggi.
Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis
L’opinione pubblica araba continua a seguire l’assurda parabola della pop star marocchino Saad Lamjarred. Dalle stelle alle stalle. Anzi dalle stelle, alle celle buie delle galere parigine. Saad Lamjarred, 31 anni, star della musica araba giovanile, figlio d’arte, madre attrice di teatro e padre cantante di successo, era diventato negli ultimi anni un’icona della musica […]
L’articolo Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis sembra essere il primo su MaroccOggi.
Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. Il Nord Africa alle prese con le difficoltà di governo
Marocco: la formazione del governo è ancora in alto mare. Ancora bloccata la costituzione del nuovo governo marocchino dopo le elezioni del 7 ottobre. Il primo ministro incaricato, Abdelilah Benkirane, che è uscito vincitore con il suo partito islamista moderato del PJD, dopo due mesi di trattative non riesce ancora a trovare una maggioranza. Il […]
L’articolo Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. Il Nord Africa alle prese con le difficoltà di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.
Adam, 27enne originario del Darfur, riferisce ad Amnesty International quello che gli è successo…
“Ci chiedevano solo di dare le impronte. Io ho rifiutato. C’erano sei poliziotti in uniforme. Mi hanno picchiato col manganello sulle…
Adam, 27enne originario del Darfur, riferisce ad Amnesty International quello che gli è successo…
“Ci chiedevano solo di dare le impronte. Io ho rifiutato. C’erano sei poliziotti in uniforme. Mi hanno picchiato col manganello sulle…
Zavattarello crocevia dell’integrazione
Riceviamo e pubblichiamo questo contributo di Matteo Vairo, Direttore del Centro di Prima Accoglienza per Richiedenti Asilo di Zavattarello…
Zavattarello crocevia dell’integrazione
Riceviamo e pubblichiamo questo contributo di Matteo Vairo, Direttore del Centro di Prima Accoglienza per Richiedenti Asilo di Zavattarello…
Amo la rivoluzione, ma non amo i rivoluzionari
Sadri Khiari Dovrebbe essere proibito a ogni militante rivoluzionario pronunciare le parole, celebri in tutto il mondo arabo, del meraviglioso canto di Julia Boutros, Win el malayine (1) Un canto di speranza, un canto d’attesa, un canto disperato ma senza rinuncia, un canto che lega la liberazione della Palestina alla rivoluzione araba e alla mobilitazione popolare. Questo canto era profetico. […]
Amo la rivoluzione, ma non amo i rivoluzionari
Sadri Khiari Dovrebbe essere proibito a ogni militante rivoluzionario pronunciare le parole, celebri in tutto il mondo arabo, del meraviglioso canto di Julia Boutros, Win el malayine (1) Un canto di speranza, un canto d’attesa, un canto disperato ma senza rinuncia, un canto che lega la liberazione della Palestina alla rivoluzione araba e alla mobilitazione popolare. Questo canto era profetico. […]
“Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan sembra essere il primo su Arabpress.
“Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan sembra essere il primo su Arabpress.
Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania
Quarto attentato nel regno arabo che si trova a fronteggiare un problema già noto
L’articolo Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania sembra essere il primo su Arabpress.
Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania
Quarto attentato nel regno arabo che si trova a fronteggiare un problema già noto
L’articolo Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania sembra essere il primo su Arabpress.
#Polettivattene
I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere
#Polettivattene
I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere
#Polettivattene
I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere
Il sole sorge sempre a Est
Proteggiamo le persone non i confini
Photo credit: Andrea Panico, Progetto Melting Pot
Photo credit: Andrea Panico, Progetto Melting Pot
La manifestazione di Roma arriva in…
Ghetti all’italiana: dove abitano gli invisibili
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione
I contrasti tra Turchia e Iran sembrano riemergere dal loro passato di imperi contrapposti, ma la loro cooperazione potrebbe avere un reale impatto sulla guerra in Iraq e in Siria
L’articolo Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione sembra essere il primo su Arabpress.
Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione
I contrasti tra Turchia e Iran sembrano riemergere dal loro passato di imperi contrapposti, ma la loro cooperazione potrebbe avere un reale impatto sulla guerra in Iraq e in Siria
L’articolo Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo.
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.
Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola
Riscoprendo l’approccio pedagogico di Paulo Freire, i percorsi di alfabetizzazione dei migranti diventano l’occasione per attivare processi…
Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola
Riscoprendo l’approccio pedagogico di Paulo Freire, i percorsi di alfabetizzazione dei migranti diventano l’occasione per attivare processi…
Poly Bridge
Chronicle Keepers The Dreaming Garden
Spy Bugs
Loot Hero DX
Redemption Eternal Quest
Street Arena
Wave of Darkness
Victor Vran
Gryphon Knight Epic
Grey Goo
Legend of Kay Anniversary
Dream
Industry giant II
Mos Speedrun 2
Airscape The Fall of the Gravity
Klaus Ps4
Professional Farmer 2017
Internet e mondo arabo
LEGO Dimensions disponibile in Italia!
CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX
Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile?
Di Murat Yetkin. Hurriyet Daily News (19/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina Esattamente una settimana dopo l’attacco suicida a Beşiktaş, avvenuto il 10 dicembre scorso e che ha ucciso 46 persone e ne ha ferite 166, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ha sferrato un altro attacco suicida il 17 dicembre, che ha ucciso 14 persone e […]
L’articolo Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile? sembra essere il primo su Arabpress.
Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile?
Di Murat Yetkin. Hurriyet Daily News (19/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina Esattamente una settimana dopo l’attacco suicida a Beşiktaş, avvenuto il 10 dicembre scorso e che ha ucciso 46 persone e ne ha ferite 166, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ha sferrato un altro attacco suicida il 17 dicembre, che ha ucciso 14 persone e […]
L’articolo Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile? sembra essere il primo su Arabpress.
“Talking hands”: un opificio autogestito da richiedenti asilo
“Talking hands” nasce come progetto che mira a creare un percorso di inclusione rivolto a richiedenti asilo e rifugiati coniugando l…
Afghanistan, cade anche l’ultimo mito
| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |
Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.
Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.
Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.
Afghanistan, cade anche l’ultimo mito
| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |
Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.
Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.
Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.
Alcuni errori che si commettono parlando di islam
L’arabista Dolors Bramon smonta i cliché più comuni sui musulmani e l’islam
L’articolo Alcuni errori che si commettono parlando di islam sembra essere il primo su Arabpress.
Alcuni errori che si commettono parlando di islam
L’arabista Dolors Bramon smonta i cliché più comuni sui musulmani e l’islam
L’articolo Alcuni errori che si commettono parlando di islam sembra essere il primo su Arabpress.
Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente
Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente
Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente
Il 22 dicembre il camper di #overthefortress arriva a Roma
Giovedì 22 dicembre 2016
A partire dalle ore 18.30
presso la Sala Convegni della Città dell’Altra Economia
Largo Dino Frisullo, Roma…
Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Germania: prime espulsioni di massa in Afghanistan
De Maizière mette in pratica un piano disumano: prime espulsioni di massa in Afghanistan
Mercoledì (14 dicembre 2016 n.d.R.)
La storia di Atai
Atai ha scritto un messaggio sulla nostra pagina FB perché a partire dalla sua storia voleva raccontare quello che sta succedendo in…
Aleppo: l’ultimo capitolo?
Dopo l’evacuazione della città di Aleppo, la Russia raccoglie i frutti del suo operato. Quali conseguenze per la regione?
L’articolo Aleppo: l’ultimo capitolo? sembra essere il primo su Arabpress.
La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme
La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere
La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme
La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere
La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme
La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere
…e intanto, nella fragile Giordania…
La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere
…e intanto, nella fragile Giordania…
La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere
…e intanto, nella fragile Giordania…
La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere
Ruspe o biberon un nuovo libro per andare oltre il luoghi comuni sui migranti
La rotta del Brennero specchio delle politiche europee
In poco meno di un mese la rotta del Brennero si è tinta di sangue e lacrime a causa delle tragedie annunciate, che sono costate la vita a…
Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji
Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()
Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji
Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()
Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji
Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()
Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji
Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()
Costa molto più respingere i migranti che accoglierli come si deve
In occasione della Giornata Internazionale del Migrante che ricorre il 18 dicembre, proponiamo un un’inchiesta su immigrazione ed accoglienza, in rapporto all’economia
L’articolo Costa molto più respingere i migranti che accoglierli come si deve sembra essere il primo su Arabpress.
Le complesse origini della lingua araba
Il 18 dicembre si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Araba
L’articolo Le complesse origini della lingua araba sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – XI puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – XI puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Giornata per Aleppo-Napoli città rifugio
Si è svolto a Napoli l’evento intitolato “Giornata per Aleppo. Napoli città rifugio”, presso Palazzo Du Mesnil, sede dell’università L’Orientale, il 14 dicembre 2016. Una giornata che ha visto la cospicua partecipazione di studenti non solo universitari ma anche liceali…. Continue Reading →![]()
Le autorità egiziane reprimono gli attivisti per i diritti umani con il divieto di viaggio
“Il governo sta lavorando da due anni alla riorganizzazione del sistema legislativo per violare la costituzione. Neanche ai tempi di Mubarak si vedevano cose simili.”
EU border force accuses charities of collusion with migrant smugglers
Duncan Robinson in Brussels, Financial Times del 15 dicembre 2016 (link all’articolo originale)
The EU’s border agency has accused…
A Roma per i migranti non si è fatto abbastanza — verso la manifestazione del 17 dicembre
La mancata accoglienza nella Capitale è una storia che parte da lontano, passando per il sistema di Mafia Capitale, si muove attraverso la…
OltreConfine: due incontri sul tema della migrazione — 16/17 Dicembre — Schio (VI)
L’Associazione Agorà in collaborazione con Melting Pot presenta due incontri sul tema della migrazione; invitiamo tutti a partecipare.
MSF chiede un chiarimento immediato da parte dell’Agenzia europea di guardia di frontiera e…
Secondo il Financial Times, l’agenzia europea di frontiera avrebbe sostenuto tali accuse in una serie di reports confidenziali, non…
Speciale Natale: kibbeh nayyeh
Eccoci con il secondo appuntamento di questo speciale natalizio. Oggi, vi proponiamo uno dei piatti principali della cucina libanese, una versione alternativa del kibbeh, pietanza diffusa in tutto il Levante arabo: il kibbeh nayyeh, tartare di carne e burghul speziata! Ingredienti: 500g di carne di agnello tritata 1 cipolla piccola 1 mazzetto di menta fresca 120g […]
L’articolo Speciale Natale: kibbeh nayyeh sembra essere il primo su Arabpress.
La geografia militare di Aleppo
L’inizio della battaglia di Al-Bab ha avuto inevitabilmente delle conseguenze sulla geografia militare di Aleppo
L’articolo La geografia militare di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.
L’Europa non vuole più accogliere rifugiati. Gravi conclusioni del Consiglio europeo
Il Consiglio europeo del 15 dicembre lascia sul tappeto tutti problemi che esistono oggi in Europa per la protezione dei rifugiati e la…
Le voci dalle occupazioni di Bari e Foggia su Radio NoBorder una radio per tutti
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Le voci dalle occupazioni di Bari e Foggia su Radio NoBorder una radio per tutti
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Privazione di libertà e mancato ricorso effettivo: Italia condannata dalla CEDU
Giovedì 15 dicembre 2016, mentre era in corso di svolgimento il Consiglio europeo sulla gestione delle migrazioni, è stata resa nota la…
Tunisia: migliora la sicurezza, ma non la situazione economica
Il comprovato aumento delle capacità delle forze di sicurezza ha preparato il terreno per affrontare ora la questione economica in Tunisia
L’articolo Tunisia: migliora la sicurezza, ma non la situazione economica sembra essere il primo su Arabpress.
Un decreto a tutela del superiore interesse del minore riconosce il P.d.s. alla mamma.
Si ringrazia l’Avv. Avv. Laura Mazza per la segnalazione ed il commento.
The Harvest — Il film sul Caporalato in Italia
The Harvest è il docu-musical che racconta la vita della comunità sikh vittima di caporalato e costretta all’uso delle sostanze dopanti che…
Nazik al-Mala’ika: la voce degli angeli
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Nazik al-Mala’ika: la voce degli angeli sembra essere il primo su Arabpress.
Elegia aleppina
 Non c’è pace all’anima nostra, non c’è fossa in cui nascondere le salme. Non c’è anfratto cerebrale in cui resti memoria della Storia, non c’è stomaco per i nostri calici amari. Non c’è sazietà per i loro appetiti. Non c’è donna che non possa essere denudata davanti al marito. Non c’è donna denudata che non possa essere stuprata. Non c’è…
Non c’è pace all’anima nostra, non c’è fossa in cui nascondere le salme. Non c’è anfratto cerebrale in cui resti memoria della Storia, non c’è stomaco per i nostri calici amari. Non c’è sazietà per i loro appetiti. Non c’è donna che non possa essere denudata davanti al marito. Non c’è donna denudata che non possa essere stuprata. Non c’è…
Se rimane il regime, rimane la rivoluzione
Le radici della rivoluzione siriana e il suo legame con il regime
L’articolo Se rimane il regime, rimane la rivoluzione sembra essere il primo su Arabpress.
Il continuo lutto dell’Egitto
Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Il continuo lutto dell’Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
Altra frontiera: il campo di Tel Abbas
Vedi anche:
Caporalato libanese, da Beirut un articolo di Baalbek
Shatila refugees camp, da Beiurt un articolo di Mazrou Leyla
Uscire…
“Le mille e una notte” in una nuova edizione illustrata
Ci sono mille e una storia e poi altre mille storie, quelle di un testo che, prima di essere testo, era una tradizione centenaria perpetrata oralmente nel tempo, dalla Persia all’Egitto, dall’India alla Mesopotamia. I primi documenti ritrovati in lingua araba e ritrovati in Siria nella metà del secolo scorso, sono datati IX secolo. Siamo agli inizi del Settecento, […]
L’articolo “Le mille e una notte” in una nuova edizione illustrata sembra essere il primo su Arabpress.
Le Scarpe dei Caporali: uno spettacolo teatrale di Salvatore Cutrì con la regia di Paolo Grossi
“Le Scarpe dei Caporali” ha come obiettivo l’avvio e il sostegno di iniziative di sensibilizzazione e azione concrete per il superamento…
I significati dietro ai nomi di otto paesi arabi
Le origini dietro ai nomi
L’articolo I significati dietro ai nomi di otto paesi arabi sembra essere il primo su Arabpress.
Sul settarismo nel mondo arabo
Fenomeno sempre più diffuso, il settarismo presenta caratteristiche ben precise nella regione
L’articolo Sul settarismo nel mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
I paesi europei hanno ricollocato solo un rifugiato su 20 tra quelli che avevano promesso di…
Più di un anno dopo la promessa dell’UE di ridistribuire 160.000 rifugiati da Italia e Grecia, ormai al limite delle loro possibilità, ad…
Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Egitto: terrorismo di stato?
mcc43 Domenica 11 dicembre un’esplosione all’ingresso della chiesa di san Pietro, adiacente la Cattedrale di San Marco al Cairo, ha ucciso 24 persone e ne ha ferite 49. E’ l’attentato più denso di incognite, sugli autori e per le conseguenze future, dentro un’escalation di attacchi. . Dalla pagina Facebook di Unheard Egypt “Quando Mubarak era […]![]()
Egitto: terrorismo di stato?
mcc43 Domenica 11 dicembre un’esplosione all’ingresso della chiesa di san Pietro, adiacente la Cattedrale di San Marco al Cairo, ha ucciso 24 persone e ne ha ferite 49. E’ l’attentato più denso di incognite, sugli autori e per le conseguenze future, dentro un’escalation di attacchi. . Dalla pagina Facebook di Unheard Egypt “Quando Mubarak era […]![]()
Egitto: terrorismo di stato?
mcc43 Domenica 11 dicembre un’esplosione all’ingresso della chiesa di san Pietro, adiacente la Cattedrale di San Marco al Cairo, ha ucciso 24 persone e ne ha ferite 49. E’ l’attentato più denso di incognite, sugli autori e per le conseguenze future, dentro un’escalation di attacchi. . Dalla pagina Facebook di Unheard Egypt “Quando Mubarak era […]![]()
Egitto: terrorismo di stato?
mcc43 Domenica 11 dicembre un’esplosione all’ingresso della chiesa di san Pietro, adiacente la Cattedrale di San Marco al Cairo, ha ucciso 24 persone e ne ha ferite 49. E’ l’attentato più denso di incognite, sugli autori e per le conseguenze future, dentro un’escalation di attacchi. . Dalla pagina Facebook di Unheard Egypt “Quando Mubarak era […]![]()
Regine di Siria
Io non ho parole, oggi. Non ho le parole giuste, quelle che spiegano. O salvano la coscienza. E a dire il vero non le ho da molto tempo, le parole giuste su Aleppo e sulle altre città martiri siriane. Non le ho, le parole giuste, per una questione di serietà: non sono esperta di coseContinua a leggere
Regine di Siria
Io non ho parole, oggi. Non ho le parole giuste, quelle che spiegano. O salvano la coscienza. E a dire il vero non le ho da molto tempo, le parole giuste su Aleppo e sulle altre città martiri siriane. Non le ho, le parole giuste, per una questione di serietà: non sono esperta di coseContinua a leggere
Regine di Siria
Io non ho parole, oggi. Non ho le parole giuste, quelle che spiegano. O salvano la coscienza. E a dire il vero non le ho da molto tempo, le parole giuste su Aleppo e sulle altre città martiri siriane. Non le ho, le parole giuste, per una questione di serietà: non sono esperta di coseContinua a leggere
I paesi europei hanno ricollocato solo un rifugiato su 20 tra quelli che avevano promesso di…
Più di un anno dopo la promessa dell’UE di ridistribuire 160.000 rifugiati da Italia e Grecia, ormai al limite delle loro possibilità, ad…
A Roma per i migranti non si è fatto abbastanza — verso la manifestazione del 17 dicembre
La mancata accoglienza nella Capitale è una storia che parte da lontano, passando per il sistema di Mafia Capitale, si muove attraverso la…
Le difficoltà della Libia dopo la battaglia di Sirte
La recente vittoria contro l’ISIS ha aperto nuovi scenari per il paese arabo
L’articolo Le difficoltà della Libia dopo la battaglia di Sirte sembra essere il primo su Arabpress.
Aleppo. Dove è morta l’umanità
Il 13 dicembre, dopo quasi 4 anni e mezzo, la parte est di Aleppo torna sotto il controllo del regime di Damasco. Cade l’Aleppo degli esperimenti di democrazia e delle radio libere, nel silenzio della comunità internazionale. E il nostro.
Aleppo. Dove è morta l’umanità
Il 13 dicembre, dopo quasi 4 anni e mezzo, la parte est di Aleppo torna sotto il controllo del regime di Damasco. Cade l’Aleppo degli esperimenti di democrazia e delle radio libere, nel silenzio della comunità internazionale. E il nostro.
Aleppo. Dove è morta l’umanità
Il 13 dicembre, dopo quasi 4 anni e mezzo, la parte est di Aleppo torna sotto il controllo del regime di Damasco. Cade l’Aleppo degli esperimenti di democrazia e delle radio libere, nel silenzio della comunità internazionale. E il nostro.
Aleppo: la danza sopra la desolazione
Il regime siriano ha distrutto il proprio paese regalando la Siria alle potenze internazionali, ma il popolo siriano rappresenta un esempio di resistenza al totalitarismo
L’articolo Aleppo: la danza sopra la desolazione sembra essere il primo su Arabpress.
Siria: “È terribile, e spaventoso, Aleppo è diventata una città degli orrori.”
Gnaid, un attivista con l’Aleppo Media Center, e sua moglie hanno recentemente avuto una bambina, la loro secondogenita, durante il letale assedio della loro città.
“Bastarda maledetta”. Storie bolzanine di ordinario razzismo
1.40 del 2 dicembre, Bolzano. Una donna keniota, in Italia da più di un decennio, biologa e sposata con un ragazzo di Bolzano, finita una…
Il cambiamento del fenomeno migratorio in Italia dopo le primavere arabe
I materiali vengono pubblicati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione — Non commerciale CC BY-NC
Università degli Studi Guglielmo…
Egitto: chi c’è dietro gli attentati del Cairo contro i copti?
I cristiani copti d’Egitto protestano affinché le autorità garantiscano la sicurezza e la tutela dei diritti di questa minoranza religiosa
L’articolo Egitto: chi c’è dietro gli attentati del Cairo contro i copti? sembra essere il primo su Arabpress.
“Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio”
 “Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio” nasce dalle sollecitazioni e la sensibilità di numerosi cittadini per la popolazione civile della città siriana.
“Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio” nasce dalle sollecitazioni e la sensibilità di numerosi cittadini per la popolazione civile della città siriana.
“Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio”
 “Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio” nasce dalle sollecitazioni e la sensibilità di numerosi cittadini per la popolazione civile della città siriana.
“Giornata per Aleppo – Napoli città rifugio” nasce dalle sollecitazioni e la sensibilità di numerosi cittadini per la popolazione civile della città siriana.
Casi Dublino clausola umanitaria. La competenza è del Giudice Ordinario
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Libano: il silenzio della “voce di chi non ha la voce”
Beirut, una volta cuore dell’editoria e della letteratura araba, sembra assistere inerme di fronte all’impoverimento culturale che si sta concretizzando anche nella chiusura della rivista As-Safir
L’articolo Libano: il silenzio della “voce di chi non ha la voce” sembra essere il primo su Arabpress.
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera
Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!
Si ringrazia l’Avv.Alessandra Ballerini per la segnalazione e Enrico Giorgino per il commento.
Con l’Ordinanza n. 4032 del 17.10.2016, il Tribunale di Genova ha accolto parzialmente l’impugnazione del cittadino pakistano della…
Turchia: così non si combatte il terrorismo
Il modo in cui il governo sta cercando di combattere il terrorismo non è corretto. Di questo passo, ogni atto di terrore non farà altro che creare altre fratture nella società, mettendo a rischio non solo la sicurezza e la democrazia in Turchia, ma in tutta Europa
L’articolo Turchia: così non si combatte il terrorismo sembra essere il primo su Arabpress.
Turchia: così non si combatte il terrorismo
Il modo in cui il governo sta cercando di combattere il terrorismo non è corretto. Di questo passo, ogni atto di terrore non farà altro che creare altre fratture nella società, mettendo a rischio non solo la sicurezza e la democrazia in Turchia, ma in tutta Europa
L’articolo Turchia: così non si combatte il terrorismo sembra essere il primo su Arabpress.
OltreConfine: due incontri sul tema della migrazione — 16/17 Dicembre — Schio (VI)
L’Associazione Agorà in collaborazione con Melting Pot presenta due incontri sul tema della migrazione; invitiamo tutti a partecipare.
Il risultato del viaggio di Gentiloni in Africa: contro i migranti finanziamo governi corrotti
Dieci giorni fa il nostro ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni ha visitato il Niger, il Mali e il Senegal per colloqui con i suoi…
Appello dalla Basilicata — Diritti violati. Il dovere dell’antirazzismo
Appare davvero incredibile la singolare coincidenza per cui oggi, 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, nonché giornata di…
Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola
Riscoprendo l’approccio pedagogico di Paulo Freirei, i percorsi di alfabetizzazione dei migranti diventano l’occasione per attivare…
Milano 17 Dicembre: Stop War Not People. Qui nessuno è straniero!
Sabato 17 Dicembre, vigilia della giornata internazionale per i diritti dei migranti, un corteo cittadino attraverserà le vie del Municipio…
Exploitation du travail et “caporalato” dans les campagnes siciliennes
5 € per 10 km : sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Appello: Diritti violati. Il dovere dell’antirazzismo
Appare davvero incredibile la singolare coincidenza per cui oggi, 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, nonché giornata di…
Daesh rientra a Palmira: quali saranno le risposte?
Quando manca ormai poco alla caduta di Aleppo e al probabile “trionfo” di Assad, la notizia di una nuova offensiva da parte di Daesh (ISIS) potrebbe guastare la festa a Bashar
L’articolo Daesh rientra a Palmira: quali saranno le risposte? sembra essere il primo su Arabpress.
Daesh rientra a Palmira: quali saranno le risposte?
Quando manca ormai poco alla caduta di Aleppo e al probabile “trionfo” di Assad, la notizia di una nuova offensiva da parte di Daesh (ISIS) potrebbe guastare la festa a Bashar
L’articolo Daesh rientra a Palmira: quali saranno le risposte? sembra essere il primo su Arabpress.
I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio
Quest’anno sono uscite le traduzioni di due raccolte di poeti siriani: Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani e Il luogo stretto di Faraj Bayrakdar. Ne ho scritto qualche giorno fa per Internazionale: “Se trovi qualcuno che ti ama come il poeta siriano Nizar Qabbani ha amato le sue donne, sei a cavallo”, ho … Continua a leggere I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio →![]()
I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio
Quest’anno sono uscite le traduzioni di due raccolte di poeti siriani: Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani e Il luogo stretto di Faraj Bayrakdar. Ne ho scritto qualche giorno fa per Internazionale: “Se trovi qualcuno che ti ama come il poeta siriano Nizar Qabbani ha amato le sue donne, sei a cavallo”, ho … Continua a leggere I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio →![]()
I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio
Quest’anno sono uscite le traduzioni di due raccolte di poeti siriani: Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani e Il luogo stretto di Faraj Bayrakdar. Ne ho scritto qualche giorno fa per Internazionale: “Se trovi qualcuno che ti ama come il poeta siriano Nizar Qabbani ha amato le sue donne, sei a cavallo”, ho … Continua a leggere I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio →![]()
I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio
Quest’anno sono uscite le traduzioni di due raccolte di poeti siriani: Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani e Il luogo stretto di Faraj Bayrakdar. Ne ho scritto qualche giorno fa per Internazionale: “Se trovi qualcuno che ti ama come il poeta siriano Nizar Qabbani ha amato le sue donne, sei a cavallo”, ho … Continua a leggere I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio →![]()
I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio
Quest’anno sono uscite le traduzioni di due raccolte di poeti siriani: Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani e Il luogo stretto di Faraj Bayrakdar. Ne ho scritto qualche giorno fa per Internazionale: “Se trovi qualcuno che ti ama come il poeta siriano Nizar Qabbani ha amato le sue donne, sei a cavallo”, ho … Continua a leggere I due poeti che raccontano la Siria attraverso l’amore e l’esilio →![]()
L’Arabia Saudita e il Consiglio di Cooperazione del Golfo
Riusciranno i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo a superare le loro divergenze e unirsi contro l’Iran e le minacce che interessano la regione araba?
L’articolo L’Arabia Saudita e il Consiglio di Cooperazione del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
L’Arabia Saudita e il Consiglio di Cooperazione del Golfo
Riusciranno i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo a superare le loro divergenze e unirsi contro l’Iran e le minacce che interessano la regione araba?
L’articolo L’Arabia Saudita e il Consiglio di Cooperazione del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità”
L’attacco alla cattedrale copta di San Marco al Cairo è un punto di svolta nelle strategie dei gruppi terroristici dopo il colpo di stato del 2013? L’assenza di una rivendicazione dell’ordigno che ha provocato almeno 25 morti e una cinquantina di feriti non può ancora fare chiarezza sull’accaduto che sta scuotendo ulteriormente la minoranza cristiana. […]
L’articolo Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità”
L’attacco alla cattedrale copta di San Marco al Cairo è un punto di svolta nelle strategie dei gruppi terroristici dopo il colpo di stato del 2013? L’assenza di una rivendicazione dell’ordigno che ha provocato almeno 25 morti e una cinquantina di feriti non può ancora fare chiarezza sull’accaduto che sta scuotendo ulteriormente la minoranza cristiana. […]
L’articolo Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità”
L’attacco alla cattedrale copta di San Marco al Cairo è un punto di svolta nelle strategie dei gruppi terroristici dopo il colpo di stato del 2013? L’assenza di una rivendicazione dell’ordigno che ha provocato almeno 25 morti e una cinquantina di feriti non può ancora fare chiarezza sull’accaduto che sta scuotendo ulteriormente la minoranza cristiana. […]
L’articolo Egitto, l’attentato in Chiesa e la tensioni fra i cristiani copti e il regime di Al Sisi: “Non protegge la comunità” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il prezzo alto pagato dagli egiziani copti
Eccole, le paure che si fanno realtà. L’attentato alla cattedrale copta del Cairo, ad Abassyyia. Un attentato compiuto nella domenica santa per i cristiani, e nel giorno in cui i musulmani si stanno preparando a celebrare il compleanno del profeta Mohammed. Una festa, quest’ultima, sentita da tutti negli strati popolari del Cairo. Il numero deiContinua a leggere
Il prezzo alto pagato dagli egiziani copti
Eccole, le paure che si fanno realtà. L’attentato alla cattedrale copta del Cairo, ad Abassyyia. Un attentato compiuto nella domenica santa per i cristiani, e nel giorno in cui i musulmani si stanno preparando a celebrare il compleanno del profeta Mohammed. Una festa, quest’ultima, sentita da tutti negli strati popolari del Cairo. Il numero deiRead more
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
La settimana di Arabpress in podcast – X puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – X puntata sembra essere il primo su Arabpress.
La settimana di Arabpress in podcast – X puntata
Le notizie e gli approfondimenti più importanti della settimana in 5 minuti! A cura di Giusy Regina
L’articolo La settimana di Arabpress in podcast – X puntata sembra essere il primo su Arabpress.
Contradictions and violations of human rights in Pozzallo hotspot
Watch the video of the press conference
5 € for 10 km: support Overthefortress’ campervan
A two-month trip from Sicily to Rome inside and…
Cos’è l’islam politico?
Accomunati da una sola ideologia e divisi da un gran numero di interpretazioni e di modus operandi, gli islamisti politici continuano a sfuggire a una definizione precisa
L’articolo Cos’è l’islam politico? sembra essere il primo su Arabpress.
Cos’è l’islam politico?
Accomunati da una sola ideologia e divisi da un gran numero di interpretazioni e di modus operandi, gli islamisti politici continuano a sfuggire a una definizione precisa
L’articolo Cos’è l’islam politico? sembra essere il primo su Arabpress.
“First steps” into Europe: the spreading of the “hotspot approach”
Watch the video of the press conference
5 € for 10 km: support Overthefortress’ campervan
A two-month trip from Sicily to Rome inside and…
La lunga attesa. Mostra fotografica di Edoardo Premoli
Dal 6 al 21 dicembre 2016 all’Università degli Studi di Milano (Via Festa del Perdono, 7 — Atrio Aula Magna) è in esposizione la mostra…
Appello internazionale di City Plaza: il 18 marzo diventi la Giornata di mobilitazione europea
Nel cupo e tetro cielo d’Europa, la Resistenza è la luce che brilla.
Domestic stories
Le collaboratrici familiari in Libano, tra diritti negati e rivendicazioni
via Migrano http://ift.tt/2h8Cgd8
Speciale Natale: fatayer di spinaci
Le feste natalizie si avvicinano e vogliamo proporvi qualche idea per dare un tocco mediorientale alle vostre tavole quest’anno: da oggi fino alla fine dell’anno, vi proporremo ricette preparate in occasione dei festeggiamenti natalizi dai cristiani in Medio Oriente, specialmente in Libano. Iniziamo subito con questo “finger food” leggero, ma davvero gustoso: i fatayer con spinaci! Ingredienti: […]
L’articolo Speciale Natale: fatayer di spinaci sembra essere il primo su Arabpress.
Speciale Natale: fatayer di spianci
Le feste natalizie si avvicinano e vogliamo proporvi qualche idea per dare un tocco mediorientale alle vostre tavole quest’anno: da oggi fino alla fine dell’anno, vi proporremo ricette preparate in occasione dei festeggiamenti natalizi dai cristiani in Medio Oriente, specialmente in Libano. Iniziamo subito con questo “finger food” leggero, ma davvero gustoso: i fatayer con spinaci! Ingredienti: […]
L’articolo Speciale Natale: fatayer di spianci sembra essere il primo su Arabpress.
I marocchini denunciano disoccupazione, corruzione e povertà
Nonostante gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la disoccupazione, la corruzione e la povertà sono ancora una dura realtà per il Marocco
L’articolo I marocchini denunciano disoccupazione, corruzione e povertà sembra essere il primo su Arabpress.
I marocchini denunciano disoccupazione, corruzione e povertà
Nonostante gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la disoccupazione, la corruzione e la povertà sono ancora una dura realtà per il Marocco
L’articolo I marocchini denunciano disoccupazione, corruzione e povertà sembra essere il primo su Arabpress.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Poly Bridge
Chronicle Keepers The Dreaming Garden
Spy Bugs
Loot Hero DX
Redemption Eternal Quest
Street Arena
Wave of Darkness
Victor Vran
Gryphon Knight Epic
Grey Goo
Legend of Kay Anniversary
Dream
Industry giant II
Mos Speedrun 2
Airscape The Fall of the Gravity
Klaus Ps4
Professional Farmer 2017
Internet e mondo arabo
LEGO Dimensions disponibile in Italia!
CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX
Tra Ionio e Tirreno poco spazio per i migranti in Calabria
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Appunti nomadici 2
di Giuseppe Cossuto
Proseguiamo il nostro viaggio nel passato di coloro che venivano considerati nomadi, scrivendo qualche nota sulla situazione degli zingari nell’ex mondo del “Socialismo Realmente Esistente” (la prima puntata è qui).
Elevare il grado socio-culturale distruggendo la cultura tradizionale
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fine del nazismo e del fascismo come sistemi di governo rappresentò per gli zingari sopravvissuti alle politiche di sterminio la fine di un tremendo incubo.…
Appunti nomadici 2 è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Appunti nomadici 2
di Giuseppe Cossuto
Proseguiamo il nostro viaggio nel passato di coloro che venivano considerati nomadi, scrivendo qualche nota sulla situazione degli zingari nell’ex mondo del “Socialismo Realmente Esistente” (la prima puntata è qui).
Elevare il grado socio-culturale distruggendo la cultura tradizionale
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fine del nazismo e del fascismo come sistemi di governo rappresentò per gli zingari sopravvissuti alle politiche di sterminio la fine di un tremendo incubo.…
Appunti nomadici 2 è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Incendio nel “Ghetto dei Bulgari” a Borgo Mezzanone: un morto
Un ragazzo di 20 anni è morto carbonizzato in un violento incendio che si è sviluppato nella notte, forse a causa di una stufetta mal…
Fuoco ai ghetti di stato casa per chi ci vive!
Nei giorni scorsi il camper di #overthefortress aveva fatto tappa a Rosarno.
Orientamento potere città. Mappe locali di migranti-bolognesi
I materiali vengono pubblicati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione — Non commerciale CC BY-NC
Alma Mater Studiorum — Università di…
Il rifugiato: l’ultima incarnazione dell’uomo senza diritto
La “crisi” dei rifugiati [1] che stiamo vivendo oggi è avvolta da una marcata nube paradossale.
Ventimiglia: criminalizzare la solidarietà
La demonizzazione del presidio, la militarizzazione del confronto
via Migrano http://ift.tt/2gjk4hJ
La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia
Nell’ultimo secolo il destino della regione è stato in mani estere, ma una condizione è necessaria perché questa situazione termini
L’articolo La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia sembra essere il primo su Arabpress.
La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia
Nell’ultimo secolo il destino della regione è stato in mani estere, ma una condizione è necessaria perché questa situazione termini
L’articolo La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia sembra essere il primo su Arabpress.
La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia
Nell’ultimo secolo il destino della regione è stato in mani estere, ma una condizione è necessaria perché questa situazione termini
L’articolo La rassegnazione degli arabi a non essere autori della propria storia sembra essere il primo su Arabpress.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
In Inghilterra 2.000 persone chiedono la chiusura di Yarl’s Wood
Londra — Sabato scorso, 2.000 persone da tutta l’Inghilterra si sono radunate davanti al centro di detenzione di Yarl’s Wood, in mezzo alle…
Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero
Dal blog Egitto in Movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero sembra essere il primo su Arabpress.
Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero
Dal blog Egitto in Movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero sembra essere il primo su Arabpress.
Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero
Dal blog Egitto in Movimento di Ludovica Brignola
L’articolo Il magnate del Medio Oriente lascia l’impero sembra essere il primo su Arabpress.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Violenza sulle donne: parola ai violenti
La violenza sulle donne raccontata dagli uomini
L’articolo Violenza sulle donne: parola ai violenti sembra essere il primo su Arabpress.
Violenza sulle donne: parola ai violenti
La violenza sulle donne raccontata dagli uomini
L’articolo Violenza sulle donne: parola ai violenti sembra essere il primo su Arabpress.
Violenza sulle donne: parola ai violenti
La violenza sulle donne raccontata dagli uomini
L’articolo Violenza sulle donne: parola ai violenti sembra essere il primo su Arabpress.
Siria: risoluzione pacifica o armata?
Quale è la strada adottare per risolvere la guerra nel Paese arabo?
L’articolo Siria: risoluzione pacifica o armata? sembra essere il primo su Arabpress.
Siria: risoluzione pacifica o armata?
Quale è la strada adottare per risolvere la guerra nel Paese arabo?
L’articolo Siria: risoluzione pacifica o armata? sembra essere il primo su Arabpress.
La letteratura araba in traduzione 2016
Come ogni anno, a dicembre pubblico la lista degli autori arabi/arabofoni (ovvero: che scrivono in arabo; di origini arabe ma che scrivono in lingue occidentali) tradotti in italiano e pubblicati dalle case editrici nostrane. Trovo la lista di quest’anno piuttosto particolare: da una parte, se escludiamo la poesia, il numero di traduzioni dall’arabo equivale a … Continua a leggere La letteratura araba in traduzione 2016 →![]()
La letteratura araba in traduzione 2016
Come ogni anno, a dicembre pubblico la lista degli autori arabi/arabofoni (ovvero: che scrivono in arabo; di origini arabe ma che scrivono in lingue occidentali) tradotti in italiano e pubblicati dalle case editrici nostrane. Trovo la lista di quest’anno piuttosto particolare: da una parte, se escludiamo la poesia, il numero di traduzioni dall’arabo equivale a … Continua a leggere La letteratura araba in traduzione 2016 →![]()
La letteratura araba in traduzione 2016
Come ogni anno, a dicembre pubblico la lista degli autori arabi/arabofoni (ovvero: che scrivono in arabo; di origini arabe ma che scrivono in lingue occidentali) tradotti in italiano e pubblicati dalle case editrici nostrane. Trovo la lista di quest’anno piuttosto particolare: da una parte, se escludiamo la poesia, il numero di traduzioni dall’arabo equivale a … Continua a leggere La letteratura araba in traduzione 2016 →![]()
La letteratura araba in traduzione 2016
Come ogni anno, a dicembre pubblico la lista degli autori arabi/arabofoni (ovvero: che scrivono in arabo; di origini arabe ma che scrivono in lingue occidentali) tradotti in italiano e pubblicati dalle case editrici nostrane. Trovo la lista di quest’anno piuttosto particolare: da una parte, se escludiamo la poesia, il numero di traduzioni dall’arabo equivale a … Continua a leggere La letteratura araba in traduzione 2016 →![]()
La letteratura araba in traduzione 2016
Come ogni anno, a dicembre pubblico la lista degli autori arabi/arabofoni (ovvero: che scrivono in arabo; di origini arabe ma che scrivono in lingue occidentali) tradotti in italiano e pubblicati dalle case editrici nostrane. Trovo la lista di quest’anno piuttosto particolare: da una parte, se escludiamo la poesia, il numero di traduzioni dall’arabo equivale a … Continua a leggere La letteratura araba in traduzione 2016 →![]()
A Roma per i migranti non si è fatto abbastanza — verso la manifestazione del 17 dicembre
La mancata accoglienza nella Capitale è una storia che parte da lontano, passando per il sistema di Mafia Capitale, si muove attraverso la…
Richiesta protezione internazionale — Annullamento decreto di espulsione
Un interessante provvedimento del Giudice di Pace di Milano del 23.11.16
Un “Gesù” muore ogni giorno
Di Francesco Matteo Landi Dite pure che Gesù Cristo si è fatto crocifiggere per l’umanità, ma ricordatevi che non è l’unica persona che si è immolata per noi. Possiamo definire Gesù anche il Clown che sotto ai bombardamenti di Aleppo continuava a dare un sostegno morale e psicologico ai bambini, e sotto gli stessi bombardamentiRead more
Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione.
Un decreto della Corte di Appello di Roma sezione per i Minorenni su ricorso ex art. 31 dlgs 286/98, nel quale viene ribadito il principio…
UK — Chiudiamo Yarl’s Wood e tutti gli altri centri di detenzione!
È arrivata l’ora della DECIMA manifestazione davanti a Yarl’s Wood — facciamo che sia la più grande di tutte e facciamo chiudere questo…
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
L’esternalizzazione dei controlli di frontiera e il falso umanitarismo dell’Unione europea
Nella tappa palermitana del viaggio dentro la rotta del Mediteranneo centrale della campagna #overthefortress abbiamo avuto il piacere di…
Falerna: vite sgomberate
Il 6 dicembre 2016, in ottemperanza a un’ordinanza emessa dal Sindaco di Falerna nel mese di ottobre, i migranti che alloggiavano presso il…
“La rana e la pioggia” di Antonello Sacchetti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “La rana e la pioggia” di Antonello Sacchetti sembra essere il primo su Arabpress.
“La rana e la pioggia” di Antonello Sacchetti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “La rana e la pioggia” di Antonello Sacchetti sembra essere il primo su Arabpress.
La rete di supporto legale ai migranti del Baobab realizzata da A Buon Diritto, Action Diritti in…
Erdoğan e la sua continua serie di errori
Il presidente turco mostra la sua forte inclinazione nel commettere una sequenza di scelte errate sia in politica interna che in politica estera
L’articolo Erdoğan e la sua continua serie di errori sembra essere il primo su Arabpress.
Erdoğan e la sua continua serie di errori
Il presidente turco mostra la sua forte inclinazione nel commettere una sequenza di scelte errate sia in politica interna che in politica estera
L’articolo Erdoğan e la sua continua serie di errori sembra essere il primo su Arabpress.
La violenza del web per fermare le donne favorevoli all’accoglienza
Una montagna. Di merda, ma pur sempre una montagna.
“La fine è vicina”, “Ricordate cosa abbiamo sacrificato”: Dispacci da Aleppo est
“Dirigo le mie parole agli attivisti siriani […] chiedo loro di inviare il nostro messaggio sul fatto che ci siamo sacrificati e continuiamo a sacrificarci.”
“La fine è vicina”, “Ricordate cosa abbiamo sacrificato”: Dispacci da Aleppo est
“Dirigo le mie parole agli attivisti siriani […] chiedo loro di inviare il nostro messaggio sul fatto che ci siamo sacrificati e continuiamo a sacrificarci.”
La geopolitica der paesello, la matita di Pelù e l’ecologia del seggio elettorale
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Lorenzo. Leonardo Bianchi si è messo a scavare su pagine facebook semi-dormienti, Tipo “800.000 iscritti per Homer Simpson presidente del Consiglio”. Consiglio una rapida visione, il mondo lì sembra fatto al contrario.…
La geopolitica der paesello, la matita di Pelù e l’ecologia del seggio elettorale è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
La geopolitica der paesello, la matita di Pelù e l’ecologia del seggio elettorale
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Lorenzo. Leonardo Bianchi si è messo a scavare su pagine facebook semi-dormienti, Tipo “800.000 iscritti per Homer Simpson presidente del Consiglio”. Consiglio una rapida visione, il mondo lì sembra fatto al contrario.…
La geopolitica der paesello, la matita di Pelù e l’ecologia del seggio elettorale è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.
Prima decisione di secondo grado sull’assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro
I cittadini extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare hanno diritto — in applicazione del principio di parit…
Do you remember balkan route?
Un viaggio attraverso i confini dei Balcani, che descrive il paradosso dei muri costruiti dai governi, in una regione oggi frammentata ma…
Le parole della guerra
Una volta, era all’incirca il 1994, la mia amica B. mi telefonò quasi disperata. “Ma l’hai letto Bossi? L’hai sentito parlare Umberto Bossi?” Certo, B. “Voi non vi rendete conto del pericolo. Io lo ascolto e sento la voce di Radovan Karadzic. Questo è un linguaggio da guerra civile” B.la conosceva bene, la guerra civile.Read more
Camerun — Status di rifugiato alla richiedente asilo vittima di violenza domestica in quanto donna
Si ringrazia l’Avv. Giovanna Stella per la segnalazione.
Gambia. Protezione umanitaria riconosciuto il positivo e consistente percorso di integrazione.
Si ringrazia l’avv, Elisa Elia per la segnalazione
Dell’ ordinanza vanno sottolineati alcuni passaggi:
…come chiarito dalla suprema Corte…
Il 7° Congresso di Fatah: svolgimento, conclusioni e discorso di Mahmoud Abbas
mcc43 Il 7° Congresso di Fatah si è chiuso il 3 dicembre. Ricostruzione dei lavori e conclusioni. Punti principali: -Obiettivi del 7° Congresso -Composizione dell’Assemblea, polemiche -Mahmoud Abbas: reincarico e discorso (Balfour, Oslo, Israele, Hamas, Trump) -Elezione Comitato Centrale e Consiglio Rivoluzionario -Chiusura e commenti Sul percorso preparatorio del 7° Congresso vedere: Palestina prepara […]![]()
Il 7° Congresso di Fatah: svolgimento, conclusioni e discorso di Mahmoud Abbas
mcc43 Il 7° Congresso di Fatah si è chiuso il 3 dicembre. Ricostruzione dei lavori e conclusioni. Punti principali: -Obiettivi del 7° Congresso -Composizione dell’Assemblea, polemiche -Mahmoud Abbas: reincarico e discorso (Balfour, Oslo, Israele, Hamas, Trump) -Elezione Comitato Centrale e Consiglio Rivoluzionario -Chiusura e commenti Sul percorso preparatorio del 7° Congresso vedere: Palestina prepara […]![]()
Il 7° Congresso di Fatah: svolgimento, conclusioni e discorso di Mahmoud Abbas
mcc43 Il 7° Congresso di Fatah si è chiuso il 3 dicembre. Ricostruzione dei lavori e conclusioni. Punti principali: -Obiettivi del 7° Congresso -Composizione dell’Assemblea, polemiche -Mahmoud Abbas: reincarico e discorso (Balfour, Oslo, Israele, Hamas, Trump) -Elezione Comitato Centrale e Consiglio Rivoluzionario -Chiusura e commenti Sul percorso preparatorio del 7° Congresso vedere: Palestina prepara […]![]()
Il 7° Congresso di Fatah: svolgimento, conclusioni e discorso di Mahmoud Abbas
mcc43 Il 7° Congresso di Fatah si è chiuso il 3 dicembre. Ricostruzione dei lavori e conclusioni. Punti principali: -Obiettivi del 7° Congresso -Composizione dell’Assemblea, polemiche -Mahmoud Abbas: reincarico e discorso (Balfour, Oslo, Israele, Hamas, Trump) -Elezione Comitato Centrale e Consiglio Rivoluzionario -Chiusura e commenti Sul percorso preparatorio del 7° Congresso vedere: Palestina prepara […]![]()
Il 7° Congresso di Fatah: svolgimento, conclusioni e discorso di Mahmoud Abbas
mcc43 Il 7° Congresso di Fatah si è chiuso il 3 dicembre. Ricostruzione dei lavori e conclusioni. Punti principali: -Obiettivi del 7° Congresso -Composizione dell’Assemblea, polemiche -Mahmoud Abbas: reincarico e discorso (Balfour, Oslo, Israele, Hamas, Trump) -Elezione Comitato Centrale e Consiglio Rivoluzionario -Chiusura e commenti Sul percorso preparatorio del 7° Congresso vedere: Palestina prepara […]![]()
Marocco – Solidarietà al movimento studentesco, per la libertà di organizzazione nelle università
Il governo marocchino ha dichiarato l’intenzione di confiscare la sede storica dell’Unione Nazionale degli Studenti Marocchini, conosciuta come UNEM dall’acronimo francese. La sede sarà poi trasferita al Ministero della Gioventù e delle Finanze. L’UNEM è stata fondata il 26 dicembre 1956 ed è stata storicamente il centro del dissenso studentesco a sinistra, tanto è vero che il regime l’ha bandita […]
Marocco – Solidarietà al movimento studentesco, per la libertà di organizzazione nelle università
Il governo marocchino ha dichiarato l’intenzione di confiscare la sede storica dell’Unione Nazionale degli Studenti Marocchini, conosciuta come UNEM dall’acronimo francese. La sede sarà poi trasferita al Ministero della Gioventù e delle Finanze. L’UNEM è stata fondata il 26 dicembre 1956 ed è stata storicamente il centro del dissenso studentesco a sinistra, tanto è vero che il regime l’ha bandita […]
Marocco – Solidarietà al movimento studentesco, per la libertà di organizzazione nelle università
Il governo marocchino ha dichiarato l’intenzione di confiscare la sede storica dell’Unione Nazionale degli Studenti Marocchini, conosciuta come UNEM dall’acronimo francese. La sede sarà poi trasferita al Ministero della Gioventù e delle Finanze. L’UNEM è stata fondata il 26 dicembre 1956 ed è stata storicamente il centro del dissenso studentesco a sinistra, tanto è vero che il regime l’ha bandita […]
Marocco – Solidarietà al movimento studentesco, per la libertà di organizzazione nelle università
Il governo marocchino ha dichiarato l’intenzione di confiscare la sede storica dell’Unione Nazionale degli Studenti Marocchini, conosciuta come UNEM dall’acronimo francese. La sede sarà poi trasferita al Ministero della Gioventù e delle Finanze. L’UNEM è stata fondata il 26 dicembre 1956 ed è stata storicamente il centro del dissenso studentesco a sinistra, tanto è vero che il regime l’ha bandita […]
Marocco – Solidarietà al movimento studentesco, per la libertà di organizzazione nelle università
Il governo marocchino ha dichiarato l’intenzione di confiscare la sede storica dell’Unione Nazionale degli Studenti Marocchini, conosciuta come UNEM dall’acronimo francese. La sede sarà poi trasferita al Ministero della Gioventù e delle Finanze. L’UNEM è stata fondata il 26 dicembre 1956 ed è stata storicamente il centro del dissenso studentesco a sinistra, tanto è vero che il regime l’ha bandita […]
È necessario che i Paesi dell’OPEC diversifichino la loro economia
L’OPEC sta riuscendo a convincere i Paesi membri e non solo a diminuire la produzione di petrolio per far aumentare i guadagni, proponendo però una soluzione che non sembra sostenibile sul lungo termine
L’articolo È necessario che i Paesi dell’OPEC diversifichino la loro economia sembra essere il primo su Arabpress.
È necessario che i Paesi dell’OPEC diversifichino la loro economia
L’OPEC sta riuscendo a convincere i Paesi membri e non solo a diminuire la produzione di petrolio per far aumentare i guadagni, proponendo però una soluzione che non sembra sostenibile sul lungo termine
L’articolo È necessario che i Paesi dell’OPEC diversifichino la loro economia sembra essere il primo su Arabpress.
Si ringrazia l’Avv.
Si segnala una interessante ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila, pubblicata il giorno 11.11.16, che ha riconosciuto la protezione…
Senegal. Protezione sussidiaria per il clima di generale violenza nella regione del Casamance
Si ringrazia l’Avv. Elisa Elia per la segnalazione.
Torino — Convegno internazionale “Desaparecidos e migranti nel Mediterraneo e nelle Americhe”
Lunedì 12 dicembre 2016 il Palazzo del Rettorato a Torino ospiterà il convegno “Desaparecidos e migranti nel Mediterraneo e nelle Americhe…
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Donne in guerra. Oltre il D.a.e.sh. Come le donne dell’Islam rispondono alle violenze
Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve
Ieri sera alla American University of Kuwait è stato assegnato il Premio letterario Multaqa per il racconto breve arabo, alla sua prima edizione, e lo ha vinto uno scrittore un po’ speciale: è il palestinese di cittadinanza islandese Mazen Maarouf, per la sua raccolta Barzellette per i miliziani, pubblicata dall’editore libanese Riad al-Rayyes. Poeta dallo … Continua a leggere Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve →![]()
Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve
Ieri sera alla American University of Kuwait è stato assegnato il Premio letterario Multaqa per il racconto breve arabo, alla sua prima edizione, e lo ha vinto uno scrittore un po’ speciale: è il palestinese di cittadinanza islandese Mazen Maarouf, per la sua raccolta Barzellette per i miliziani, pubblicata dall’editore libanese Riad al-Rayyes. Poeta dallo … Continua a leggere Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve →![]()
Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve
Ieri sera alla American University of Kuwait è stato assegnato il Premio letterario Multaqa per il racconto breve arabo, alla sua prima edizione, e lo ha vinto uno scrittore un po’ speciale: è il palestinese di cittadinanza islandese Mazen Maarouf, per la sua raccolta Barzellette per i miliziani, pubblicata dall’editore libanese Riad al-Rayyes. Poeta dallo … Continua a leggere Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve →![]()
Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve
Ieri sera alla American University of Kuwait è stato assegnato il Premio letterario Multaqa per il racconto breve arabo, alla sua prima edizione, e lo ha vinto uno scrittore un po’ speciale: è il palestinese di cittadinanza islandese Mazen Maarouf, per la sua raccolta Barzellette per i miliziani, pubblicata dall’editore libanese Riad al-Rayyes. Poeta dallo … Continua a leggere Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve →![]()
Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve
Ieri sera alla American University of Kuwait è stato assegnato il Premio letterario Multaqa per il racconto breve arabo, alla sua prima edizione, e lo ha vinto uno scrittore un po’ speciale: è il palestinese di cittadinanza islandese Mazen Maarouf, per la sua raccolta Barzellette per i miliziani, pubblicata dall’editore libanese Riad al-Rayyes. Poeta dallo … Continua a leggere Lo scrittore palestinese Mazen Maarouf vince il premio Multaqa del Kuwait per il racconto breve →![]()
Pezzi di Siria in una libreria di Istanbul
Samer al-Kadri and Gulnar Hajou hanno avviato il progetto della libreria “Pagine” per ricordare ai rifugiati le bellezze della Siria
L’articolo Pezzi di Siria in una libreria di Istanbul sembra essere il primo su Arabpress.
Pezzi di Siria in una libreria di Istanbul
Samer al-Kadri and Gulnar Hajou hanno avviato il progetto della libreria “Pagine” per ricordare ai rifugiati le bellezze della Siria
L’articolo Pezzi di Siria in una libreria di Istanbul sembra essere il primo su Arabpress.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
La Lega algerina per la difesa dei diritti umani (LADDH) ha denunciato venerdì 2 dicembre gli…
In un comunicato pubblicato sul suo sito web, la ONG ha accusato le autorità algerine di “violazione” delle norme internazionali che…
Le donne rifugiate vogliono un posto sicuro
Quando vediamo in televisione le immagini di persone recuperate dal mare, o che provano ad attraversare a piedi un confine, o che tengono i…
Rapporti Iran-USA: tra sanzioni ed egemonia nel Golfo
I congresso degli Stati Uniti potrebbe prolungare le sanzioni sull’Iran, che di rimando si accinge ad estendere il suo controllo sullo Stretto di Hormuz
L’articolo Rapporti Iran-USA: tra sanzioni ed egemonia nel Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Rapporti Iran-USA: tra sanzioni ed egemonia nel Golfo
I congresso degli Stati Uniti potrebbe prolungare le sanzioni sull’Iran, che di rimando si accinge ad estendere il suo controllo sullo Stretto di Hormuz
L’articolo Rapporti Iran-USA: tra sanzioni ed egemonia nel Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Muros no Puentes sì! Si conclude la Carovana centroamericana delle madri dei Migranti Scomparsi
La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos (Buscando vida en caminos de muerte), partita il 15 novembre di quest’anno dalla città di…
Shatila refugees camp
1949.
13 aprile 1975.
16–18 settembre 1982.
Queste sono tre date fondamentali per Shatila, tre date difficili da dimenticare e che…
I lager ai tempi della biopolitica
Israele, Russia e Iran: fratelli-nemici!
Chi c’è dietro gli ultimi attacchi in Siria?
L’articolo Israele, Russia e Iran: fratelli-nemici! sembra essere il primo su Arabpress.
Israele, Russia e Iran: fratelli-nemici!
Chi c’è dietro gli ultimi attacchi in Siria?
L’articolo Israele, Russia e Iran: fratelli-nemici! sembra essere il primo su Arabpress.
Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha
Chiudono il tour delle fiere del libro arabe quest’anno la Fiera di Beirut (1 – 14 dicembre) e quella di Doha in Qatar (30 novembre – 10 dicembre). La Fiera di Beirut, giunta alla sua 60° edizione, è una delle più “vecchie” fiere arabe del libro, nonché una delle più prestigiose in termini di editori … Continua a leggere Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha →![]()
Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha
Chiudono il tour delle fiere del libro arabe quest’anno la Fiera di Beirut (1 – 14 dicembre) e quella di Doha in Qatar (30 novembre – 10 dicembre). La Fiera di Beirut, giunta alla sua 60° edizione, è una delle più “vecchie” fiere arabe del libro, nonché una delle più prestigiose in termini di editori … Continua a leggere Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha →![]()
Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha
Chiudono il tour delle fiere del libro arabe quest’anno la Fiera di Beirut (1 – 14 dicembre) e quella di Doha in Qatar (30 novembre – 10 dicembre). La Fiera di Beirut, giunta alla sua 60° edizione, è una delle più “vecchie” fiere arabe del libro, nonché una delle più prestigiose in termini di editori … Continua a leggere Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha →![]()
Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha
Chiudono il tour delle fiere del libro arabe quest’anno la Fiera di Beirut (1 – 14 dicembre) e quella di Doha in Qatar (30 novembre – 10 dicembre). La Fiera di Beirut, giunta alla sua 60° edizione, è una delle più “vecchie” fiere arabe del libro, nonché una delle più prestigiose in termini di editori … Continua a leggere Al via la 60° Fiera del libro di Beirut e la 27° Fiera del libro di Doha →![]()
Migranti anche nell’hotspot di Taranto trattamenti inumani e degradanti
Varco nord del porto di Taranto, una grossa nave ferma al quarto sporgente, le gru, i nastri trasportatori carichi di minerale in movimento…
Mobilitazione MSF: basta bombe su civili e ospedali — Solidarietà alla popolazione siriana
Da più di cinque anni la Siria è intrappolata nella morsa di un terribile conflitto che non risparmia nessuno.
Verità e giustizia per le vittime del naufragio del 18 aprile 2015 in Sicilia rimanga la memoria
Da anni denunciamo le tragiche conseguenze delle leggi liberticide dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, che, impedendo canali d…
Costa libica: meno navi di soccorso più persone a rischio. Gli effetti dei nuovi accordi
Ripiegamento delle navi umanitarie dopo il rafforzamento dei rapporti tra EUNAVFOR MED e Guardia Costiera libica.
Russia: l’intermediario tra Turchia e Siria
L’affievolirsi dei toni della Turchia nei confronti di Damasco dimostra che la Russia tiene a bada i due Stati in conflitto
L’articolo Russia: l’intermediario tra Turchia e Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Taranto — Iniziativa #nohotspot. Né qui né altrove
Il presidio della mattinata odierna davanti all’ingresso dell’hotspot di Taranto restituisce sensazioni contraddittorie.
Yemen: Ali Abdullah Saleh non se n’è andato
Gli Houthi annunciano la creazione di un governo di “salvezza nazionale”, frutto di un processo innescatosi già da tempo
L’articolo Yemen: Ali Abdullah Saleh non se n’è andato sembra essere il primo su Arabpress.
Verona — Protesta dei rifugiati eritrei: la relocation non funziona
di Jacopo Rui
“Verona, scoppia il caso profughi”, intitola il giornale L’Arena in merito ai fatti accaduti lo scorso 29 novembre sulla…
Accoglienza o esclusione?
Più o meno a bassa voce, ma con sempre maggiore insistenza, da più parti si incomincia a dire che il sistema di accoglienza italiano ed…
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Speciale cucina: burbarah, il dolce di Santa Barbara
L’Eid al-Burbarah (Santa Barbara, 4 dicembre) viene celebrato dai cristiani di diversi Paesi del Medio Oriente, quali Palestina, Giordania, Siria e Libano. Per l’occasione, viene preparato un dolce a base di grano cotto, cereali e frutta secca. Scopriamo come preparare la burbarah! Ingredienti: 500g di grano decorticato 500g di uva passa 500g di albicocche secche 2 cucchiaini di […]
L’articolo Speciale cucina: burbarah, il dolce di Santa Barbara sembra essere il primo su Arabpress.
Iraq: legalizzate le milizie sciite, il settarismo si infiamma
L’Iraq rischia di diventare un’altra Libia, gestita da milizie con ambizioni, interessi e alleanze contrastanti e con un senso di legittimità e di impunità conferitogli dal loro grande contributo nel fronteggiare Daesh su richiesta di un governo debole
L’articolo Iraq: legalizzate le milizie sciite, il settarismo si infiamma sembra essere il primo su Arabpress.
Migranti in transito a Roma: compiuto un primo passo la soluzione ancora non c’e’
Roma, 2 dicembre 2016 — Dopo i due incontri dell’ultima settimana tra le associazioni impegnate sul campo e l’assessore Baldassarre, un…
Analisi politica: Hamas e il 7° congresso di Al-Fatah
Di Mohsen M. Saleh. Middle East Monitor (01/12/2016). Traduzione e sintesi di Irene Capiferri. Dalle dichiarazioni rassicuranti dei suoi leader, sembra che Hamas non voglia ostacolare il 7° congresso di al-Fatah di fine novembre. Ha affermato di non voler interferire, né supportare alcun partito contro gli altri all’interno del movimento, e che non impedirà ai membri […]
L’articolo Analisi politica: Hamas e il 7° congresso di Al-Fatah sembra essere il primo su Arabpress.
La conquista di Mosul. Attori, scenari e prospettive
Un mese fa ho assistito ai lavori del gruppo speciale per il Mediterraneo (GSM) dell’Assemblea parlamentare della NATO nella bellissima sala di Montecitorio. In questa occasione il generale Graziano, capo di stato maggiore della difesa italiano e Brett McGurk,… Continue Reading →![]()
Arrivederci!
SiriaLibano volta pagina. Ma prima di farlo vuole ringraziare tutti i suoi lettori. E tutti coloro che dal 2010 a oggi hanno contribuito a vari livelli e in vari modi […]
Arrivederci!
SiriaLibano volta pagina. Ma prima di farlo vuole ringraziare tutti i suoi lettori. E tutti coloro che dal 2010 a oggi hanno contribuito a vari livelli e in vari modi […]
Arrivederci!
SiriaLibano volta pagina. Ma prima di farlo vuole ringraziare tutti i suoi lettori. E tutti coloro che dal 2010 a oggi hanno contribuito a vari livelli e in vari modi […]
Arrivederci!
SiriaLibano volta pagina. Ma prima di farlo vuole ringraziare tutti i suoi lettori. E tutti coloro che dal 2010 a oggi hanno contribuito a vari livelli e in vari modi […]
Mani e terra nel silenzio di Rosarno
5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress
Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…
Consiglio di lettura: “L’amante palestinese” di Sélim Nassib
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di lettura: “L’amante palestinese” di Sélim Nassib sembra essere il primo su Arabpress.
Ora in Tunisia abbiamo l’occasione per dire la verità e perdonare
Le testimonianze presso la Commissione Dignità e Giustizia tunisina portano indietro di 30 anni Amel Agrebi: suo marito in carcere sotto tortura e lei che mantiene la famiglia
L’articolo Ora in Tunisia abbiamo l’occasione per dire la verità e perdonare sembra essere il primo su Arabpress.
Rapporto ONU: una nuova primavera araba in arrivo
(Middle East Eye). Secondo il Rapporto sullo Sviluppo Arabo, pubblicato dalle Nazioni Unite, il Medio Oriente potrebbe vedere una nuova “primavera araba”. Secondo il rapporto, i governi arabi dovrebbero cogliere la “storica occasione” offerta da una nuova generazione di giovani altamente istruiti, mettendo però in guardia dal fatto che, se questi giovani non vengono aiutati […]
L’articolo Rapporto ONU: una nuova primavera araba in arrivo sembra essere il primo su Arabpress.
Giovani invisibili
Nelle pieghe delle guerre per procura in corso nella regione araba, nelle pieghe delle dittature per procura, qualcuno si chiede che cosa facciano e pensino i giovani. Li avevamo abbandonati, dopo il 2011. Sovraesposti durante i primi mesi delle rivolu…