La firma del protocollo in una foto del DailyStar di DaccaBangladesh e Myanmar firmano un protocollo per il rientro della minoranza. Ma senza una data. Il controesodo dovrebbe iniziare entro la fine di gennaioC’è un accordo tra Bangladesh e Myanmar per…
Categoria: Great Game
Viaggio all’Eden e Califfo a Mendrisio sabato 25 novembre
Apartheid, un nuovo termine per i rohingya
Si chiama “In gabbia senza un tetto” l’ultimo rapporto di Amnesty International sui Rohingya, la minoranza musulmana cacciata dal Myanmar nell’esodo forzato più recente della Storia da un Paese non in conflitto. E aggiunge una nuova parola a un vocabolario dove si è letto di stupri, eccidi, violenze, incendi, disastri umanitari, genocidio e pulizia etnica: apartheid. Questa volta Amnesty, che lavorava al caso da due anni, documenta infatti la condizione interna dei rohingya in Myanmar, dove fino a qualche mese fa viveva poco più di un milione di questa minoranza ora ridotta drasticamente a meno della metà (oltre centomila vivono in campi profughi nel Paese mentre 600mila sono stati espulsi). Chi vive in Myanmar era ed è intrappolato «in un sistema vizioso di discriminazione istituzionalizzata sponsorizzata dallo Stato che equivale all’apartheid». Il rapporto (in italiano sul sitowww.amnesty.it) disegna il contesto della recente ondata di violenze, quando le forze di sicurezza hanno incendiato interi villaggi e hanno costretto centinaia di migliaia di rohingya a fuggire verso il Bangladesh. Molti, non si sa quanti, sono stati uccisi o sono morti cercando di attraversare la frontiera.
Fa un salto in avanti la condanna che per ora ha visto soprattutto la società civile impegnata in un’operazione di denuncia (Amnesty, Human Rights Watch, il Tribunale permanente dei popoli e diverse Ong come Msf ad esempio) con le Nazioni Unite (molte le prese di posizione e le denunce) ma, per il momento, non si sono viste forti pressioni internazionali anche se, nel suo recente viaggio in Myanmar, l’Alto commissario Federica Mogherini non è stata tenera con Aung San Suu Kyi. Nondimeno per ora, l’Unione europea si è limitata a confermare il divieto alla vendita di armi e ha riattivato il meccanismo (soppresso quando i militari hanno ceduto il potere) che vieta agli alti gradi dell’esercito birmano di venire nel Vecchio Continente. Poco o nulla ha invece fatto il Consiglio di sicurezza, come se la questione riguardasse semplicemente i rapporti tra Myanmar e Bangladesh.
 |
| La foto è tratta dal sito di Amnesty Italia |
Il rapporto di Amnesty dice chiaramente che il Myanmar ha confinato i rohingya in un’esistenza ghettizzata dove è difficilissimo avere accesso a istruzione e cure mediche in un quadro di esodo forzato dalle proprie case. Questa situazione – secondo Ai – corrisponde da ogni punto di vista alla definizione giuridica di apartheid, «un crimine contro l’umanità». «Questo sistema appare destinato a rendere la vita dei rohingya umiliante e priva di speranza – dice in una nota Anna Neistat, direttrice di Amnesty per le ricerche – e la brutale campagna di pulizia etnica portata avanti dalle forze di sicurezza del Myanmar negli ultimi tre mesi è l’ennesima, estrema dimostrazione di questo atteggiamento agghiacciante. Le cause di fondo della crisi in corso devono essere affrontate per rendere possibile il ritorno dei rohingya a una situazione in cui i loro diritti e la loro dignità siano rispettati». Difficile, anche perché, dice il rapporto, i rohingya vivono esclusi da qualsiasi contatto col mondo esterno.
Sebbene i rohingya subiscano da decenni una sistematica discriminazione promossa dal governo, la ricerca rivela come la repressione sia aumentata drammaticamente dal 2012, quando la violenza tra la comunità musulmana e quella buddista ha sconvolto lo stato di Rakhine. Queste limitazioni sono contenute in una serie di leggi nazionali, “ordinanze locali” e politiche attuate da funzionari statali che mostrano un’evidente attitudine razzista. Un regolamento in vigore nello stato di Rakhine dice chiaramente che gli “stranieri” e le “razze bengalesi” (un’espressione dispregiativa usata per indicare i rohingya) hanno bisogno di un permesso speciale per spostarsi da un luogo a un altro.
Durante la violenza del 2012, decine di migliaia di rohingya vennero espulsi dalle zone urbane dello stato di Rakhine, in particolare dalla capitale Sittwe. Attualmente 4000 di loro restano – dice ancora Ai – in città, in una sorta di ghetto isolato, circondato dal filo spinato e sorvegliato da posti di blocco, e rischiano costantemente di essere arrestati o aggrediti dalle comunità che li circondano.
The roof is gone: esplosioni ed evasioni letterarie
 |
| Roberta Mazzanti* |
Pubblico qui il contributo di Roberta Mazzanti, una cara e vecchia amica, al Convegno “Abitare, corpi, spazi, scritture” che si è tenuto a Roma a metà Novembre organizzato dalla Società italiana delle letterate. In cui si parla anche di Viaggio all’Eden
 |
| Grace Slick |
 Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10
Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10Se l’islamista sequestra la capitale
 |
| Lo svincolo della discordia: unisce Islamabad a Pindi |
Lo svincolo di Faizabad è la porta principale tra le due città pachistane di Islamabad, la capitale
amministrativa del Pakistan col suo milione di abitanti, e Rawalpindi, uno snodo commerciale importante del Punjab con oltre tre milioni di residenti. Bloccarlo con un sit-in, come ormai avviene da tre settimane, vuol dire creare un caos che divide le due città gemelle su un’importante arteria che collega la capitale all’aeroporto. A sequestrare lo svincolo è un manipolo di qualche centinaio di radicali che chiedono la testa del ministro Zahid Hamid, considerato dagli zeloti di alcune formazioni islamiste alla stregua di un apostata. Il caso, innescato dalla protesta degli islamisti, è un emendamento apportato alla legge che regola le candidature in vista delle prossime elezioni generali che si terranno in Pakistan l’anno prossimo.
L’emendamento, che riguarda l’atteggiamento del candidato verso il messaggio del Profeta Maometto, ha sostituito con la locuzione “I belief” (credo) la precedente “I solemnly swear” (giuro solennemente). La nuova viene considerata assai meno forte e rispettosa dell’originaria e una porta aperta a credenti troppo tiepidi. Nel formulario per candidarsi, secondo gli ulema radicali, chi si dichiara musulmano (se non lo è viene aggiunto in una lista apposita) lo deve fare in una forma solenne e non con una semplice professione di fede. Cavilli da dottori della legge e, secondo alcuni, un modo per preparare la campagna elettorale. Ma sufficienti a scatenare una bufera.
 |
| Zeloti: un momento del raduno che va avanti da un mese pubblicato da Pakistan Today A destra sotto un’immagine del posto |
La legge è stata rapidamente emendata dall’emendamento ed è tornata alla formula originaria, un cedimento che laici e progressisti non hanno visto di buon occhio. Ma gli ulema non mollano e continuano a chiedere che il ministro si dimetta altrimenti il blocco continuerà. Quel che è peggio è che, in un Paese dove le manifestazioni politiche o di rivendicazione sindacale vengono messe sotto schiaffo dalla polizia per molto meno, nessuno ha osato sgomberare manifestanti noti per le loro dichiarazioni al vetriolo. All’Alta corte di Islamabad però non l’hanno digerita e hanno chiamato il ministro dell’Interno a rendere conto dello stallo. Così, il ministro Ahsan Iqbal, d’accordo con i magistrati, ha reso nota l’ultima data utile per lo sgombero: giovedi 23 novembre, ma senza che si capisca cosa accadrà se gli islamisti delle tre formazioni (Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat, Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, Sunni Tehreek Pakistan) insisteranno.
 La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro
La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro
emendamento che cancellava l’ipotesi che un uomo condannato all’interdizione dai pubblici uffici potesse capeggiare un partito politico: un modo per riaprire la porta a Nawaz Sharif, l’ex premier costretto a lasciare in luglio su ordine della Corte suprema per via dello scandalo che lo vede implicato in transazioni poco ortodosse (Panama Papers). Ma sulle prime pagine campeggiano gli zeloti e ora ci si chiede cosa potrà accadere il 23 novembre se gli islamisti non molleranno.
Una campagna per avere Abiti Puliti
 Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.
Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.
Perché?
Perché
In alcune fabbriche che producono per grandi marchi le operaie sono arrivate a dover indossare gli assorbenti per non assentarsi neppure per andare in bagno.
Più di 500 operaie sono svenute in un anno in alcune fabbriche Cambogiane che producono per notissimi marchi della moda e dello sport. Esauste e malnutrite l avoravano con almeno 37 gradi , senza neppure un ventilatore.
Le fabbriche del Bangladesh dove vengono cuciti i tuoi jeans, sono palazzi di molti piani con centinaia di operaie e dove le uscite di sicurezza sono spesso assenti o bloccate.
Un’operaia albanese deve lavorare un’ora intera per poter comprare un litro di latte , mentre a un’operaia inglese bastano 4 minuti di lavoro…
Fai una donazione qui
Il Bangladesh alle porte di casa
 |
| L’Europa dello sfruttamento: l‘ultimo rapporto della Campagna Abiti puliti |
Il Made in Europe della moda anche italiana investe e delocalizza in Europa Orientale. Ma il conto lo paga chi lavora
In Serbia, alle porte di casa nostra, la “soglia di povertà” per una famiglia di quattro persone viene calcolata a 256 euro. Ma il salario medio netto di un lavoratore dell’industria del cuoio e delle calzature arriva a 227 e a soli 218 nell’industria dell’abbigliamento. Se poi viene applicato il salario minimo legale netto, siamo a 189 euro. E’ la politica di incentivi che Belgrado ha deciso di applicare a diversi settori industriali per rilanciare l’economia e attirare investimenti. Regali alle aziende straniere, tra cui molte italiane, formalmente pagati dallo Stato ma di fatto dai lavoratori. Qualche nome? Armani, Burberry, Calzedonia, Decathlon, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Golden Lady, Gucci, H&M, Inditex/Zara, Louis Vuitton/LVMH, Next, Mango, Max Mara, Marks & Spender, Prada, s’Oliver, Schiesser, Schöffel, Top Shop, Tesco, Tommy Hilfiger/PVH, Versace. E ancora Benetton, Esprit, Geox e Vero Moda. Solo questione di soldi?
Nel luglio scorso la stampa locale riferiva di lavoratrici costrette a indossare gli assorbenti per evitare di interrompere il lavoro per andare in bagno. L’episodio era riferito alla fabbrica Technic Development Ltd di Vranje, società controllata di Geox, marchio italiano di abbigliamento per uomo, donna e bambino, noto per le scarpe “traspiranti”. La denuncia è costata il lavoro a Gordana Krstic, eppure quella storia non ha trovato eco sulla stampa italiana, un po’ distratta sulle questioni del lavoro delocalizzato. Ma non siamo in Bangladesh o in Cambogia e la fabbrica in questione occupa 1400 operai. Con salari netti medi (compresi straordinari e indennità) di 248 euro, meno della soglia di povertà. Straordinari che arrivano anche a 32 ore settimanali contro le 8 ammesse dalla legge. Sono i conti della moda.
Se sappiamo queste cose è perché un gruppo di attivisti della Clean Clothes Campaign (in Italia Abiti puliti) ha appena pubblicato un rapporto sui salari e le dure condizioni di lavoro nell’industria tessile e calzaturiera dell’Est e Sud-Est Europa. Non solo Serbia: in Ucraina, nonostante gli straordinari, alcuni lavoratori guadagnano appena 89 euro al mese in un Paese in cui il salario dignitoso dovrebbe essere di oltre 400. E anche se in in Slovacchia si arriva a 374 euro siamo sempre sulla soglia del salario minimo legale, quello – per intendersi – che non serve a mantenere una famiglia e forse nemmeno una persona. Anche tra i clienti di queste fabbriche ci sono marchi globali come Benetton, Esprit, Geox, Triumph e Vera Moda.
Più di 1,7 milioni di persone lavorano nell’industria dell’abbigliamento/calzature in Europa centrale, orientale e sud-orientale e spesso la differenza tra i salari reali e il costo della vita è drammatica in una situazione in cui – dice il rapporto L’Europa dello sfruttamento – l’attuazione della legislazione sul lavoro è “fallimentare”, con un impatto negativo sulla vita di chi, più o meno direttamente, cuce i nostri vestiti e le nostre scarpe. Per questi marchi, dice il rapporto, i Paesi dell’Europa Orientale sono paradisi per i bassi salari. E anche se molte firme della moda enfatizzano l’appartenenza al Made in Europe, cioè con condizioni di lavoro eque, molti lavoratori “vivono in povertà, affrontano condizioni di lavoro pericolose, straordinari forzati, indebitamento”. I salari minimi legali in questi Paesi sono attualmente al di sotto delle loro rispettive soglie di povertà e dei livelli di sussistenza. Le conseguenze, dice la Campagna, “sono terribili. I salari bastano appena per pagare le bollette elettriche, dell’acqua e del riscaldamento in Paesi dove ai marchi che investono vengono praticati grossi sconti proprio sulle utenze. Per loro le pagan gli operai.
Il Califfo a BookCity
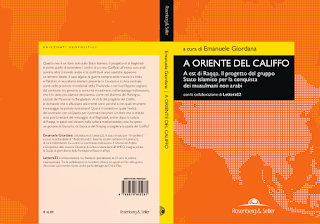 Autori Vari (Lettera22)
Autori Vari (Lettera22)
A cura di E. Giordana
“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei
musulmani non arabi”
– Rosenberg & Sellier 2017
Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5
Emanuele Giordana con Massimo Campanini
Non è un libro solo sullo Stato Islamico.
Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i
confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il
mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno
ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e
Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia
centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel
Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità
musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà
musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei
rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del
progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il
messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale
l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.
Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-
Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti
dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di
Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Emanuele Giordana cofondatore di Lettera22, collaboratore de “il manifesto” e voce di “Radio3mondo”. Con altri redattori di Lettera22, ha scritto La scommessa indonesiana,
Diversi ma uguali, A Oriente del Profeta, Il Dio della guerra, Geopolitica dello tsunami e Tibet. Lotta e compassione sul tetto del mondo. Già docente di cultura indonesiana all’IsMEO, insegna alla
Scuola di giornalismo della Fondazione Basso e all’Ispi. È presidente dell’associazione Afgana.
Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25 anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno anche parte dell’agenzia China Files.
Viaggio all’Eden a BookCity
Il grande viaggio da Milano a Kathmandu ripercorso da un giornalista a distanza di 40 anni
Con Emanuele Giordana e Guido Corradi. A cura di Centro di Cultura Italia-Asia
Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il “grande viaggio” in India fatto da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Un sogno che portò migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa, fino ai templi della valle di Kathmandu.
DATA:
Venerdì, 17. Novembre 2017 – 15:00
SEDE:
MUDEC – Museo delle Culture Spazio delle Culture – via Tortona 56, Milano
RELATORI:
Emanuele Giordana
Guido Corradi
 |
| Illustrazione di Maurizio Sacchi |
Il Califfo e Viaggio all’Eden a BookCity
Emanuele Giordana
“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” – Laterza
con Guido Corradi
MUDEC Venerdi ore 15
Autori Vari (Lettera22)
“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei
musulmani non arabi”
– Rosenberg & Sellier
Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5
Emanuele Giordana con Massimo Campanini
Piccola pubblicità: perchè sostengo DINAMOpress
DINAMOpress è un progetto editoriale di informazione indipendente nato l’11 novembre 2012 dalla
cooperazione tra diversi spazi sociali di Roma, giornalisti professionisti, ricercatori universitari, video maker e attivisti. “Racconta e approfondisce – spiegano i suoi promotori – le questioni principali che riguardano il presente: politica locale e internazionale, precarietà e sfruttamento, femminismi, emergenze razziste e fasciste, forme di vita giovanili, produzioni culturali cinematografiche e musicali, migrazioni internazionali, problematiche ecologiche, cortei e mobilitazioni, beni comuni…”
Quello che viene presentato in questi giorni è il progetto di finanziamento alla luce del sole di un’iniziativa editoriale che ha lo scopo di allargare l’informazione su ciò che avviene. Può piacervi e anche non piacervi ma credo che vada sostenuta. Date un’occhiata al sito e poi se credete andate alla pagina dov’è spiegato il progetto e dove è possibile fare una donazione. Se posso aggiungere un pensiero, riguarda il fatto che oggi siamo bombardati da informazioni ma molto spesso di bassa qualità. Lasciamo stare le fake news, le bufale evidenti e le coglionate (al mondo c’è posto per tutti) ma quel che è da temere è la disinformazione: ben cucinata, professionalmente perfetta e apparentemente asettica. DinamoPress asettica non è. Professionale si. E’ una lampadina (o una dinamo se preferite) accesa nel buio dell’informazione mainstream. Anche 5 euro possono fare la differenza.
Allarme in mare
 Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.
Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.
In Indonesia, ad esempio, cui Al Jazeera (vedi il video qui sotto) dedicava ieri un reportage dal villaggio di Bahagia (che significa…felice) a Sumatra, uno dei tanti minacciati dal livello dei mare, l’innalzamento degli Oceani è un serio pericolo per un un Paese eminentemente insulare dove 42 milioni di abitazioni costiere corrono rischi enormi e non solo per la violenza di uno tsunami (come avvenne in modo gravissimo proprio a Sumatra nel dicembre del 2004). La storia non è nuova. Già due anni fa, nel dicembre del 2015, lo specialista per le politiche pubbliche del ministero indonesiano per la Marina e la Pesca, Achmad Purnomo, aveva lanciato l’allarme, ripreso dall’Agenzia nazionale di notizie Antara e dalla stampa locale. E quel dato, 42 milioni di abitazioni con l’aggiunta di 2mila isole, non è dunque una congettura di stampa ma la proiezione degli esperti del ministero. Con una data: 2050 per vedere sommerse migliaia di isole e la scomparsa di interi villaggi, molti dei quali sorgono su palafitte, le tradizionali rumah panggung.
Anche in questo caso, seppur in maniera indiretta, c’entra l’uomo. Gli esperti del ministero di Giacarta puntano il dito sui cambiamenti climatici che, non è una novità, stanno sciogliendo i ghiacciaia e facendo salire il livello delle acque. Il primissimo allarme fu lanciato per le Maldive, isole coralline che sfiorano la superficie marina. Ma 42 milioni di villaggi non sono uno scherzo: se nel piccolo arcipelago turistico vive poco meno di mezzo milione di abitanti, l’Indonesia di milioni di residenti ne conta 255, sparsi in gran parte sulle coste che si estendono per 80mila chilometri su circa 17mila isole.
Al ministero sono preoccupati perché il Paese non ha le risorse sufficienti (anche dal punto di vista della formazione dei quadri) per affrontare un’emergenza che, nel giro di meno di 35 anni, vedrà innalzarsi il livello delle acqua di 90 centimetri con effetti devastanti per molti villaggi costieri e per 2mila piccole isole a rischio di essere inghiottite dall’Oceano. Oltre a ciò, dicono al ministero, altri effetti del riscaldamento globale incidono sulle attività economiche di questi stessi villaggi: le sempre più incerte le stagioni della pesca e i cambiamenti negli schemi della migrazione ittica oltre a un crescente numero di pesci che sono stati uccisi dal fenomeno dello spiaggiamento: si arenano sulle spiagge dopo aver smarrito la via.
Gli indonesiani chiamano il loro Paese, il più vasto mondo insulare del pianeta proprietà di un singolo Stato, tanah air kita, la “nostra terra d’acque”. E in effetti di acqua ce n’è parecchia perché ufficialmente l’Indonesia si estende su un milione e 900mila kmq quadrati di suolo in gran parte circondato dal mare. Il fatto è che questo suolo è formato sia da grandi isole, sia da strisce di terra sino ad atolli che misurano solo qualche centinaio di metri quadri. Molte sono abitate e altre non conoscono l’intervento umano. Quante? Secondo una stima del 1969, il più vasto arcipelago del mondo ne conterebbe 17.508 ma è una stima appunto e non tutte le isole hanno uno status giuridico riconosciuto a livello internazionale. Di queste, inoltre, solo 13.466 hanno un nome. Adesso Giacarta si sta dando da fare per fare i conti definitivi sulla base di un criterio accettato in sede internazionale e sancito dalla Un Convention on the Law of the Sea, secondo la quale un’isola è una formazione naturale di territorio circondata dal mare e che non sparisce con l’alta marea. Se non sparirà per effetto dell’innalzamento delle acque.
Eravamo in centomila…
Eravamo in centomila, cantava Adriano Celentano nel 1967. Lui si riferiva allo stadio dove aveva visto una ragazza che gli piaceva. Ma questo è anche il bel ricordo dei generali della Nato e del Pentagono e, chissà, di Via XX Settembre. La voglia di stivali sul terreno cresce e la Nato annuncia che da 13.400 soldati passeremo a 14.400 circa. Che con i nuovi arrivi americani (3mila più 11mila già presenti) farà circa 30mila uomini. Non sono i quasi 150mila di una volta ma son pur sempre di più dei 15mila di qualche mese fa. Per fare che? La nebulosa dice che faremo assistenza tecnica ma questo termine vago preannuncia un lavoro in cui ci si sporcano le mani. Cambia la strategia però: bombe dal cielo, sempre di più, sempre più mirate (?), sempre più potenti, sempre meno segrete. Nell’indifferenza del mondo che guarda stupefatto ai deliri calcolati dei Kim, alla macelleria saudita, e all’America first di Trump – che si traduce in profitti per il comparto industrial militare – l’Afghanistan sta conoscendo una nuova escalation. In sordina. Ssssssssssssstttt. Che nessuno se ne accorga. Eravamo centomila e abbiam perso la guerra. Ci riproviamo in 30mila e poi vediamo.
Chi sono i Rohingya?
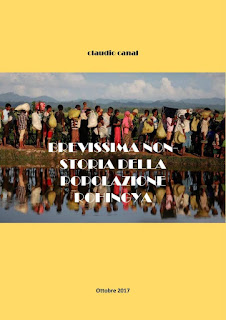 Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:
Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:
qui può essere sfogliata come un libretto
qui scorre come un pdf.
Dopo la Rivoluzione (d’ottobre)
C’era una volta la Rivoluzione d’Ottobre. E in occasione del centennale della rivoluzione russa, dal 7 al 10 novembre si terrà a Torino, nel Campus Luigi Einaudi, il convegno internazionale Dopo la Rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917, organizzato dall’associazione Memorial Italia e dall’Università degli Studi di Torino
Il tema del Convegno*
La rivoluzione russa: difficile dire quando è iniziata, quando è finita, e di cosa si è trattato. Il centennale dell’ottobre 1917 diventa occasione per rileggere i fatti di allora rispettandone la complessità e per osservarli con punti di vista differenti. Crisi, rivoluzioni e controrivoluzioni, ritorno all’ordine, caos, fame e violenze si intrecciarono per un lungo periodo, quantomeno dalla prima guerra mondiale agli anni ’50. Proprio per discutere e riflettere su aspetti significativi di questo periodo storico, l’associazione Memorial, che in Russia opera per la difesa dei diritti, e l’Università degli Studi di Torino organizzano il convegno internazionale Dopo la rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917 che si terrà a Torino, dal 7 al 10 novembre, nel Campus Luigi Einaudi. Non quindi una commemorazione, ma una riflessione con cent’anni di distacco dalla rivoluzione.
Il convegno è diviso in due parti. Nella prima si affrontano in modo del tutto innovativo gli eventi della rivoluzione; lo studio della guerra civile sul territorio dell’ex-Impero russo ci spiega quanto il paese fosse lontano dagli avvenimenti della rivoluzione: il partito, le discussioni rivoluzionarie, l’organizzazione politica operaia. Nelle periferie dell’Impero la rivoluzione arriva come crollo dello stato, bande armate, fame. La formazione dell’URSS poggia sulla riconquista militare del territorio, sull’imposizione di una dittatura militare-politica, sulla repressione di ogni istanza autonomista e di ogni richiesta di elezioni.
La seconda parte del convegno è dedicata alla sopravvivenza della cultura e al suo rapporto complesso con la rivoluzione. Interverranno studiosi italiani e stranieri, che esamineranno le conseguenze del 1917 da diversi punti di vista, complementari e variegati, a testimonianza della complessità e della varietà di suggestioni intellettuali e culturali del periodo.
Per approfondire questi temi e confrontarsi con studiosi italiani e stranieri appuntamento a Torino dal 7 al 10 novembre nel Campus Luigi Einaudi.
* Riproduco qui la scheda di invito
Avviso di reato
 |
| Fatou Bensouda. Sotto, Donald Trump |
«La situazione nella Repubblica Islamica d’Afghanistan è stata assegnata a una Camera preliminare della Corte Penale Internazionale (Icc) a seguito della mia decisione di chiedere l’autorizzazione ad avviare un’inchiesta sui reati che si suppone siano stati commessi in relazione al conflitto armato». La dichiarazione della procuratrice capo del Tribunale penale internazionale Fatou Bensouda rimbalza nelle agenzie di stampa nella notte di venerdi, giorno della partenza di Trump per il suo viaggio in Asia, il più lungo – recita la velina della Casa Bianca – che un presidente americano abbia fatto nell’ultima quarto di secolo. Ma Trump non andrà in Afghanistan e del resto la tegola era attesa da circa un anno: da quando, a metà novembre 2016, la giurista del Gambia a capo della Corte dal 2012, aveva annunciato nel suo Rapporto preliminare di attività (quel che in sostanza si intendeva fare) che il dito era puntato anche contro gli Stati Uniti per i quali c’erano «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che in Afghanistan avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Con loro, sotto la lente, polizia e 007 afgani e parte dei talebani. Ma adesso il passo è diventato formale e dunque esecutivo, con una richiesta di autorizzazione a procedere per le accuse di crimini di guerra in Afghanistan dopo l’invasione guidata dagli Usa 17 anni fa.
L’indagine, col mandato alla procura di sentire testimoni, interrogare vittime, avere accesso a informazioni riservate (almeno in teoria anche perché né gli Usa né i talebani riconoscono l’autorità dell’Icc), riguarda le attività della Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento talebano); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (Nds); militari e agenti americane. Il testo del rapporto preliminare diceva che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Cia, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram.
Se per i talebani (nella dichiarazione non si specifica se l’indagine riguarderà altre ali del
movimento diretto da mullah Akhundzada) le accuse di crimini di guerra non sono una novità, per Washington e Kabul la questione è seria, al netto della possibile collaborazione tra le due intelligence. Bensouda sostiene che durante gli interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citavano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania .
 |
| Il Nyt di ieri: 13 civili uccisi in un raid. Non si sa se gli “effetti collaterali” siano inclusi nelle indagini |
Probabilmente, nell’anno intercorso tra il rapporto preliminare e la richiesta formale di indagine, la procura deve averne esaminati assai di più e comunque già un anno fa si chiariva che i crimini presunti «non sono stati abusi di pochi individui isolati (ma)… commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… (con) una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli…». Quanto a polizia e intelligence afgani, la tortura sarebbe un fatto sistematico: tra il 35 e il 50% dei detenuti vi sarebbero stati sottoposti.
Adesso la procura deve convincere i giudici della Camera preliminare della fondatezza delle accuse. Poi toccherà ai magistrati dare l’ultimo via libera che, considerata l’ampiezza delle prove raccolte in un arco di tempo sufficiente a non correre rischi, pare scontata. Una volta terminato l’iter, toccherà allora alla procuratrice formulare le accuse e chiamare alla sbarra i responsabili. Sarà quello il momento più difficile ma sembra ormai solo questione di tempo.
Viaggio d’affari nel Rakhine
Il viaggio è a sorpresa. Lo annuncia il portavoce del governo mentre Aung San Suu Kyi è già a Sittwe, capitale dello stato birmano del Rakhine; da lì si muoverà verso Maungdaw e Buthiduang. Il comunicato è scarno e anche la Nobel, al comando del nuovo Myanmar democratico, non fa grandi concessioni. Le cronache dicono che parla con qualche abitante dei villaggi e probabilmente vuole tentare di rilanciare il suo piano per far rientrare quei 600mila rohingya che da agosto sono fuggiti oltre confine. Come non è chiaro e comunque nessun accenno alle responsabilità dell’esodo forzato più massiccio della storia recente da un Paese in pace. Invita la gente a “non litigare” e a rivolgersi al governo se ci sono problemi. Più che altro sfodera il blando rimedio dello sviluppo. Con lei, su un elicottero militare, scrive la Bbc, ha preso posto infatti anche uno dei più ricchi imprenditori birmani. E’ un viaggio in un cono d’ombra: la sua visita nel Rakhine avviene mentre il Tribunale Permanente dei popoli ha emesso la sua sentenza su quanto avviene nel Paese. Il documento è un pesante atto d’accusa per due gruppi a rischio: i Kachin e i Rohingya. Ma se nel caso dei Kachin, dice la sentenza dei giudici della società civile, si rileva un intento genocidario, nel caso dei Rohingya la responsabilità di atti di genocidio è chiara. Fatti, non intenti.
 E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).
E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).
Per ora le pressioni sul governo birmano sono relativamente poche e nei luoghi dove si decide – come il Consiglio di sicurezza dell’Onu – oltre alle prese di posizione e a qualche blanda misura, non si è andati. In un quadro che vede in difficoltà anche le agenzie umanitarie che non sempre hanno accesso alle zone dove si sono verificati – documenta il tribunale – stupri, incendi, esecuzioni. Anche la via di fuga è un problema: il Bangladesh, Paese già in difficoltà, non sa come far fronte all’esodo e vorrebbe anche rispedirli a casa, ma quale casa?
 |
| Il segretario dell’Onu Guteres. Sopra Aung San Suu Kyi. Al centro un manifesto storico del Tribunale dei popoli |
Il ritorno sembra impossibile. L’incontro promosso dalla Lega per la democrazia nei giorni scorsi – una preghiera interreligiosa di pace – non ha sollevato la questione rohingya è Suu Kyi gode di un enorme consenso che la giustifica. Tutti sanno per altro che le sue responsabilità sono relative e che il vero potere è saldamente in mano ai militari che devono averle concesso il contentino del viaggio. Quanto accade sul terreno però parla chiaro e riguarda, ancora una volta, la terra. Non dunque solo l’odio razziale o l’intolleranza religiosa. Da sabato i soldati hanno iniziato a supervisionare la raccolta del riso – dice la stampa locale – su un’area di circa 300 kmq dove viveva chi è fuggito. E non si tratta solo di qualche tonnellata di cereali: il ministro per lo Sviluppo sociale, soccorso e reinsediamento, Win Myat Aye, ha detto in settembre – riportava Simon Lewis di Reuters – che «Secondo la legge, la terra bruciata diventa terra gestita dal governo». Quindi vendibile e acquistabile. Terra bruciata appunto specie se il suo proprietario è all’estero.
Lo spettacolo del dolore
 A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).
A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).
Qui accanto vedete una delle immagini del servizio, forse la più gettonata (che mi fa piacere Internazionale non abbia scelto per la copertina). Vogliamo provare a commentarla? Immaginate di non sapere di cosa si parla: c’è l’acqua, una madre che indica l’infinito o la speranza, un padre col bimbo e una croce sullo sfondo. Un amico, cui l’ho mostrata decontestualizzata, mi ha detto “E’ un battesimo!” E’ rimasto male sapendo di chi si tratta: gente in fuga da omicidi, stupri, incendi… La foto in sé può piacere o non piacere (la scelta della luce, il bianco e nero, i ritocchi, il taglio etc) ma una foto difficilmente è “in sé”. C’è sempre un contesto a maggior ragione se si tratta di un reportage. Ma come lo si comunica?
Mario Dondero (il mio grande maestro che sulla fotografia mi ha insegnato tutto) è noto per aver (anche) detto che “fotografare la guerra a colori è immorale”. Kevin segue il suo consiglio perché, anche se non dichiarata, quella fatta ai rohingya è proprio una guerra. Ma tra lui e Mario c’è una differenza enorme. In questo reportage di Frayer c’è il dolore, il dramma, la speranza ma raffigurati come in una sorta di grande affresco in cui è più il fotografo a essere il protagonista che non i suoi soggetti. Di Mario Dondero si è detto che era un fotografo “senza uno stile”. E’ vero, perché il “suo stile” era quello di non apparire. Se guardate le sue foto sulla guerra, vi soffermate sempre sui soggetti non sulla bravura del fotografo. Nei suoi fotogrammi il fotografo proprio non c’è. Come se il fotoreporter fosse solo passato di li e avesse fatto…clic. Nella foto di Frayer c’è prima di tutto Frayer e poi, magari, anche i suoi soggetti. La sua presenza però, la presenza dell’autore, finisce col distrarvi: restate colpiti dalla sua bravura nel catturare le luci, dalla capacità di “scolpire” i volti, dalla forza delle espressioni come se lui avesse messo tutti in posa. Venite colpiti dallo spettacolo. Se poi è uno spettacolo del dolore (e non un battesimo), il dolore arriva dopo. Prima c’è lo spettacolo. Direi che questa è proprio una foto spettacolare. Tanto spettacolare che dolore, guerra, incendi e stupri restano sulla sfondo. Come quella croce che evidentemente non è una croce visto che siamo in territori del Budda o di Maometto.
 Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.
Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.
Insomma dopo tutta questa tirata e questa professione di modestia (chissà se poi io predico bene ma razzolo altrettanto) vorrei proporvi la foto qui sotto tratta dal bangladese Daily Star. Nella sua semplicità mi dice (guardate i piedi di questa ragazzina) più che abbastanza sul dramma di questa gente e mi commuove (dunque mi spinge a saperne di più). Non c’è compiacimento e nemmeno spettacolo. Anzi, apparentemente non c’è neppure dolore (anche se quei piedini nudi e segnati raccontano tutto). Il fotografo questa volta è talmente in disparte che, tanto per cambiare, non c’è neanche il credito della foto. Chi l’ha scattata è ingiustamente anonimo: è purtroppo il solito discorso per cui la maggior parte delle foto servono solo a occupare uno spazio in pagina. Il loro modesto autore scompare – come in questo caso – più di quanto avrebbe dovuto.
* Ecco a proposito a questo link fb uno dei rarissimi filmati sui Rohingya, realizzato a A. Ricucci e S. Bianchi per Tv7 (provate a scommettere a che ora è andato in onda…)
Ius soli birmano
 Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
La maggior parte delle volte le storie di confine sono drammatiche. Dove un cartografo disegna una frontiera, approfittando di un fiume, di una catena montuosa o semplicemente tracciando una linea retta su un territorio che la mappa geografica rende asettico, vivono persone e animali e si dipana la storia infinita della biodiversità. La geopolitica tiene poco in conto le persone (gli animali e la biodiversità) ed è semmai attenta alla proprietà (se è in mano a uomini potenti) o ai prodotti della terra, siano essi agricoli o fossili. Le vicende che in questi giorni hanno a che vedere con la fuga dal Myanmar verso il Bangladesh di 500mila rohingya, una minoranza musulmana che vive (o meglio viveva) nello Stato birmano del Rakhine, hanno molto a che vedere con la storia di un confine – quello tra il mondo birmano e quello bengalese – che nei secoli si è spostato, cambiando di mano e di segno in seguito a guerre, dispute, cambi della guardia al vertice dei poteri che, di volta in volta, hanno comandato su questi territori.
Tutti conoscono la storia di violenze che i rohingya subiscono dal 2012, quando il primo pogrom recente (la persecuzione ha radici antiche) ha prodotto oltre centomila sfollati interni. Allora pareva soprattutto una vicenda di intolleranza religiosa alimentata da gruppi identitari buddisti che vedevano nei rohingya, considerati non birmani e immigrati bengalesi per di più musulmani, un pericolo per l’integrità di un Paese che è stato la culla del buddismo. Nel 2016 una nuova ondata di violenze si doveva nuovamente abbattere su quel milione di rohingya ancora in possesso di una casa e un campo da coltivare o una capra da mungere. L’attacco di un gruppo secessionista ad alcuni posti di frontiera scatena una reazione che produce allora un esodo di circa 80mila persone verso il Bangladesh. Passato qualche mese, nell’agosto di quest’anno, in seguito a un altro attacco dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), una nuova spropositata reazione dell’esercito (sono parole dell’Onu che non ha esitato a utilizzare anche la locuzione “pulizia etnica”) ha invece prodotto un nuovo massiccio esodo di circa mezzo milione di profughi. A far le somme, e considerato che ormai la diaspora di questa comunità conta nel mondo quasi due milioni di persone, non solo la maggioranza dei rohingya risiede ormai all’estero (oltre un milione nel solo Bangladesh) ma i numeri di questa popolazione nel Myanmar sono ormai così ridotti che la scomparsa dei rohingya dai territori birmani è ormai forse solo questione di qualche anno. Forse di mesi.
Cosa c’entrano in tutto ciò le frontiere e la loro eredità?
 |
| Il Rakhine oggi, area birmana. Cosa è stato nei secoli? |
Dobbiamo fare un passo indietro. Fino al 1700 l’Arakan, l’attuale Stato birmano del Rakhine, era un regno indipendente che alla fine di quel secolo doveva finire sotto i monarchi birmani. I birmani però volevano espandersi sempre più a Ovest ed entrarono in conflitto con le mire di Calcutta, la capitale della British India, che voleva invece allargarsi sempre più a Est. Sono però i birmani a perdere e nel 1824 – in seguito al trattato di Yandabo che conclude la prima guerra anglo-birmana – l’Arakan e altri territori sotto influenza birmana passano sotto l’India britannica. I rohingya, chissà da quanto tempo nell’Arakan, si ritrovano dunque, dall’essere stati sudditi di un regno indipendente prima e delle monarchie birmane poi, a diventare vassalli di Sua Maestà britannica, o meglio dell’amministrazione coloniale della Regina in India. Nei primi mesi del 1886 l’intera Birmania diventa una provincia dell’India britannica e nel 1887 diventa sede di un vice governatorato che solo nel 1937 passa direttamente a un’amministrazione separata, sotto la direzione del Burma Office di Londra (segretariato di Stato per l’India e la Birmania). Dunque i rohingya sono adesso sudditi britannici sotto un’altra formula e lo saranno sino al 1948 quando la Birmania, come la chiamavamo allora, diventerà indipendente. C’è anche da notare che, seppur brevemente, i rohingya, come i birmani, sono stati anche sudditi dell’Imperatore Hirohito – dal 1942 al 1945 – quando le forze nipponiche dell’Asse avevano invaso la Birmania per “liberarla” dal giogo coloniale britannico con la parola d’ordine “L’Asia agli asiatici”. In poche parole, più che essere i rohingya a spostarsi (cosa sicuramente avvenuta in passato nel corso di quel flusso migratorio universale che ha interessato e interessa tutti i popoli del mondo che si muovono per i più svariati motivi), sono stati i confini a tendersi o contrarsi come un elastico. La sola colpa dei rohingya, vine da dire, è quella di essere sempre stata una minoranza debole, non in grado di far sentire la propria voce.
Ora, le legge sulla cittadinanza del Myanmar, varata durante la dittatura militare nel 1982, riconosce tre categorie di cittadini: cittadini propriamente detti, associati o naturalizzati. Ma i rohingya non sono riconosciuti in nessuna delle categorie. La legge dice che, come recita la Costituzione del 1947, è cittadino birmano chi ha radici in una “razza indigena” o viveva nella “British Burma” prima del 1942, ossia prima dell’arrivo dei giapponesi. A quell’epoca chi abitava nell’Arakan era già da tempo sotto dominio britannico: un dominio strappato ai birmani e ancor prima a un regno indipendente aracanese. Autoctoni o meno dell’Arakan-Rakhine, nel 1942 la presenza dei rohingya nel Rakhine – che questi ultimi chiamano Rohang – datava probabilmente da secoli. E comunque, al di là delle polemiche sul termine “rohingya” che alcuni storici birmani dicono sia apparso solo negli anni Cinquanta del XX secolo, nel 1942 erano stati già stati sudditi britannici ben due volte: in un primo tempo sotto Calcutta (e dal 1911 Delhi) e in seguito direttamente sotto l’Ufficio Birmania a Londra. Benché sia certo che durante la dominazione britannica molte popolazioni, tra cui i bengalesi, si siano mosse all’interno dell’Impero, cosa è successo prima e durante gli inglesi? Non è difficile immaginare che nei secoli vi sia stata una sorta di osmosi tra le pianure e le colline del Bengala e le limitrofe aree birmane. E se è difficile determinare quando il primo rohingya sia nato e dove, si perde nella notte dei tempi la loro presenza (e quella più in generale musulmana) in un’area che un tempo confini non ne aveva affatto: tutt’al più fiumi, mari, colline o catene montuose. Barriere naturali geografiche che la Storia deve aver visto attraversare più volte, in questa o quella direzione: dal cacciatore nomade al pescatore, dal pastore transumante allo stesso agricoltore sedentario in cerca di luoghi dove eleggere domicilio.
Questa legge è dunque una cattiva legge – imperfetta, astorica, obsoleta e ingiusta – e andrebbe
 |
| Terrore buddista. Un’analisi sufficente? |
riformata anche perché originariamente i rohingya avevano assai più diritti: potevano votare e candidarsi. Al netto delle colpe del governo civile birmano non si può dimenticare che proprio nei giorni del pogrom di fine agosto, l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, incaricato da Aung San Suu Kyi, lo abbia detto a chiare lettere alla conclusione di un’inchiesta svolta proprio per affrontare la questione rohingya, un nome che in Bangladesh non si può nemmeno menzionare. Ma i militari, autori delle peggiori leggi del Paese, non solo non vogliono riconoscere il lavoro di Annan, che hanno definito “fazioso” e dunque falso, ma hanno spinto i partiti d’opposizione al governo di Suu Kyi, nato dalle elezioni del 2015 (con la vittoria della Lega nazionale per la democrazia), a una campagna contro il dossier Annan che ha tutta l’aria di una minaccia. La minaccia è che, se Suu Kyi, il suo partito e il suo governo dovessero tirare troppo la corda, i militari potrebbero ricorrere a un altro articolo della Costituzione, emendata dai generali nel 2008, che prevede (oltre a una quota a loro riservata in parlamento di un quarto dei seggi) che l’esercito possa ribaltare il governo in carica nel momento in cui esiste un pericolo reale per la stabilità del Paese. Il richiamo dell’opposizione a un dossier definito un’operazione che favorisce le forze straniere che minacciano il Myanmar non è, in altre parole, che la proiezione sulla situazione attuale dell’ombra di questo emendamento. Che garantisce un golpe costituzionale, dunque legittimo. Se finora non si è verificato è solo perché i militari controllano tre dicasteri chiave: Interno, Difesa, Frontiere.
 |
| Aung San Suu Kyi: immagine tratta da BigThink |
E’ questo il motivo per cui una paladina dei diritti umani e Nobel per la pace come Aung San Suu Kyi, e così i vertici del suo partito, sta tanto attenta a come parla (non li chiama rohingya ma semplicemente musulmani) e a cosa fa (oltre alla commissione Annan ne ha nominate altre ma con limitatissimo potere) a costo di attirarsi le ire del mondo intero. I militari vegliano sul Paese e, nel consesso internazionale, ci pensa Pechino – e in parte Mosca – a frenare eventuali prese di posizione del Consiglio di sicurezza (che finora ha adoperato un gergo assolutamente debole). Infine c’è l’India, non più britannica ma retta da un campione anti musulmano come Narendra Modi. Che, non solo ritiene al pari di Pechino il Myanmar un partner strategico ma che vorrebbe espellere tutti i rohingya immigrati in India (circa 40mila).
C’è un’ultima domanda ancora senza risposta. Perché? Basta una legge restrittiva? Una sorta di suprematismo buddista? Forme di xenofobia etnica e religiosa? C’è altro e ci sono altre leggi su cui merita soffermarsi. Le immagini satellitari diffuse recentemente da Human Rights Watch e da Amnesty International su vaste aree incendiate nella zona rohingya dello Stato del Rakhine riportano alla memoria fotogrammi più antichi come quelli con cui Hrw aveva stimato, nell’autunno scorso, ad almeno 1500 gli edifici dei rohingya dati alle fiamme. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto, ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, unità amministrative dello Stato del Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya o quel che ne rimane.
Quei fotogrammi, ieri come oggi, rendono più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma anche con l’ipotesi che, dietro alla cacciata di persone senza cittadinanza, ci sia anche un piano per accaparrarsi la loro terra. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione di terre considerate mal sfruttate per affidarle a grosse compagnie private al fine di metterle a profitto. E’ quello che – in altri termini – si scrive “sviluppo” ma si legge “land grabbing” a beneficio di società con grandi mezzi. Dal 2012 un nuovo pacchetto legislativo ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari e che ora possono anche aprirsi al capitale estero sempre affamato di terra. E’ un vero assalto sia alla foresta, che ogni anno perde 400mila ettari, e a piccoli appezzamenti di terreno o ad aree di utilizzo consuetudinario. Col vantaggio che questa legge ne ha anche abolita un’altra del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya il passaggio di mano conterebbe ora oltre un milione e duecentomila ettari con un balzo rilevante rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012. Se si mettono assieme le due cose, l’aspetto razzista e islamofobico passa in secondo piano e sembra semmai una concausa benché con radici antiche che risalgono al periodo coloniale e forse anche a prima.
E’ una lettura naturalmente ma non priva di suggestione anche se, in settembre, le tesi della Sassen,
 |
| Saskia Sassen |
riprese anche da un gruppo di ricercatori (Forino, von Meding, Johnson) sulla rivista britannica The Conversation, sono state duramente criticate sul sito NewMandala – e tacciate di “marxismo volgare” – da Lee Jones, un noto esperto di cose birmane (su land grabbing e legislazione birmana si può comunque vedere il sito https://library.ecc-platform.org). Ciò che per altro merita una riflessione è il fatto che chi se ne va perde ogni diritto, persino quello della consuetudine. E se non ha cittadinanza e passaporto non avrà mai più, ammesso che possa tornare nel Myanmar, un documento valido per reclamare la sua terra e la sua casa. Qualcuno, non casualmente, l’ha definita una politica della “terra bruciata”. Bruciata oggi perché domani cambi di padrone. Una storia di frontiere e confini. A danno di uomini, animali, biodiversità.
* Con cui sono onorato di collaborare
Il turista nudo al Salone dell’editoria sociale
Viaggio all’Eden a Perugia venerdi 27 ottobre
VIAGGIO ALL’EDEN
Venerdì 27 ottobre 2017
alle ore 18:30
Biblioteca San Matteo degli Armeni
Via Monteripido, 2 – Perugia
Introduzione di
Emmanuel di Tommaso
Ne discute con l’autore
Floriana Lenti
Luce verde ai raid segreti della Cia in Afghanistan
 |
| Mike Pompeo: muscolare come Trump |
Il viaggio lampo del segretario di Stato americano Rex Tillerson, che dopo Irak e Afghanistan è arrivato ieri in Pakistan per visitare poi Nuova Delhi, è la prima vera offensiva diplomatica in casa dell’amico-nemico. L’amico nemico è il Pakistan verso cui Tillerson – assai più morbido a Islamabad – ha avuto parole durissime durante i suoi colloqui afgani. Accusati di essere la sentina della guerra, i pachistani – colpevoli di dare rifugio ai talebani afgani – non la prendono molto bene questa offensiva diplomatica preceduta dalle parole di fuoco di Trump e della sua ambasciatrice all’Onu che sul Paese dei puri han sparato duro. I pachistani – messi in imbarazzo anche da un’intervista di Caitlan Coleman (un’americana liberata col marito canadese Joshua Boyle che ha appena detto al Toronto Star, smentendo Islamabad, che il rapimento afgano si è trasformato in una cattività in Pakistan per più di un anno) sono allarmati soprattutto da due cose: una diplomatica e l’altra militare. Quella diplomatica riguarda l’India, il fratello-coltello oltre confine, la cui espansione in Afghanistan preoccupa molto Islamabad. E da che gli americani hanno addirittura chiesto a Delhi di “tenere d’occhio” il Pakistan, il furore è difficile da nascondere. La seconda è che il viaggio di Tillerson inaugura anche un nuovo stadio della guerra afgana e della sua scia pachistana.
La notizia riguarda la luce verde del presidente alla nuova strategia contro insurrezionale di Michael “Mike” Pompeo, parlamentare repubblicano (di origini italiane) nelle grazie del Tea Party che da gennaio è a capo della Cia. Pompeo, che ha frequentato West Point e ha una carriera militare alle spalle, è un tipo muscolare proprio come Trump. La sua interpretazione del messaggio di Donald (nessuno avrà più un luogo dove nascondersi) è una nuova espansione delle attività dell’Agenzia che superino le restrizioni dell’era Obama, che autorizzava le operazioni coi droni solo all’esercito e che, al massimo, consentiva alla Cia di operare in Pakistan. Negli ultimi tre anni i raid coi droni militari sono comunque aumentati (ammesso che il dato sia veritiero) da 304 nel 2015 a 376 nel 2016 a 362 nei primi otto mesi del 2017 (mentre la Cia ne avrebbe totalizzati solo 3 l’anno scorso e 4 quest’anno e solo in Pakistan). Ma per Pompeo, e per Trump, non bastano né basta più che la Cia addestri la sua controparte (Nds) afgana. Da adesso la Cia potrà fare tutti i raid che vuole in Afghanistan senza rispondere all’esercito schierato al comando del generale Nicholson che guida anche le truppe Nato. La gestazione del progetto Pompeo, che impiega le cosiddette forze paramilitari dell’agenzia o soldati prestati dal Pentagono, non è stata facile: la Cia è nota per andar ancor meno per il sottile in fatto di danni collaterali così che alla Difesa diversi generali – dice la stampa americana – hanno storto il naso: «Cosa possono fare che non possiamo fare noi»? In realtà i servizi segreti fanno solo operazioni “coperte” e dunque bypassano ogni catena di comando. Ma chi pagherà il conto delle vittime civili, già alto durante i raid aerei “normali”? Per l’afgano della strada, un drone è un drone e una pallottola non ha firma. Le colpe della Cia si riverseranno sull’esercito.
Gli afgani dal canto loro plaudono. La pratica hunt and kill (caccia e uccidi) piace al ministero della Difesa che ha espresso apprezzamento. Washington sostiene che la nuova massiccia campagna di omicidi mirati porterà più facilmente i talebani al tavolo del negoziato. Ma è molto più probabile che si limiti a far crescere la guerra e il bilancio delle vittime civili.
Il Califfo asiatico a Roma giovedi 26 ottobre alle 18
Il Califfo a Roma: una presentazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio
26 ottobre 2017 ore 18.00
modera: Valeria Martano
A oriente del Califfo
A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi
a cura di
Emanuele Giordana
con la collaborazione di
Lettera 22
Rosenberg&Sellier 2017
Non è un libro solo sullo Stato Islamico.
Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà
musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.
Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25
anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno
anche parte dell’agenzia China Files.
Viaggio all’Eden a Pisa mercoledi 25 ottobre
Con il giornalista Alessandro De Pascale e Alberto Mari, un attivista dell’Osservatorio Antiproibizionista
VIAGGIO ALL’EDEN
La settimana nera di una guerra dietro le quinte
La settimana appena conclusa ha un bilancio di oltre 200 morti, una delle peggiori della guerra afgana. Una guerra che apparentemente non c’è più ma che sta continuando ininterrottamente da 36 anni. Ecco la lista stilata dalla Tv afgana Tolo.
E’ stata una buona occasione, come si rileva dall’articolo, per le polemiche interne.
Saturday’s attack on Ministry of Defense (MoD) cadets in Kabul:
15 cadets killed
4 cadets wounded
Friday’s attack on Imam Zaman Mosque in Dast-e-Barchi in Kabul:
about 70 civilians killed
55 civilians wounded
Attack on mosque in Ghor province on Friday:
10 civilians killed
20 civilians wounded
Thursday’s attack on a base in the Maiwand district of Kandahar:
43 soldiers killed
9 soldiers wounded
Tuesday’s attack in Paktia on the police headquarters:
Over 50 soldiers and civilians killed
Over 150 civilians and soldiers wounded
Monday’s attack on Andar district of Ghazni province:
28 soldiers killed
18 soldiers wounded
5 civilians killed
40 civilians wounded
Rohingya, l’ultima accusa
 “Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i
“Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i
rohingya”. Dopo che il vocabolario dell’orrore sembrava ormai aver esaurito tutte le parole – esodo forzato, violenza, genocidio, stupro, pulizia etnica – Amnesty International, nel suo ultimo rapporto, aggiunge l’aggettivo “sistematico” a una campagna che ha come risultato il più numeroso esodo della storia recente da un Paese non in conflitto, una nuova biblica cacciata dai propri luoghi di origine. Il popolo senza identità, invisibile nei registri delle autorità birmane, accusato di essere la prole di un’immigrazione illegale dal Bengala, è così fisicamente minacciato che il governo birmano sembra aver in mente un solo obiettivo: cacciarli finché non resti un solo rohingya.
Amnesty non lo dice ma le “nuove prove” raccolte dall’organizzazione, che con Human Rights Watch ha immediatamente preso le difese della minoranza, mettono in chiaro un quadro sistematico di violenza continuata con una “campagna di omicidi, stupri e incendi di villaggi” portata avanti – dicono decine di testimonianze – da “specifiche unità delle forze armate, come il Comando occidentale, la 33ma Divisione di fanteria leggera e la Polizia di frontiera”. La contabilità ha ormai superato quota 530mila, un record possibile solo se, in un Paese apparentemente in pace, c’è in realtà una guerra che ha come obiettivo l’esodo di intere famiglie, tribù, villaggi. “Centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini – scrive Amnesty – sono vittime di un attacco sistematico e massiccio che costituisce un crimine contro l’umanità” così come lo concepisce lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale. Il Tpi elenca 11 atti che, se commessi intenzionalmente durante un attacco, costituiscono il più grave dei reati. E Amnesty ne ha riscontrati almeno sei: “omicidio, deportazione, sfollamento forzato, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione oltre a ulteriori atti inumani come il diniego di cibo e di altre forniture necessarie per salvare vite umane”.
Alla voce di Amnesty si aggiunge quella di organizzazione come Msf:“Le strutture mediche, incluse le nostre cliniche, sono al collasso. E in poche settimane – scrivono i Medici senza frontiere – abbiamo ricevuto 9.602 pazienti in ambulatorio e 3.344 pazienti in pronto soccorso. Tra loro, anche adulti sul punto di morire a causa della disidratazione: il sintomo che una catastrofe sanitaria è dietro l’angolo”. La voce dell’Onu è risuonata molte volte ma con scarsi risultati. E lo sa bene il sottosegretario Jeffrey Feltman che martedi a Yangoon si è sentito fare una reprimenda dal generale Min Aung Hlaing, il capo di stato maggiore birmano, che non vuole l’Onu tra i piedi: la maggior parte delle agenzie del palazzo di Vetro infatti nel Rakhine, il luogo del delitto, non ci può andare. Sono di parte, dicono i generali, che si apprestano a rilasciare un loro dossier su come sono andate le cose. Ai militari birmani non basta evidentemente che, per non turbare troppo gli equilibri, il Programma alimentare mondiale (Wfp) abbia fatto sparire un dossier “imbarazzante” e che per molto tempo, fin dal 2016, le agenzie dell’Onu abbiano fatto di tutto per evitare polemiche e scandali. Una mediazione senza risultati.
La diplomazia comunque batte un colpo e ieri l’Alto commissario Ue Federica Mogherini ha comunicato per telefono ad Aung San Suu Kyi, ministro degli Esteri ma premier de facto, che tutti i 28 membri Ue (inclusa l’Italia che ha recentemente inviato il suo ambasciatore, Pier Giorgio Aliberti, nel Rakhine) hanno chiesto l’immediato accesso alle agenzie umanitarie nel Paese ma che soprattutto, per via dello “sproporzionato uso della forza”, hanno deciso che né il generalissimo, né altri soldati birmani potranno mettere piede in Europa sino a che esista questa situazione (e a breve anche gli Stati Unite potrebbero seguire l’esempio).
L’embargo sulle armi, già in essere da tempo, non solo continuerà ma gli uomini in divisa non potranno nemmeno venire a girare le fiere e i mercati degli armamenti che probabilmente si procurano con oculate triangolazioni. E’ almeno un primo passo e a ridosso di due incontri importanti: il meeting nella capitale birmana dell’Asem il 20 novembre (Asia-Europe Meeting, un processo di dialogo tra i Paesi Ue, altri due paesi europei, e 22 paesi asiatici più il segretariato dell’Asean) e, subito dopo, la visita di papa Francesco il 26. Anche li è già in corso una guerra delle parole: i vescovi locali non vogliono che il pontefice parli di “rohingya”, termine che la stessa Suu Kyi non utilizza mai. I “self-identifying Rohingya Muslims” come li chiamano i giornali più progressisti birmani (anche loro molto attenti a non incorrere nelle maglie della censura) oltre a non aver più la casa non hanno nemmeno più un’identità.
Rohingya, un incontro ad Arco (Tn) venerdi 20 ottobre
Venerdì 20 ottobre 2017 ore 20.30
Arco (Trento) Palazzo dei Panni
Un incontro sulla questione rohingya
Un filo conduttore tra la fortunata ascesa del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi e le difficoltà nell’estendere i diritti umani a tutta la popolazione birmana, tra interessi economici delle super potenze vicine, India e Cina. Un quadro d’insieme accompagnato da un reportage fotografico e dall’esperienza di un progetto di solidarietà in campo medico da parte di un’associazione trentina.
Promosso da Apibimi Onlus e Biblioteca di Arco
con Emanuele Giordana e il fotografo Ramon Sist
Un’agenzia birmana per aiutare i rohingya: buona idea o foglia di fico?
 Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.
Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.
Penso che quanto Suu Kyi sta facendo sia qualcosa che si può comprendere anche se tutto ciò non giustifica il suo operato. Sono contrario alla campagna per la restituzione del Nobel e sono contrario alle sue dimissioni ma penso che il suo comportamento vada censurato anche se ci sono diversi motivi che rendono comprensibile il suo modo di agire. Si può comprendere ma non si può giustificare. Quello dei rohingya è l’esodo più imponente da un Paese non in conflitto che la storia recente ricordi. Circondato da un assordante silenzio rotto solo dal dolore degli uomini e donne invisibili che attraversano, ormai da un anno, la frontiera maledetta sul fiume Naf.
* A questo link un articolo ben documentato di Francesca sul land grabbing in Myanmar
Afghanistan, quanto costa la guerra
La guerra di Afghanistan, secondo un rapporto di Milex, è costata complessivamente 900 miliardi di dollari. Dopo 16 anni di conflitto il costo della partecipazione italiana alle operazioni in Afghanistan a partire da novembre 2001 è stimata dal dossier a “oltre 7,5 miliardi, a fronte di 260 milioni investiti in iniziative di cooperazione civile”.
Scarica il rapporto dal sito di Milex
Viaggio all’Eden a Milano, Mercoledi 11 ottobre
Con Tino Mantarro e i disegni di Maurizio Sacchi su Viaggio all’Eden
C’era una volta la Guerra Fredda
 Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera
Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera
raccontati da Icei e Radio Popolare”. Lunedì 2 ottobre alle 21, nell’auditorium di via Ollearo 5, il sesto appuntamento, dedicato all’Oriente: “L’Asia, dal Vietnam alla “fabbrica del mondo””. Intervengono i relatori Gabriele Battaglia ed Emanuele Giordana, conduce Chawki Senouci.
Leggi tutto
Aiuto, nei libri di testo scolastici si sponsorizza lo Ius Soli
“Ormai quindi l’Italia è terra di immigrazione e gli immigrati sono una presenza indispensabile, soprattutto in alcuni settori lavorativi come l’edilizia, il lavoro domestico, l’assistenza a bambini e anziani. La convivenza tra italiani e stranieri non è sempre facile e non sempre la legge italiana favorisce l’integrazione. Ad esempio i figli di stranieri nati in Italia continuano a non aver diritto alla cittadinanza italiana, anche se vivono nel nostra Paese da sempre“.
Non so cosa ne pensate di questa frase che è tratta da un libro di testo per la scuola media: Zoom Geografia da vicino scritto a sei mani da tre autori (Brandi, Corradi, Morazzoni). Direi che si tratta di una verità inequivocabile tra l’altro illustrata, nel libro, da tabelle e dati. Che gli immigrati facciano un lavoro che molti italiani non vogliono più fare è del resto un elemento così assodato che penso possa riconoscerlo persino Matteo Salvini. Eppure per il Giornale, con un articolo a firma Giuseppe De Lorenzo, si tratta di uno “spot allo ius” che, se non fosse chiaro, sarebbe lo ius soli, legge appena affossata da Alfano e che lascia nel limbo migliaia di ragazzi che avrebbero diritto alla cittadinanza italiana. Rimando all’articolo di De Lorenzo e alle reazioni (come questo commento sul blog Butac o lo stesso comunicato della casa editrice Loescher): spiegano meglio di me come l’articolo del quotidiano milanese sia non solo riferito a un testo del 2015, ma abbia tutta l’aria di essere uno dei tanti elementi utilizzati ad arte nella campagna contro i migranti, gli stranieri, i loro figli e i loro diritti. Uno spot contro lo ius soli insomma. Aggiungo solo una piccola nota.
Secondo il Giornale il testo di Brandi, Corradi, Morazzoni – che ha stimolato la reazione di un gruppo vicentino che si chiama “Prima Noi” – esprime una “sponsorizzazione” dell’immigrazione atta a “plasmare la malleabile mente di un bambino, propenso com’è a credere a quasi tutto quello che gli viene proposto dagli insegnanti“. In buona sostanza, meglio non pensare. Meglio non farsi domande, in tenera età, su cosa ci fanno persone di altri Paesi nel nostro. Meglio non domandarsi – secondo Prima Noi e l’articolista – come mai queste persone non abbiano i nostri stessi diritti (e da bambino mi sarebbe sembrato normale chiederlo). Che miseria italiana. I libri di testo dovrebbero spiegarci che gli immigrati sono inutili, spesso se non sempre delinquenti, e che, se ci sono problemi di convivenza, è colpa loro. Se l’articolista si fosse limitato a riportare la notizia della reazione oscurantista di Prima Noi – il cui nome è tutto un programma – sarebbe cronaca, ma il pezzo opina, mette in guardia, paventa danni psicologici. E allora non sarebbe stato meglio, visto che si parla di scuola e di bimbi italiani, fare un piccolo ripasso della lingua di Dante? Il libro infatti sarebbe un’opera scritta a “tre mani“. Ma come, gli autori di mani ne hanno una sola a testa? L’altra se la son già presa i migranti? Chi di italiano ferisce, di italiano perisce.
Rohingya, melina al Consiglio di sicurezza
 |
| Guterres al CdS: tutte le parole possibili per scardinare l’inazione |
Mentre il numero dei rohingya fuggiti in Bangladesh continua ad aumentare il bilancio di un esodo che sembra senza fine e sarebbero ormai 500mila i profughi di questa minoranza musulmana vittima di una cacciata biblica, il Consiglio di sicurezza dell’Onu aspetta. Riunitosi da giovedi per ora ascolta in attesa di pronunciarsi su possibili sanzioni e passi forti nei confronti del Myanmar da cui i rohingya fuggono in massa. Ma per ora non ci si aspetta molto altro che un messaggio formale forte. Anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres non sa più bene che parole utilizzare: dalla “catastrofe umanitaria” è passato a “incubo dei diritti umani” ma le bocce restano ferme. Gli ha fatto eco l’ambasciatore all’Onu del Bangladesh Masud Bin Momen che, nelle riunioni consultive del Consiglio, ha chiesto alle Nazioni Unite un’indagine su quanto accade. Fatti che stanno facendo del suo Paese la riserva indiana dove cacciare la minoranza musulmana il cui nome, in Myanmar, non si può nemmeno menzionare.
La vicenda dei rohingya, per cui è già stato usato il termine “genocidio” e la locuzione “pulizia etnica”, infiamma però solo i Paesi musulmani e appena un pochino britannici e francesi. Persino gli americani, di solito molto “vocalist” – come si dice in gergo – quando si tratta di diritti umani, stanno un po’ in disparte. Nei discorsi preparatori nessuno è stato comunque avaro di frasi di rito ma al Consiglio di sicurezza, dove si prendono le decisioni che contano, tutti sanno che, soprattutto Pechino – spalleggiata da Mosca – non vuole soluzioni dure contro il Myanmar, alleato di ferro delle sue politiche energetiche. Ha già utilizzato in passato il diritto di veto anche se, si dice, la Cina si sarebbe ammorbidita in questa vicenda dove ormai ogni linea rossa è stata varcata. La gente che fugge, lasciandosi dietro case incendiate, stupri e violenze, arriva in Bangladesh stremata e assai spesso, è accaduto anche ieri, non ce la fa: fragili imbarcazioni che si capottano, gente che affoga nel fiume-mare che divide i due paesi: almeno una sessantina ieri dopo il ribaltamento di una barca.
Guterres, che potrebbe decidere un viaggio in Myanmar su invito del governo, vuole intanto almeno una Conferenza dei donatori e un po’ di quattrini per le sue agenzie. Ma c’è un problema di accesso – nello Stato del Rakhine da cui i rohingya fuggono – che renderebbero il denaro assai poco utile. Il problema è politico non umanitario. O meglio, la catastrofe umanitaria e l’incubo sui diritti, gli stupri e le violenze non sono che gli effetti di una politica disattenta su una vicenda annosa, marcata dall’imbarazzo di avere a che fare questa volta con dei musulmani che non sono dalla parte del torto. I rohingya però sono solo una piccola popolazione senza protezione né protettori, non vivono in deserti petroliferi e le loro terre ormai stanno passando nelle mani di altri padroni: erano un milione e ora son solo la metà. Questione di tempo e il caso, con qualche spicciolo per i campi profughi, si risolverà da solo.
Guterres lo sa e infatti ha paventato il rischio che questa situazione, oltre che catastrofica sul piano umanitario, diventi nuova benzina da gettare sul fuoco – in Bangladesh o in Myanmar – per chi ha interesse ad allevare gruppi armati e terroristici. Intanto Facebook dà una mano: i post dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), il gruppo secessionista rohingya accusato dai birmani di terrorismo, è stato oscurato. Un regalo a chi sta pensando a scelte radicali e ai Paesi che possono essere interessati a creare caos nella regione finanziando chi non ha più nulla da perdere.
Il Califfo e l’Asia al Festival di Internazionale: i Rohingya e il web
 Chiostro di San Paolo
Chiostro di San Paolo
piazzetta Schiatti 7
Festival di Internazionale
VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017
17.00
Il gruppo Stato islamico (Is) vuole estendere i confini del califfato oltre il mondo arabo e alcune regioni asiatiche sembrano un terreno ideale. Una raccolta di saggi per capire il progetto dell’Is per la conquista dei musulmani non arabi e per comprendere chi sta dando una mano al califfato.
Giordana racconterà del suo viaggio alla frontiera Bangladesh/Myanmar di cui ha scritto per Internazionale e di come i secessionisti rohingya possano cadere nella trappola dello Stato islamico. Tiziana Guerrisi racconterà di come la diffusione del verbo di Al Baghdadi si sia diffusa nella Rete sperimentando un nuovo tipo di guerra a tecnologia avanzata
(Sarà presente il cane Fanny)
Bellezza oltre la guerra a Trani. Afghanistan in terra di Puglia
 |
| Con Soraya sullo sfondo del castello di Federico II a 25 km da Trani |
Il tema della bellezza è al centro di un Festival cui mi sarebbe sempre piaciuto andare e che si intitola Dialoghi di Trani anche se poi gli appuntamenti corrono qui e la in questa bella terra di Puglia. Con mio grande piacere quest’anno sarò li domenica 24 con Soraya d’Afghanistan e Giorgio Zanchini a parlare della “bellezza oltre la guerra” dell’Afghanistan, Paese bellissimo e purtroppo in gran parte distrutto. Di cosa parlerò? Di cos’è ma anche di com’era. Posto dunque il mio ricordo di quella che un afgano definì l'”età dell’oro” ossia il periodo in cui visitammo l’Afghanistan durante il “Viaggio all’Eden”, libro nel quale ho dedicato a questo splendido Paese gran parte delle pagine… Ne pubblico qualche estratto dal 4 Capitolo: L’epopea di chicken street
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
…La notte, a quelle latitudini, arriva velocemente. Avevamo appena lasciato il posto di frontiera iraniano di Tayyebad ed eravamo entrati in Afghanistan mentre le luci del giorno si andavano affievolendo. Il passaggio del confine non era stato indolore ma sapevamo che la vera frontiera del Viaggio all’Eden, la mitica strada che portava dall’Europa sino all’India e a Kathmandu, era finalmente qui. Qui dove il grande altipiano del Khorasan persiano si perde nei deserti dell’Afghanistan, un luogo, un nome che con l’andar del viaggio – nelle storie raccolte a Istanbul o Teheran – stava diventando qualcosa in più di una semplice tappa. Alla frontiera iraniana la polizia dello Scià imponeva, a chi andava o veniva, un passaggio obbligato in un corridoio degli orrori: batterie scoperchiate, scatole di conserva squarciate, gomme rivoltate come calzini, cruscotti smontati, tubetti di dentifricio svuotati. Mentre ti avventuravi nella terra di nessuno tra le due frontiere, quel passaggio obbligato nel museo della punizione divina, ti dava un avvertimento chiaro: stavi entrando nel Paese patria, tra l’altro, dell’ “afgano nero”, l’hascisc più ricercato del pianeta. Lasciavi la Persia del Trono del pavone con le sue lugubri promesse penitenziarie e agenti azzimati dalle divise luccicanti e arrivavi al posto di frontiera de la “République d’Afghanistan”, che allora il francese era la lingua di una monarchia che, appena un anno prima, nel 1973, era diventata repubblica con un golpe bianco dei suoi parenti, mentre il re Zaher Shah era in vacanza a Capri…
 … Dopo qualche chilometro il minibus carico di stranieri zazzeruti e completamente fumati si arrestava in una ciakana, una taverna dove si beve il tè, si può dormire e mangiare sdraiati su tappeti pulciosi ma altrettanto ricchi di fascino, odori e geometrie colorate approntate da abili tessitori. Completamente stravolti dalla potenza dell’afgano nero, i giovani viaggiatori vedevano entrare uomini scesi da cammelli battriani a una sola gobba e avvolti in tabarri – il patu, coperta di finissima lana dell’Hindukush –, fieri pastori delle montagne, abili commercianti della pianura, chapandaz dal prezioso cavallo arabo che ti proiettavano in una sorta di medioevo islamico, dove regole antiche come massicci dirupi e vigili come guardiani occhiuti di una tradizione millenaria, sembravano – complice l’ambiente e l’hascisc – aver costruito a tua misura la magia di una notte stellata perduta nei grandi spazi dell’Oriente che finalmente si era fatto realtà. Altro che scimmiottamenti di un’altra cultura, altro che divise in stile germanico, altro che modernità più o meno digerita: dopo l’Iran dello Scià – dove l’impronta della modernità sapeva di esportazione forzata di un modello del tutto estraneo – l’Afghanistan era una favola perfetta dove ti era consentito immergerti fino al midollo. Dovevi solo rispettare le sue regole scandite dall’adhan, la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno. O dal pashtunwali, le norme rigorose della tradizione. Regole ferree. Una notte, un povero fricchettone di qualche città europea, in nome del leggendario codice d’onore dei pashtun che prevede non si possa negare l’ospitalità a chi la chiede nemmeno se si tratta di un assassino, viene accolto di buon grado in una famiglia cui domanda riparo. Ma il povero giovinastro si sveglia nella notte per la sete e, nel buio, sbaglia stanza entrando in quella delle donne, oggetto di un desiderio irrivelabile e negate alla vista altrui dai dettami della purdah (letteralmente: tenda). Punizione: la morte. Rapida come era stata la grazia con cui era stato accettato e ospitato…
… Dopo qualche chilometro il minibus carico di stranieri zazzeruti e completamente fumati si arrestava in una ciakana, una taverna dove si beve il tè, si può dormire e mangiare sdraiati su tappeti pulciosi ma altrettanto ricchi di fascino, odori e geometrie colorate approntate da abili tessitori. Completamente stravolti dalla potenza dell’afgano nero, i giovani viaggiatori vedevano entrare uomini scesi da cammelli battriani a una sola gobba e avvolti in tabarri – il patu, coperta di finissima lana dell’Hindukush –, fieri pastori delle montagne, abili commercianti della pianura, chapandaz dal prezioso cavallo arabo che ti proiettavano in una sorta di medioevo islamico, dove regole antiche come massicci dirupi e vigili come guardiani occhiuti di una tradizione millenaria, sembravano – complice l’ambiente e l’hascisc – aver costruito a tua misura la magia di una notte stellata perduta nei grandi spazi dell’Oriente che finalmente si era fatto realtà. Altro che scimmiottamenti di un’altra cultura, altro che divise in stile germanico, altro che modernità più o meno digerita: dopo l’Iran dello Scià – dove l’impronta della modernità sapeva di esportazione forzata di un modello del tutto estraneo – l’Afghanistan era una favola perfetta dove ti era consentito immergerti fino al midollo. Dovevi solo rispettare le sue regole scandite dall’adhan, la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno. O dal pashtunwali, le norme rigorose della tradizione. Regole ferree. Una notte, un povero fricchettone di qualche città europea, in nome del leggendario codice d’onore dei pashtun che prevede non si possa negare l’ospitalità a chi la chiede nemmeno se si tratta di un assassino, viene accolto di buon grado in una famiglia cui domanda riparo. Ma il povero giovinastro si sveglia nella notte per la sete e, nel buio, sbaglia stanza entrando in quella delle donne, oggetto di un desiderio irrivelabile e negate alla vista altrui dai dettami della purdah (letteralmente: tenda). Punizione: la morte. Rapida come era stata la grazia con cui era stato accettato e ospitato…
…Oggi a Kabul o a Herat si arriva in aereo. Si può ancora fare quella strada ma l’ossessione della guerra o dei sequestri fanno sì che il viaggiatore sia costretto ad aspettare l’ingresso nel sogno orientale non più a Mashhad ma a Dubai o ad Abu Dhabi, città ad aria condizionata (come Terzani battezzò Singapore nel suo Un indovino mi disse), senza calore umano e in compenso intorpidite da un clima torrido, umido, arrogante e impietoso come la gente del Golfo. L’aeroporto civile della capitale e quello della provincia occidentale – dal 2003 posta sotto controllo italiano – condividono la pista con panciuti aerei militari, grigi come il fumo delle bombe e anonimi come il colore della guerra. C’è poco fascino, se non per gli amanti di elmetti e gagliardetti, nel discendere una scaletta che approda su una terra ostile e polverosa che ospita città militarizzate in piena evoluzione e ormai quasi irriconoscibili. I bulldozer della famiglia Karzai, speculatori di Ankara o Dubai, ostinati ingegneri della sicurezza delle ambasciate, hanno ricoperto la capitale di cemento. I soldi della guerra avevano fatto dell’afghanis una moneta così forte che conveniva convertirla per comprare ovunque – fuorché in Afghanistan – merci che in Iran, Pakistan e Tagikistan costavano la metà. Facevano eccezione le noci di Baghlan o il melone di Kunduz, famoso per la succosa dolcezza, tra i pochi doni agricoli sopravvissuti: per il resto quasi tutto, dai pomodori alle uova, veniva e viene dai vicini. La bolla speculativa dell’economia di guerra – dall’edilizia alle commesse per gli scarponi dell’esercito – è però durata sino a quando i soldati americani e della Nato sono rimasti padroni del campo arrivando a contare 150mila militari e altre migliaia di contractor: con la loro presenza, accanto a una popolazione di diplomatici, umanitari e spioni, son stati una potente macchina per far girare i soldi. Adesso, che i soldati hanno iniziato ad andarsene con la fine nel 2014 della missione Isaf lasciando soltanto qualche migliaio di uomini a guardia del bidone, la bolla si è sgonfiata. E in un mercato del lavoro ormai asfittico dove i soldi facili son finiti e si affacciano ogni anno 400mila nuovi soggetti in cerca di occupazione, forse scenderà anche il prezzo di noci e meloni tanto quanto è scesa la speranza che la guerra, perfida matrigna, un giorno smetta di abbracciare questo Paese…
…Gli afgani sono poeti. Lo erano e lo restano ancora oggi. L’usignolo (bulbul) è un protagonista assoluto nei romanzi, nelle poesie e persino nei serial televisivi. Ne sa qualcosa Parwin Mushthal, attrice afgana di una serie televisiva intitolata appunto Bulbul e a cui gli islamisti hanno ucciso il marito per punirla. Per le donne è dura in questo Paese e lo era ovviamente anche negli anni Settanta. Eppure noi allora, pur essendo accompagnati da fervide femministe che il corpo è mio e lo gestisco io, facevamo poco conto a quella condizione di assoluta esclusione della figura femminile dal consesso sociale. Relativismo culturale? Facevano anche poca attenzione agli usignoli.
Nella casa che per alcuni anni abbiamo affittato a Kabul durante la guerra, sulle pendici di De Afghanan, il quartiere forse più antico della capitale, lo sguardo si perde fuori dalla finestra: si vedono le vette dell’Hindukush che circondano la città e i tetti delle case che in parte ancora sono fatti col sistema tradizionale: un miscuglio di fango e paglia che riveste gli ampi terrazzi e accompagna le balze degli edifici ammantati da un intonaco giallastro che ne segue le curve, come se fosse stato lavorato con le mani, anziché con la cazzuola. Siamo fortunati. Vediamo ancora una Kabul in via di rapida estinzione. Ancora, ma solo in parte, simile a quella città di soli 400mila abitanti (oggi son quattro milioni) che conoscemmo quarant’anni fa. Adesso che è iniziata cilleh-e-qurd, la seconda parte dell’inverno, il sole e il risveglio della natura cominciano a spandersi nei bagh, nei giardini aihmè sempre più rari in una città che ogni giorno costruisce palazzi nuovi e di dubbio gusto. Cilleh-e qalon, la prima parte dell’inverno, inizia invece col nostro solstizio del 21 dicembre e arriva in sostanza fino a fine gennaio. Dura 40 giorni come la fase successiva, cilleh-e-qurd, che segna la transizione di altri 40 giorni e che ci porterà fuori dal freddo secco dell’inverno. Da inguaribile romantico, lo ammetto, continuo a inseguire i segni del passato e dell’impossibile che è anche forse un modo per fingere che la guerra sia lontana e che, anche a Kabul, si possa vivere una vita normale: osservando il volo degli uccelli, spiando le gemme sui rami, indovinando suoni e bisbigli di una natura quotidianamente calpestata….
Come ti insegno a uccidere meglio
Dopo l’assurdo errore del volantino sganciato dal cielo in cui un cane “cattivo”, animale impuro per l’islam, portava una frase del Corano sul corpo mentre era inseguito da un leone “buono” (l’idea era che il cane fossero i talebani), a dimostrazione di una confusa strategia anche mediatica, l’unica certezza all’orizzonte del nuovo surge trumpiano è che dal cielo non cadranno solo volantini ma sempre più bombe
Volantini dal cielo bombe dall’aria
 Dai cieli afgani non piovono solo volantini. La nuova strategia americana, fumosa e incerta, una sicurezza l’ha data: più bombe, più omicidi mirati, miglior utilizzo dell’arma aerea e un maggior impegno – con l’aiuto dei partner Nato – per costruire una forza aerea nazionale con più aerei e piloti meglio addestrati. Non è una novità perché è la stessa politica di Obama (meno soldati più bombe) ma con almeno tre differenze: la prima è che l’impegno di “stivali sul terreno” aumenterà: per ora siamo a oltre 15mila soldati ma potrebbero crescere; la seconda è che l’Afghanistan può essere un buon teatro dove testare nuove armi (come quella da 11 tonnellate sganciata nell’aprile scorso nella provincia orientale di Nangarhar, nella foto a sinistra); la terza è che sono tornati i B-52, le “fortezze volanti” rese note dalla guerra nel Vietnam. Già utilizzati in passato, non erano stati più usati a partire dal 2005 ma sono riapparsi nel 2012 quando giunsero a sganciare sino a 600 bombe nel mese di agosto di quell’anno. Poi c’è stato un nuovo arresto e ora sono ricomparsi con una media di 150 bombe al mese: ad agosto 2017 hanno superato quota 500. I B-52, gli stessi da cui sarebbero stati sganciati i volantini, portano normalmente bombe da 220 chili (Gbu-38/B) fino a una tonnellata (Gbu-31/B). Ogni aereo ne può portare sino a una trentina per un totale di 31 tonnellate, salvo che non si tratti della Gbu-43 Moab da 11 tonnellate di Tnt – quella utilizzata nel Nangarhar – che per la dimensione deve essere lanciata da un C-130.
Dai cieli afgani non piovono solo volantini. La nuova strategia americana, fumosa e incerta, una sicurezza l’ha data: più bombe, più omicidi mirati, miglior utilizzo dell’arma aerea e un maggior impegno – con l’aiuto dei partner Nato – per costruire una forza aerea nazionale con più aerei e piloti meglio addestrati. Non è una novità perché è la stessa politica di Obama (meno soldati più bombe) ma con almeno tre differenze: la prima è che l’impegno di “stivali sul terreno” aumenterà: per ora siamo a oltre 15mila soldati ma potrebbero crescere; la seconda è che l’Afghanistan può essere un buon teatro dove testare nuove armi (come quella da 11 tonnellate sganciata nell’aprile scorso nella provincia orientale di Nangarhar, nella foto a sinistra); la terza è che sono tornati i B-52, le “fortezze volanti” rese note dalla guerra nel Vietnam. Già utilizzati in passato, non erano stati più usati a partire dal 2005 ma sono riapparsi nel 2012 quando giunsero a sganciare sino a 600 bombe nel mese di agosto di quell’anno. Poi c’è stato un nuovo arresto e ora sono ricomparsi con una media di 150 bombe al mese: ad agosto 2017 hanno superato quota 500. I B-52, gli stessi da cui sarebbero stati sganciati i volantini, portano normalmente bombe da 220 chili (Gbu-38/B) fino a una tonnellata (Gbu-31/B). Ogni aereo ne può portare sino a una trentina per un totale di 31 tonnellate, salvo che non si tratti della Gbu-43 Moab da 11 tonnellate di Tnt – quella utilizzata nel Nangarhar – che per la dimensione deve essere lanciata da un C-130.
 Il totale delle bombe sganciate nel 2017 è 2.487, più della metà di quelle lanciate in tutto il 2012 ma solo 271 in meno che in tutto il 2013 e quasi il doppio di quelle del 2016. I B-52 sono coadiuvati nei bombardamenti da caccia F-16 e droni MQ-9. In totale 761 missioni con bombe (su 2.861 uscite) nel 2017. Sul fronte interno – spiega l’Air Power Summary americano del 31 agosto – “ L’Afghan Air Force ha espanso la sua capacità aerea con la prima operazione di sganciamento notturno il 22 agosto con propri C-208”. Train Advise Assist, come vuole l’imperativo della missione Nato “Supporto risoluto”.
Il totale delle bombe sganciate nel 2017 è 2.487, più della metà di quelle lanciate in tutto il 2012 ma solo 271 in meno che in tutto il 2013 e quasi il doppio di quelle del 2016. I B-52 sono coadiuvati nei bombardamenti da caccia F-16 e droni MQ-9. In totale 761 missioni con bombe (su 2.861 uscite) nel 2017. Sul fronte interno – spiega l’Air Power Summary americano del 31 agosto – “ L’Afghan Air Force ha espanso la sua capacità aerea con la prima operazione di sganciamento notturno il 22 agosto con propri C-208”. Train Advise Assist, come vuole l’imperativo della missione Nato “Supporto risoluto”.
Insegnare a bombardare meglio in un paese dove nei primi mesi del 2017, guarda caso, l’Onu ha segnalato un aumento del 43% negli incidenti dovuti ai raid aerei.
Fantasmi birmani
Dopo un’attesa durata settimane la Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, sotto i riflettori della cronaca per l’esodo forzato di oltre 400mila rohingya, ha preso la parola e affrontato la questione. Sotto gli occhi delle telecamere e dei parlamentari e militari del Myanmar nel quale conta più di un nemico. L’attesa non è stata tradita e la leader de facto del governo birmano ha affrontato la questione con un lungo discorso, per certi versi anche coraggioso, ma che in sostanza ha difeso l’operato dell’esercito e messo davanti a tutto la stabilità del suo Paese. Un Paese sempre minacciato dal rischio di un golpe militare che non sarebbe nemmeno tale visto che la Costituzione lo prevede in caso la sicurezza nazionale sia compromessa. Suu Kyi dice che il suo governo non teme il “controllo internazionale” sulla gestione della crisi e ha dichiarato di sentirsi profondamente colpita per la sofferenza di “tutte le persone” imprigionate nel conflitto; che il Myanmar è comunque “impegnato in una soluzione sostenibile … per tutte le comunità”. Ha infine detto che non ci sono state “operazioni di pulizia”, la terribile accusa che è piovuta dall’Onu quando il Myanmar è stato appunto accusato di pulizia etnica.
Poche ore dopo il suo discorso, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra – da cui l’accusa è piovuta – ha chiesto l’accesso completo alla regione in modo da poter indagare la situazione “con i propri occhi”. Il suo messaggio al parlamento (con un discorso in inglese) è stato giudicato insufficiente da Amnesty International, che ha lamentato l’assenza di un riferimento diretto ed esplicito al ruolo dell’esercito nelle violenze nel Paese. Human Rights Watch dal canto suo continua invece a testimoniare il contrario di quanto il governo vorrebbe far credere (Suu Kyi ha detto che la maggior parte del Rakhine è in pace) perché, stando all’organizzazione, ci sono ancora “colonne di fumo che si levano dallo Stato del Rakhine”.
Ma l’aspetto forse più inquietante del discorso della Nobel è che non ha mai usato il termine “rohingya”, il nome della comunità che in Myanmar è un tabù perché la minoranza musulmana perseguitata (e ormai ridotta al lumicino dopo l’ennesimo esodo in Bangladesh) viene considerata solo una popolazione di immigrati illegali dal Bengala.
Il video integrale del discorso della Nobel ripreso da Al Jazeera
Vero è che il discorso pubblico richiedeva coraggio in un Paese dove il neo governo civile e democratico è sotto il tiro incrociato dei partiti di opposizione ma soprattutto dei militari. Ci voleva dunque coraggio a citare la missione affidata mesi fa a Kofi Annan che ha chiesto al Myanmar nel suo rapporto di rivedere la legge sulla cittadinanza che vieta ai rohingya di essere “birmani”. Un rapporto che il capo dell’esercito ha rigettato considerandolo “parziale” e per il quale Suu Kyi è stata accusata di avallare chi rema contro la stabilità del Paese. L’equilibrio è difficile: il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, nel ribadire la posizione del suo Paese, lo ha messo in luce: “Non possiamo assistere al ritorno di un regime militare” ed è dunque “vitale che Aung San Suu Kyi e il governo civile dicano chiaramente che questi abusi devono finire”. Una sorta di contraddizione in termini che rivela quanto la faglia sia sottile.
L’anno scorso, all’Assemblea generale delle Nazioni unite, la leader birmana aveva promesso di difendere i diritti delle minoranze e promesso anche impegno contro pregiudizi e intolleranza. Ma quest’anno, anche se il Myanmar non teme il “controllo internazionale”, la Nobel a New York non c’è. Per evitare imbarazzi e, alla fine, tener buoni i militari.
Il Ttp e le minoranze birmane
 «Massacri condotti e patrocinati dallo Stato, esecuzioni extragiudiziali, omicidi, sparizioni,
«Massacri condotti e patrocinati dallo Stato, esecuzioni extragiudiziali, omicidi, sparizioni,
annegamenti, stupri e violenze sessuali, distruzione di interi villaggi, negazione dei diritti in un cointesto di terrore promosso dallo Stato, diffuso e sistematico…». La lista delle accuse riempie cinque cartelle nel primo giorno in cui il Tribunale permanente dei popoli (Tpp) si riunisce a Kuala Lumpur per giudicare «…lo Stato del Myanmar, i dipartimenti del governo, il complesso militare nel suo insieme, polizia, polizia di frontiera, membri della Lega Nazionale per la Democrazia, il presidente, Htin Kyaw, e la consigliera, Aung San Suu Kyi, accusati di detti crimini in relazione ai gruppi etnici Kachin e Rohingya e alla popolazione islamica…». C’è altro: pur se non rientra nell’ambito di queste accuse, la Procura riconosce «il ruolo significativo dei media, degli ultranazionalisti del Rakhine e delle organizzazioni buddiste anti-musulmane estremiste nella diffusione di propaganda anti-musulmana e anti-Kachin, nell’incitamento all’odio con discorsi e ideologie atte a promuovere e raccogliere il sostegno pubblico per la persecuzione di questi gruppi…».
Benché le sentenze del Tribunale non siano vincolanti e benché si tratti per ora solo di accuse, per la prima volta in questi anni un gruppo autorevole di ricercatori e magistrati della società civile mette sotto accusa senza mezzi termini la politica birmana sulle minoranze e, in particolare, sui Kachin e i Rohingya per i quali Amnesty International chiede la fine della “pulizia etnica” e Human Right Watch chiede al Consiglio di sicurezza sanzioni e embargo sulla vendita di armi al Myanmar. Intanto la vicenda dei profughi verso il Bangladesh – 400mila – si avvicina alla “catastrofe umanitaria” prevista dal segretario generale dell’Onu Guterres. (Em. Gio.)-
Che bestialità vietare il cricket nei parchi italiani!
 |
| Foto tratta da EastWest |
“Il recente ferimento di un bimbo di due anni, colpito alla testa da una pallina vagante mentre era sul balcone di casa, ha indotto il sindaco (di Bolzano) Renzo Caramaschi a vietare lo sport più amato dalla comunità pakistana” rende noto una cronaca del Corsera del 12 settembre. Per ora, scrive Francesco Clementi, il provvedimento di veto sul cricket è limitato a Parco Mignone, ma si valuta l’estensione a tutti gli spazi aperti, dopo una “valutazione con rappresentanti della comunità pakistana”. In effetti una palla di cricket, una sorta di solido agglomerato di pelle di cervo, può arrivare a 150 km/h di velocità anche se questo attrezzo fondamentale del gioco più famoso dell’Impero britannico e delle sue colonie è così costoso che i giovani giocatori gli devono spesso preferire le più volgari palle da tennis. Non sappiamo quanto il bambino sia stato ferito ma sappiamo bene quanto possa far male una pallina da tennis: nella finale junior degli Us Open edizione 1983 per esempio, un giudice di linea fu colpito all’inguine da un “servizio killer” che lo precipitò a terra dove batté la testa e morì. Se invece si avesse la voglia di scorrere google per vedere tutti gli effetti collaterali di un pallone da calcio, si troverebbero circa un paio di milioni di risultati dove la sfera è una truce protagonista, più o meno diretta (“colpito da pallone in spiaggia sviene” “insegue pallone e viene travolto da un’auto” “cerca pallone e cade dal tetto”…). Nessuno però ha mai pensato di vietare il tennis e soprattutto il pallone nei parchi pubblici. Vien da pensare che, come spesso accade con le cose che non conosciamo, l’ignoranza connessa alla diffidenza finisca per produrre scelte sconsiderate…. (continua su EastWest)
Viaggio all’Eden in Trentino
Presento Viaggio all’Eden domenica sera a Flavon (ore 20.30, sala civica del Municipio) – organizzato da La Viaggeria e presentato da Raffaele Crocco.Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ritorna sulla rotta degli anni Settant…
Come ti insegno a uccidere meglio
Dopo l’assurdo errore del volantino sganciato dal cielo in cui un cane “cattivo”, animale impuro per l’islam, portava una frase del Corano sul corpo mentre era inseguito da un leone “buono” (l’idea era che il cane fossero i talebani), a dimostrazione di una confusa strategia anche mediatica, l’unica certezza all’orizzonte del nuovo surge trumpiano è che dal cielo non cadranno solo volantini ma sempre più bombe
Volantini dal cielo bombe dall’aria
 Dai cieli afgani non piovono solo volantini…(continua nei prossimi giorni su il manifesto in un articolo a due mani con Giuliano Battiston)
Dai cieli afgani non piovono solo volantini…(continua nei prossimi giorni su il manifesto in un articolo a due mani con Giuliano Battiston)
Lo ius soli visto dai rohingya
 Il villaggio di Yandabo si trova nel Myanmar centrale sulle rive del fiume Ayeyarwady ed è famoso oggi per i suoi manufatti in terracotta. Ma il 24 febbraio del 1826 fu il teatro di un trattato tra birmani e britannici a conclusione della prima guerra anglo-birmana.
Il villaggio di Yandabo si trova nel Myanmar centrale sulle rive del fiume Ayeyarwady ed è famoso oggi per i suoi manufatti in terracotta. Ma il 24 febbraio del 1826 fu il teatro di un trattato tra birmani e britannici a conclusione della prima guerra anglo-birmana.
In un certo senso il dramma dei rohingya, la minoranza musulmana di lingua bengalese oggetto in queste settimane di una persecuzione che ne ha espulsi circa 380mila dal Myanmar in Bangladesh, è iniziata a Yandabo oltre duecento anni fa. A quell’epoca l’attuale stato di Rakhine – luogo di residenza dell’ormai sempre più ridotta comunità rohingya – era ancora sotto l’influenza birmana, le cui monarchie avevano sottomesso i regni indipendenti di questo territorio affacciato sul Golfo del Bengala. Gli interessi dei birmani e quelli della East India Company, che da Calcutta dirigeva l’espansione dell’impero commerciale con sede a Londra, entrarono in conflitto a spese del Rakhine e di altre regioni sotto dominio birmano. E la guerra privò i birmani, col trattato di Yandabo, del territorio che un tempo, prima delle invasioni da Est, arrivava fino all’odierna Chittagong, la seconda città dell’attuale Bangladesh….
Continua su Reset
Catastrofe sui rohingya
 |
| Si aggiungono sempre nuovi campi profughi come spiega l’infografica di Al Jazeera. Sianmo a quota 380mila |
E’ forse stata anche la decisione di Aung San Suu Kyi di non partecipare alla prossima Assemblea dell’Onu a New York a scuotere nuovamente il Palazzo di Vetro sulla questione rohingya. Il segretario generale Antonio Guterres, che già aveva preso posizione nei giorni scorsi ma non si era spinto così avanti, ha usato ieri parole forti: la situazione di questa minoranza si avvia ad essere “catastrofica” e sono “completamente inaccettabili” le azioni dei militari birmani che devono essere sospese. Le parole di Guterres – e nel linguaggio della diplomazia a volte anche un solo termine o un rafforzativo fanno la differenza – segnano un livello sempre più alto nell’asticella che registra gli umori della comunità internazionale e la sensibilità delle agenzie umanitarie – dell’Onu e non – che non riescono a fare il proprio lavoro per dare sollievo alla minoranza rohingya – circa 380mila persone – che nel giro di due settimane sono scappate dal Myanmar. Fuggite per la “spropositata reazione” (sono ancora parole dell’Onu) delle forze dell’ordine birmane all’attacco di un gruppo armato rohingya il 25 agosto scorso a diversi posti di polizia. Il crescendo è iniziato con le dichiarazioni dell’inviato speciale per il Myanmar, la docente coreana Yanghee Lee, che di fatto non ha potuto fare la sua inchiesta. Poi, Zeid Ra’ad Al Hussein – Alto commissario per i diritti umani – ha usato senza girarci troppo intorno la locuzione “pulizia etnica”. Anzi, una pulizia etnica – ha detto – “da manuale”.
La posizione critica dell’Onu ha continuato a inasprirsi riflettendo il contegno del governo e soprattutto della sua leader de facto, la Nobel Aung San Suu Kyi. Che prima ha rotto il suo imbarazzante silenzio per denunciare un “iceberg di disinformazione” in quella che definito “propaganda” sulla questione rohingya. Poi ha deciso di disertare la prossima Assemblea generale dell’Onu, un palco pubblico dove ha già difeso le posizioni del suo governo l’anno scorso (dopo le violenze dell’ottobre 2016) ma che quest’anno rischierebbe di vederla oggetto di pesanti accuse, soprattutto dai Paesi musulmani ma anche da molte organizzazioni della società civile: da Human Rights Watch ad Amnesty, da Msf alle varie organizzazioni rohingya o semplicemente attive nel campo dei diritti.
Guterres comunque, nel rivolgersi al governo e ai militari birmani, stava in realtà mandando anche un segnale al Consiglio di sicurezza dell’Onu, riunito per la seconda volta sulla questione rohingya ma dove soprattutto Cina e Russia frenano prese di posizione troppo dure. Il motivo è chiaro: la situazione nel Myanmar è drammatica per i rohingya ma è estremamente pericolosa anche per il governo di Suu Kyi: un governo debole, nonostante i numeri, e ostaggio del vecchio potere militare. Pechino, soprattutto, non vuole instabilità nei Paesi dove investe. E quanto sia complicata la situazione lo si vede in questi giorni: mentre all’estero il dibattito continua ad allargarsi (sono state Svezia e Gran Bretagna a chiedere al CdS dell’Onu di riunirsi e che però si è limitato a chiedere “passi immediati per por fine alle violenze”) in casa le acque sono agitate. Una coalizione di 29 partiti con a capo l’Union Solidarity and Development Party (erede del vecchio governo militare) ha condannato il governo per aver dato ascolto al consiglio della Rakhine advisory commission, capeggiata su incarico di Suu Kyi dall’ex segretario Onu Kofi Annan, accusato di “parzialità” dal capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing. La commissione chiede che sia rivista la legge del 1982 sulla nazionalità, legge che ne esclude i rohingya. I partiti non solo usano termini minacciosi ma bollano il rapporto di Annan come opera di “traditori e gruppi stranieri che vogliono distruggere la nazione”.
E a dare una mano a chi sulla questione agita lo spettro dell’islamismo radicale ci si mette anche Al Qaeda: in un comunicato reso noto dal sito di intelligence SITE i qaedisti accusano il governo del Myanmar di un “trattamento selvaggio” dei fratelli musulmani che deve essere “punito”. Minacce di altro tipo dunque ma che alimentano la propaganda dei militari secondo cui esiste un piano che si serve di “terroristi” jihadisti per distruggere il Paese. Il gruppo sotto accusa però, l’Arsa, non ha legami – per quanto si sa – né con Al Qaeda né con lo Stato islamico.
L’Onu a chiare lettere: in Myanmar pulizia etnica
 |
| L’Alto commissario Zeid Ra’ad Al Hussein |
…According to UNHCR, in less than three weeks over 270,000 people have fled to Bangladesh, three times more than the 87,000 who fled the previous operation. Many more people reportedly remain trapped between Myanmar and Bangladesh. The operation, which is ostensibly in reaction to attacks by militants on 25 August against 30 police posts, is clearly disproportionate and without regard for basic principles of international law. We have received multiple reports and satellite imagery of security forces and local militia burning Rohingya villages, and consistent accounts of extrajudicial killings, including shooting fleeing civilians.
I am further appalled by reports that the Myanmar authorities have now begun to lay landmines along the border with Bangladesh, and to learn of official statements that refugees who have fled the violence will only be allowed back if they can provide “proof of nationality”. Given that successive Myanmar governments have since 1962 progressively stripped the Rohingya population of their political and civil rights, including citizenship rights – as acknowledged by Aung San Suu Kyi’s own appointed Rakhine Advisory Commission – this measure resembles a cynical ploy to forcibly transfer large numbers of people without possibility of return.
Last year I warned that the pattern of gross violations of the human rights of the Rohingya suggested a widespread or systematic attack against the community, possibly amounting to crimes against humanity, if so established by a court of law. Because Myanmar has refused access to human rights investigators the current situation cannot yet be fully assessed, but the situation seems a textbook example of ethnic cleansing…
Estratto da
Darker and more dangerous: High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights issues in 40 countries
Human Rights Council 36th session / Opening Statement by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights/ 11 sept 2017
Le due mappe tematiche sono scelte da un servizio dedicato di Al Jazeera
Addio a Nancy Dupree
Nancy Hatch Dupree, cittadina americana nata in Kerala nel 1927 è morta ieri a Kabul all età di 89 anni.
All’Afghanistan ha dedicato sforzi, passione e amore anche nei momenti più difficili. E non ha voluto lasciare il Paese per far ritorno negli Usa a farsi curare. Addio Nancy e che onore averti conosciuta! Grazie per il lavoro che hai fatto.
Ci siamo: luce verde ai soldati Usa in Afghanistan
 Un ufficiale delle forze armate americane ha detto ieri ad ABC che il ministro Mattis ha firmato ‘ ordine di invio in Afghanistan per 3500 soldati, poco meno dei 4mila previsti. Mattis, il titolare della Difesa, aveva confermato la firma dell‘ordine ma senza dare dettagli. Bizzarro! E pensare che qualche giorno fa, per dovere di trasparenza, il Pentagono aveva detto che i militari Usa in Afghanistan sono 11mila e non 8.400 come si era sempre detto. Cento più, cento meno, mille più mille meno, che differenza fa del resto? E la guerra bellezza e i dettagli han poca importanza.
Un ufficiale delle forze armate americane ha detto ieri ad ABC che il ministro Mattis ha firmato ‘ ordine di invio in Afghanistan per 3500 soldati, poco meno dei 4mila previsti. Mattis, il titolare della Difesa, aveva confermato la firma dell‘ordine ma senza dare dettagli. Bizzarro! E pensare che qualche giorno fa, per dovere di trasparenza, il Pentagono aveva detto che i militari Usa in Afghanistan sono 11mila e non 8.400 come si era sempre detto. Cento più, cento meno, mille più mille meno, che differenza fa del resto? E la guerra bellezza e i dettagli han poca importanza.
l
Venerdi a Ostuni Viaggio all’Eden
Festival della Letteratura di Viaggio
direttore artistico: Antonio Politano
X edizione
Ostuni 8-10 settembre 2017
Venerdi 8 settembre
Ore 20.30
Fino a Kathmandu e Brindisi, dalla Macedonia alla Siria
Chiostro di San Francesco, Piazza della Libertà
[«Conoscere i luoghi, vicino o lontani, non vale la pena, non è che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica, è vera geografia», Wolfgang Johann Goethe] Visioni locali e globali, in alcune produzioni dell’editoria nata in Puglia, dall’editore di respiro e prestigio nazionale alle piccole case editrici di qualità. Incontro con Emanuele Giordana, autore di Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu (Laterza), Matteo Sabato, per Crocevia, rivista di scritture straniere, migranti e di viaggio (Besa), Pierfrancesco Rescio, autore di Via Appia. Strada di imperatori, soldati e pellegrini e Via Traiana. Una strada lunga duemila anni (Schena Editore). Con accompagnamento musicale e letture.
Visioni locali e globali, in alcune produzioni dell’editoria nata in Puglia, dall’editore di respiro e prestigio nazionale alle piccole case editrici di qualità. Incontro con Emanuele Giordana, autore di Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu (Laterza), Matteo Sabato, per Crocevia, rivista di scritture straniere, migranti e di viaggio (Besa), Pierfrancesco Rescio, autore di Via Appia. Strada di imperatori, soldati e pellegrini e Via Traiana. Una strada lunga duemila anni (Schena Editore). Con accompagnamento musicale e letture.
La diaspora rohingya nel mondo
Fonte: Al Jazeera settembre 2017Oggi 7 settembre: According to the UN office in Cox’s Bazaar, over 164,000 refugees have crossed into Bangladesh since August 25 [Mohammad Ponir Hossain/Reuters]
Rohingya? Una montagna di bugie dice Suu Kyi
 Mentre Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e ministro degli Esteri del Myanmar, liquida la questione rohingya come un “enorme iceberg di disinformazione”, fonti del governo di Dacca citate dalla stampa locale accusano i soldati birmani di aver disseminato mine antiuomo lungo il confine col Bangladesh per impedire ai profughi di far ritorno nel “loro” Paese. Il governo di Dacca ha consegnato ieri pomeriggio una protesta formale ai diplomatici di Naypyidaw e, anche se nelle note ufficiali non si fa menzione di ordigni, nell’incontro al ministero degli Esteri della capitale bangladese la questione sarebbe stata affrontata. Se la notizia fosse confermata (cioè causando vittime) sarebbe di estrema gravità proprio nel momento in cui le prime reazioni alla persecuzione della minoranza musulmana del Myanamr cominciano sempre di più a travalicare i confini nazionali dei due Stati coinvolti: il Myanmar che caccia e il Bangladesh che accoglie. Il flusso dei profughi si sarebbe attestato a oltre 10mila unità al giorno e, secondo le Nazioni unite, martedi scorso il bilancio sarebbe già stato di 125mila. Non è però chiaro quanti riescano di fatto a passare il fiume Naf che divide come frontiera i due Paesi: molti sarebbero infatti imprigionati nello no man’s land tra i due Stati asiatici.
Mentre Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e ministro degli Esteri del Myanmar, liquida la questione rohingya come un “enorme iceberg di disinformazione”, fonti del governo di Dacca citate dalla stampa locale accusano i soldati birmani di aver disseminato mine antiuomo lungo il confine col Bangladesh per impedire ai profughi di far ritorno nel “loro” Paese. Il governo di Dacca ha consegnato ieri pomeriggio una protesta formale ai diplomatici di Naypyidaw e, anche se nelle note ufficiali non si fa menzione di ordigni, nell’incontro al ministero degli Esteri della capitale bangladese la questione sarebbe stata affrontata. Se la notizia fosse confermata (cioè causando vittime) sarebbe di estrema gravità proprio nel momento in cui le prime reazioni alla persecuzione della minoranza musulmana del Myanamr cominciano sempre di più a travalicare i confini nazionali dei due Stati coinvolti: il Myanmar che caccia e il Bangladesh che accoglie. Il flusso dei profughi si sarebbe attestato a oltre 10mila unità al giorno e, secondo le Nazioni unite, martedi scorso il bilancio sarebbe già stato di 125mila. Non è però chiaro quanti riescano di fatto a passare il fiume Naf che divide come frontiera i due Paesi: molti sarebbero infatti imprigionati nello no man’s land tra i due Stati asiatici.
Quanto alla Nobel, accusata di un silenzio imbarazzante e connivente con le scelte dei militari e che è stata fortemente criticata da altri Nobel – come Malala – e dalla stessa Amnesty International (l’organizzazione che per anni ha seguito il suo caso), il suo ufficio ha reso nota una telefonata che Suu Kyi ha avuto con Erdogan, il leader turco che tra i primi ha criticato il Myanmar sulla questione rohingya (pur avendo di che riflettere su quanto Ankara sta facendo con gli oppositori al regime). Suu Kyi sostiene che l’intera vicenda è frutto di disinformazione di cui sarebbero colpevoli “terroristi”, come i militari hanno definito il gruppo armato secessionista responsabile degli attacchi del 25 agosto che hanno dato la stura a una una reazione brutale dell’esercito birmano. Secondo Suu Kyi, il suo Paese sta già difendendo la popolazione dello Stato di Rakhine, dove vive la maggior parte dei rohingya, “nel miglior modo possibile”. Commento assai poco credibile anche perché l’unico in sostanza fatto dalla Nobel sulla vicenda.
 |
| Lelio Basso: Qui le dichiarazioni dei giudici del Tpp al lancio della sessione sul Myanmar che si è tenuta a Londra, nel marzo del 2017 |
Per ora, soprattutto da parte occidentale (con l’esclusione del papa che andrà in Myanmar a fine novembre), le reazioni al dramma della minoranza senza cittadinanza del Myanmar sono state blande e poco più che formali. Solo il Palazzo di Vetro ha preso una posizione chiara e lo stesso stanno facendo soprattutto Paesi a maggioranza musulmana. La Malaysia, la prima nazione ad aver usato per i rohingya il termine “genocidio”, ospiterà tra l’altro dal 18 al 22 settembre una sessione del Tribunale Permanente dei Popoli (Ttp, fondato da Lelio Basso a prosecuzione del lavoro del Tribunale Russell II) che si occuperà dei crimini commessi dal Myanmar nei confronti delle minoranza e in particolare nei casi dei Rohingya, dei Kachin e dei musulmani (5% della popolazione). E’ stata proprio Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia che ha vinto le elezioni del 2015, a non volere candidati musulmani nel suo partito. Allora la questione rohingya aveva già visto le prime violenza – nel 2012 – da parte di gruppi mobilitati da estremisti buddisti anche con l’abito monacale. Ma in seguito, nel 2016, i pogrom si sono ripetuti con l’effetto di cacciare oltre 70mila rohingya. Questa volta il numero dei profughi si è già raddoppiato: si lasciano alle spalle una regione in fiamme e dove questa volta sono già morte 400 persone.
Rohingya/Rakhine. Chi ha appiccato il fuoco? (aggiornato)*
 |
| La bandiera dei secessionisti. Per il governo sono loro ad aver distrutto migliaia di case |
Mentre il Programma alimentare dell’Onu ha deciso di sospendere gli aiuti nello Stato birmano del Rakhine dove, dal 25 agosto, infuria l’ennesimo pogrom contro la minoranza rohingya, i militari del Myanmar hanno innescato anche una guerra di numeri. Fonti governative hanno tracciato un bilancio di 2.625 case date alle fiamme nei villaggi di Kotankauk, Myinlut e Kyikanpyin e in due distretti. Ma sarebbero case incendiate dall’Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army), il gruppo armato definito “terrorista” responsabile degli attacchi di agosto. Un conteggio che non risponde a quanto affermano le testimonianze degli sfollati e le ricerche di Human Rights Watch che accusano i militari della responsabilità degli incendi: «Nuove immagini mostrano la totale distruzione di un villaggio musulmano e fanno crescere seriamente la preoccupazione che tale stato di devastazione nel Nord del Rakhine possa essere ben più vasto di quanto credevamo», ha detto alla Reuters Phil Robertson il vicedirettore Asia dell’organizzazione. In quel villaggio il 99% degli edifici è andato in fumo.
Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati il bilancio di chi è in fuga verso il Bangladesh ha ormai sfondato quota 58mila sabato e quota 75mila domenica e fa pensare che il pogrom sia di proporzioni ancora più vaste di quello dell’ottobre scorso, quando in migliaia scapparono verso il Paese vicino. Ma oggi le condizioni sono cambiate e il Bangladesh oppone resistenza per evitare un’altra invasione di profughi in un Paese dove povertà e sovrappopolazione sono due costanti. La gente resta dunque intrappolata nella no man’s land tra i due Paesi mentre il flusso alla frontiera non si arresta.
 |
| Il lavoro di Hrw attraverso il satellite contraddice la versione dei militari |
Il segretario generale dell’Onu Guterres esprime «seria preoccupazione» ma le sue parole servono a poco. La sua preoccupazione in compenso si è tradotta nello stop all’agenzia con sede a Roma che distribuisce gli aiuti alimentari ai rohingya in Myanmar, la cui popolazione sfollata internamente ha raggiunto quota 250mila, la metà dei quali vive in campi allestiti per dar loro rifugio dal 2012 (quando si scatenò una campagna che vide distruzioni e violenze in diverse aree musulmane del Paese). Nell’ottobre del 2016, a seguito di nuove violenze, i militari vietarono alle agenzie umanitarie di intervenire dando così la stura all’emigrazione di massa. Secondo Al Jazeera, il Pam è stato accusato dal governo di aver fornito razioni alimentari poi finite nelle mani dei ribelli e dello stesso tenore sono state le accuse verso altre agenzie umanitarie. Come il caso italiano ben dimostra, quando i piani di un governo violano le regole elementari del diritto, parte sempre una campagna che demonizza Ong e organizzazioni umanitarie, colpevoli di essere neutrali e di assistere chi ha bisogno senza fare domande.
A volte però succedono anche cose in controtendenza. Se è vero che il governo di Dacca sta cercando di porre un freno all’immigrazione di nuovi sfollati, un corrispondente della Bbc da Cox Bazar, la città al confine dove ha sede il Comitato che si occupa dei rifugiati, sostiene che la polizia bangladese sta in parte ignorando gli ordini che vengono dall’alto e chiude un occhio quando vede la gente in fuga passare la frontiera. Può anche darsi che il Bangladesh tenga due posizioni: una ufficiale, l’altra – nascosta – umanitaria. Un Paese disastrato dalle piogge alluvionali, dove vivono 1145 persone per chilometro quadrato e dove il reddito medio è di 160 dollari al mese, dà una lezione di civiltà, accogliendo non senza difficoltà chi scappa dalla guerra. Nei suoi campi profughi alloggiano decine di migliaia di sfollati e nel Paese i rohingya sono ormai almeno mezzo milione, arrivati a ondate successive. Intanto si aspetta la visita del premier indiano Modi in Myanmar. Si parlerà dei rohingya. L’India ne vuole espellere 40mila. Difficile che Naypyidaw li voglia indietro.
* aggiornato domenica 3 settembre 2017
Una campagna per Santiago Maldonado
Si è svolta a Buenos Aires una grande manifestazione per la scomparsa di Santiago Maldonado, un attivista scomparso in Patagonia. Una richiesta di verità e giustizia come per Giulio Regeni…
Rohingya, i generali danno i numeri
 |
| La pagina fb del generale generale Min Aung Hlaing capo delle forze armate |
Tra i corpi dei 15 rohingya che il colonnello Ariful Islam dice all’agenzia Reuters di aver trovato venerdi sulle rive del fiume Naf, che divide il Myanmar dal Bangladesh, ci sono in maggioranza bambini: sono undici a non avercela fatta. Ma non sono da annoverare tra i 399 che, con agghiacciante precisione numerica, i militari birmani hanno fatto sapere di aver ucciso nella settimana di fuoco che ha seguito il “venerdi nero” scorso, quando secessionisti rohingya hanno attaccato alcuni posti di polizia scatenando una ritorsione dal sapore di pulizia etnica. Non si tratta di una dichiarazione “ufficiale” ma di un post sulla pagina FB di uno dei più importanti generali del Paese. La strage dei rohingya ridotta a qualche “like” o a condivisione sul social più diffuso.
 |
| Myanmar, India, Cina e Bangladesh |
Il bilancio ufficiale era 108 morti e sembrava già tanto così come i 3mila scappati oltre confine. Ma da ieri le cifre sono ben altre: 400 i morti dunque tra cui, dicono i militari, 29 “terroristi”. E poi ben 38mila profughi – la cifra aumenta di ora in ora – che si aggiungono agli 87mila già arrivati in Bangladesh dopo il pogrom dell’ottobre 2016 (nel precedente, nel 2012, i morti erano stati 200 con oltre 100mila sfollati interni). I dati li fornisce l’Onu che fino a due giorni fa ne aveva contati “solo” 3mila. Ma non è ben chiaro dove questa gente si trovi: secondo fonti locali almeno 20mila sono ancora intrappolati nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di frontiera bangladesi tengono il piè fermo. Molti fanno la fine di quelli trovati dal colonnello Ariful se non riescono ad attraversare il fiume – a nuoto o con barche dov’è più largo – mentre altri aspettano il momento buono, quando si può sfuggire alle guardie di frontiera. Quel che è certo è che indietro non si può tornare. I rapporti tra i due vicini sono tesi: Dacca ha protestato per ripetute violazioni dello spazio aereo da parte di elicotteri birmani in quella che sembra, una volta per tutte, una sorta di soluzione finale per chiudere il capitolo rohingya, minoranza musulmana che, prima del 2012, contava circa un milione di persone. Adesso, di questa comunità cui è negata la cittadinanza in Myanmar, non è chiaro in quanti siano rimasti in quello che loro considerano, forse obtorto collo, il proprio Paese mentre per il governo non si tratta che di immigrati bangladesi.
 |
| Mappa del Rakhine |
Lontano dal Mediterraneo, lungo un fiume che sfocia nel Golfo del Bengala, si consuma lentamente ma con determinazione la persecuzione di un popolo. I militari agitano lo spettro di uno “stato islamico”, incarnato da un gruppo secessionista armato responsabile degli attacchi. E se anche i residenti locali non musulmani (11mila) sono oggetto di “evacuazione” dalle zone sotto tiro, Human Rights Watch ha documentato la distruzione di case e villaggi rohingya con incendi che hanno tutta l’aria di essere dolosi. Reazione troppo brutale, come dice la diplomazia internazionale, o un piano di eliminazione? «Siamo ormai in una nuova fase – dice a Radio Popolare il responsabile Asia di Hrw – e siamo convinti che dietro alle operazioni dell’esercito ci sia il governo, col piano di chiudere definitamente la questione cacciando la popolazione rohingya grazie alla campagna militare contro gli insorti».
 |
| Modi: settimana prossima in visita d’affari |
Se la diplomazia resta a guardare, i vicini non sono da meno. La Thailandia si richiama al principio di “non ingerenza”. Delhi ha deciso l’espulsione di 40mila rohingya illegali e settimana prossima il premier Modi sarà in Myanmar, Paese strategico per l’economia del colosso asiatico. La decisione ha però suscitato polemiche, editoriali sui giornali e anche il ricorso di due rohingya alla Corte suprema che, proprio, ieri ha accolto la richiesta: pare che Delhi intenda espellere persino chi già gode dello status di rifugiato con l’Acnur (14mila persone).
C’è poi un altro colosso – la Cina – che difende le ragioni del governo birmano a cominciare dalle riunioni del Consiglio di sicurezza dove fa sentire il suo peso perché la questione rohingya resti al palo. Pechino è il maggior investitore e ha interessi anche nel Rakhine, lo Stato dove vive questa scomoda minoranza. E’ interessata al porto di Kyaukphyu, strategico per i rifornimenti di petrolio. Non solo i cinesi stanno acquisendo azioni della società portuale ma finanziano l’oleodotto che dal Rakhine arriva a Kunming, nella Cina del Sud. C’è un altro investimento nella cosiddetta Kyaukphyu Special Economic Zone che prevede una linea ferroviaria. Un corridoio ritenuto vitale nel suo progetto One Belt, One Road, meglio noto come “Nuova via della seta”. E per evitare complicazioni Pechino ha ottimi rapporti con un parlamentare locale dell’Arakan National Party, ritenuto uno dei bastioni del nazionalismo identitario locale. E’ il partito che vorrebbe nel Rakhine lo stato di emergenza.
Sorpresa: in Afghanistan le truppe Usa son già aumentate! (aggiornato)
Con adamantina franchezza e a dimostrazione di un’amministrazione più “trasparente” della guerra afgana, il generale Kenneth McKenzie, joint staff director al Pentagono, ha fatto sapere che le truppe Usa sono 11mila e non 8.400 come si è sempre detto. Solo 2600 soldati in più! Washington chiarisce che non si tratta di un aumento di truppe: semplicemente erano già lì. Intanto si comincia a intravedere la nuova linea della guerra: ancora più soldati e più vittime civili. Ci sono già due casi con una dozzina di civili morti per raid aerei avvenuti recentemente a Logar e a Herat. Raid aerei a caccia di talebani con effetti collaterali. Ecco la nuova guerra dello sceriffo Trump che resta comunque una nebulosa. Pericolosa (le vittime civile sono state confermate venerdi da Uanma, la sede Onu a Kabul.
Ma come la vedono gli alleati nell’area. Cosa ne pensano a Kabul e a Islamabad? C’è chi la approva e chi ne teme gli effetti. Quanto agli americani, sono divisi della nuova strategia presidenziale (vedi foto in basso)?
Lunga gestazione
Il 22 agosto, a oltre un mese dalla data in cui i nuovi obiettivi americani sull’Afghanistan avrebbero dovuto essere resi noti, il presidente Trump li ha definiti con un discorso ripreso in diretta Tv. Ma tutti gli osservatori, americani e non, sono abbastanza concordi nel definire la nuova strategia presidenziale abbastanza oscura e non molto dissimile da quella che aveva caratterizzato il mandato di Obama. Quella che al momento appare una nebulosa senza obiettivi tattici – se non quello strategico finale di “vincere! – e che dovrebbe modularsi senza un’agenda precisa sulle richieste “che vengono dal terreno” ha lasciato perplessa buona parte dei commentatori statunitensi e gli analisti dei Paesi della Nato che, al di là delle dichiarazioni di principio (la fedeltà all’alleato americano), non nascondono le preoccupazioni per un nuovo surge di cui non si capisce né la portata né la quantità e la qualità di nuove possibili truppe, né quali esattamente saranno gli accordi tra Usa, Nato e governo afgano sulla gestione della catena di comando.
Ma la strategia di Trump, costata almeno otto mesi di gestazione e svelata in parte col filtrare ciclico di indiscrezioni di stampa basate su fonti anonime dell’Amministrazione, ha però certamente sollevato due reazioni, diametralmente opposte quanto chiaramente espresse, nei due principali attori regionali: l’Afghanistan, felice e soprattutto sollevato dalle dichiarazioni di Trump, e il Pakistan, additato in modo più violento che in passato come il “cattivo” istituzionale, eterno inaffidabile doppiogiochista, colpevole di ospitare le retrovie talebane.
Contenti a Kabul
| La base di Bagram, caposaldo americano |
Il governo di Kabul aspettava con un certa ansia che il presidente americano svelasse la sua strategia per diversi motivi: il primo, e più cogente, risiede nel fatto che a Kabul c’è un governo debole, con un sistema economico finanziario in caduta libera e che gode ormai di consensi ridotti al lumicino. Il fatto che gli americani decidano di non abbandonare l’Afghanistan – cosa che si poteva temere dai molti tweet di Trump durante la campagna elettorale – significa per Kabul non solo che il magro flusso di denaro garantito dalla permanenza della missione alleata non si arresterà ma che, presumibilmente, aumenterà. Il presidente ha fatto capire di voler sostenere un miglioramento delle forze aeree locali (argomento ribadito anche dal segretario generale della Nato), che sono l’apparato più costoso della guerra, e di essere favorevole all’utilizzo di nuove armi come ha dimostrato la bomba da 11 tonnellate lanciata in aprile nella zona di confine col Pakistan infestata da militanti dello Stato islamico. Infine, anche se non è chiara la quantità di “stivali sul terreno” che Washington è disposta a impiegare, è evidente che un aumento di uomini ci sarà e che lo stesso avverrà, pur se con riluttanza, anche per i partner Nato. Nuove truppe significano più denaro fresco e più spese che ridaranno fiato all’economia di guerra (che che ai tempi in cui la coalizione contava 130mila soldati, andava a gonfie vele), con nuove commesse, posti di lavoro e un possibile rilancio di settori come la logistica e l’edilizia oltre a un rafforzamento della moneta. La presenza resta garantita, sia sul piano militare, sia sul piano politico. Infine Kabul potrebbe sentirsi rassicurata anche dal fatto che, accanto a Trump, ci sono tre generali: il consigliere per la sicurezza McMaster, il titolare della difesa Mattis e il capo di gabinetto Kelly. Dovrebbero esser loro a garantire la continuità (e la mano più pesante) chiesta da mesi dal generale John Nicholson, al comando delle truppe Usa e Nato nel Paese. L’unico vero ostacolo all’interno dell’Amministrazione è infatti andato a casa: con il siluramento di Bannon, il capo stratega della Casa Bianca – il più cauto e il più contrario a un nuovo surge – le cose andranno come devono andare, garantendo a Kabul di tornare ad essere, da Cenerentola del Pentagono, una nuova reginetta, pur se in forma più contenuta che in passato.
Scontenti a Islamabad
 Quanto a Kabul si festeggia, tanto a Islamabad si mastica amaro. Nel discorso di Trump il Pakistan è stato uno degli elementi centrali del “piano” e il responsabile maggiore, nelle parole del presidente, di una guerra che non si riesce a vincere. Tanto rapidi sono stati gli apprezzamenti di Kabul (poche ore dopo il discorso, Trump incassava il plauso dell’ambasciatore afgano a Washington e subito dopo quello di Ghani e del suo governo) tanto veloci sono state le rimostranze pachistane che hanno avuto una buona eco anche nelle dichiarazioni della Cina, il Paese più solidale con Islamabad. Il Pakistan – che versa tra l’altro in un momento complesso della sua vita politica dopo l’uscita di scena del premier Nawaz Sharif per il cosiddetto scandalo Panamaleaks – si è indignato per il tenore delle accuse – per altro non molto diverse da quelle sempre avanzate dall’amministrazione Obama – ma soprattutto perché Trump si è rivolto all’India chiedendole uno sforzo maggiore nel Paese dell’Hindukush: un invito che, alle orecchie pachistane, suona come un via libera a Delhi per rafforzare la testa di ponte già creata in Afghanistan con l’apertura di consolati, l’esborso di aiuti economici e progetti di formazione per l’esercito afgano. Un consolidamento che Islamabad vede come il fumo negli occhi. Infine, Trump ha omesso di ricordare, cosa che la diplomazia americana ha invece sempre fatto, di enumerare almeno gli sforzi del governo contro gli islamisti e il tributo di sangue pagato dai suoi militari nelle aree di confine. Senza contare il fratto che, se i talebani afgani hanno i loro santuari in Pakistan, i talebani pachistani godono in Afghanistan della possibilità di sfuggire alla giustizia del Paese dei puri.
Quanto a Kabul si festeggia, tanto a Islamabad si mastica amaro. Nel discorso di Trump il Pakistan è stato uno degli elementi centrali del “piano” e il responsabile maggiore, nelle parole del presidente, di una guerra che non si riesce a vincere. Tanto rapidi sono stati gli apprezzamenti di Kabul (poche ore dopo il discorso, Trump incassava il plauso dell’ambasciatore afgano a Washington e subito dopo quello di Ghani e del suo governo) tanto veloci sono state le rimostranze pachistane che hanno avuto una buona eco anche nelle dichiarazioni della Cina, il Paese più solidale con Islamabad. Il Pakistan – che versa tra l’altro in un momento complesso della sua vita politica dopo l’uscita di scena del premier Nawaz Sharif per il cosiddetto scandalo Panamaleaks – si è indignato per il tenore delle accuse – per altro non molto diverse da quelle sempre avanzate dall’amministrazione Obama – ma soprattutto perché Trump si è rivolto all’India chiedendole uno sforzo maggiore nel Paese dell’Hindukush: un invito che, alle orecchie pachistane, suona come un via libera a Delhi per rafforzare la testa di ponte già creata in Afghanistan con l’apertura di consolati, l’esborso di aiuti economici e progetti di formazione per l’esercito afgano. Un consolidamento che Islamabad vede come il fumo negli occhi. Infine, Trump ha omesso di ricordare, cosa che la diplomazia americana ha invece sempre fatto, di enumerare almeno gli sforzi del governo contro gli islamisti e il tributo di sangue pagato dai suoi militari nelle aree di confine. Senza contare il fratto che, se i talebani afgani hanno i loro santuari in Pakistan, i talebani pachistani godono in Afghanistan della possibilità di sfuggire alla giustizia del Paese dei puri.
 |
| Divisi: nel sondaggio di Politico.com il 45% degli americani approva l’aumento di truppe. Il 41% è contrario |
Incognite sul futuro
Se lo si guarda da Kabul e da Islamabad l’oscuro piano afgano di Trump resta dunque una nebulosa con luci e ombre non priva di rischi. I rapporti con Kabul sono ottimi ma sono basati sulla debolezza di un governo senza consensi e disposto a tutto pur di ricevere nuovi finanziamenti esterni. Un alleato debole in un quadro complesso. I rapporti col Pakistan rischiano invece di peggiorare e nessuno meglio di Islamabad può far deragliare qualsiasi processo negoziale. Processo su cui merita spendere una parola. Trump ha invitato i talebani a scendere a patti ma li ha anche minacciati, con uno stile da sceriffo, senza alcuna concessione. Una parafrasi delle sue parole l’ha poi fatta due giorni dopo il suo discorso, il generale Nicholson a Kabul che ha apostrofato la guerriglia in turbante “banda di criminali”, dediti al traffico di droga e ai rapimenti a scopo di estorsione. Invitare il nemico al tavolo negoziale minacciandolo di morte e dandogli dell’assassino, può forse funzionare come mossa tattica ma è l’esatto opposto di una strategia diplomatica che dovrebbe, con cautela, costruire le condizioni per far tacere le armi e tentare un dialogo che vada oltre gli insulti. La sensazione è che, dal punto di vista diplomatico, gli Stati Uniti si stiano infilando in un ginepraio che complicherà le cose più che renderle chiare. E se queste son le premesse politiche anche la guerra rischia di essere l’ennesima nebulosa senza via d’uscita.
Il profitto dell’espulsione
 Sarebbero già 5mila i rohingya in fuga che tentano di raggiungere il Bangladesh. Gente che scappa dall’ennesima stretta militare che ha tutta l’aria di un pogrom verso la minoranza musulmana che fugge da un territorio che è appena stato fotografato dal satellite cui ha fatto seguito una denuncia di Human Roights Watch: incendi a macchia di leopardo nelle tre township (unità amministrativa birmana) di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, lungo un percorso di 100 chilometri in aree prossime alla frontiera bangladese. Di questi 5mila però circa 4mila – secondo il magazine birmano Irrawaddy – si trovano nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di Dacca li respingono. Lo hanno già fatto con 550 persone. Ad altre lasciano che passino il confine per avere medicine ma poi devono tornare dall’altra parte, dove c’è il “loro” Paese che però non li vuole. Gli appelli dell’Onu cadono nel vuoto e intanto il governo agita lo spettro di uno “stato islamico” nel cuore del buddista Myanmar, progetto all’origine dell’attacco del 25 agosto a trenta posti di polizia. In una conferenza stampa, il ministro dell’Interno generale Kyaw Swe (i militari gestiscono anche Difesa e Frontiere) ha detto che l’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) vuole stabilirlo nelle township di Maungdaw e Buthidaung.
Sarebbero già 5mila i rohingya in fuga che tentano di raggiungere il Bangladesh. Gente che scappa dall’ennesima stretta militare che ha tutta l’aria di un pogrom verso la minoranza musulmana che fugge da un territorio che è appena stato fotografato dal satellite cui ha fatto seguito una denuncia di Human Roights Watch: incendi a macchia di leopardo nelle tre township (unità amministrativa birmana) di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, lungo un percorso di 100 chilometri in aree prossime alla frontiera bangladese. Di questi 5mila però circa 4mila – secondo il magazine birmano Irrawaddy – si trovano nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di Dacca li respingono. Lo hanno già fatto con 550 persone. Ad altre lasciano che passino il confine per avere medicine ma poi devono tornare dall’altra parte, dove c’è il “loro” Paese che però non li vuole. Gli appelli dell’Onu cadono nel vuoto e intanto il governo agita lo spettro di uno “stato islamico” nel cuore del buddista Myanmar, progetto all’origine dell’attacco del 25 agosto a trenta posti di polizia. In una conferenza stampa, il ministro dell’Interno generale Kyaw Swe (i militari gestiscono anche Difesa e Frontiere) ha detto che l’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) vuole stabilirlo nelle township di Maungdaw e Buthidaung.
C’è dunque anche una scusa securitario-terroristica dietro alle violenze in cui sarebbero coinvolti, stando ai racconti che alcuni fuggitivi han fatto a Reuters, anche civili: «Siamo qui perché abbiamo paura per le nostre vite, ma non possiamo attraversare il confine e quindi non sappiamo cosa fare» dice Aung Myaing e aggiunge che militari e civili buddisti saccheggiano e incendiano i loro villaggi, utilizzando anche lanciagranate. E quando il reporter chiede loro della guerriglia risponde: «Non li abbiamo visti, non abbiamo alcuna relazione con loro. Ma il Myanmar non distingue tra i terroristi e i civili. Stanno cacciando tutti i rohingya». Granate, saccheggi, incendi e un bilancio che ha già superato i cento morti.
 |
| La bandiera di Tatmadaw, l’esercito birmano. Non solo militari. Sopra, la mappa degli incendi pubblicata da Hrw |
Le immagini diffuse da Hrw sugli incendi fanno pensare a fotogrammi più vecchi: quelli con cui la stessa organizzazione, nell’autunno scorso, riuscì a stimare a 1500 gli edifici incendiati. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township, la zone dello Stato di Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya.
Sono quelle immagini a rendere più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma l’ipotesi che, dietro alla cacciata di queste genti senza documenti, ci sia anche un piano economico per sfruttare le loro terre. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione delle terre considerate mal sfruttate per affidarle a compagnie private e metterle a profitto, land grabbing per società con grandi mezzi in nome dello sviluppo. Dal 2012 una legge ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari aprendo anche a investitori stranieri: assalto alla foresta (ogni anno 400mila ettari) o a piccoli appezzamenti confiscati visto che la legge ne aboliva una del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya siamo a 1.269mila ettari con un balzo rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012.
Rohingya, fuga senza fine
Sembra che si chiami Francesco Bergoglio l’ultima speranza dei Rohingya, minoranza musulmana in fuga dal suo Paese e ora respinta sia dal Bangladesh che ha chiuso le frontiere sia dall’India che ne minaccia l’espulsione. Ma il pontefice, che dopo aver ricordato all’Angelus la tragedia birmana e fatto sapere a sorpresa ieri mattina che andrà in Myanmar e in Bangladesh, inizierà il suo viaggio solo il 27 novembre: mancano tre mesi, un tempo sufficiente a ridurre al minimo questa minoranza ormai così vessata e strangolata dalla violenza che ormai i suoi numeri in Myanmar sono ridotti al lumicino.
L’inizio dell’ultimo pogrom è di alcune settimane fa quando i militari birmani hanno stretto d’assedio tre township nella zona orientale dello Stato di Rakhine, la regione al confine con Bangladesh e India dove vivevano oltre un milione di rohingya, una minoranza che in Myanmar non ha diritto alla cittadinanza, non può votare, è considerata immigrazione bangladese illegale e vive in gran parte in campi profughi nel suo stesso Paese. Per reagire all’accerchiamento delle aree di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, il gruppo armato Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) – accusato di terrorismo da Naypyidaw – ha sferrato venerdi scorso un’offensiva contro trenta obiettivi militari, scatenando una vera e propria battaglia con oltre 100 morti e la conseguente repressione – anche a colpi di mortaio – mentre si riprendeva una fuga in realtà mai interrotta dall’ottobre scorso quando si erano verificati incidenti simili. L’uso “sproporzionato” della forza militare – avverte International Crisis Group, un organismo di monitoraggio che da tempo segue la questione – non è solo da condannare in sé ma rischia di favorire la radicalizzazione della minoranza, favorendo la crescita di gruppi armati. Arsa, guidato da Ata Ullah alias Abu Ammar Jununi, rohingya nato in Pakistan che godrebbe di finanziamenti privati pachistani e sauditi, ha lanciato messaggi video di sfida al governo. Ma gli scontri nelle tre città del Nord hanno registrato anche singoli episodi di violenza verso buddisti, indù o altre minoranze.
Il flusso della fuga verso il Bangladesh si ferma quando le acque si calmano ma riprende appena l’esercito stringe la morsa. A metà agosto, la stampa del Bangladesh ha cominciato a dare conto dei nuovi arrivi che già avevano totalizzato un migliaio di profughi, riusciti a passare la frontiera clandestinamente. Ora sono almeno 3mila (in tre giorni), secondo l’Onu. Da quel che si capisce, aumentata la pressione ai posti tradizionali di passaggio dei profughi, i rohingya in fuga hanno trovato nuovi percorsi per sfuggire alle guardie accampandosi in campi informali e senza registrarsi. Ma in tanti sono ora nella no man’s land tra i due Paesi perché Dacca ha detto basta: oltre 80mila sono i rohingya già arrivati in Bangladesh da ottobre e in tutto sono circa mezzo milione, arrivati a ondate successive a partire già dal secolo scorso. Una tragedia senza fine consumata in silenzio ma con un bubbone sempre più purulento che adesso fa rumore anche se, di fatto, non si va oltre le pressioni verbali: il Myanmar non è la Libia e neppure l’Afghanistan o i Balcani. E le parole diritti, pulizia etnica, tortura, stupro, omicidio commuovono ma fino a un certo punto.
 |
| I messaggi di Arsa su Youtube. A dx il simbolo dell’organizzazione |
La situazione è complicata dal fatto che al potere c’è, per la prima volta da decenni, un governo civile guidato, anche se informalmente (la Costituzione glielo vieta), da una Nobel per la pace. Ma la signora Suu Kyi, figlia di un eroe della resistenza anti britannica e icona della battaglia per i diritti e la libertà, è rimasta zitta. O meglio, ha cercato in modo indolore di far digerire l’amara pillola con mezze parole e qualche timido rimedio: l’ultimo consisterebbe nell’applicazione delle raccomandazioni contenute in un dossier scritto da Kofi Annan che chiede al Myanmar la revisione della legge sulla cittadinanza. Ma Suu Kyi deve fare i conti con un potere militare ferocemente contrario alle aperture. Per eccesso di zelo buddista o spinto dal pericolo islamista? La sociologa Saskia Sassen ha spiegato che i generali, casta economica oltreché militare, stanno favorendo l’accaparramento dei terreni del Rakhine, resi sempre più appetibili se chi li possiede fugge e non ha le carte per dimostrarlo. Gli strumenti per opporsi sono scarsi anche se ieri il parlamento ha bloccato la richiesta della minoranza (filo militare) di dichiarare lo stato di emergenza a Maungdaw.
La solidarietà è scarsa a parte quella di Bergoglio, l’unico capo di Stato che ha strigliato Suu Kyi quando alcuni mesi visitò l’Europa. Malaysia e Indonesia fanno accoglienza. Molta l’ha fatto il Bangladesh che ora però chiude. Quanto all’India, fa sapere che vuole rimpatriare i rifugiati sul suolo indiano: 14mila registrati con l’Acnur e, pare, altri 400mila illegali.
Nuove violenze nel Rakhine birmano
Nelle prime ore della giornata di ieri un attacco congiunto su una trentina di obiettivi militari nella Birmania occidentale ha scatenato l’ennesima ondata di violenza nello Stato del Rakhine. La regione è sede anche della minoranza musulmana dei Rohingya nel Paese a maggioranza buddista dove la Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi è al governo ma sotto la spada di Damocle di un ancora forte potere militare. L’attacco coordinato è avvenuto nelle aree di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung dopo un’escalation di violenze seguite, nelle ultime settimane, a un ennesimo invio di soldati nella regione che avrebbe spinto alla fuga verso il Bangladesh migliaia di Rohingya, andati a ingrossare le fila di una massa di profughi che da ottobre scorso conta nel Paese vicino già oltre 80mila nuovi rifugiati. Nello stesso periodo di sarebbero verificate nel Rakihine violenze anche contro monaci buddisti, molti dei quali poi evacuati.
Gli scontri di ieri, rivendicati da una sigla nazionalista rohingya – Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) che ha dato notizia delle azioni via twitter – si sarebbero conclusi con un bilancio – secondo fonti governative – di oltre 80 morti: dieci poliziotti, un soldato, undici agenti della sicurezza, un ufficiale dell’immigrazione e 59 sospetti militanti dei circa 150 che, dalla una del mattino, avrebbero scatenato l’attacco. Le Nazioni Unite hanno chiesto alle parti di astenersi da nuove violenze, ormai cicliche nello Stato di Rakhine.
L’azione dell’Arsa è stata messa in relazione alla pubblicazione delle raccomandazioni che l’ex segretario Onu Kofi Annan ha consegnato al governo birmano poche ora prima dei raid anche se – sebbene molto probabilmente il rapporto di Annan venga ritenuto dall’Arsa troppo moderato – l’attacco fa pensare a un’azione preordinata e preparata da tempo, forse proprio a partire dalle violenze scatenate col nuovo “surge” dell’esercito nel Rakhine nelle ultime settimane. Così sembrerebbe di capire anche dal tenore delle dichiarazioni di Arsa secondo cui si sarebbe trattato di un’ “azione difensiva”. La signora Suu Kyi ha condannato le azioni della guerriglia e il suo ufficio ha rilasciato una dichiarazione nella quale si citano estremisti “bengalesi”, il termine con cui i Rohingya – senza cittadinanza né diritti in Myanmar e considerati immigrati illegali – vengono normalmente chiamati. Proprio il documento di Annan, morbido probabilmente per evitare a Suu Kyi uno scontro coi militari, chiede comunque che ai Rohingya siano riconosciuti i diritti che sono loro negati dalla legge del 1982 sulla cittadinanza, di cui il rapporto chiede una revisione: si tratta di raccomandazioni che un comitato ministeriale ad hoc ha ora il compito di studiare e mettere in pratica secondo quanto promesso dalla Nobel. A dimostrazione di quanto sia delicata la situazione in cui si trova il governo civile, il capo delle Forze armate Min Aung Hlaing ha messo in questione l’imparzialità del rapporto e lo ha accusato di una ricostruzione inaccurata.
La nebulosa afgana disastro annunciato. Ora di tornare a casa
 |
| Nicholson durante la conferenza stampa. La foto correda l’articolo sulle esternazioni del generale |
Rinfrancato dal fatto che per ora non sarà mandato a casa e bypassando le più elementari categorie della diplomazia negoziale, il generale Jhon Nicholson, al comando delle truppe Usa e Nato in Afghanistan, ha detto la sua dopo le esternazioni del presidente. Il generale, sicuro del fatto che ormai Trump abbia passato la mano ai McMaster (sicurezza) e Mattis (Difesa) di turno (generali come il suo capo gabinetto Jhon Kelly, pensa che ormai tocchi a lui interpretare anche politicamente la confusa idea che Trump vuole applicare in Afghanistan per vincere la guerra. E così ha definito i talebani una “criminal organization that is more interested in profits from drugs, kidnapping and murder for hire.” Un testo che non mi pare il caso di stare a tradurre…
Forse anche Trump pensa lo stesso ma se le parole del presidente sono state improvvide – come in altri casi – nel suo discorso di due giorni fa sull’Afghanistan, quelle di Nicholson sono una traduzione ancora peggiore. Da un lato invita i talebani – come Trump – a deporre le armi, dall’altro apostrofa la parte che dovrebbe negoziare nel modo che abbiamo riportato. Nemmeno Trump lo sceriffo era giunto a tanto. Sarebbe come se, dovendo negoziare col vostro padrone di casa l’affitto e/o lo sfratto, gli deste del bandito prima ancora di esservi seduti al tavolo. Anche un idiota capisce che se c’è un modo per irritare i talebani questa è la via giusta. Nemmeno più il bastone e la carota. Solo bastoni e, come si evince dalle parole del generale, un bastone sempre più aereo: sempre più raid, bombe dal cielo, droni e omicidi mirati. Nicholson e Trump pensano che i talebani afgani si possano trattare come l’Isis a Raqqa e che anzi siano più o meno la stessa cosa. In un Paese dove l’intelligenza e l’analisi non mancano, quella che si sente è adesso una sola campana che annuncia una stagione pericolosa, dominata dai generali. Che, come la storia insegna, son magari bravi a fare la guerra ma in politica sono un disastro. Purtroppo il governo di Kabul appoggia e la Nato pure. Stiamo andando verso una nuova catastrofe e non si riesce che ad applaudire.
Allora sarebbe bene prendere subito le distanze da questa strategia oscura e muscolare che già si annuncia col fiato corto e danni di lungo periodo. Sarebbe opportuno che i nostri politici pensassero anche all’Afghanistan dove abbiamo quasi mille soldati che stiamo esponendo a un’ennesima guerra peggio guerreggiata delle precedenti e che non risiede certo nei nostri interessi nazionali. Un governo serio si ritirerebbe da una politica avventurista e guerrafondaia e, semmai, impiegherebbe i soldi che ora spende ( circa 500mila euro al giorno) in opere di bene e di pace. Ma, come avvenne per la Libia e prima ancora per l’Iraq, alla fine sappiamo solo dire signorsi e, nel farlo, non facciamo un piacere né ai nostri alleati né – tanto meno – agli afgani. Che iddio protegga quel povero popolo. E che il mio paese abbia un sussulto di orgoglio e intelligenza.
Lo sceriffo, l’Alleanza e le nostre responsabilità
 |
| Marshall Trump, stanco dei polticanti di Washington ha adesso una nuova idea: “Ci penso io”. Ma come non si sa |
E’ una strana “nuova” strategia quella che Donald Trump, e con lui la Nato, sta mettendo in piedi per rinfocolare la guerra infinita che da 16 anni vede impegnata anche l’Italia. Una nuova guerra senza numeri e con molte reticenze, frasi di rito e un plauso incondizionato a un piano che par confuso allo stesso burattinaio che ne dovrebbe tirare le fila. Un piano che non vuole insegnare nulla agli afgani e li invita a fare la pace coi talebani ma che al contempo mira a far fuori i “nemici” con maggior determinazione. Una strategia che chiede nuove truppe ma quante non si sa. Una guerra da modularsi sulle richieste che vengono dal terreno ma che sembra in realtà una nebulosa senza obiettivi che pare rispondere alla domanda che lo stesso Trump si faceva in campagna elettorale: «Che ci stiamo a fare»? L’impressione è che lo sceriffo di New York, dove Trump è nato nel 1946, ancora non lo sappia anche se i suoi generali devono aver convinto il guerrafondaio riluttante che l’Afghanistan bisogna controllarlo.
Quel che Trump e i suoi generali sanno non è solo che, come ha twittato Trump nel 2012, l’Afghanistan è un Paese dove «abbiamo costruito strade e suole per della gente che ci odia» ma l’avamposto da cui, grazie a una decina di basi aeree, gli Stati Uniti possono controllare l’Iran e soprattutto la Russia. Nessuno disvela o ammette questa evidente verità che costò a Washington un lungo braccio di ferro con Karzai che non voleva cedere ai diktat americani.
Il refrain resta il solito: scompaiono diritti e democrazia ma resta la lotta alle basi del terrore anche se, nel caso dei talebani, non son certo una minaccia né per gli States né per l’Europa. Per gli alleati di Trump nella Nato dovrebbe invece esser chiaro che, oggi più di ieri, restare e mandare nuove truppe come Washington chiede, significa limitarsi a sostenere un disegno soprattutto americano pur se assai più vago che in precedenza. Per ora una quindicina di Paesi avrebbero detto si: Londra manderà circa cento soldati e Varsavia altri 30. Ma di altri Paesi, come la Danimarca, il numero resta incerto mentre i tedeschi hanno chiaramente detto no e anche l’Italia, che un pensierino ce l’aveva fatto, ha poi preferito saggiamente declinare l’invito forse per evitare a Gentiloni l’ennesimo grana. Purtroppo anche se Roma non invierà altri soldati noi ne abbiamo già mille in Afghanistan che sarebbe bene far tornare a casa. Lasciarli lì significa accettare supinamente un piano confuso, incerto e dunque pericoloso. Ed esserne dunque corresponsabili.
Andarsene o restare? La strategia confusa di Trump sull’Afghanistan
 |
| A metà luglio la Casa Bianca aveva promesso di rivelare il nuovo piano per l’Afghanistan |
Donald Trump sta pensando da qualche mese a cosa fare a Kabul, un luogo in cui non ha ancora messo piede anche se si è intrattenuto al telefono più volte con Ashraf Ghani che già aveva conosciuto negli States. Ci sono sul tavolo diverse opzioni che si potrebbero riassumere in due posizioni abbastanza chiare. La prima : aumentare il numero dei soldati, intensificare i raid aerei e rivedere i laccioli imposti agli Usa da un accordo militare che li vincola ad agire solo dopo aver consultato la Difesa afgana. Seconda opzione: utilizzare un esercito di mercenari e far la guerra senza perdere uomini e consensi. Ma adesso pare ce ne sia una terza di opzione: andarsene complemtamente: full withdrawal, come ha spiegato il segretario alla Difesa Mattis in una conferenza stampa mentre diceva che ormai è questione di poco e presto si saprà quanto tutti stanno aspettando di sapere da ormai un mese, data in cui Trump avrebbe dovuto rendere nota la sua scelta.
Sappiamo che la prima opzione è appoggiata dal Pentagono ma anche da potenti repubblicani come John McCain o da generali come il consigliere per la sicurezza McMaster per non parlare dei papaveri del Pentagono e del comandante in loco John Nicholson, per quanto il generale non sia esattamente nelle grazie di Trump. La seconda opzione ha qualche sostenitore, sia nella famiglia Trump, sia nella lobby dei contractor, ma la terza – full withdrawal – è un’assoluta novità. Come si vede non sono tre opzioni parallele ma tre perpendicolari che viaggiano in opposte direzioni. Tre idee assi lontane l’una dall’altra e così differenti tra loro da giustificare in effetti un certo tentennamento: poche idee chiare insomma in una strategia confusa. Se non fosse un dramma verrebbe da sorridere.
Viaggio all’Eden a "Le antiche vie dell’Hospitale"
 XIII incontro sulla Via di San Tommaso
XIII incontro sulla Via di San Tommaso
Villa san Tommaso Majano (Udine)
sulle antiche vie dell’Hospitale,
oltre Gerusalemme
sulle Vie Reali di Persia, vie della Seta,
verso l’altra metà del Mondo
PASSAGGIO IN AFGHANISTAN
ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
A SAN TOMASO DI MAJANO (UD)
Nel frattempo, nel pomeriggio, per i bambini presenti (0-90) laboratorio di aquiloni (l’Afghanistan è il paese degli aquiloni) a cura della Refugees Public School di OIA.
Ore 17.00 Afghanistan, storia, arte, cultura e poesia. Racconti e letture a cura della Refugees Public School di OIA con introduzione di Morena Maresia. Volontari, richiedenti asilo e afghani a cui è già stata riconosciuta la protezione internazionale leggeranno poesie e brani di Rahman Baba, Gialal al-din Rumi, Basir Ahang, Umar Khayyam, Tiziano Terzani e altri.
Ore 19.15 assaggi di cucina afghana a cura di Refugees Public School di OIA (**)
Ore 20.45 “Un altro Afghanistan, oltre il velo del tempo”. Identità etniche e frontiere culturali nel Pamir afghano. Conferenza di Giovanni Pedrini. Testimonianze di Maurizio Peselj e di Valerio Pellizzari che hanno vissuto e studiato la regione del Badakhshan, il corridoio del Wakhan nel Pamir tra Cina, Pakistan e Tagikistan.
Ore 17.30 “Afghanistan Crocevia dell’Asia”, barnabiti in terra afghana. Un altro modo di guardare l’Afghanistan e la sua storia. Incontro con lo scrittore Emanuele Giordana, dialoga con Giovanni Pedrini.
Ore 19.15 cena condivisa (*)
Ore 20.45 “Viaggio all’Eden” Da Milano a Kathmandu (Laterza 2017). Presentazione del libro di Emanuele Giordana. L’autore parlerà anche di progetti e collaborazioni attuali tra Italia e Afghanistan. A fine serata sono graditi interventi e racconti liberi di coloro che hanno vissuto esperienze similari.
Sogno americano*
 Greyhound coast to coast. La panamericana. Droghe e lotta armata. Allucinogeni e allucinati. Scuola di illegalità. Rimpatrio alla portoghese. L’ultimo capitolo di Viaggio all’Eden*
Greyhound coast to coast. La panamericana. Droghe e lotta armata. Allucinogeni e allucinati. Scuola di illegalità. Rimpatrio alla portoghese. L’ultimo capitolo di Viaggio all’Eden*
A quelli di noi cui andava stretto persino il Viaggio all’Eden, il volo magico che negli anni Settanta portava verso Kathmandu, si apriva anche un’altra pista. Era il viaggio negli States che proseguiva fino in Messico e da lì, attraverso il Centroamerica, lungo la Panamericana, nella lunga discesa che percorreva le Ande, attraversava la selva e la montagna, raggiungeva il deserto del Perù, risaliva in Bolivia, si allungava fino al Brasile. Era un altro viaggio, naturalmente, ma lo spirito non era per niente diverso. Chi aveva soldi comprava una macchina a New York e correva fino a Frisco, Sognando la California come gli italici Dik Dik avevano tradotto California Dreamin’, cantata dai Mamas and Papas o dai Beach Boys. Ma la maggior parte di noi, denari ne aveva meno e aveva fretta di raggiungere i posti da uno o due dollari al giorno (uscivano allora volumi col titolo South America on …. dollar a day, con cifre per tutte le tasche) e poiché il viaggio negli Usa era competitivo sul prezzo, si sceglieva di cominciare da Nord. Una volta guadagnata la Grande Mela, si saliva su un Greyhound, l’inconfondibile pullman col levriero, per fare in 10 giorni coast to coast. Negli anni Settanta, il volo Lussemburgo-New York costava appena 100 dollari e con altri 500 si poteva star via mesi. Gli Stati Uniti – la cui cultura underground era all’origine dei grandi movimenti degli anni Sessanta-Settanta poi declinati in chiave nazionale – erano solo una tappa veloce per gli squattrinati abituati ai prezzi indiani. Il fascino del rock, della letteratura Beat, dei santoni dell’Hyppismo restava confinato in un tributo ideale – leggere Kerouac o sentire Zappa – e venivamo trascinati inevitabilmente al Sur. Il Messico non era ancora stato sequestrato dalle narcomafie ma era saldamente occupato dalla mafia politica del Partido Revolucionario Institucional, che di rivoluzionario aveva solo il nome e longevità infinita. Laggiù, sorseggiando Tecate in lattina o Carta blanca in bottiglia, ascoltando le frequenze di Radio Mundo, fumando marijuana e andando in cerca del peyote, il cactus magico degli Huicholes, ci ammaestravamo con i libri di Carlos Castaneda, peruviano statunitense che ci aveva affascinato con gli insegnamenti di Don Juan, personaggio forse di fantasia che gli aveva fatto partorire 12 libri tradotti in 17 lingue. La sua «via Yaqui alla Conoscenza» (A scuola dallo stregone, 1968) era un’iniziazione allo sciamanesimo che andava a braccetto con la mistica che ci stregava in Oriente.
 |
| Illustrazione di Maurizio Sacchi. Sotto, a sn foto di Guido Corradi. Sotto a dx foto di Davide Del Boca |
La Panamericana si poteva attraversare con mezzi pubblici scalcinati, autostop che andava alla grande o treni merci frequentati da poveracci locali e da banditi che aspettavano il prossimo gonzo. Molte delle informazioni fondamentali riguardavano le droghe, le chiavi per aprire le Porte della Percezione che nelle Americhe non erano meno presenti che in Asia. Con quei viatici scendevamo fino alla bellissima Colombia in cerca di funghi allucinogeni e la miglior erba del mondo, giù fino alla Quito coloniale e verso le Ande peruviane in cerca del cactus San Pedro, che come il peyote contiene mescalina. Oppure verso l’Amazzonia in cerca della Ayahuasca, la liana degli spiriti dei morti, i cui viaggi allucinati necessitano un curandero. Infine, come tacere della cocaina e non certo quella in foglie masticata dagli indigeni delle Ande. La mafia colombiana con le sue alleanze trasversali ne aveva già fatto un lucroso commercio che partiva dalle raffinerie clandestine sparse nella foresta e che controllava coi suoi manovali assoldati a poco prezzo nei barrio marginali della grandi città o con accordi con la guerriglia che in Colombia controllava intere regioni e amministrava città, tasse, arruolamenti e coltivazioni.
 La rivoluzione era l’altra grande attrattiva di un continente dove gli scritti di Camillo Torres e Che Guevara avevano abbeverato i nostri sogni di giovani ribelli cui già sembrava che la revolucion cubana avesse tradito gli ideali originari. A quell’epoca il Nicaragua era ancora sotto il tallone dei Somoza, la Colombia era una fucina della guerra di guerriglia e in Bolivia la dittatura di Hugo Banzer aveva fatto fuori, una decina di anni prima, il mitico Ernesto detto “che” per quell’intercalare comune tra i porteños, gli argentini di Buenos Aires. Infine c’era stato il colpo di Stato in Cile che aveva assassinato Allende, fatto sparire centinaia di persone e scritto fine sulla via pacifica del socialismo nel Cono Sur. In Sudamerica c’era tutto e il contrario di tutto: la rivoluzione cubana e i forse inevitabili compromessi con l’Urss, i movimenti maoisti, la lotta armata, partiti populisti, puri e duri col fucile in spalla e paramilitari assassini, assoldati spesso dai cartelli della droga capaci di allearsi ora coi primi ora coi secondi sfruttando l’estesissimo odio del Sud per il Nordamerica, odio cui sfuggivamo proprio perché non eravamo yankee. Abimael Guzmán aveva da poco fondato Sendero Luminoso.
La rivoluzione era l’altra grande attrattiva di un continente dove gli scritti di Camillo Torres e Che Guevara avevano abbeverato i nostri sogni di giovani ribelli cui già sembrava che la revolucion cubana avesse tradito gli ideali originari. A quell’epoca il Nicaragua era ancora sotto il tallone dei Somoza, la Colombia era una fucina della guerra di guerriglia e in Bolivia la dittatura di Hugo Banzer aveva fatto fuori, una decina di anni prima, il mitico Ernesto detto “che” per quell’intercalare comune tra i porteños, gli argentini di Buenos Aires. Infine c’era stato il colpo di Stato in Cile che aveva assassinato Allende, fatto sparire centinaia di persone e scritto fine sulla via pacifica del socialismo nel Cono Sur. In Sudamerica c’era tutto e il contrario di tutto: la rivoluzione cubana e i forse inevitabili compromessi con l’Urss, i movimenti maoisti, la lotta armata, partiti populisti, puri e duri col fucile in spalla e paramilitari assassini, assoldati spesso dai cartelli della droga capaci di allearsi ora coi primi ora coi secondi sfruttando l’estesissimo odio del Sud per il Nordamerica, odio cui sfuggivamo proprio perché non eravamo yankee. Abimael Guzmán aveva da poco fondato Sendero Luminoso.
Il viaggio poteva finire bene o male a seconda dell’attività illegale intrapresa. Come e forse più che nel Viaggio all’Eden, il Sudamerica era in effetti una vera scuola di illegalità: traffico di stupefacenti, dollari falsi oppure perdita o furto fasullo di travelers cheques, “assegni turistici” assicurati che, dopo aver incassato l’equivalente mostrando la denuncia (vera) di furto o smarrimento (falsi), venivano poi incassati appena passata la più vicina frontiera nella prima banca dove avrebbero saputo forse solo un mese dopo di aver pagato una seconda volta cheque già rimborsati. Poteva finir bene anche con un altro sistema che, per noi italiani, si era poi dimostrato per anni un ottimo modo di tornare a casa come portoghesi a carico dello Stato. Come in India qualcuno aveva scoperto lo sportello ferroviario “per soli bianchi”, noi avevamo scoperto che le ambasciate italiche in Sudamerica potevano offrire un servizio di rimpatrio gratuito via nave agli emigranti italiani cui l’indigenza non consentiva di pagare il biglietto.
Chi dunque arrivava in Brasile senza ormai più una lira in tasca, andava a batter cassa al consolato
 |
| …ma il sogno restava Kathmandu… |
di San Paolo o di Rio piangendo in sette lingue e mostrando le foto dei parenti e le tasche bucate. Quei diplomatici che non avevano ancora conosciuto le orde di questuanti che affollavano le varie legazioni sulla rotta dell’Eden, compilavano il formulario di rimpatrio fino al porto di Genova con annesso biglietto ferroviario fino alla città natale. Senza ritegno sfruttavamo cinicamente l’antica miseria dei nostri migranti che all’inizio del secolo avevano cercato fortuna nel Nuovo Mondo con alterni destini. Era la scuola dell’Eden e stavamo già pensando a come tornarci perché si favoleggiava di una nave da Rio per Dakar e da lì a Bombay… Discoli, certamente, e sempre in compagnia di cattivi maestri, avremmo importato salsa e merengue, canti rivoluzionari, poncho di alpaca, frasi gergali imparate nel Salvador, cocaina e maria. E avremmo esibito un’altra sequela di tacche sul passaporto che, tra l’altro, nelle Americhe di visti non c’era bisogno. Fatta eccezione per gli Stati Uniti, che per rilasciarlo pretendevano che tu sottoscrivessi di non esser mai stato comunista. Beffare gli yankee con una menzogna burocratica era una delle nostre più grandi soddisfazioni.
Su quelle strade ripetevamo come un mantra l’ultima frase con cui Jack Kerouac aveva terminato Sulla strada – On the Road – uno dei nostri testi sacri: «Così in America quando il sole va giù e io siedo sul vecchio diroccato molo sul fiume a guardare i lunghi, lunghissimi cieli sopra il New Jersey e avverto tutta quella terra nuda che si svolge in un’unica incredibile enorme massa fino alla Costa Occidentale… nessuno sa quel che succederà di nessun altro se non il desolato stillicidio del diventare vecchi, allora penso a Dean Moriarty, penso persino al vecchio Dean Moriarty, il padre che mai trovammo, penso a Dean Moriarty».
* Questo capitolo (leggermente ridotto rispetto all’originale nel libro, è uscito venerdi 4 agosto su il manifesto)
Afghanistan, la prima vittima della guerra di Trump
 |
| Trump. A sn John Nicholson. Sotto il trailer di War machine |
La prima vittima eccellente della nuova strategia della Casa bianca per l’Afghanistan potrebbe proprio essere la persona che ha sostanzialmente
chiesto al presidente un nuovo “surge”, con un maggior impegno di soldati e soldi a un capo dello Stato che, in campagna elettorale, voleva tirare via anche l’ultimo singolo soldato dal Paese dell’Hindukush.
Stando a un dispaccio di Reuters, in una burrascosa riunione il 19 luglio scorso col segretario alla Difesa James Mattis e il capo del Joint Chiefs of Staff (lo stato maggiore) Joseph Dunford, Trump avrebbe chiesto la testa di John Nicholson, che comanda nel Paese asiatico gli americani e la Nato dal marzo del 2016. La sua colpa? Non aver vinto la guerra… che adesso Trump invece vuole vincere senza indugi. Come? Non si sa. Il suo stratega Steve Bannon e il suo national security adviser H.R. McMaster hanno tentato di blandire Trump nel burrascoso meeting ma non sembra ci siano riusciti.
Se Nicholson sarà fatto secco si vedrà ma la cosa non piacerà al Pentagono. C’è una sorta di guerra tra il presidente e le istituzioni repubblicane. Probabilmente a Trump piace l’idea che la macchina della guerra si rimetta in moto con commesse e dunque lavoro ma non si fida né dei militari né della sua intelligence. A chi darà retta? Teoricamente a metà luglio avremmo dovuto sapere se è vero che gli Usa manderanno nuovi soldati e se è vero che chiederanno agli afgani di cambiare le regole della guerra che, almeno in teoria, ora prevedono che la catena di comando risponda in ultima istanza a Kabul. Si è anche ventilata l’ipotesi di una guerra per procura con i contractor. Ma sono tutte speculazioni e il presidente tace.
Silurare il capo locale dei soldati può essere un modo per far vedere che si ha la situazione in pugno ma non può bastare. Viene in mente il generale Stanley McChristall che, mandato a Kabul per vincere la guerra, si ritrovò sotto il fuco incrociato dopo che la rivista Rolling Stones aveva pubblicato un servizio in cui il generale non le mandava a dire. Fu licenziato e forse sapeva benissimo cosa sarebbe successo dopo le sue dichiarazioni. Forse voleva farsi cacciare. La sua storia è adesso un film (non particolarmente eccitante). La prossima puntata, con Nicholson protagonista, è ancora da scrivere.
Da Raqqa con furore
 |
| Il sito di Amq, voce del “califfato” |
Colpire il nemico fuori dal teatro siriano iracheno. Punirlo per aver annunciato (alcuni giorni fa con un incontro stampa) la presa di Mosul. Attaccare un obiettivo che dia risalto mediatico all’azione esemplare. Sembra questo il ragionamento che ha portato ieri un commando dello Stato islamico, nella sua versione “Territorio del Khorasan”, ad attaccare l’ambasciata irachena a Kabul, nel cuore commercial diplomatico della capitale. Azione rapida e con meccanismi noti: un kamikaze vestito da poliziotto afgano si fa esplodere all’ingresso della legazione irachena; la porta si apre e un commando di tre uomini entra per fare strage. Ma le cose vanno male: un poliziotto viene ferito e mentre i guardiani dell’ambasciata impegnano il commando gli altri riescono a fuggire. Poi escono tutti mentre la legazione viene circondata e finisce sotto il fuoco incrociato della truppe speciali afgane. Dura circa quattro ore l’assedio al commando (dalle 11 del mattino alle 15), poi i tre vengono fatti fuori mentre l’agenzia Amaq, la sirena mediatica del califfato di Al Baghdadi, rivendica l’azione. Fortunatamente sfortunata. Il prezzo lo pagano soprattutto gli uomini del commando anche se due civili hanno perso la vita ed è sempre presto per sapere se non vi siano altre vittime. Le vittime civili della guerra, come ha appena denunciato il rapporto semestrale dell’Onu, sono quelle con i numeri più alti, in un conflitto che si è spostato sempre più nella capitale: degli 1662 morti nei primi sei mesi del 2017, il 20% ha perso la vita a Kabul.
L’attentato sembra indicare il desiderio dello Stato islamico di affermare la sua presenza nella guerra afgana nel tentativo di farla apparire come un pezzo della guerra globale volta alla riconquista di vecchi e nuovi territori della Umma sunnita. Ma la guerra afgana di Al Baghdadi segna pochi successi ed è particolarmente sotto tiro anche da parte dei talebani che non amano affatto questi jihadisti d’importazione che hanno reclutato vecchi quadri espulsi dal movimento o qualche clan, guerrigliero più per convenienza che per fede. Colpire l’ambasciata irachena, un obiettivo davvero inusuale nel panorama diplomatico della capitale, indica poi un cambio di strategia che esce dai binari che hanno sempre condotto le azioni verso la “zona verde”, una città nella città dove c’è il quartier generale della Nato e l’ambasciata americana, il “nemico lontano” per Al Qaeda, il nemico di sempre per i talebani che imputano a Washington l’escalation della guerra, pur coi suoi alti e bassi, e soprattutto la scelta di mantenere un’occupazione militare che, per quanto avallata dal governo locale, mostra sempre più la corda.
Per uscire dall’impasse gli americani stanno pensando a una nuova strategia che per ora è solo una sommatoria di indiscrezioni dove c’è tutto e il contrario di tutto: Trump avrebbe dovuto rendere noto il suo piano a metà luglio ma i giorni passano e la montagna non riesce a partorire nemmeno un topolino. Più soldati? Più aerei? Più omicidi mirati di leader guerriglieri? E come la mettiamo con la missione Nato “Resolute support” che, come dice il nome, dovrebbe essere di sola assistenza tecnica, senza sparare un colpo? Una missione che vede impegnati quasi mille militari italiani. Quanto alle indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi secondo cui truppe italiane e statunitensi sarebbero sbarcate a Farah (sudoccidente), lo Stato maggiore della Difesa ha precisato che attualmente non vi sono soldati italiani a Farah e che comunque le missioni italiane fuori da Camp Arena (base Nato del quadrante Ovest) «non prevedono l’uso delle armi» ma solo training e formazione. Non di meno, a metà agosto circa cento militari italiani si sposteranno a Farah una volta conclusa l’attività esterna di Train Advise e Assist a favore della 3ª brigata del 207˚ Corpo d’Armata dell’esercito afgano dislocata a Qual-eye-naw, 150 Km a Nord di Herat.
Italiani a Farah: assistere o combattere?
 In seguito alla minaccia di un possibile attentato talebano al governatorato di Farah, soldati italiani e americani si sono spostati nella provincia centroccidentale afgana che ricade sotto la responsabilità militare italiana del Regional Command West della missione Nato Resolute Support. I solerti PIO (Public Information Offfice), distaccati nei “teatri” dove è impegnato l’esercito italiano, solitamente pronti a informare di questa o quella visita e di quel corso di formazione, stavolta però la notizia non l’hanno trasmessa ai giornalisti del loro elenco. Resa nota dai media afgani, non c’è nemmeno nel sito della Difesa dove un’immagine di Gentiloni campeggia sull’approvazione della missione di sostegno alla guardia costiera libica. Bisogna dunque affidarsi alle fonti locali e al portavoce del governatore Nasir Mehri secondo cui americani e italiani sono arrivati aerotrasportati giovedi scorso nella capitale di provincia. Quanti sono non è dato sapere. Non è la prima volta che gli italiani sono a Farah da che la missione Isaf della Nato ha chiuso i battenti tramutandosi in Resolute Support, col compito di formare e assistere l’esercito afgano. Ma se dei bersaglieri dislocati a Farah all’interno di una forza di 200 uomini per lo più italiana qualche mese fa non si è saputo granché – anche allora la notizia era passata abbastanza inosservata – la differenza è che adesso il quadro è cambiato.
In seguito alla minaccia di un possibile attentato talebano al governatorato di Farah, soldati italiani e americani si sono spostati nella provincia centroccidentale afgana che ricade sotto la responsabilità militare italiana del Regional Command West della missione Nato Resolute Support. I solerti PIO (Public Information Offfice), distaccati nei “teatri” dove è impegnato l’esercito italiano, solitamente pronti a informare di questa o quella visita e di quel corso di formazione, stavolta però la notizia non l’hanno trasmessa ai giornalisti del loro elenco. Resa nota dai media afgani, non c’è nemmeno nel sito della Difesa dove un’immagine di Gentiloni campeggia sull’approvazione della missione di sostegno alla guardia costiera libica. Bisogna dunque affidarsi alle fonti locali e al portavoce del governatore Nasir Mehri secondo cui americani e italiani sono arrivati aerotrasportati giovedi scorso nella capitale di provincia. Quanti sono non è dato sapere. Non è la prima volta che gli italiani sono a Farah da che la missione Isaf della Nato ha chiuso i battenti tramutandosi in Resolute Support, col compito di formare e assistere l’esercito afgano. Ma se dei bersaglieri dislocati a Farah all’interno di una forza di 200 uomini per lo più italiana qualche mese fa non si è saputo granché – anche allora la notizia era passata abbastanza inosservata – la differenza è che adesso il quadro è cambiato.
Gli americani hanno fatto sapere che una nuova strategia è allo studio del presidente e del Pentagono: più uomini e più missioni aeree e un nuovo approccio molto combattivo in cui Washington vuole concordare con Kabul più mano libera nelle operazioni speciali. La Difesa americana ha chiesto alla Nato di appoggiare questo nuovo “surge” ma l’Italia ha risposto picche, perlomeno per quel che riguarda l’aumento del nostro contingente che è di circa mille uomini, il secondo per numero dopo quello statunitense. Inoltre, la missione Resolute Support è una “non combat mission” ossia una presenza di mera assistenza tecnica all’esercito afgano che prevede formazione e sostegno ma senza l’uso delle armi. Preparasi a resistere a un attacco della guerriglia però è qualcos’altro anche perché l’arrivo dei militari, stando a informazioni locali, riguarda anche l’impiego di velivoli – droni, elicotteri o caccia – in linea con un massiccio impiego dell’aviazione sempre più utilizzata dal nostro più potente alleato.
Ordinaria barbarie sulle donne
 |
| Benazir Bhutto: la prima premier donna in Pakistan ma pochi cambiamenti nel Paese |
Un caso di ordinaria barbarie ai danni di due donne, una delle quali minorenne, stuprate nella provincia pachistana del Punjab è stato ieri preso in carico dal Chief Justice del Pakistan, la più alta carica del sistema giudiziario del Paese dei puri. Accanto a una delle ricorrenti pessime notizie che accompagnano la violenza contro le donne ce n’è dunque almeno una positiva. Un caso che rischiava di restare confinato in ambito locale è stato assunto motu proprio da Mian Saqib Nisar, costituzionalista non certo noto per essere un progressista ma che ha deciso di voler andare a fondo in questa terribile storia avvenuta nel cuore del Punjab e che il capo della giustizia pachistana ha appreso dai giornali.
Comincia a metà luglio in un campo di fieno della zona di Muzzafarabad un sobborgo della città di Multan. Una ragazzina di 12-13 anni, che i giornali locali chiamano F, viene violentata da un uomo. Due giorni dopo si riunisce il panchayat, il consiglio degli anziani della zona, che individua il colpevole e stabilisce la pena. Occhio per occhio: il fratello di F si deve vendicare con uno sturo equivalente su N, sorella diciassettenne del colpevole. Pena eseguita e, stando alla stampa locale, addirittura in presenza del primo violentatore e dei suoi parenti. Non è purtroppo una novità e i consigli degli anziani sono spesso accusati di applicare le leggi consuetudinarie in barba alle più elementari norme che regolano il pur modesto apparato difensivo pachistano nei confronti delle donne. Ma questa volta qualcuno non ci sta e viene sporta denuncia dai membri delle due famiglie agli agenti i cui uffici si trovano a Multan, nel Centro contro la violenza sulle donne. A quel punto si muove la polizia e comincia a far scattare le manette: per ora sarebbero già in carcere venti persone mentre proseguono le ricerche sugli altri componenti del panchayat (una quarantina) e mentre il caso arriva agli uffici giudiziari di Islamabad. I due violentatori sarebbero però ancora uccel di bosco.
 |
| La difficoltà di essere donna. Nell’immagine (Dfid Uk)FID ragazze a scuola nel Khyber Pakhtunkhwa |
Il panchayat (assemblea) è un sistema antico diffuso nel subcontinente indiano che resiste da secoli. E’ una delle tante forme di amministrazione del consenso e della giustizia che spesso sfuggono non solo al dettato legislativo nazionale ma persino agli ordini del clero. Ne esistono forme diverse a seconda della tradizione. Nel Nordovest pachistano, area abitata da popolazioni afgane, la jirga assume lo stesso ruolo. Proprio qualche mese fa una di queste assemblee di anziani condannò a morte un ragazzo che era stato ripreso da un telefonino mentre ballava con delle giovanette. Le ragazze sparirono e non è ancora chiaro se, dopo che il caso aveva interessato la magistratura, quelle che erano riapparse fossero davvero le vittime dell’anatema. Si teme siano state uccise. Ma queste punizioni del codice d’onore non fanno parte solo delle popolazioni afgane della montagna, confinate nelle cosiddette aree tribali e strenue avvocate della tradizione: il Punjab è il cuore del Pakistan moderno e Multan è una città di quasi due milioni di abitanti.
 |
| Qandel Baloch; libera e provocatoria. Suo fratello l’ha uccisa |
Un caso famoso (e denunciato) fu quello di Asma Firdous, una donna di 28 anni a cui, nell’aprile del 2011, due uomini tagliarono sei dita, il naso e sfregiarono labbra e braccia. Alla base c’era una disputa col marito e la vendetta si scaricò sulla ragazza. Il rapporto sulla violenza femminile relativo al 2010 e redatto dalla Commissione diritti umani del Pakistan, diceva allora che almeno 800 donne erano state vittime di “delitto d’onore” e punite con la morte mentre altre 2900 erano state violentate, al ritmo di otto al giorno. Il Punjab deteneva il primato. Ancor più noto del caso di Asma è stato quello di Mukhtar Mai, una giovane ragazza punjabi di Muzaffargarh che nel 2002 era stata violentata da quattro uomini per il sospetto di una presunta relazione tra il fratello minore di lei, Shakoor, e una parente. In realtà, grazie alla determinazione della ragazza, che non si suicidò per il disonore e anzi denunciò gli stupratori, si scoprì che l’accusa a Shakoor doveva in realtà coprire la violenza subita dal ragazzo stesso da parte di altri membri del clan. Ne venne fuori un libro (In nome dell’onore), una scuola per ragazze finanziata da Mukhtar Mai e Thumbprint, un’opera teatrale di respiro internazionale. Un altro caso recente è quello di Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il corpo e le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confesso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei
genitori l’anno scorso sempre a Multan.
Lentamente però anche in Pakistan le cose cambiano: in termini di dati (1000 morti nel 2016) la situazione sembra stabile o peggiore ma è anche vero che ora le donne – anziché uccidersi come vorrebbe la consuetudine – denunciano e la magistratura, come in questo caso, interviene; si lavora su leggi che evitino la scappatoia del delitto d’onore che, ufficialmente, dovrebbe essere considerato un omicidio tout court. Strada in salita e non solo in Asia: nella civile Italia l’abolizione del “delitto d’onore” e del “matrimonio riparatore” è solo del 1981 e le donne che vengono uccise, assai spesso dai loro mariti, conviventi o ex, muoiono al ritmo di una ogni 3 giorni. Quasi 7 milioni, secondo l’Istat, le italiane che nel corso della propria vita hanno subito abusi.
Viaggio all’Eden: venerdi 28 a Milano
 Cosa fu davvero il Viaggio all’Eden? Cosa eravamo noi, protagonisti inconsapevoli di un’epopea in
Cosa fu davvero il Viaggio all’Eden? Cosa eravamo noi, protagonisti inconsapevoli di un’epopea in
cui ognuno faceva la sua strada e il suo trip, parola inglese che significa viaggio in senso lato: a piedi, in macchina o con qualche mezzo psicotropo? Cosa siamo stati veramente? Fuor di dubbio fummo un pezzo di quell’avanguardia giovanile che sconvolse il mondo tra gli anni Sessanta e Settanta. Fuor di dubbio di quell’avanguardia fummo la frangia più anarchica e libertaria. Ma, alla fine della fiera, fummo anche l’avanguardia del turismo di massa e – proprio noi che viaggiavamo con consapevolezza, anticipando di trent’anni il turismo sostenibile ecofriendly – fummo anche gli araldi di una globalizzazione della valigia nel frattempo divenuta trolley. Quel vasto movimento di arrivi e partenze è senz’altro una risorsa ineludibile per tanti Paesi, ma è stata ed è – come un po’ abbiamo raccontato – anche il segno della sua rovina, della fine di un sogno tropicale…
Venerdi 28 luglio alle ore 19 al Rob de matt di Milano Via Enrico Annibale Butti 18 (traversa di viale Jenner) letture di Carlina Torta da Viaggio all’Eden
Strage senza fine
 Dopo qualche settimana di apparente tranquillità la guerra afgana torna nella capitale con un’autobomba che il suo guidatore scaglia contro un autobus che sta portando al lavoro – sono le 6.45 del mattino – alcuni impiegati del ministero per le miniere e il petrolio. Non è una tecnica nuova e a farne le spese sono già stati lavoratori dei media o di altri ministeri. Ma non son certo gli alti papaveri dei dicasteri a perdere la vita in un attentato che avrebbe ucciso almeno 36 persone e ne avrebbe ferite altre quaranta anche se nel quartiere abita anche un alto dignitario del governo: Mohammad Mohaqiq, un mullah integralista che sta però dalla parte “giusta” della barricata. La responsabilità viene attribuita ai talebani che non sono comunque rimasti con le mani in mano nei giorni scorsi: la guerra in Afghanistan è pane quotidiano in tutto il Paese e non solo per la guerriglia. E’ di qualche giorno fa una polemica su “fuoco amico” americano che per errore avrebbe colpito militari afgani. Intanto c’è attesa sulla nuova strategia promessa da Trump che prevede un nuovo “surge” nel Paese dell’Hindukush. Ma il presidente fa melina tra indiscrezioni e speculazioni sul numero di soldati da inviare (4mila?) e se è vero che darà carta bianca anche a qualche società di contractor.
Dopo qualche settimana di apparente tranquillità la guerra afgana torna nella capitale con un’autobomba che il suo guidatore scaglia contro un autobus che sta portando al lavoro – sono le 6.45 del mattino – alcuni impiegati del ministero per le miniere e il petrolio. Non è una tecnica nuova e a farne le spese sono già stati lavoratori dei media o di altri ministeri. Ma non son certo gli alti papaveri dei dicasteri a perdere la vita in un attentato che avrebbe ucciso almeno 36 persone e ne avrebbe ferite altre quaranta anche se nel quartiere abita anche un alto dignitario del governo: Mohammad Mohaqiq, un mullah integralista che sta però dalla parte “giusta” della barricata. La responsabilità viene attribuita ai talebani che non sono comunque rimasti con le mani in mano nei giorni scorsi: la guerra in Afghanistan è pane quotidiano in tutto il Paese e non solo per la guerriglia. E’ di qualche giorno fa una polemica su “fuoco amico” americano che per errore avrebbe colpito militari afgani. Intanto c’è attesa sulla nuova strategia promessa da Trump che prevede un nuovo “surge” nel Paese dell’Hindukush. Ma il presidente fa melina tra indiscrezioni e speculazioni sul numero di soldati da inviare (4mila?) e se è vero che darà carta bianca anche a qualche società di contractor.
Dall’altra parte del confine intanto i talebani del Tehreek-i-Taliban Pakistan, i “cugini” pachistani della guerriglia afgana, hanno messo a segno l’ennesima strage a Lahore, città del Punjub, dove un attacco suicida che voleva colpire la polizia locale si è trasformato in una carneficina con almeno 26 vittime tra cui nove poliziotti.
In un caso e nell’altro – e così nella maggior parte delle azioni della guerra sui due fronti caldi – i civili continuano a pagare il prezzo più alto: in Afghanistan, secondo la missione Onu a Kabul, nei primi sei mesi del 2017 il numero di civili uccisi o feriti continua a rimanere elevato. Dal primo gennaio al 30 giugno ci sarebbero stati 1662 civili uccisi e 3581 feriti. I morti raccontano di un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo nel 2016. Il 40% sarebbero imputabili alla guerriglia talebana o allo Stato islamico mentre si ricorda che il solo attacco a Kabul del 31 maggio (senza paternità) ha ucciso 92 civili e ne ha feriti 500 conquistando il primato dell’attacco più stragista dal 2001. I talebani hanno preso le distanze dai dati di Unama contestandone i numeri e le responsabilità: citando le azioni delle milizie di villaggio (Arbakis) o i raid dei droni i cui effetti sono coperti da segreto militare.
La biblioteca di Amanullah
Risistemare la propria biblioteca è un lavoraccio ma anche un sistema piacevole per fare non solo ordine e polvere ma anche qualche piacevole scoperta. Vedi questo articolo sull’Afghanistan a firma Erodoto II uscito su Noi e il mondo, magazine de La Tribuna, giornale romano diretto da mio nonno Tullio Giordana.
Foto d’epoca tra cui re Amanullah e altro, con un invito all’Italia perché stringa rapporti con il re (ferocemente antibritannico).
La data è agosto 1925. Da notare l’artifico grafico “orientalista” della scritta Afghanistan nel titolo
Viaggio all’Eden a Levico Terme
Venerdì 21 luglio, a Levico Terme (ore 21 a Villa Sissi, Grand Hotel Imperial) Massimo Libardi e Fernando Orlandi dialogano del Viaggio all’Eden e degli anni Settanta con Emanuele Giordana. Organizzazione La piccola libreria.
Era davvero il viaggio della vita, ha scritto Enrico Deaglio. Un viaggio iniziato dopo che i Beatles andarono a meditare con Maharishi Mahesh Yogi.
Impossibile dire quanti, dall’Italia, partirono e quanti arrivarono alla meta: migliaia sicuramente, forse di più. Non era come andare a Londra, a New York o a Marrakech. Era un viaggio di mesi, da cui si tornava smagriti, diversi, cambiati. Più lenti, in genere.
Erano altri tempi, più o meno mezzo secolo fa, nella seconda metà del Novecento. La meta era lontana: l’India, il Nepal, l’Afghanistan. Le condizioni del viaggio erano disagevoli: niente aerei, carte di credito, cellulari e bed and breakfast; piuttosto (pochi) traveler’s cheque, scassati uffici del telegrafo, fermo posta, ostelli e tutte le malattie gastrointestinali in agguato. Le utilitarie Fiat non erano attrezzate, i più fortunati viaggiavano sul pulmino Volkswagen, se no erano bus, treni, autostop, con tanto di appuntamenti in caravanserragli.
Fu davvero una grande migrazione, ricordata da un prezioso Baedeker di ricordi,
Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu di Emanuele Giordana; lui – oggi giornalista specializzato in Paesi asiatici – fu uno dei pionieri. Non era per lavoro, non era per cercare fortuna, cose che gli italiani avevano nel sangue da sempre. Non era neppure il Grand Tour che i poeti inglesi dell’Ottocento, specie se di deboli polmoni, compivano nell’Italia degli archi e delle rovine per meditare sull’effimera gioventù. Fu piuttosto un viaggio interiore, individuale
e collettivo, alla ricerca di spiritualità, meditazione, allargamento della conoscenza e, soprattutto, una reazione alla vita materialistica, competitiva e violenta, che si conduceva in occidente.
(dall’invito per la serata)
Afghanistan. E se mettessimo un Viceré con esercito privato?
 |
| Lord Mountbatten, ultimo Viceré in India |
Sarà una nuova guerra, una guerra “speciale” e forse anche “privata”, con modalità già testate dall’Irak allo stesso Afghanistan. Ma se i contractor son sempre stati un riempitivo dei conflitti per la logistica e la sicurezza, davanti a caserme e ambasciate, la nuova strategia del Pentagono, non ancora ufficiale ma inesorabilmente annunciata dalle indiscrezioni, potrebbe prevedere che la guerra per procura affidata a mercenari diventi uno dei nodi della pianificazione del nuovo “surge” afgano. La notizia filtra sulla stampa americana mentre la ministra Pinotti si trova negli Stati Uniti per un incontro con il suo omologo James Mattis che – ha spiegato la ministra – oltre alle vicende siriane è servito per “rimodulare” il contributo italiano pari oggi a poco meno di mille soldati schierati a Herat, il secondo contingente straniero dopo quello statunitense. Le indiscrezioni fanno due nomi pesanti: Erik Prince, il fondatore della famigerata Blackwater e Stephen Feinberg, un miliardario proprietario della DynCorp International, “gigante” – scrive il New York Times – del comparto militare privato. Per ora saremmo solo a suggerimenti richiesti però da due spalle importanti di Trump: Steve Bannon, responsabile delle strategie del presidente e poco favorevole e all’invio di soldati in Afghanistan, e Jared Kushner, senior adviser di Trump e marito di Ivanka. Il piano ha comunque già un nome: “Laos Option”, richiamo alle operazioni segrete scatenate nel Paese confinante col Vietnam per mettere in difficoltà i vietcong.
 |
| Lord Aucklan, governatore del Raj amministrato dalla Compagnia delle Indie. Invase l’Afghanistan. Sotto: Mc Arthur |
L’uso dei contractor potrebbe forse far rientrare i dubbi di Bannon e dei molti che temono una nuova
escalation e dunque nuovi morti tra i soldati a stellestrisce, ma non piace troppo né ai vertici militari in divisa né ai militari, come Mattis o McMaster – consigliere per la sicurezza nazionale –, che vestono adesso panni civili. Sono loro i sostenitori del nuovo impegno che dovrebbe coinvolgere 4 o 5mila soldati americani e qualche altro migliaio di militari Nato anche se per ora continuano a rinviare dichiarazioni ufficiali e numeri. Temono però, non solo i guai che i mercenari hanno combinato in passato, ma soprattutto la possibile erosione del controllo del Pentagono. Il piano, prevede infatti che i “privati” non si limitino a sicurezza e logistica ma anche a operazioni “speciali” ad alto rischio in stretta collaborazione con la Cia. Prince del resto non fa mistero delle sue idee: in maggio ha scritto sul Wall Street Journal che, in una guerra già costata agli Usa 828 miliardi, oltre 2mila soldati uccisi e 20mila feriti, serve un “modello Mc Arthur”, il generale americano che alla fine della seconda guerra mondiale governò il Giappone come un proconsole: esautorò l’Imperatore ma si servì però di soldati americani non certo di privati. Prince immagina invece un “viceré” forse sul modello dell’incarico affidato, dopo l’invasione dell’Irak, a Paul Bremer, il proconsole di Rumsfeld. Scegliere la parola “viceré” fa pensare, più che a Louis Mountbatten, l’ultimo viceré dell’India britannica, ai governatori generali (o viceré) della Compagnia delle Indie, a tutti gli effetti una società commerciale che impiegava un esercito privato. L’idea del vicereame afgano sedurrà Trump?
 Stando alle dichiarazioni di Pinotti, Trump avrebbe invece sedotto gli italiani solo in parte. E l’Italia si opporrebbe all’invio di nuovi soldati in Afghanistan, decisione che richiederebbe un passaggio parlamentare che probabilmente non andrebbe a buon fine. Non tanto forse per una attenta coscienza della guerra quanto perché si presterebbe a creare un ennesimo ostacolo sull’impervio cammino di Gentiloni. Per ora si parla solo di rimodulare e cambiare funzioni. Come si vedrà.
Stando alle dichiarazioni di Pinotti, Trump avrebbe invece sedotto gli italiani solo in parte. E l’Italia si opporrebbe all’invio di nuovi soldati in Afghanistan, decisione che richiederebbe un passaggio parlamentare che probabilmente non andrebbe a buon fine. Non tanto forse per una attenta coscienza della guerra quanto perché si presterebbe a creare un ennesimo ostacolo sull’impervio cammino di Gentiloni. Per ora si parla solo di rimodulare e cambiare funzioni. Come si vedrà.
La sera andavamo alla Martesana: l’idea e l’incipit di Viaggio all’Eden
 Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:
Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:
Mi è piaciuto l’articolo di Emanuele Giordana sul numero di giovedi 2 agosto. Ma sulla Martesana definita “fiumiciattolo maleodorante” non sono assolutamente d’accordo. Verde rigoglioso, canne, acqua abbastanza limpida con pesci e ricca vegetazione sommersa, gracidar di rane, gallinelle d’acqua, germani reali… questa è la Martesana, un pezzetto di natura quasi selvatica nei tristi quartieri Nord di Milano. Claudio Longo, 8/8/07 (lettera inviata al manifesto )
Poi, nell’estate 2013, decisi che quell’articolo poteva partorire una piccola serie rievocativa e proposi al giornale dieci puntate. Anche questa volta ci furono un mucchio di reazioni miste. Alcune davvero confortanti. Perché allora non farne un libro? Ripresi alcuni dei pezzi scritti per il Mani e gli feci acquistare dignità di capitolo ma faticavo a trovare un editore. Poi Laterza si è convinto, grazie anche al sostegno di Giovanni Carletti, la persona che poi ha seguito impianto, nuovo indice e nuova stesura. Se siete arrivati fin qui ecco allora il prologo del libro. Sperando ovviamente che poi corriate in libreria…Ce n’è giusto una all’angolo.
L’indice lo trovate qui
Sì, anche Allen Ginsberg, allora molto gettonato, era stato in India ma alla fine ci passavamo di mano soprattutto un altro classico dell’epoca, pura operazione furbescamente commerciale ma non priva di seduzione: quel raccontone letterariamente scadente ma altrettanto avvincente di Charles Duchaussois, junkiefrancese che aveva fatto il giro del mondo con un ago infilato nel braccio. Il suo Flash. Katmandu il grande viaggiodescriveva l’Old Gulhane di Istanbul e raccontava di sordidi buchi del bazar di Bombay per fumatori d’oppio, di santoni, contrabbandieri, guru e ashramdove poter allargare la coscienza a colpi di mantra e di “manali”, l’hascisc nero e profumato delle valli del Nord dell’India. Insomma la partenza si preparava così: amuchina e antibiotici per i più paranoici, pile e lamette da barba per i previdenti, Sulla stradadi Kerouac o Siddhartadi Hesse per i più raffinati, Autobiografia di uno yogidi Paramhansa Yogananda per gli spiritualisti. Inseguiti dagli anatemi di quelli che «no compagni, non si può andar via e mollare la lotta di classe», ci rodeva – sotto la pergola della Bocciofila Martesana – il tarlo della strada e non ci scalfiva quel refrain di Giorgio Gaber che cantava di una generazione che scappava «in India e in Turchia»fingendo di essere sana. Eravamo malati, come no. Bruciati dalla passione per quel treno che partiva dalla Stazione Centrale e proveniva da Parigi diretto a Istanbul, dove immigrati turchi accaldati di ritorno a casa esibivano i gilet e le coppole d’ordinanza mentre si attraversava la Iugoslavia di Tito fino alla Porta d’Oro aperta sull’Oriente.
 |
| La copertina di “Viaggio all’Eden”, la prima mitica guida al volo magico (altro titolo dell’epoca) |
Traversata la prima frontiera, i ritrovi all’occidentale cui eravamo abituati (dal piccolissimo bar Erika di zona Loreto al mitico Jamaica, già troppo caro all’epoca per le nostre tasche) finivano di colpo. C’era qualche locale a Belgrado dove potevi bere acquavite e un ultimo espresso ma già trionfava il caffè serbo, che in Grecia è caffè greco e in Turchia caffè finalmente turco. E quando ormai avevi passato anche l’ultimo confine alcolico bagnato di Retzina e Demestika ghiacciati, restava la birra turca ma si affacciava anche un primo stupore per quello splendido tè servito in bicchieri stretti stretti con la pancia sporgente e l’orlo striato da una collanina d’oro, trascinati su un vassoio rotondo di metallo martellato ai tavolini all’aperto di Sultan Ahmet. Sempre affannati a cercare il posto più economico – per mangiare e dormire, attività primigenie ed essenziali del genere umano – si finiva nei grandi stanzoni degli ostelli della Sublime Porta che, ai meno abbienti, offrivano i tetti, più per risparmiare qualche lira turca che per sfuggire all’afa distesa sul Bosforo. La mattina al Pudding Shop, luogo deputato allo scambio di informazioni sul prossimo pullman, era un’occasione per ingollare yogurt e pasticceria ottomana grassa e zuccherina, ammantata di miele e pinoli e di cui avevi già avuto qualche sentore nei Balcani. Ora il Pudding è un ritrovo alla moda con le foto degli Anni Settanta alle pareti, locale senz’anima affacciato sulla fluorescente rivisitazione modernista del grande parco di Sultan Ahmet e dei suoi gioielli architettonici.
 |
| Le foto in questa pagina sono di Guido Corradi |
Viaggio all’Eden a Qui Comincia
Stamattina a Qui Comincia (Radio3) è toccato a Viaggio all’Eden finire nelle mani di Attilio Scarpellini. La puntata era dunque dedicata al libro che racconta del mio vecchio viaggio dall’Italia a Kathmandu. Sono davvero contento di questo risveglio
Qui la pagina dei podcast per riascoltare le trasmissioni del programma
Qui Comincia si avvale della regia e della consulenza musicale di Federico Vizzaccaro. Attilio Scarpellini (nella foto) è il suo conduttore storico
Viaggio all’Eden: un libro a chilometro molti zeri
 Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.
Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.Una guerra molto speciale
Forze speciali. E’ questa la parola chiave che d’ora in poi si dovrà tenere a mente pensando
all’Afghanistan: una nuova fase della guerra affidata appunto a soldati “speciali”, coadiuvati da raid aerei per operazioni mirate. Gli operativi delle forze speciali – afgane, americane, britanniche o italiane – sono già attivi in Afghanistan e presto saranno in buona compagnia. Stando a quanto ha appena dichiarato il segretario generale della Nato a Bruxelles, promettendo l’impegno di “migliaia” di nuovi soldati dell’Alleanza con gli “stivali sul terreno”, il nuovo mantra sarà forze speciali per operazioni speciali. Di che tipo?
Una luce recente l’ha gettata il britannico Sunday Times che per ora smentite non ne ha ricevute. Secondo il giornale domenicale un’unità dello Special Air Service (Servizio Aereo Speciale), noto anche come Sas – il principale corpo speciale dell’esercito britannico – avrebbe ucciso afgani civili – innocenti e disarmati – nascondendo poi i dettagli dell’operazione per evitare una possibile accusa di crimini contro l’umanità. Sotto la lente di ingrandimento della Polizia militare britannica, che sta indagando oltre una cinquantina di casi, ci sarebbe in particolare un episodio del 2011 nel quale, durante un raid notturno, le forze speciali avrebbero ammanettato e incappucciato i membri di una famiglia dell’Helmand ritenuta talebana prima di sparare. Sparare per uccidere. L’indiscrezione, confermata poi da altri giornali del Regno unito, riferisce di un capitolo nelle carte dell’Operation Northmoor: creata nel 2014, ha il compito di redarre un rapporto classificato preparato dagli investigatori della Royal Military Police che inizialmente avrebbe iniziato a indagare su episodi controversi accaduti tra il 2010 e il 2013 anche se pare che l’indagine avrà comunque un seguito sino al 2021, pur se la maggior parte del lavoro dovrebbe essere completo entro l’estate. Grave tanto quanto la strage sarebbe proprio il fatto che le Sas avrebbero poi nascosto o artefatto lo scenario del killeraggio per farlo apparire in carico ai colleghi afgani. Un esempio perfetto di collaborazione interforze. I raid notturni furono tra l’altro tra i grandi contenziosi tra le forze occupanti e l’amministrazione Karzai.
Nella Gran Bretagna di Theresa May, che ha già promesso l’invio di nuove truppe sul terreno con la Nato, Jeremy Corbyn ha detto di tenere in “seria considerazione” la notizia augurandosi che si faccia piena luce in un caso sul quale chiede anche una commissione indipendente. Dobbiamo temere che la cosa si possa ripetere. Qualche giorno fa, a fine giugno, il segretario generale della Nato Stoltenberg – in occasione di un summit dell’Alleanza – ha confermato che Bruxelles manderà sul terreno “migliaia” di nuovi soldati. Numeri non ne ha fatti ma in compenso ha spiegato che “La Nato ha concluso le operazioni combat” ma che i suoi soldati “continueranno ad aiutare i colleghi afgani”. Come? “Rafforzando le forze speciali afgane”.
 |
| Incursori del Col Moschin. Sopra, i badge di riconocimento Usa e GB |
A metà luglio il Pentagono dirà quanto soldati manderà in Afghanistan (da 3 a 5mila). Un numero “esiguo” se paragonato ai 130mila (60mila erano Nato di cui 4mila italiani) che persero la guerra prima di ritirarsi nel 2014. E’ dunque probabile se non certo che la nuova sarà una strategia molto mirata: raid aerei – di cui è stato un assaggio anche l’ormai famosa “Madre di tutte le bombe” – e operazioni speciali con forze speciali non solo afgane. Inoltre, la nuova strategia prevede carta bianca al Pentagono e maggior autonomia dalla catena di comando nazionale afgana. Per quella data anche il governo italiano dovrà dire se e quanti uomini vuole mandare. Lo chiederà come dovrebbe al parlamento? Chiederà al Paese se siamo disposti ad “aiutare” i colleghi afgani e americani? O conterà sulla pausa estiva? E le forze speciali? Quelle italiane già ci sono da tempo e vanno per conto loro. Sono così speciali che vengono temute anche dai colleghi “ordinari”. Che, quando passano gli speciali, si devono fare da parte senza fare domande.
Meno uno
VIAGGIO ALL’EDENTra oggi e domani in libreriaLaterza edizioniDettagli a seguire…..
Meno due
VIAGGIO ALL’
Meno tre
VIAGGIO
T-shirt e scarpe dell’altro mondo
Non sempre la filiera tra i grandi marchi della moda e i Paesi poveri è così diretta. Un maglietta made in Bangladesh può essere tessuta con cotone uzbeco. E il cuoio di una scarpa prodotta in Cambogia può arrivare da Dacca. Viaggio nella catena nascosta di un’industria che nasconde bene anche il dolore
| Il “palazzo rosa” simbolo del potere del Nawab di Dacca Oggi è un museo. Poco più a Nord i quartieri produttivi di Kamrangirchar e Hazaribagh. Sversano nel Buriganga |
Dal cuore di Old Dakha, la capitale del Bangladesh, bisogna prendere dei piccoli battellini per attraversare il Buriganga e raggiungere l’altra sponda. Su questo largo fiume dalle acque nere come la pece si viene traghettati su piroghe sottili e dall’equilibrio apparentemente instabile. C’è un gran traffico di umanità, animali, utensili che, per qualche centesimo, si spostano dalla riva dove troneggia il palazzo rosa di Ahsan Manzil, una volta sede del “nababbo” (nawab), a un quartiere anonimo dall’altra parte del fiume che scorre verso il Golfo del Bengala. Pieno di negozi di tessuti naturalmente, una delle grandi ricchezze del Bangladesh che ogni anno porta al Paese 30 miliardi di dollari in valuta. Le fabbriche però, grandi o piccole, sono lontane dal centro città: stanno a Savar, dove si è consumato il dramma del Rana Plaza, o adAshulia, distretti suburbani industriali. Ma in pieno centro c’è invece il cuore della produzione di un altro grande bene primario del Bangladesh che se ne va tutto in esportazione: il cuoio. Decine di fabbriche dove si fa la concia delle pelli: la prima lavorazione e quella più tossica che trasforma la materia prima nel prodotto base che può poi diventare scarpa o borsetta. A un pugno di isolati dal Palazzo rosa, nel distretto di Kamrangirchar e in quello gemello di Hazaribagh, divisi dal Buriganga, si lavora in condizioni bestiali anche con l’aiuto di ragazzi di 8 anni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 90% di chi lavora in queste fabbriche di veleni che si sciolgono nel fiume non supera i cinquant’anni. Pavlo Kolovos, il responsabile di tre cliniche di Medici Senza Frontiere a Kamrangirchar, spiega che «la metà dei pazienti che viene negli ambulatori di Msf lo fa per problemi legati al lavoro: malattie della pelle, intossicazioni, insufficienze respiratorie…». Dice Deborah Lucchetti della campagna “Abiti Puliti”: «Le nostre inchieste mostrano come l’esposizione al cromo, quando viene trattato in maniera non adeguata e si trasforma in cromo esavalente, può portare anche al tumore. Senza contare che gli scarti delle lavorazioni vanno a finire in falde e terreni espandendo il danno anche oltre la fabbrica».
Il paradosso è che la materia prima – cotone o cuoio – non sempre viene dal Bangladesh che pure è un grande produttore di uno dei migliori cotoni del mondo. E non sempre i semilavorati finiscono, come avveniva una volta, nei Paesi dove hanno sede le grandi firme americane o europee che sono le vere regine del mercato dell’abbigliamento, dalla gonna allo stiletto, dalla t-shirt al mocassino. Uno dei grandi produttori mondiali di cotone ad esempio è l’Uzbekistan. E’ una produzione antica come il mondo che un tempo rese famosa la Valle di Fergana. E il cotone uzbeco va a finire in Bangladesh che non ne produce abbastanza per alimentare un’industria che vale il 90% dell’export nazionale. Quanto al cuoio, la pelle conciata, prima di andare a finire come scarpa nelle boutique di via Montenapoleone o di Bond Street, fa strade molto diverse. Magari arriva in Serbia oppure, ancora in Asia, in Indonesia, Cina, Cambogia. Due recenti inchieste ci aiutano a gettare una luce, anche se assai sinistra, su questa retrovia dei nostri abiti e delle nostre scarpe. Cominciamo dall’Uzbekistan.
Cotone uzbeco
Un rapporto di Human Rights Watch mette sotto accusa svariati milioni di dollari concessi dalla Banca Mondiale all’Uzbekistan proprio nel campo del cotone. Si chiama aiutare lo sviluppo. Ma se si va a far visita al campo di cotone vero e proprio si scoprono cose molto spiacevoli: nel dossier “We Can’t Refuse to Pick Cotton” Hrw sostiene che il cotone viene raccolto anche da minori e, in gran parte, da gente che non avrebbe nessuna voglia di raccoglierlo (per 5 euro al giorno). Hrw non è l’unica organizzazione ad aver messo sotto la lente la filiera del cotone uzbeco e soprattutto i suoi finanziamenti. Come quello per l’irrigazione – oltre 300 milioni di dollari – nei distretti di Turtkul, Beruni, Ellikkala nel Karakalpakstan dove il cotone conta per il 50% delle terre arate, in un Paese che è il quinto produttore mondiale ed esporta in Cina, Bangladesh, Turchia, Iran. In quelle zone, dice il rapporto, lavoro forzato e minorile continuano. E la Banca Mondiale lo sa perché un gruppo misto – Uzbek-German Forum for Human Rights – glielo ha già fatto sapere da un paio d’anni. Ma anziché sospendere i finanziamenti, BM li ha allargati. Per la verità anche la Banca sta attenta alle condizioni di lavoro e anzi il lavoro minorile è un mantra assoluto nella scala dei diritti da rispettare. Ma i burocrati di Washington non hanno sempre il tempo e la voglia di guardare oltre le carte e così hanno chiesto all’Ufficio internazionale del lavoro di fare accertamenti. L’Ilo l’ha fatto e ha stilato un rapporto dove si citano “progressi”. Ma gli attivisti di Hrw fanno notare che, per stessa ammissione dell’Ilo, non solo un terzo dei raccoglitori è stato obbligato a lavorare (quasi un milione di lavoratori su tre) ma le autorità avevano messo in guardia gli intervistati. Lo stesso rapporto ammette che «…molti intervistati sembravano essere stati preparati alle domande”.
Secondo Hrw la Banca Mondiale e Ifc (International Finance Corporation, un’agenzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) dovrebbero immediatamente sospendere ogni finanziamento fino a che il governo non riesca a dimostrare che non esiste più lavoro minorile e lavoro forzato.
Scarpe e tessuti in Cambogia
Passiamo alla Cambogi. Qualche giorno fa il britannico The Observer ha pubblicato un’inchiesta condotta con la Ong Danwatch sugli incidenti nelle fabbriche cambogiane di alcune delle più note marche sportive: Nike, Puma, Asics e VF Corporation. Solo nell’ultimo anno più di 500 dipendenti di quattro diverse fabbriche che lavorano per le firme occidentali sono state ricoverate in ospedale. Svenimenti di massa. Il problema è il caldo, la mancanza di ventilazione e di regole sui limiti sopportabili in giornate di lavoro anche di dieci ore. I prodotti chimici usati per la produzione fanno il resto. Insomma si lavora così. Lontano dai negozi a quattro luci che esibiscono scarpette e tailleur. Nell’ombra asfissiante del grande supermercato asiatico.
Più truppe in Afghanistan: la Nato risponde signorsi
Non è una novità quanto sta emergendo dal summit Nato a Bruxelles. Già sapevamo che gli Stati Uniti (che – ha detto il capo della Difesa Usa – vogliono “finire il lavoro“) stanno decidendo l’invio di 3-5mila soldati in Afghanistan. E già sapevamo che la richiesta è stata fatta anche agli alleati, in via diretta o indiretta attraverso appunto la Nato. Sappiamo anche che l’Italia avrebbe in animo di mandare 100 soldati per aumentare il secondo contingente straniero numericamente più importante. Ma oggi veniamo a conoscenza del fatto che gli americani non si accontenteranno di “centinaia” di soldatini a far da sostegno ai loro ma ne vogliono “migliaia“. Quante migliaia? Sembra di capire che la richiesta sia per un numero più o meno equivalente alle scelte americane e dunque, probabilmente, attorno ai 4mila uomini. Attualmente la Nato ha 13mila soldati da 29 nazioni (gli italiani sono 1000). Forse si arriverebbe a 17mila. Gli americano di soldati ne hanno 8500 e dunque salirebbero a circa 13mila. In totale potremmo dunque avere entro la fine dell’anno un corpo di spedizione di circa 30mila soldati. Non sono i 130mila di alcuni anni fa ma è pur sempre un bell’impegno che si profila per altro del tutto inutile. Se la Nato non ha vinto la guerra con 130mila militari come spera di farlo con un quarto di quei soldati? Anche perché, vero o falso, la Nato dice che le truppe inviate non saranno “combat”. Che ci vanno dunque a fare?
A metà luglio il Pentagono ci dirà qual è la nuova strategia e come intende vincere la battaglia persa in oltre 16 anni di guerra. A quanto sappiamo sarà una strategia aerea: più aerei e più bombe oltre a un’accordo che dia agli Usa mano libera senza dover sempre chiedere il permesso a Kabul (ammesso che ora lo faccia ma sulla carta è così). Quanto a noi, parteciperemo a questa nuova campagna. In che modo? Forse segnalando gli obiettivi, facendo cioè da sostegno a operazioni dall’aria e senza correre il rischio di riportare a casa i soldati con i piedi in avanti. Non combatteremo ma… Sono davvero pessime notizie anche perché, in Italia, il parlamento non sembra avere voce in capitolo. Tutto è già stato deciso. Altrove. E’ uno stato di vassallaggio che non ci fa onore anche perché, prima di andare in guerra (giusto o sbagliato che lo si ritenga), bisogna sapere a far cosa.
Siamo d’accordo ad appoggiare una strategia di guerra dall’aria? A colpire dal cielo guerriglieri e supposti tali? A sparare nel mucchio con tutti gli effetti collaterali stravisti? La politica dica una parola. Fughi il sospetto che stiamo aderendo all’ennesima missione suicida solo perché siamo vassalli o, peggio, per ottenere qualche poltrona a Bruxelles. Si interroghi la politica e chieda spiegazioni. Il silenzio, ancora prima di partecipare a questo nuovo surge, è già complicità.
The U.S. calls, Italy responds with another 100 troops in Afghanistan
Commentary. The war in Afghanistan is so political that ministers and prime ministers will stay away from it, yielding policy power to the military. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. (il manifesto/global published June 21, 2017)
written by Giuliano Battiston, Emanuele Giordana
 |
| Original source here |
In Afghanistan, politics has abdicated. The military decides everything.
This applies to the United States, where President Donald Trump has delegated to the Secretary of Defense James Mattis the decision on the number of soldiers to be sent to the Central Asian country. It’s also true for Italy, where the Parliament has become an office that certifies decisions already made: paper, stamp, protocol. In an article published by La Repubblica on Saturday, we learned that “the leadership of the armed forces has prepared a plan for boosting the Afghan contingent by another 100 soldiers, who will join the 950 already deployed at the Herat base.”The decision will then be “evaluated by [Defense] Minister [Roberta] Pinotti and Prime Minister Paolo Gentiloni. If approved, Gentiloni will have to communicate it to the Chambers. The involvement of parliamentary committees is not ruled out…”
The pyramid is inverted. The political leadership is not the one — as a result of a collective consultation — to indicate what to do to the armed forces; the armed forces mark the route. There’s more and more inertia. The increase in the number of Italian soldiers deployed in Afghanistan reflects the traditional Atlantic subordination: If the U.S. calls, Italy responds at attention, if anything, claiming a place in the sun (“Italy aspires to occupy some key seats” at NATO).
And it goes back to the balance between institutional powers, with foreign policy subjugated to “defense” and the Parliament as a place of policy and conflict resolution.
But the war in Afghanistan is, first and foremost, a political war. Actually, so political that ministers and prime ministers will stay away from it. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. Their solution, then, is simple: Discuss it as little as possible, while giving carte blanche — and responsibility — to the military. Get used to saying yes.
The Italian “yes” follows that of other countries such as the U.K. and Denmark, which have already promised their support to NATO for the American surge that, so far, has been discovered through leaks to the press. Trump gave Mattis the authority to decide how and how many U.S. troops will go to swell the ranks of the 8,400 star-spangled soldiers are already operating in Afghanistan. According to Mattis, details will be clarified in mid-July.
In the meantime, the debate rages. Analysts wonder what the new American surge will accomplish in a country where the military mission has been fruitless. But the leading theoretician of the surge, retired General David Petraeus, has not only given his support to sending new soldiers but made clear in an interview some of the details of Mattis’s plan. For the surge in Iraq and Afghanistan, not only is the number of 3,000 or 5,000 soldiers “sustainable,” but the United States “should relax the remaining restrictions on the use of our air power to support our Afghan partners.”
In other words, not just more troops, but more bombs — and without restrictions that, at least in theory, require the Air Force to advise and agree with Kabul on its raid plans. However, the Afghan authorities have already experienced a surge in a way: For the last two years, the number of civilian casualties from the sky has increased.
The Pentagon may finally get a free hand without having to await permission from Kabul or orders from the president for actions that normally require the approval of the White House.
If the U.S. military is no longer mandated to present its plans in Kabul, the military would become a superpower. It already gave a sign of its intentions in April with the deployment of the so-called “Mother of All Bombs,” which dropped 11 tons of explosives in the border area with Pakistan.
Il Califfo e l’Asia a Radio Radicale
Una presentazione di A Oriente del Califfo su Radio Radicale nel programma di Francesco De Leo.Un libro di Lettera22Al minuto ’32
Lacrime sul golfo del Bengala – Passioni del 24 e 25 giugno
 Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di
Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di
Giulia Nucci, un viaggio nel lavoro esternalizzato. E nel dolore
alle 14.30 sulle frequenze di Radio3
Diretta
Podcast
Dacca non è solo la capitale del Bangladesh ma anche la capitale della globalizzazione del lavoro, dalle nostre scarpe alle magliette. Finisce così anche per essere una capitale del dolore in un Paese che cresce a ritmi vertiginosi ma dove i profitti vanno a vantaggio di un’élite molto ristretta. Dalle macerie del Rana Plaza alle concerie del cuoio in pieno centro città, viaggio nella nazione affacciata sul Golfo del Bengala. Che sembra lontanissima ed è invece presente nella quotidianità diffusa del “Made in Bangladesh”.
Il viaggio che mi ha permesso di scrivere il capitolo sul Bangladesh di “A Oriente del Califfo”
Buon viaggio Americo
 |
| Una rarissima immagine (presa dal sito dell’Agenzia Italia) dello schvio Sbardella |
Due giorni fa se n’è andato Americo Sbardella. Un amico ma anche una pietra miliare della mia e di altre generazioni. L’ho conosciuto diversi anni fa a Prati, un quartiere della capitale – quando sono stato a casa di Americo, sua moglie Isabella e la figlia Angelica – per la festa dell’ultimo dell’anno. Non sapevo che Americo, un signore di poche parole e dalla conversazione assolutamente non invasiva, era stato il fondatore e l’ideatore del FilmStudio, un’esperienza che, con Annabella Miscuglio, aveva segnato profondamente la vita culturale della capitale e non solo. Quando andavamo a Roma, negli anni Settanta, il Filmstudio era una sorta di riferimento fisso. Potevi anche non andarci al cinema, ma c’era. Anche se non sapevi il nome di chi aveva inventato quell’incredibile aeroporto culturale con voli da tutto il mondo.
Per dirla con Massimiliano Studer (la sua intervista ad Americo si può sentire qui) “Su posizioni vicine al situazionismo francese e giovane cinefilo “assatanato”, Americo Sbardella nel 1966/67 sostenne la necessità di collegarsi in maniera non episodica con le cooperative di produzione e di distribuzione di cinema sperimentale e di quello politico-militante, in Italia ma soprattutto all’estero … con gli autori indipendenti europei e americani… con la prospettiva di creare e gestire uno spazio- cinema del tutto autonomo, un filmclub. Si trattava di creare una nuova forma associativa, un’associazione privata con tessera per i frequentatori, non aderente alle federazioni nazionali dei cine-club riconosciute dallo Stato, con proprie salette di proiezione, attrezzate con il 35mm, il 16mm, il super8 e il videoproiettore. Questo tipo di struttura prescindeva dal visto di censura ufficiale…”. Già, la censura ufficiale in grado di mandare al rogo le pellicole.
 Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.
Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.
Poiché un tipo come Americo detestava l’agiografia mi fermo qui. Anche perché non so nulla di cinema (anche se la mia famiglia ha prodotto un grande regista e una studiosa della materia che ne sanno ovviamente più di me) e sarei davvero di scarso aiuto per chi si avvicina allo Sbardella uomo di cinema. Lo voglio invece ricordare come uomo di mondo e non solo per esser stato quel gentiluomo che è stato (lavorammo tra l’altro assieme per presentare l’ultima grande rassegna che nel 2003 passò al Filmstudio), ma anche per essere stato quel bandito necessario che l’epoca richiedeva. Bandito? Si, un bandito disposto a bypassare, oltre alla censura, le maglie troppo strette del business legato a suoni e immagini. Una volta, e probabilmente non fu l’unica, proiettò il concerto di un importante gruppo musicale inglese che era stato piratescamente riprodotto da un amico a Londra. Lo rese disponibile a tutti nello spirito che allora ci accomunava negli anni Settanta. Che un po’ forse si è perso. Ma che Americo non deve aver credo mai perduto. Buon viaggio Americo. E un abbraccio a Isabella e Angelica.
Armiamoci e partiamo: anche i nostri stivali nel deserto afgano
 Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto
Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto
Il “si” italiano seguirebbe quello di altri Paesi che, come Regno Unito e Danimarca, hanno già promesso alla Nato il loro appoggio al surge americano, anche quello per ora affidato solo a indiscrezioni di stampa. Stando al capo del pentagono James Mattis. i dettagli della nuova missione saranno chiariti definitamente a metà luglio. Il dibattito intanto infuria. E mentre sui giornali ci si chiede a cosa serve il nuovo “surge” americano in un Paese dove la missione militare non sta ottenendo risultati, il massimo teorico del “surge”, il generale in pensione David Petraeus, non solo ha dato il suo appoggio all’invio di nuovi soldati ma ha chiarito, in un’intervista, alcuni dei dettagli che probabilmente Mattis si prepara e mettere nero su bianco: non solo, dice l’ex teorico del surge in Irak e Afghanistan, 3 o 5mila soldati sono un numero “sostenibile”, ma gli Stati Uniti devono “sciogliere le restrizioni” ancora in piedi nell’uso della forza aerea. Se non si dovesse render più conto nemmeno a Kabul di quel che si fa, quello militare diventerebbe uno strapotere che ha già comunque dato un segno nell’aprile scorso col lancio della famosa Moab da 11 tonnellate di esplosivo. Operazioni di cui, ancora una volta, stiamo diventando non solo silenti spettatori ma solerti conniventi.
A seguire per il manifesto un’analisi a 4 mani con G. Battiston
Dondero l’Africano
Da domani sino al 5 luglioLeggi qui la presentazione di Peppino Buondonno su il manifesto
La luce verde del guerrafondaio riluttante ai generali
 |
| Tre generali: Mattis, attuale capo del Pentagono. Sotto a sn Nicholson. A dx McMaster |
Alla fine la luce verde del presidente è arrivata. E benché si tratti ancora una volta di indiscrezioni giornalistiche, anche se ben verificate, Donald Trump, l’uomo che aveva promesso il disimpegno dai fronti di guerra, ha dato l’autorità al titolare della Difesa James Mattis di decidere come e quanti soldati americani andranno a ingrossare le fila degli 8.400 militari stellestrisce che operano in Afghanistan.
In un’audizione al Senate Armed Services Committee, Mattis – un generale dei marine, già a capo dell’US Central Command, responsabile del teatro afgano e mediorientale – numeri non ne ha fatti. Ma a detto che a metà luglio renderà conto della nuova strategia per battere la guerriglia talebana. Un “nemico barbaro”, come Mattis l’ha definito in altra occasione, in perfetta sintonia con le recenti aperture del governo di Kabul a quelli che Karzai chiamò persino “fratelli”. Mattis però, così come il consigliere per la sicurezza di Trump generale McMaster, alla via pacifica crede poco. E in questo è davvero in sintonia con John Nicholson, il capo delle forze Usa e Nato sul terreno (altri 5mila uomini tra cui mille italiani): è lui il principale fautore di “più stivali” in teatro, come si dice in gergo.
 La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).
La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).
Per ora gli americani hanno circa 7mila uomini nel contingente multinazionale Nato di cui hanno il comando e che ha come mandato quello di fare formazione militare e non di combattere. Ma ora le regole potrebbero cambiare: i nuovi arrivi si unirebbero probabilmente ai circa 2mila soldati Usa impegnati in operazioni “combat” e sarebbe il Pentagono, non la presidenza, a decidere regole di ingaggio e strategia locale. Che per adesso, da un paio d’anni a questa parte, si è concentrata sui bombardamenti dal cielo, l’attività dei droni e il test della GBU-Moab, la cosiddetta “Madre di tutte le bombe” che solo il Papa ha per ora avuto il coraggio di criticare. Quanto all’Italia, nemmeno una parola. Né dal governo, né dall’opposizione. La guerra in Afghanistan, nonostante le Moab, il surge e mille soldati, è dietro le spalle anche per noi.
Stivali sul terreno
 Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.
Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.
E’ ormai da un mese che se ne discute e ci si attendeva da Trump una aperta richiesta di sostegno ai partner della Nato nell’ultimo vertice dell’Alleanza dove però il presidente non ha fatto menzione di una scelta che contraddice quanto ha sempre sostenuto in campagna elettorale. La Nato ha comunque già chiesto agli alleati un possibile aumento delle loro forze nel Paese dove sono schierati in totale circa 13mila militari stranieri, 5mila dei quali in forza all’Alleanza (l’Italia con 1000 uomini).
Bombe a Kabul: il giallo si infittisce
 |
| Sirajuddin Haqqani in una ricostruzione dell’Fbi |
Dopo aver preso lo stesso 31 maggio e con una solerte rapidità le distanze dalla bomba che ha ucciso a Kabul un centinaio di persone, i talebani tornano a smentire ogni coinvolgimento nell’attentato del mercoledi nero chiarendo, con un messaggio affidato al loro sito internet, che la guerriglia colpisce solo obiettivi militari e non spara mai nel mucchio. A dar più forza alla presa di distanze (la terza in pochi giorni) c’è anche un messaggio audio di Sirajuddin Haqqani, l’uomo a capo della Rete Haqqani e vice di mullah Akhundzada il leader del movimento. L’intelligence afgana è invece certa del coinvolgimento degli Haqqani che risponderebbe, dicono a Kabul, a un ordine venuto dia pachistani. E’ la prima volta non solo che i talebani reiterano una loro presa di distanze da un attentato ma che difendono con tanta alacrità la Rete Haqqani, in passato scheggia impazzita del movimento e solita agire per suo conto.
Quanto al “Processo di Kabul”, l’ultimo sasso lanciato dal governo per negoziare con la guerriglia (con l’offerta ai talebani di aprire un loro ufficio nella capitale) i guerriglieri di mullah Akhundzada ribadiscono la loro posizione con un messaggio di poche righe: “Qualsiasi conferenza venga riunita per prolungare la presenza degli occupanti è futile e viene rigettata”.
L’Afghanistan visto dall’Asia Centrale*
 |
| Asia centrale, il cuore dell’Asia |
Abstract: The countries of Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan define a human and political space strongly influenced by its bordering territories: by Russia, obviously, but also by Pakistan, Iran, and, most importantly, by Afghanistan – a country wretched by forty years of war and generally seen as a threat rather than as a resource. However, interactions between the former five soviet republics and Kabul are unavoidable: the Islamic common denominator, the porosity of borders, the presence of shared norms and practices and the existence of communities, often speaking the same language, further reinforce such belief. Furthermore, in light of future infrastructural developments of road networks, railway lines and, possibly, of energy vectors, partnerships between the five republics and Afghanistan seem the most logical solutions.
Even if each county deals with Kabul its unique way, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan all fear the contagion of war or that of the jihadi message and explain the spread of the politics of Islam within their territories through the failures of the Afghan government. A statement contested both from the inside, with the Afghan government refusing to validate the jihadi narrative, and from the outside: many observers have indeed highlighted how the ‘Afghan danger’ is better understood as a political tool used to repress possible challenges to the political establishment, rather than as an effective threat.
Nevertheless, some positive developments are on their way: negotiations regarding a seemingly difficult partnership between Kabul and the five republics is currently ongoing and further supported, in several instances, by manifestations of international cohesion fostering and financing the expansion of strengthened bilateral agreements.
Le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan formano uno spazio umano e politico fortemente influenzato dai Paesi vicini. La Russia, naturalmente, ma anche il Pakistan o l’Iran e, soprattutto, l’Afghanistan, un Paese in guerra ormai da quasi quarant’anni che è visto più come pericolo che come risorsa. Il rapporto con l’Afghanistan è però ineludibile: per il comun denominatore islamico, la porosità delle frontiere, tradizioni comuni e presenza di comunità che spesso parlano la stessa lingua. Un rapporto che ha un senso anche in ragione di un possibile futuro sviluppo di reti stradali, ferroviarie o di vettori di energia. Se ogni Paese ha nei rapporti con Kabul un atteggiamento diverso, tutte le repubbliche ex sovietiche temono il contagio della guerra o del messaggio islamista e attribuiscono all’Afghanistan la responsabilità dell’espansione dell’islam politico all’interno dei propri confini. E’ una posizione contestata sia all’interno da chi si ritene ingiustamente accusato di propaganda jihadista, sia all’esterno: molti osservatori infatti ritengono che il “pericolo afgano” venga agitato per consentire la repressione e il contenimento di qualsiasi forma di contestazione delle leadership al potere. Non di meno, alcuni progressi si vedono: è in corso un’operazione di difficile costruzione di una partnership con Kabul aiutata, in molti casi, da esperimenti di coesione internazionale che hanno dato impulso e garantito finanziamenti per l’espansione di rapporti bilaterali più saldi.
* Questo articolo è stato pubblicato su IL POLITICO (Univ. Pavia, Italy) 2016, anno LXXXI, n. 3, pp. 136-149 (le note al testo sono contenute nell’edizione cartacea)
 |
| Asia Centrale e Caucaso |
In una carta geografica dell’Asia, l’Afghanistan rappresenta una sorta di centro ideale: al confine con l’Iran a Occidente, con quello rappresentato dal subcontinente indiano a Oriente, frontiera meridionale delle repubbliche centroasiatiche ex sovietiche a Nord. Se effettivamente l’Afghanistan faccia parte dell’Asia Centrale, e cioè di quel mondo che comprende le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, è in realtà una convenzione per alcuni e non per altri. Ne fa parte in un certo senso geograficamente ma in realtà il suo centro di gravità sono i due grandi confinanti che la circondano a Est, Ovest e Sud: l’Iran e il Pakistan, la fine del Medio Oriente e l’inizio dell’Asia meridionale.. Quanto alle cinque repubbliche ex sovietiche, lo sguardo è sicuramente più centrato, seppur con forme e modalità diverse, verso Russia e Cina e Stati Uniti. Il legame col parente meridionale (sicuramente parente per motivi storici, culturali etnici e linguistici) appare oggi soprattutto o come una sorta di “dovere” (spesso suggerito da altri), o uno sguardo obbligato dalle preoccupazioni che riguardano due aspetti in particolare: la sicurezza – col corollario di un possibile contagio lungo i confini meridionali – e il narcotraffico. I legami economici sono poca caso, salvo rare eccezioni (come nel caso del progetto tapi1), il flusso transfrontaliero è limitato, le alleanze sono fragili e il sostegno alla partecipazione dell’Afghanistan a percorsi politici aggregativi (come nel caso del Processo di Istanbul)2 appare più come un aspetto di strategia politica generale – spesso su pressione di altri attori – che non un focus volto a rafforzare il parente bistrattato dalla guerra. Il quadro delle relazioni tra le cinque repubbliche e Kabul va dunque visto anche all’interno delle pressioni e delle relazioni con i grandi attori non solo regionali ma internazionali: la Russia, in primis, la Cina, soprattutto per l’aspetto economico, e gli Stati Uniti (in misura assai minore l’Unione europea). Quanto agli attori regionali, per questi Paesi contano forse più dell’Afghanistan il peso economico e la statura politica di nazioni come Iran e Pakistan.
Che la preoccupazione principale di Astana, Bishkek, Ashkabad, Tashkent, Dushanbe, sia soprattutto l’aspetto sicurezza e stabilità lo dimostra anche il fatto che nel 2014, alla vigilia delle presidenziali afgane, i riflettori delle cinque capitali si sono riaccesi – come quelli di tutti gli altri Paesi coinvolti nella guerra afgana a vario titolo – in attesa di eventi da cui ci si aspettavano grandi novità; lo dimostra anche la pubblicazione di numerose monografie e ricerche sui rapporti tra l’Afghanistan e le repubbliche (due in particolare da segnalare3), attenzione che è poi scemata pur se il quadro uscito dalle elezioni afgane è in realtà ancor più instabile del precedente e il conflitto, benché snobbato dai riflettori della cronaca, stia conoscendo una nuova accelerazione e proprio nel Nord del Paese. Che ha, nelle repubbliche frontaliere, creato un nuovo allarme specie dopo la presa di Kunduz da parte dei Talebani, anche se per pochi giorni, nell’ottobre 2015 e poi ancora nel 2016.
1 La partita regionale
Secondo diversi analisti le preoccupazioni che riguardano la sicurezza sono in realtà da leggersi, in molti casi, anche in chiave interna: più che per il timore di un contagio o per fatti reali che giustifichino una preoccupazione vera per la minaccia di un’espansione dell’islamismo armato,
i Paesi centroasiatici avrebbero cioè utilizzato e utilizzerebbero il “pericolo jihadista” anche per contenere le spinte dal basso che possono mettere in difficoltà (come già avvenuto in passato) il sistema di potere locale. Lo stesso per il narcotraffico, attività economica sotto traccia che consente il transito di oppio e oppiacei prodotti in Afghanistan. Riprendendo i due temi (sicurezza e narcotraffico) Bleuer e Kazemi scrivono che: «Il rischio in termini di sicurezza che lega l’Afghanistan alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale viene di frequente altamente esagerato e così il presunto collegamento tra narcotraffico e gruppi radicali islamisti. In realtà in tutta l’Asia Centrale i principali attori del narcotraffico sono impiegati governativi, agenti della sicurezza e personaggi legati alla mafia… ». E ancora, scrivono, non esiste « …una grave minaccia alle Repubbliche centroasitiche da parte di terroristi e insorti del Nord dell’Afghanistan che vengono normalmente reclutati tra gli afgani per agire localmente4». I Talebani afgani del resto, contrariamente ad Al Qaeda o allo Stato islamico, la cui presenza in quest’area è al momento residuale, hanno sempre sottolineato la natura nazionalistica della loro battaglia per l’instaurazione di un Emirato in Afghanistan e solo in Afghanistan. Chiarendo, al primo punto della loro agenda politica, che l’obiettivo primario è la cacciata degli stranieri dal territorio afgano5, non certo l’espansione oltreconfine del loro jihad.
Non di meno, è evidente che per i Paesi dell’Asia centrale l’Afghanistan resta un elemento importante e preoccupante in un quadro regionale complesso e da secoli al centro di interessi geostrategici, economici e politici che hanno ripreso fiato dopo la fine del dominio sovietico e un ridimensionamento della presenza russa, come provano soprattutto la politica espansiva di Cina e Stati Uniti6. L’Afghanistan resta infine particolarmente preoccupante per tre delle cinque repubbliche che ne condividono il confine, come ha provato nel 2015 la mobilitazione sia centroasiatica sia russa lungo l’Amu Darya (per via degli accordi sulla difesa delle frontiere), specie per Uzbekistan e Tagikistan a un pugno di chilometri dalla città di Kundz, presa allora per qualche giorno dalle milizie in turbante e nuovamente sotto tiro dall’ottobre del 20167.
L’Afghanistan è dunque comunque importante nel rapporto con i grandi attori dell’area centroasiatica (e più o meno direttamente legati alle vicende della guerra afgana) e il Paese, se non lo è oggi, resta d’altronde uno snodo fondamentale per il transito delle merci (anche se ora l’interscambio con le repubbliche è minimo) e soprattutto delle pipeline. Vista dalle cinque capitali dunque, Kabul è forse attualmente più motivo di cruccio che risorsa pur se lo è diventata sia per l’utilizzo in chiave interna dello spauracchio jihadista, sia perché la relazione con l’Afghanistan passa anche per il rapporto con altri attori (dalla Turchia al Pakistan, da Mosca a Washington, da Teheran a Pechino) o organismi internazionali (onu, nato alleanze regionali). Quel che va rilevato è che non essendoci in realtà una politica comune dei cinque Paesi centroasiatici, ogni nazione agisce per suo conto e percepisce, osserva e agisce in maniera diversa e a volta addirittura opposta.
Vedremo qui le grandi linee su cui si muovono i singoli Paesi e infine dedicheremo uno spazio all’attuale situazione afgana, per ora assolutamente lontana da una stabilizzazione efficace e soprattutto da una indicazione che si stia modificando lo scenario dominato dal conflitto anziché da quel negoziato politico con la guerriglia, al netto dei tentativi per ora senza successo, e da cui le repubbliche centroasiatiche sono per ora quasi totalmente escluse.
2 Tagikistan, il vicino prossimo
 |
| Il paesaggio: montagne, pianure, acque |
Il Tagikistan, teoricamente il parente più prossimo tra le cinque repubbliche – per affinità storiche, linguistiche e culturali oltre a un confine comune di oltre 1.300 chilometri – ha con l’Afghanistan scarsi rapporti economici (benché in ascesa) e un diffuso pregiudizio8 sia nei confronti dei rifugiati afgani nel Paese (circa 2.550 nel 2014) sia nei confronti di una nazione che si ritiene un pericolo costante alla frontiera, per problemi legati alla guerra, a infiltrazioni e alleanze jihadiste o al narcotraffico9. Collegate dal grande ponte sull’Amu Darya che unisce la provincia afgana di Kunduz a quella tagica di Kathion e da altri sei piccoli ponti che portano dal Tagikistan nella provincia orientale afgana del Badakshan, Dushanbe e Kabul restano lontane anche se esiste un rapporto a volte di una certa intensità sul piano culturale per iniziativa della società civile dei due Paesi.
Nonostante un interscambio commerciale ridotto, per Dushanbe l’Afghanistan rappresenta comunque un buon investimento nel settore energetico, soprattutto a partire dal 2012 quando è iniziata l’esportazione verso l’Afghanistan di energia elettrica. Kabul aveva anzi aderito al progetto noto come casa-1000, che inizialmente avrebbe dovuto portare da Tagikistan e Kirghizistan elettricità in Pakistan e Afghanistan per un totale di 1300 megawatt (1000 in Pakistan e 300 in Afghanistan). Kabul si è poi ritirata dal progetto, lanciato ufficialmente nel 2016, a un mese dalla cerimonia di avvio10 e il Pakistan usufruirà dell’intera fornitura presumibilmente entro il 2018. Ma il futuro potrebbe riservare sorprese.
Il Tagikistan, retto dal 1992 da Emomali Rahmon (che dal 1992 al 1997 ha affrontato una gravissima crisi senza risolvere i problemi alla base della guerra civile11) considera il turbolento vicino un elemento in più di destabilizzazione per un Paese, il suo, che si regge su un fragile equilibrio. Non di meno, nel giugno del 2009, il presidente tagico aveva proposto un incontro nella sua capitale tra afgani, pachistani e russi per costruire una cooperazione quadrilaterale (Dushanbe Four). Di fatto, al netto di diversi incontri, l’iniziativa non ha prodotto grandi risultati se non quello di apparire come un tassello del piano di riavvicinamento di Mosca a Kabul.
3 Uzbekistan, il vicino in allarme
L’Uzbekistan e l’Afghanistan – collegate dal tristemente famoso “Ponte dell’Amicizia” riaperto nel 2001 – hanno visto nell’ultima decade la firma di numerosi accordi per dare impulso a un interscambio economico che, sino al 2001, era praticamente inesistente. Ma gli accordi non sembrano per ora vedere un trend particolarmente significativo anche se l’interscambio è aumentato e Tashkent vende a Kabul elettricità diretta soprattutto nel Nord del Paese. Non di meno, la strategia uzbeca, più che quella di favorire il vicino – in realtà osservato con grande preoccupazione – mira a utilizzare l’Afghanistan semmai come area di passaggio in un piano di ristrutturazione delle forniture energetiche che ha come obiettivo altri Paesi. Può essere indicata come una scelta comunque significativa quella della ferrovia Hairatan-Mazar-e-Sharif, un progetto di 75 chilometri di strada ferrata, in gran parte finanziato dall’Asia Development Bank12, che collega l’importante centro afgano alla frontiera uzbeca e quindi a Termez. Inaugurata nel gennaio del 2012, la ferrovia avrebbe, secondo l’adb, trasportato in 5 anni 11,7 milioni di tonnellate di beni per un valore di oltre 115 milioni di dollari, favorendo la connessione coi mercati dell’Asia Centrale e della Cina13. Il progetto rappresenta la prima fase di un network ferroviario che include Herat e collegamenti con Tagikistan e Pakistan14.
Sul piano politico va segnalata nel 2008, durante l’incontro nel quadro dell’Euro-Atlantic Partnership Council della Nato tenutosi in Romania, la proposta dell’allora presidente Islam Karimov (morto nel settembre 2016) di istituire un ‘6+3’ Contact Group for Afghanistan sotto egida ONU che avrebbe incluso Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan accanto a NATO, Russia e Stati Uniti (escludendo sia il governo di Kabul sia la resistenza armata), con l’obiettivo di studiare l’approccio a una risoluzione del conflitto. Proposta poi rilanciata in sede ONU nel dicembre 2013 ma senza seguito.
L’Uzbekistan, assai più di altri partner regionali (con l’eccezione del Turkmenistan), si è mosso negli anni con iniziative anche autonome – spesso di segno opposto – sia col governo o con gruppi anti- talebani (noto il suo appoggio al generale Dostum, attuale vicepresidente afgano) ma anche con la guerriglia diretta allora da mullah Omar: l’obiettivo era soprattutto quello di far terra bruciata attorno al Movimentato islamico dell’Uzbekistan (mui), al punto che il governo uzbeco era arrivato a proporre ai Talebani, agli inizi del 2001, persino un riconoscimento dell’Emirato in cambio dell’espulsione dei militanti del mui15 dall’Afghanistan. Nel contempo il governo uzbeco si è distinto per una militarizzazione dei suoi confini (non solo afgani ama anche tagichi e kirghisi) considerando l’Afghanistan e i suoi movimenti islamisti una minaccia per la sicurezza del Paese, preoccupazione reiterata formalmente in più occasioni e sostenuta da una preparazione militare e di intelligence (con formazione tecnica fornita dagli Stati Uniti) che non teme confronti con le altre repubbliche.
Sul piano interno il governo uzbeco, più volte denunciato per la brutalità del trattamento riservato agli oppositori16, utilizza il “rischio afgano”, assai più che in altre repubbliche, come elemento in chiave interna volto alla repressione non solo di gruppi islamisti (aderenti al mui o all’Unione della Jihad islamica17 o supposti tali) ma in generale di oppositori al regime.
4 Turkmenistan, il vicino attivo
Durante l’epoca del governo talebano, il governo del Turkmenistan, pur non avendo ufficialmente riconosciuto il regime, aveva mantenuto rapporti stabili e, in un certo senso, cordiali con l’Emirato di mullah Omar: una scelta volta a preservare il Paese da ritorsioni o infiltrazioni talebane e confermata dalla neutralità al momento dell’invasione delle truppe straniere che nel 2001 combatterono il regime della guerriglia in turbante. Un altro buon motivo era quello di conservare buone relazioni col Pakistan (che aveva riconosciuto il regime), cliente per le forniture energetiche. Le cose sono cambiate alla morte di Niyazov nel 2006 con l’arrivo dell’attuale presidente Gurbanguly Berdimuhammedow che ha aperto agli Stati Uniti e ha autorizzato il sorvolo del Paese da parte dell’aviazione militare americana, cui ha fornito negli anni sostegno logistico e rifornimenti di carburante. Al di là delle dichiarazioni di disponibilità a sostenere ogni possibile strategia di uscita dalla crisi afgana e una discreta attività in campo diplomatico, l’iniziativa forse più rilevante del Turkmenistan è l’ospitalità offerta all’UN Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia ad Ashkabad18. Non di meno, pur non ritenendo l’Afghanistan un rischio così temibile come altre repubbliche, il Turkmenistan ha rafforzato il suo sistema di sicurezza lungo la frontiera (744 chilometri) negli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, il progetto più interessante e che prevede un investimento stimato a circa 7 miliardi di dollari è il già citato tapi19 Coinvolge Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e Unione indiana e prevede l’esportazione di oltre 33 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso circa 1800 chilometri di tubi dal Turkmenistan, via Afghanistan, al Pakistan e all’India (i lavori sono iniziati nel 2015 e dovrebbero concludersi nel 2019). L’Afghanistan dovrebbe goderne per 5 miliardi di metri cubi (lungo l’asse stradale Herat-Kandahar-Quetta) e 14 rispettivamente andrebbero a Pakistan e India. Da segnalare infine il progetto tat (Turkmenistan-Afghanistan-Tagikistan) che dovrebbe sviluppare oltre 600 chilometri di ferrovia (di cui 400 in territorio afgano) che collegherebbero Atamurat in Turkmenistan a Panji in Tagikistan passando per il Nord dell’Afghanistan e collegandosi alla linea che già porta in Uzbekistan. Il costo stimato varia tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. Il 28 novembre 2016 il presidente afgano Ghani e il suo omologo turcmeno Berdimuhamedow hanno inaugurato la tratta da Imam Nazar (Turkmenistan) ad Aqina (Afghanistan), passo in avanti sul progetto tat.
5 Kirghizistan, il vicino preoccupato
Con l’avvio del progetto casa-1000, da cui come abbiamo visto Kabul si è al momento ritirata, il Kirghizistan avrebbe assunto un ruolo rilevante nei confronti dell’Afghanistan e l’accordo avrebbe segnato una svolta in relazioni economiche il cui volume d’affari resta minimo (se si esclude quello illecito legato la narcotraffico e al contrabbando). La presenza di afgani nel Paese non ha grandi numeri limitandosi a qualche centinaia di persone, che comprendono, oltre ai rifugiati, migranti economici o studenti, molti dei quali sostenuti da borse di studio. La relazione forte con le vicende afgane si deve in realtà alla presenza della base militare americana di Manas (2001-2014) attualmente un Centro di transito dopo che è tornata nelle mani di Bishkek. La base, che serviva alle forze aeree americane come spazio logistico, è stata chiusa anche grazie alle forti pressioni in questo senso di Mosca e Pechino20. Il Kirghizistan ha comunque sempre considerato l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza definendolo addirittura il maggior pericolo esterno per il Paese, una formula reiterata nel National Security Concept. E una formula che tende a far apparire maggiore più di quanto non sia il rischio di contagio dall’Afghanistan anziché da alcune aree della Federazione russa21. Al netto delle speculazioni sull’utilizzo del “rischio Afghanistan” in chiave interna, va però menzionata un’idea lanciata per la prima volta nel 1998 per la preparazione di una Conferenza di pace internazionale sull’Afghanistan che però non ha mai fatto strada, nonostante nel 2009 il presidente Kurmanbek Bakiyev avesse riproposto l’iniziativa (chiamata appunto “Bishkek Initiative”) che intendeva costruire un centro di studi e ricerca sulla sicurezza e la stabilità in Asia centrale (anche quella senza seguito22). Il Kirghizistan aveva anche lanciato l’idea di una ristrutturazione del suo debito in cambio di forme di assistenza allo sviluppo in Afghanistan.
6 Kazakistan, il vicino lontano
Pur essendo geograficamente il Paese più lontano tra le cinque repubbliche, il Kazakistan si è comunque distinto per il sostegno all’integrazione regionale e internazionale dell’Afghanistan in più occasioni e in più organismi multilaterali. Ha investito in aiuto allo sviluppo, avviato sforzi per migliorare le relazioni commerciali, offerto sostegno per la formazione locale e nominato un rappresentante speciale per Afghanistan e Pakistan sull’onda di quanto fatto dai maggiori protagonisti stranieri nella guerra afgana. Nel 2012 ha anche lanciato un’iniziativa per la creazione di un Centro con sede in Kazakistan per facilitare una migliore cooperazione tra i Paesi dell’Asia centrale e volta a sostenere l’Afghanistan. Benché gli scettici giudichino questa politica più mirata a rafforzare all’estero l’immagine del Paese che non a immaginare un investimento strategico vero e proprio in Afghanistan, nel 2010 i kazachi hanno dichiarato in sede osce (di cui avevano la presidenza) che l’Afghanistan sarebbe stato una delle priorità della politica estera di Astana.
Il governo kazaco, a differenza di altri, non considera comunque l’Afghanistan un rischio per la sua sicurezza nazionale.
7 Il quadro afgano
Le elezioni presidenziali del 2014 che, come abbiamo visto hanno attirato nuovamente l’attenzione sul Paese anche se i riflettori della cronaca si sono poi andati lentamente spegnendo, si sono concluse con un accordo a tavolino che ha prodotto una bizzarra alchimia istituzionale, non prevista dalla Costituzione ma frutto di un disegno pragmatico volto a salvare almeno le apparenze di una tornata elettorale gravata da brogli e reciproche accuse tra i due principali candidati. Ashraf Ghani è diventato presidente della Repubblica e ad Abdullah Abdullah, un uomo legato alla vecchia Alleanza del Nord composta in gran parte da afgani tagichi23, è stato riservato un ruolo a metà tra il co-presidente e il primo ministro (chief executive). Il parto non è stato privo di difficoltà e il risultato sembra solo averle aumentate: questa sorta di diarchia ha di fatto paralizzato il governo per mesi sia nella nomina dei ministri, sia nell’attribuzione delle cariche secondarie, sia nella scelta dei governatori. Qualsiasi decisione, dalla più grande alla più piccola, è stata oggetto di dibattiti infiniti mal digeriti sia dal parlamento sia dal corpo elettorale che, nei sondaggi, ha visto un enorme calo di consenso verso quel governo di unità nazionale in cui tante speranze erano state riposte.
Questo preoccupante quadro politico è purtroppo sempre accompagnato da una cornice non meno angosciante: unama, la missione onu a Kabul, nel rendere noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015 ha riferito di 11.002 casi24, con un incremento del 4% rispetto al 2014 e un trend impressionante di crescita25. Anche le perdite dell’esercito afgano sono state pesanti e, tra gennaio e agosto 2016, sarebbero stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti (9.665 i feriti). Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi.
Il quadro economico resta segnato da una crisi iniziata col ritiro della maggior parte dei contingenti militari americani e Nato ed è marcato da un indebolimento della valuta, da una caduta degli investimenti e dalla fine della bolla speculativa nel settore edilizio creatasi nelle principali città26. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine dell’Onu infine, il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero mentre la produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 nel 201627.
Il vero malato è però il processo negoziale che dovrebbe por fine alla guerra. I due principali attori regionali – i governi di Kabul e Islamabad – continuano ormai dal 2015 a litigare accusandosi reciprocamente in una sorta di gara a dimostrare che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese vicino. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione con toni anche violenti: Pakistan e Afghanistan si creano inoltre vicendevolmente problemi alla frontiera per il transito delle merci e l’intelligence dei due Paesi, anziché collaborare, nasconde o mistifica le informazioni. In questo quadro, il Pakistan ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. Le espulsioni (che nel novembre 2016 avevano già raggiuntano quota 400mila) hanno messo in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani che vivono in Europa che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi. Quanto al processo negoziale, che nell’estate del 2015 era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni nel movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte ha visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader. In realtà, ma il condizionale resta d’obbligo, il processo negoziale, o quantomeno le trattative più o meno segrete, continuano sotto traccia. Mentre il governo di Kabul ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyar, fonti di stampa hanno rivelato28 che sarebbero avvenuti due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l’Ufficio politico del movimento guidato da Akhundzada. I talebani hanno smentito ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Vi avrebbe partecipato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan, ma non i pachistani il che ha fatto riemergere nuove tensioni anche se in seguito i Talebani hanno inviato una missione “informativa” nel Paese dei puri.
Conclusioni
Lungi dall’essere stato risolto, il nodo della guerra rimane il peggior nemico di un processo di integrazione sia a livello regionale in Asia Centrale sia a livello multilaterale, si tratti del Processo di Istanbul29 o di qualsivoglia iniziativa volta a migliorare la cooperazione in questo o quel campo. Al momento il Paese dell’Hindukush non può che restare una preoccupazione, più o meno agitata sia che si tratti di rischi reali sia che si tratti di propaganda a uso interno. La guerra, col suo portato di instabilità e insicurezza, non richiama investimenti, blocca il flusso delle merci ed esporta al massimo colonne di rifugiati (anche se i grandi Paesi di immigrazione restano i due confinanti Pakistan e Iran). Coinvolte spesso indirettamente nella guerra afgana (o per motivi economico-militari, come nel caso della base di Manas, o per la porosità delle frontiere o per singole iniziative negoziali come nel caso turcmeno o uzbeco), le cinque repubbliche si mantengono a debita distanza in attesa che il caso si risolva e che l’Afghanistan possa tornare ad essere un Paese di transito, cosa che lo renderebbe appetibile soprattutto per il passaggio delle pipeline, ipotesi al momento molto rischiosa. Naturalmente le relazioni esistono e si vanno lentamente rafforzando, a volte anche per spinte o suggerimenti di Paesi terzi, ma l’Afghanistan rimane un luogo da cui è bene mantenere una distanza di sicurezza. L’interesse delle repubbliche è dunque rivolto verso altri Paesi, non esclusi i grandi confinati dell’Afghanistan, Iran e Pakistan.
Risolto il nodo della guerra, una nuova stagione potrebbe cambiare percezione e visuale e andare incontro a un’attenzione che comunque, e forse più che nel recente passato, Kabul ha dimostrato verso le cinque sorelle del Nord cui comunque le unisce una Storia antica e un desiderio comune di indipendenza che per l’Afghanistan, e in parte anche per le repubbliche, resta una chimera in attesa che finisca l’eterno Great Game30 il vero comun denominatore che collega tutti e sei i Paesi.
A Oriente del Califfo al Festival della memoria di Seravezza
Al via il festival dedicato alla memoria a Seravezza (Lucca). Un fine settimana di teatro e incontri al Memofest con Ilaria Cucchi, il sindaco di Amatrice e altri. Alle 18.30 di domenica 11 giugno presentiamo “A Oriente del Califfo”Vedi il programma
Il "week end" nero di Kabul
 |
| Sulla copertina de Il Tascabile l’ultimo attentato a Herat il 6 giugno |
Stragi senza rivendicazioni, collasso del sistema politico, lotta tra fazioni, confusione tra gli alleati internazionali. L’Afghanistan sembra attraversare un nuovo periodo buio. O un’ennesima riedizione del Grande Gioco. Un tentativo di analisi
Alle 8 e venti del mattino di mercoledi 31 aprile un’autocisterna rossa per l’acqua viene fermata all’imbocco della cosiddetta “green zone” di Kabul, un’area blindatissima dove si trovano diverse ambasciate – l’americana, la tedesca, la nostra –, il quartier generale della Nato, rimesse e caserme che ospitano soldati americani. Appena fermato e probabilmente sviato dal suo vero obiettivo, uno dei luoghi inviolabili della zona verde, l’autista si fa esplodere facendo saltare l’autobotte che contiene 1500 chili di esplosivo e che, nel creare un cratere vasto e profondo, uccide un centinaio di persone e ne ferisce circa 500, alcune delle quali in maniera semi letale. Si tratta del più grosso attentato che la capitale abbia conosciuto dal 2001, da che sono iniziati gli ormai 16 anni di guerra infinita che hanno seguito i dieci di conflitto con i sovietici dal 1979 all’89 e in seguito altri sette tra soli afgani fino alla nascita dell’emirato di mullah Omar nel settembre del 1996.
Il fatto singolare è che l’attentato non viene rivendicato…
segue su Il Tascabile
Vedi anche questo servizio della Bbc sulla vita sotto i talebani nell’Helmad
Dietro le bombe senza un padrino
 |
| Babur: si vuole che la sua tomba a Kabul respingesse le pallottole durante la guerra tra mujahedin |
Sono da poco passate le tre del pomeriggio al cimitero di Khair Khana a Kabul. Un migliaio di persone sono li a rendere l’ultimo omaggio alle vittime della manifestazione antigovernativa di venerdi dove le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla. Tra questi c’è anche il cadavere di Salem Izdyar, figlio di un senatore della Repubblica e dunque sono presenti anche le alte cariche dello Stato: c’è il primo ministro Abdullah Abdullah e il ministro degli Esteri Salahuddin Rabbani. Anche perché il padre di Salem, Mohammad Alam Izdyar, non è un senatore qualsiasi ma il rappresentante alla Meshrano Jirga della Provincia del Panjshir – a maggioranza tagica e bacino elettorale fieramente antitalebano di Abdullah. La funzione religiosa viene interrotta da tre esplosioni: un ordigno e due kamikaze che si fanno saltare in aria e gettano nello scompiglio la folla che cerca salvezza nella fuga. Il bilancio è ancora incerto: decine i feriti e, secondo alcune fonti, almeno 20 morti.
Ma cosa c’è dietro questa nuova stagione del terrore con un quadro ancor più confuso dal fatto che gli attentati non vengono rivendicati e sono stati prontamente condannati dai talebani?
La pista pachistana
I servizi segreti afgani lo hanno detto sin dalle prime ore di mercoledi quando una cisterna è esplosa nel cuore ella capitale uccidendo un centinaio di civili: dietro le stragi ci sono i servizi pachistani che si servono, come in passato, della Rete Haqqani, la fazione più stragista dei talebani. E’ un’ipotesi non nuova e con diversi precedenti anche se spesso Islamabad sembra solo il colpevole più facile da indicare: una pista che raccoglie sempre il consenso dell’uomo della strada. In passato queste stragi senza paternità erano soprattutto servite a far deragliare l’avvio degli stentati tentativi di mettere in piedi un tavolo negoziale che però – almeno per quel se ne sa – in questo momento è ben lungi dall’essere apparecchiato.
Pista talebana
 |
| Abdullah e Ghani: il primo Ceo (una specie di premier, il secondo presudente. Due anime in guerra perenne |
Gli Haqqani però, anche se dotati di larga autonomia, fanno pur sempre parte della galassia talebana. Possono dunque agire del tutto fuori linea rispetto a quanto decide mullah Akhundzada, leader della guerriglia? Se fosse così ci sarebbe un motivo che spiegherebbe bene un piccolo giallo: la presa di distanze della strage di mercoledi è infatti stata riscritta sul sito ufficiale della guerriglia (smentendo il coinvolgimento di Haqqani) e non vi appare la smentita della strage al funerale. Si potrebbe dunque anche ipotizzare una lotta intestina tra fazioni e immaginare dunque che anche l’attentato di mercoledi rientri in questa logica. Le esplosioni al funerale confermerebbero le ipotesi che vogliono gli irriducibili esasperare la tensione tra le due anime del governo: quella irriducibile rappresentata da Abdullah e dai “panjshiri” e quella di Ghani, pashtun e più possibilista anche se in realtà da tempo il presidente si è spostato su posizioni di netta chiusura al Pakistan e avrebbe appena ordinato l’esecuzione di alcuni talebani prigionieri.
Pista politica interna
 |
| Il manifesto di oggi: dopo 16 anni di guerra il Paese è un “posto sicuro” solo per chi ordina i rimapatrii (forzati) |
Stando ai talebani, le stragi sono il frutto della tensione tra queste due anime: una tensione palpabile e
che si è manifestata nella manifestazione di venerdi che aveva però preso di mira entrambe le fazioni chiedendo le dimissioni di Ghani e Abdullah e quelle del capo della guarnigione di Kabul generale Gul Nabi Ahmadzai – che da due giorni invita i residenti a stare a casa e lontani da luoghi affollati – del capo dei servizi Massoum Stanekzai e del capo del National security council, Haneef Atmar, un uomo che è stato anche ministro di Karzai. A farsi portavoce della protesta c’è Asif Ashna, anche lui con un passato governativo: nel 2015 si è dimesso da vice portavoce di Abdullah. Accanto a lui anche Zia Massud, un altro panjshiri già nell’esecutivo di Karzai e poi in quello di Ghani finché il presidente non lo ha fatto fuori. Dunque, dietro la comprensibile rabbia dei parenti delle vittime c’è chi soffia sul fuoco ma da qui a immaginare che questi personaggi fabbrichino bombe da 1500 chili, come quella di venerdi, ce ne corre. Certo il quadro interno è confuso e il governo è barcollante, litigioso e senza consenso salvo l’appoggio della Nato e degli americani che non sembrano che aspettare il momento per poter aumentare il numero delle truppe straniere nel Paese, un piano che il Pentagono avrebbe già sottoposto a Trump e ai partner dell’Alleanza ma che è rimasto in stand-by. Quanto a Ghani ha già detto che non si dimetterà. Abdullah è della stessa opinione
Pista Stato islamico
Data per buona mercoledì solo da alcuni siti online (italiani) sembra da scartare completamente: il Califfato ha armi di propaganda ben affilate e quando prepara un attentato è già pronto anche il piano di comunicazione. Certo le truppe del califfo in Afghanistan sono in difficoltà ma, a maggior ragione, se dietro le stragi ci fossero loro, lo avremmo saputo con rapidità e certezza.
Kabul spari sulla folla 5 morti
 |
| Chi non vuole vedere l’abisso afgano? |
La strage senza paternità che mercoledi ha ucciso un centinaio di cittadini di Kabul e ne ha feriti ennesimo episodio mortale. A farne le spese alcuni dimostranti uccisi dalle forze di sicurezza afgane mentre, assieme ad altri, erano convenuti sul ruolo della strage per protestare contro l’insicurezza quotidiana che circonda la vita nella capitale e in un Paese dove, nei primi tre mesi del 2017, sono state uccise oltre settecento civili e che nel 2016 ha totalizzato il bilancio più grave della guerra infinita: 3.500 morti, in aumento rispetto all’anno precedente.
oltre 400 con effetti devastanti sul centro città che si sono sentiti fino a 4 chilometri dal sito dell’esplosione, è stata seguita ieri da un
La protesta che dalle prime ore del mattino aveva raccolto un migliaio di persone si è rapidamente trasformata in una manifestazione politica con slogan che chiedevano la testa dei capi degli apparati di sicurezza ma anche le dimissioni del governo di unità nazionale. Numerosi gli slogan contro i talebani (che hanno preso le distanze dalla strage) e il Pakistan. I media locali sostengono che molti dimostranti fossero armati e che abbiano lanciato pietre contro gli agenti (alcuni dei quali sono stati feriti) ma la reazione delle forze dell’ordine, stando anche a quanto dichiarato dai responsabili di Amnesty International nella regione, sarebbe stata spropositata. L’organizzazione internazionale chiede ora un’inchiesta sull’impiego di armi da fuoco durante il corteo. Quel che è certo è che la tensione è salita alle stelle quando i dimostranti hanno cercato di spingersi verso il palazzo presidenziale, non molto distante dal luogo dell’attentato. In sostanza, quando la manifestazione, da semplice reazione di rabbia spontanea, è diventata politica, la sicurezza del governo è entrata in azione. Gas e acqua non sono stati ritenuti sufficienti e si è iniziato a sparare. I morti accertati sarebbero almeno cinque. Molti anche i feriti, con pallottole che hanno colpito alcuni dimostranti ai piedi e alle gambe.
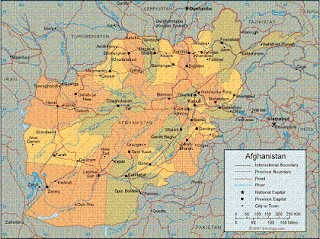 |
| Afghanistan: la guerra infinita strage dopo strage |
Alla protesta hanno partecipato anche alcuni parlamentari e anche l’ex rappresentante speciale di Ashraf Ghani per le Riforme e il Buon governo, Ahmad Zia Massud, licenziato dal presidente qualche tempo fa. Zia Massud (fratello minore del “leone del Panjshir” ed eroe nazionale Ahmad Shah), già vicepresidente con Karzai, si è unito a un sit in nel pomeriggio che chiedeva la testa di Ghani e Abdullah, i reggenti del governo “a due teste” dell’Afghanistan. La situazione resta tesa in città mentre è ancora senza paternità l’attentato che mercoledi mattina ha raggiunto il primato del più sanguinoso attacco suicida che la capitale afgana ricordi.
Il massacro senza padrini di Kabul per l’intelligence afgana una firma invece l’avrebbe: i servizi sono infatti sicuri che dietro la strage ci sia la fazione talebana della cosiddetta Rete Haqqani, sanguinaria e favorevole ad attentati stragisti con grandi numeri, che è notoriamente vicina ai servizi segreti del Pakistan. Gli afgani sono così certi della paternità pachistana della strage che il presidente Ghani avrebbe deciso, dopo l’attentato di mercoledi, di firmare l’ordine di esecuzione per undici talebani, alcuni dei quali appartengono appunto alla Rete Haqqani. Nelle stesse ore l’Afghanistan Cricket Board cancellava tutte le partite con il Pakistan fino a nuovo ordine, un segnale non certo solo sportivo in quella che spesso viene chiamata cricket-diplomacy e che lavora proprio in quei Paesi dove il vecchio gioco degli inglesi è ora sport nazionale. Latore di buoni propositi ma anche di totali chiusure.
Ghani, che ha ricevuto anche una telefonata di Trump e la solidarietà del generale Nicholson, che comanda le truppe Nato e Usa nel Paese ed è un fautore dell’aumento di soldati stranieri in Afghanistan, è comunque in seria difficoltà. Non solo potrebbe non bastargli il possibile aumento di nuove truppe straniere (anche italiane?) ma il presidente sa che l’abisso del suo Paese non fermerà comunque l’esodo forzato degli afgani venuti in Europa a chiedere asilo: nonostante lo stop alle deportazioni deciso a caldo, Angela Merkel ha fatto infatti sapere che il piano di rimpatrio andrà avanti.
The day after
 |
| Guerra senza fine |
E’ ancora senza paternità l’attentato che mercoledi mattina ha raggiunto il primato del più sanguinoso attacco suicida che la capitale afgana ricordi. Fonti del ministero della Sanità di Kabul hanno contato almeno cento morti e 600 feriti ma è un bilancio che è per difetto: ci sono ancora circa una ventina di dispersi e ancora non sono stati trovati i corpi dei poliziotti che erano di guardia al check point di Zarbaq Square, nella zona “diplomatica” di Wazir Akbar Khan che si trova nel pieno centro della capitale. Un’area, non lontana dall’ospedale di Emergency, che a quell’ora, le 8 e 20 del mattino, è solitamente un ingorgo di mezzi civili guidati da chi va al lavoro. Tra i dispersi c’è ad esempio il comandante Assadullah Andarabi dell’Afghan National Police che, al comando di otto poliziotti, era di guardia al check point. Le prime ricostruzioni dicono che l’ufficiale avrebbe fermato la cisterna bloccandola nella piazza e che il conducente si sarebbe dunque fatto esplodere forse ancora lontano dal suo obiettivo reale. Il risultato dell’attentato resta comunque spaventoso: sia in termini di vite umane, mutilazioni e danni che la Camera di commercio afgana ha stimato a circa dieci milioni di dollari.
I dubbi sulla paternità si devono sia al fatto che, con una rapidità inconsueta, i talebani hanno preso le distanze dal massacro, sia che lo Stato islamico, che è invece notoriamente rapidissimo nelle rivendicazioni e incline a stragi con grandi numeri (come nel luglio dell’anno scorso), non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale né per altro ufficiosa. Uno dei suoi punti di forza è invece proprio la comunicazione, rapida ed efficace, che molto spesso si serve di lanci via twitter, pagine social o di agenzie di notizie come la famosa “Amaq” il cui fondatore, l’ideologo del Bahrein Turki al-Binali, sarebbe stato ucciso durante un raid a Raqqa. Notizia confermata proprio da fonti dello Stato islamico. Stato islamico che ha invece rivendicato un’auto bomba con autista kamikaze che si è fatto esplodere poco lontano dall’aeroporto di Jalalabad nella provincia orientale di Nangarhar – dove il 13 aprile gli americani hanno testato la super bomba GBU-43 Moab – che è ritenuta la base dei militanti della cosiddetta “Provincia del Khorasan”, come il Califfato ha rinominato l’area afgano pachistana. Avrebbe ucciso un soldato afgano – dicono fonti ufficiali – e ne avrebbe ferito un altro. Ma c’è un piccolo giallo: poco prima che Site Intelligence Group – l’organizzazione che monitora le attività jihadiste – rilanciasse la notizia data dal Califfato (secondo cui i morti sarebbero invece sette) anche il sito dei talebani riportava la notizia di un attacco a Jalalabad che aveva ferito cinque soldati americani. Ma nelle ore seguenti la notizia è sparita (è singolarmente sparita anche la presa di distanze dell’attentato di Kabul….)..
 |
| Poco spazio ormai per poeti e letterati |
Come che sia, il massacro di Kabul per ora non ha padrini anche se i servizi afgani sono sicuri che dietro la strage ci sia la fazione talebana degli Haqqani, sanguinaria e favorevole agli attentati stragisti con grandi numeri, notoriamente vicina ai servizi segreti del Pakistan. Gli afgani sono così certi della paternità pachistana della strage che, secondo indiscrezioni, il presidente Ashraf Ghani avrebbe deciso, dopo l’attentato di mercoledi, di firmare l’ordine di esecuzione per undici talebani, alcuni dei quali appartengono appunto alla Rete Haqqani (Ghani ieri ha ricevuto anche una telefonata di solidarietà di Trump mentre il generale Nicholson, che comanda le truppe Nato e Usa nel Paese ed è un fautore dell’aumento di soldati stranieri nel Paese, si è recato sul luogo della strage). Nelle stesse ore l’Afghanistan Cricket Board cancellava tutte le partite con il Pakistan fino a nuovo ordine, un segnale non certo solo sportivo in quella che spesso viene chiamata cricket-diplomacy e che lavora proprio in quei Paesi dove il vecchio gioco inglese è diventato lo sport nazionale a volte latore di buoni propositi. Oppure di totali chiusure.
Il massacro di Kabul non fermerà comunque l’esodo forzato degli afgani venuti in Europa a chiedere asilo: nonostante lo stop alle deportazioni deciso a caldo, Angela Merkel ha fatto sapere che il piano di rimpatrio andrà avanti. Bomba non bomba.
Strage a maggio senza padrini
 |
| Afghanistan, la guerra infinita |
Nel Paese che l’Unione europea considera ormai sicuro e dove i migranti sono obbligati a tornare, la guerra infinita continua a mietere vittime con atrocità sempre maggiori. Una gara al rialzo dove stamattina la protagonista è stata una cisterna per l’acqua carica di esplosivo saltata in aria a Kabul nell’ora di punta, le 8 e trenta, uccidendo almeno ottantacinque persone e ferendone almeno quattro centinaia. Un bilancio che mentre scriviamo continua ad aggravarsi e che non ha ancora una paternità (illazioni, ma solo quelle, su Haqqani e Stato islamico). Paternità che i talebani, con un messaggio affidato invece in tempi rapidissimi al loro sito ufficiale, hanno sdegnosamente rifiutato chiarendo che il movimento non prende mai di mira la popolazione civile.
L’esplosione (1500 chili di esplosivo), che si è udita in tutta la città e il cui fumo ha invaso interi quartieri del centro, è avvenuta poco distante dalla porta d’ingresso della zona diplomatica dove ha sede anche l’ambasciata italiana. Sembra ricordare quella che, nel 2009, fece saltare in aria una cisterna di benzina davanti all’ambasciata tedesca che si trova appunto sull’ingresso della cosiddetta “green zone”. Da allora aumentarono sbarramenti di cemento, poliziotti privati e controlli accurati ma nessuno è ancora riuscito a trovare la ricetta per impedire atti terroristici di tale portata anche se per fare esplodere un tale quantitativo di esplosivo c’è chi lo vende e chi lo compre in un Paese dove il commercio delle armi – legali e illegali – è moneta corrente.
Le modalità della strage potrebbe far pensare a una mossa dell’autoproclamato Stato islamico che in Afghanistan ha già firmato stragi di civili con grandi numeri. Ma la memoria corre anche a episodi senza firma come il camion bomba che, senza rivendicazioni, esplose nell’agosto di due anni fa in un quartiere della capitale creando un cratere profondo dieci metri. Anche le immagini di oggi restituiscono la vista di un enorme cratere che ha inghiottito l’autocisterna e portato all’altro mondi decine di impiegati, lavoratori informali, più di un giornalista.
Intanto un gruppo di famigliari di vittime della guerra ha inviato a Unama, la missione Onu, di Kabul, una denuncia che vuole portare davanti al tribunale internazionale dell’Aja i responsabili di omicidi di gente comune. Il dito è puntato su Gulbuddin Hekmatyar, il capo mujaheddin che oggi gode dell’impunità che gli è stata garantita dal governo di Kabul in cambio della smobilitazione del suo gruppo armato (che si è però rifiutato di consegnare le armi).
Un summit per Donald
 E’ un’agenda zeppa di impegni quella che il presidente americano Donald Trump, arrivato martedi sera a Roma, ha davanti prima del suo ritorno in Italia per l’incontro del G7 in Sicilia. Tra le due tappe italiane c’è infatti il summit della Nato a Bruxelles dove, accanto ai partner dell’Alleanza, Trump vedrà anche i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, ma anche il neo presidente francese Macron o il difficile alleato turco che Erdogan rappresenta. Non è ancora chiaro infine cosa dirà sui due temi di punta del vertice: la spesa militare della Nato – prima definita «obsoleta» poi rivalutata a struttura ineludibile – né in fatto di guerra al terrorismo. Una guerra che, dicono le indiscrezioni, si basa anche su una nuova strategia americana in Afghanistan con un aumento delle truppe di terra: statunitensi e dell’Alleanza. Sul due volte spinoso tema russo ucraino forse sorvolerà.
E’ un’agenda zeppa di impegni quella che il presidente americano Donald Trump, arrivato martedi sera a Roma, ha davanti prima del suo ritorno in Italia per l’incontro del G7 in Sicilia. Tra le due tappe italiane c’è infatti il summit della Nato a Bruxelles dove, accanto ai partner dell’Alleanza, Trump vedrà anche i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, ma anche il neo presidente francese Macron o il difficile alleato turco che Erdogan rappresenta. Non è ancora chiaro infine cosa dirà sui due temi di punta del vertice: la spesa militare della Nato – prima definita «obsoleta» poi rivalutata a struttura ineludibile – né in fatto di guerra al terrorismo. Una guerra che, dicono le indiscrezioni, si basa anche su una nuova strategia americana in Afghanistan con un aumento delle truppe di terra: statunitensi e dell’Alleanza. Sul due volte spinoso tema russo ucraino forse sorvolerà.
Prima di partire per Bruxelles Trump vedrà il papa, nelle prime ore del mattino, e poi Mattarella e Gentiloni. L’accoglienza a Roma ha già visto muoversi diverse associazioni anche di “expat” pacifisti americani che contestano la sua politica guerrafondaia di cui Trump ha dato prova coi bombardamenti in Siria e con la “madre di tutte le bombe” (Moab) sganciata il 13 aprile in Afghanistan. Una bomba che al papa non è proprio piaciuta: «….la mamma dà vita – ha detto Francesco al recente Meeting delle Scuole per la pace – le bombe danno morte». Chissà se il santo padre toccherà l’argomento.
Due settimane fa la stampa americana ha dato notizia di una nuova strategia messa a punto dal Pentagono e caldeggiata dal consigliere per la sicurezza di Trump, generale McMaster, che prevede un aumento di truppe sul terreno (da 3 a 5mila a sostegno degli 8400 già presenti in Afghanistan) ma anche un nuovo modo di condurre la guerra: le decisioni sulla sua gestione passerebbero però direttamente dal Pentagono senza bisogno della sigla del presidente e gli Usa si sgancerebbero (più di quanto non facciano ora) dalla catena di comando afgana, con più mano libera dunque, come ha dimostrato proprio il lancio della Moab. Secondo l’editorialista americano Eli Lake (Bloomberg View) il piano prevederebbe in realtà una forza di soli americani pari a 50mila uomini che però non dovrebbero essere soli. Ecco perché il segretario generale Nato Jens Stoltenberg ha lavorato in queste settimane chiedendo un aumento anche ai partner. Oltremare avrebbe guadagnato una promessa dall’Australia e un “ni” dal Canada. In Europa Londra e Copenaghen hanno già detto si. La Germania ha risposto picche. Altri tentennano, altri ancora – come la Polonia – potrebbero farci un pensierino. L’Italia ancora non si sa. E proprio rispetto alla posizione italiana, altre voci si sono intanto aggiunte a quelle della Tavola della pace e di “Afgana” che hanno chiesto al governo italiano di opporsi a un nuovo aumento di truppe in Afghanistan dove mancano – aggiunge Pangea Onlus – «politiche e finanziamenti per promuovere l’avanzamento delle donne, il contrasto alla violenza e l’applicazione di programmi sulla base delle risoluzioni Onu».
I giochi comunque dovrebbero essere già fatti anche se Trump, noto per i suoi repentini cambiamenti di idea (era contrario a impegnarsi militarmente all’estero in campagna elettorale) potrebbe spiazzare: o essere molto prudente (non facendo numeri) o molto netto chiedendo agli alleati l’impegno militare a sostegno del nuovo “surge”. Come ha detto proprio McMaster : America first didn’t mean America alone. La supremazia americana, grande totem di Trump, non si può costruire da soli.
"Afgana" su summit Nato: contro il surge di Donald Trump
 Afghanistan: Roma cambi strategia e rifiuti aumento soldati
Afghanistan: Roma cambi strategia e rifiuti aumento soldati
Alla vigilia del summit Nato a Bruxelles ancora non è nota la posizione dell’Italia
In occasione del mini-vertice della Nato del 25 maggio a Bruxelles, l’associazione italiana Afgana – impegnata da anni nel dialogo con la società civile afgana – chiede al governo italiano quali politiche intenda adottare nel Paese centroasiatico. Secondo le indiscrezioni di stampa, l’amministrazione Trump ha intenzione di annunciare l’aumento delle truppe dispiegate in Afghanistan, portandole dalle attuali 8.500 unità a oltre 11mila, e di chiedere un contestuale aumento anche ai partner dell’Alleanza atlantica, tra cui l’Italia. Nell’ambito della missione-Nato “Resolute Support”, il nostro Paese stanzia in Afghanistan il secondo contingente per numero di soldati, dopo quello degli Stati Uniti. Afgana chiede dunque di sapere se il nostro governo abbia ricevuto una richiesta formale in tal senso, se abbia intenzione di assecondarla e in quali termini.
Di fronte agli evidenti fallimenti della strategia militare adottata negli ultimi 16 anni in Afghanistan, l’associazione italiana auspica un’inversione di rotta: più cooperazione civile e un impegno maggiore nel promuovere il processo di pace e di riconciliazione. Afgana si augura inoltre che qualunque decisione passi attraverso un dibattito parlamentare trasparente e condiviso.
comunicato stampa di “Afgana”
Il Califfo in libreria dal 25 maggio
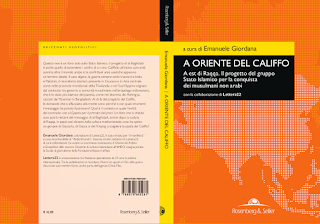 Non è un libro solo sullo Stato Islamico. Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle provincie meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei Rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, le domande che si affacciano alla mente sono: perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare? Qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad ?. Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Non è un libro solo sullo Stato Islamico. Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle provincie meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei Rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, le domande che si affacciano alla mente sono: perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare? Qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad ?. Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?A ORIENTE DEL CALIFFO
A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi
Rosenberg&Sellier
pp 188
euro 15,00
A cura di Emanuele Giordana
Mario Dondero alla Polveriera di Ancona
 |
| Una bellissima immagine di Mario Dondero Sarei grato se mi si volesse segnalare il suo autore |
Il 18 maggio al Primo Festival del Fotogiornalismo di Ancona, si ricorderà Mario DONDERO il grande fotografo recentemente scomparso. Ne Parleranno Paolo Marasca, Assessore del Comune di Ancona, Emanuele Giordana, giornalista amico e biografo di Mario Dondero, Marco Cruciani regista del film su Mario DONDERO “Calma e Gesso” , Valerio Bispuri fotoreporter di fama internazionale. Il Presidente della Fototeca Provinciale di Fermo Giuseppe Buondonno parlerà dell’opera di catalogazione e archiviazione dell’enorme patrimonio fotografico di Dondero in loro possesso.
A Oriente del Califfo a Torino
A Oriente del Califfo a Trento il 17 maggio
Polveriera di Ancona 18 maggio
Afghanistan, cresce la voglia di "boots on the ground"
La Danimarca e la Gran Bretagna hanno detto si alla richiesta della Nato di inviare truppe fresche in Afghanistan a sostegno della decisione americana (non ancora formalizzata ufficialmente) di mandare tra 3mila e 5mila nuovi soldati nel Paese asi…
Surge afgano
 Ci siamo. Anzi, ci risiamo. La guerra afgana torna al centro della politica militare americana con un
Ci siamo. Anzi, ci risiamo. La guerra afgana torna al centro della politica militare americana con un
nuovo piano strategico che, una volta siglato da Trump, riporterà nel Paese asiatico migliaia di nuovi soldati: 3mila secondo il Washington Post, che per primo ha rivelato il piano, fino a 5mila secondo il New York Times e i giornali afgani. Si aggiungeranno agli 8.400 già sul posto che partecipano in parte alla missione Nato di sostegno all’esercito afgano. E proprio la prossima riunione della Nato a Bruxelles, il 25 maggio, dovrebbe vedere la conferma del nuovo “surge” americano, accompagnata da una richiesta ai partner dell’Alleanza, dunque anche all’Italia, di mettere a disposizione truppe fresche nell’ordine di “migliaia”.
La cosa era nell’aria da mesi, preceduta dalle audizioni al Congresso di alte cariche militari e in particolare del generale John Nicholson che comanda le truppe Nato in Afghanistan e che è fautore dell’aumento di “stivali sul terreno”. Poi se ne è riparlato quando Trump – in campagna elettorale favorevole al ritiro delle truppe – ha mandato a Kabul il suo consigliere per la sicurezza Herbert Raymond McMaster, un falco che viene dalle forze armate e che, durante Bush, fu uno dei padrini del “surge” – aumento consistente di truppe – in Iraq. McMaster si era fatto precedere dalla Gbu-43 – Moab (massive ordnance air blast bomb o anche mother of all bombs), un ordigno da 11 tonnellate di esplosivo sganciato alla vigilia della Conferenza di pace sull’Afghanistan organizzata a Mosca dai russi. McMaster era andato a Kabul per verificare con il presidente Ghani proprio il possibile invio di nuove truppe (cosa cui il governo di Kabul è favorevolissimo) tanto che adesso, i contrari alla nuova operazione hanno ribattezzato il piano: “McMaster’s War”, la guerra di McMaster.
L’esatto numero di soldati americani da inviare, confermano fonti dell’Amministrazione, dipenderà anche dalla disponibilità degli alleati, evidentemente già consultati in merito a un ennesimo sforzo in appoggio alla nuova strategia di Trump. Ma il piano non prevede solo l’invio di soldati. Il piano prevede che sarà il Pentagono e non la Casa Bianca a decidere sui numeri e anche ad autorizzare raid aerei che, essendo in corso ormai da mesi, aumenteranno probabilmente di numero. Autorizza anche una “mobilità” dei soldati americani che va oltre quanto Obama aveva stabilito a suo tempo quando aveva deciso una lenta uscita di scena dal teatro (salvo poi ripensarci). Le limitazioni che furono oggetto di polemiche col gabinetto Karzai (che si rifiutò di firmare l’accordo militare voluto da Obama che fu poi siglato da Ghani) dovrebbero dunque cadere e garantire agli americani maggior capacità d’azione senza troppi laccioli nella catena di comando condivisa con gli afgani.
Manca dunque solo la firma del presidente che sta probabilmente facendo i conti (la guerra afgana costa all’erario americano 23 miliardi di dollari l’anno) e sondando la disponibilità degli alleati di una Nato non più ritenuta “obsoleta”. Trump è probabilmente imbaldanzito da alcuni successi (l’uccisione un mese fa dal capo dello Stato islamico in Afghanistan Abdul Hasib o del capo talebano Akhtar Mansur nel 2016 o ancora dalla super bomba del 13 aprile scorso) ma sembra soprattutto aver dato carta bianca al Pentagono dove il capo della Difesa, Jim Mattis, è tra i fautori della nuova strategia.
L’Onu intanto ha fatto i conti di quanti afgani sono stati costretti dalla guerra a lasciare le loro case nel 2017: sono 88.841. L’anno scorso sono stati 660mila e quest’anno la stima è di 450mila.
Islam in Afghanistan
LE DIVERSE ANIME DELL’ISLAM
Ciclo di conferenze organizzato dal 27 aprile al 25 maggio 2017
dalla Casa della Cultura, in collaborazione con il Centro di cultura Italia-Asia
Emanuele Giordana – “L’Islam in Afghanistan”
Giovedì 11 maggio, ore 21.00
Guardato come un sorvegliato speciale, l’Islam afgano non è solo estremismo radicale, ma un pianeta diffuso e tutt’altro che omogeneo, attraversato da correnti sufi, da movimenti sciiti e ismaeliti e anche da un Islam sunnita pacifista, che si affermò, nei primi del secolo scorso, a cavallo della frontiera con l’attuale Pakistan. Uno sguardo per andare oltre una guerra di cui l’Islam non è certo l’unico responsabile.
Sede degli incontri: Casa della Cultura – Via Borgogna 3, Milano
MM1 San Babila – Ingresso libero
Per informazioni: 02 79.55.67 – 02 76.00.53.83 – [email protected]
Siti web di riferimento
Centro di cultura Italia-Asia: www.italia-asia.it
Casa della Cultura: www-casadellacultura.it
Associazione Casa della Cultura – Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MM1 – San Babila)
02 795567 – 02 76005383 – fax 02 76008247
e-mail: [email protected] – www-casadellacultura.it
C.F. 80115850150 – P.IVA 13307640154
“Peccato mortale sfruttare il lavoro ”
 Il Papa incontra i giovani studenti delle “Scuole per la pace” e prende posizione sulla guerra e le sue cause. “I governanti? Solo parole. Attenti ai terroristi delle chiacchiere”
Il Papa incontra i giovani studenti delle “Scuole per la pace” e prende posizione sulla guerra e le sue cause. “I governanti? Solo parole. Attenti ai terroristi delle chiacchiere”
Alla fine ci sta pure una battuta: “I governi e gli impegni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo? Non lo dico da papa ma lo dico con la grande Mina: parole, parole, parole”. La platea dell’Auditorium Paolo VI in Vaticano ride e si spella le mani. Sono soprattutto studenti, settemila, arrivati un po’ da tutta Italia. Fan parte di un progetto iniziato tre anni fa dalla Tavola della pace d’intesa con il Miur e promosso dal Coordinamento degli Enti Locali per la Pace, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e un altra decina di sigle tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia e i Giovani Musulmani d’Italia. I ragazzi, dalle medie al liceo, han lavorato in questi anni sul tema della guerra: informandosi, interrogandosi e anche suggerendo soluzioni. L’ultima, uscita da una media di Udine giorni fa, quella di istituire un”ora di pace” a scuola, come si fa con quella di religione.
 Bergoglio, uomo attento allo spirito ma anche al corpo degli uomini, accetta di incontrarli e di rispondere alle domande di Maria, Michele, Luca, Costanza su conflitti, violenza, discriminazione. Su quest’ultimo punto cita lo scontro tra Macron e Le Pen come pessimo esempio di “non ascolto” ma la stoccata c’è anche per i Salvini di turno, anche se il papa nomi non ne fa mai: “Ci sono persone che usano le parole per discriminare e ferire: li chiamo terroristi delle chiacchiere”. Sulla guerra, dramma del mondo, l’accusa è soprattutto al traffico d’armi, arte in cui, come ci ha appena ricordato Rete Disarmo, l’Italia eccelle. E a proposito di bombe non risparmia Trump: ”Han chiamato quell’ordigno la madre di tutte le bombe. Ma una madre dona vita, quella regala morte. Ho provato vergogna”. Ma se c’è chi traffica in armi e chi traffica in droga, avverte Bergoglio, c’è chi traffica anche in esseri umani e non solo permettendo le stragi nel Mediterraneo: “C’è chi sfrutta il lavoro altrui e non solo in luoghi lontani: lo si fa qui, in Europa, in Italia. Lo si fa pagando chi lavora in nero e con assunzioni stagionali, per evitare la continuità. Questo sfruttamento è, per noi cattolici, peccato mortale”.
Bergoglio, uomo attento allo spirito ma anche al corpo degli uomini, accetta di incontrarli e di rispondere alle domande di Maria, Michele, Luca, Costanza su conflitti, violenza, discriminazione. Su quest’ultimo punto cita lo scontro tra Macron e Le Pen come pessimo esempio di “non ascolto” ma la stoccata c’è anche per i Salvini di turno, anche se il papa nomi non ne fa mai: “Ci sono persone che usano le parole per discriminare e ferire: li chiamo terroristi delle chiacchiere”. Sulla guerra, dramma del mondo, l’accusa è soprattutto al traffico d’armi, arte in cui, come ci ha appena ricordato Rete Disarmo, l’Italia eccelle. E a proposito di bombe non risparmia Trump: ”Han chiamato quell’ordigno la madre di tutte le bombe. Ma una madre dona vita, quella regala morte. Ho provato vergogna”. Ma se c’è chi traffica in armi e chi traffica in droga, avverte Bergoglio, c’è chi traffica anche in esseri umani e non solo permettendo le stragi nel Mediterraneo: “C’è chi sfrutta il lavoro altrui e non solo in luoghi lontani: lo si fa qui, in Europa, in Italia. Lo si fa pagando chi lavora in nero e con assunzioni stagionali, per evitare la continuità. Questo sfruttamento è, per noi cattolici, peccato mortale”.
 Nessun pontefice si era spinto così lontano, difendendo, in un certo senso, anche l’ormai sepolto articolo 18. E se Bergoglio condanna ritualmente il “Dio denaro” – come ogni papa ha sempre fatto – questa volta il monito non è solo ai mercanti nel tempio. E i diritti dei lavoratori, nel giorno in cui nella stessa città si manifesta per difenderli, diventano nelle parole di Francesco un elemento che non è avulso dal discorso sulla pace. I ragazzi sono commossi e con loro sindaci, amministratori locali e professori. 162 insegnanti gli consegnano un piccolo manuale di linee guida sull’educazione alla pace. Il Papa apprezza. I ragazzi applaudono. Fuori, un timido sole scaccia la pioggia.
Nessun pontefice si era spinto così lontano, difendendo, in un certo senso, anche l’ormai sepolto articolo 18. E se Bergoglio condanna ritualmente il “Dio denaro” – come ogni papa ha sempre fatto – questa volta il monito non è solo ai mercanti nel tempio. E i diritti dei lavoratori, nel giorno in cui nella stessa città si manifesta per difenderli, diventano nelle parole di Francesco un elemento che non è avulso dal discorso sulla pace. I ragazzi sono commossi e con loro sindaci, amministratori locali e professori. 162 insegnanti gli consegnano un piccolo manuale di linee guida sull’educazione alla pace. Il Papa apprezza. I ragazzi applaudono. Fuori, un timido sole scaccia la pioggia.
A destra “Mina” Anna Maria Mazzini, cantante famosa anche in Argentina. “Parole Parole” era la sigla finale di Teatro10 con Alberto Lupo nel 1972
Sopra: la GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb (MOAB)
1 maggio sulla T-shirt
 Rana Plaza, quattro anni dopo. Il 24 aprile del 2013, una settimana prima della festa internazionale
Rana Plaza, quattro anni dopo. Il 24 aprile del 2013, una settimana prima della festa internazionale
di chi lavora, un edifico di cinque piani crollava alla periferia industriale di Dacca, Bangladesh. 1.134 morti e 2mila feriti. L’edificio ospitava cinque fabbriche di abbigliamento che producevano per marchi europei e nordamericani, alcuni dei quali fecero di tutto per non essere coinvolti nel crollo e dunque nei risarcimenti. Non è certo stato l’unico “incidente” (fu preceduto dagli incendi nella fabbrica Ali Enterprises in Pakistan e alla Tazreen Fashions in Bangladesh che uccisero più di 350 persone) ma il dossier Rana Plaza, anche se con il pagamento di un prezzo altissimo in vite umane, ha però segnato un punto di svolta. Un punto di svolta, deve essere ben chiaro, dovuto alla resistenza delle famiglie dei lavoratori di quelle fabbriche e a un’attività sindacale locale fortissima quanto rischiosa. Una resistenza e una lotta sindacale che forse non avrebbe raggiunto i loro obiettivi se non fossero state accompagnate da campagne internazionali e dalla solidarietà di altri lavoratori, attivisti, comuni cittadini.
Alcuni programmi innovativi sono stati sviluppati per evitare nuovi disastri e per garantire i risarcimenti alle famiglie. Il primo riguarda l’Accordo sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi che è un programma quinquennale, giuridicamente vincolante, col quale i firmatari si impegnano a migliorare la sicurezza delle fabbriche con cui lavorano. Lanciato dopo un mese dal crollo e non senza una forte pressione internazionale sui marchi, dopo sei mesi aveva più di 200 firmatari. L’Accordo per il risarcimento delle vittime del disastro ha terminato il suo percorso nel 2015 dopo una battaglia durata due anni per ricevere il denaro e per l’istituzione di un fondo medico fiduciario per sostenere i sopravvissuti feriti. Ma, dicono alla Campagna Abiti Puliti – la sezione italiana della Rete internazionale Clean Clothes – «Questi risultati hanno bisogno di essere costantemente difesi e sviluppati, non erosi e invertiti» perché – sostengono – le promesse di un cambiamento strutturale «non sono ancora divenute realtà: restano i problemi sistematici di una concorrenza spietata, bassi salari, repressione sindacale, un diritto del lavoro debole e l’impunità legale».
E’ anche per questo che la Campagna invita le aziende dell’abbigliamento e delle calzature che non l’hanno ancora fatto a unirsi alle 17 che già sono in linea con una nuova importante iniziativa per la trasparenza che impegna i marchi a pubblicare le informazioni che permettano a lavoratori e consumatori di scoprire dove e come vengono realizzati i loro prodotti. Un rapporto di 40 pagine (“Segui il filo”) chiede alle aziende di adottare un modello che garantisca trasparenza nella catena di fornitura dell’abbigliamento e delle calzature. «Le aziende che vi aderiscono – dicono gli attivisti di Abiti Puliti* – si impegnano a pubblicare informazioni che identifichino le fabbriche che realizzano i loro prodotti, rimuovendo un ostacolo fondamentale per sradicare pratiche di lavoro abusive e aiutando a prevenire disastri come quello del Rana Plaza». Delle 72 aziende contattate, 17 saranno perfettamente in linea con gli standard dell’iniziativa entro il 31 dicembre 2017. «La trasparenza è uno strumento molto potente per promuovere la responsabilità di impresa verso i lavoratori del tessile lungo tutta la catena di fornitura e permette alle organizzazioni e ai lavoratori di avvertire le aziende riguardo agli abusi nella fabbriche fornitrici. Facilita il ricorso più veloce a meccanismi di reclamo per abusi dei diritti umani». Ed è anche un modo per rendere più responsabili i consumatori (alcune aziende hanno dichiarato che rivelare le informazioni potrebbe svantaggiarle commercialmente…).
E perché i consumatori sappiano ecco la lista dei refrattari: American Eagle Outfitters, Canadian Tire, Carrefour, Desigual, DICK’S Sporting Goods, Foot Locker, Hugo Boss, KiK, MANGO, Morrison’s, Primark, Sainsbury’s, The Children’s Place e Walmart non si sono impegnate a pubblicare nulla. Inditex si è rifiutata di pubblicare le informazioni, ma mette a disposizione i dati. Armani, Carter’s, Forever 21, Matalan, Ralph Lauren Corporation, Rip Curl, River Island, Shop Direct, Sports Direct e Urban Outfitters non hanno risposto alla coalizione e non pubblicano alcuna informazione.
* Fa parte della coalizione composta da: Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, IndustriALL Global Union, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, International Trade Union Confederation, Maquila Solidarity Network, UNI Global Union e Worker Rights Consortium.
Anime dell’Islam
LE DIVERSE ANIME DELL’ISLAM
Ciclo di conferenze organizzato dal 27 aprile al 25 maggio 2017
dalla Casa della Cultura, in collaborazione con il Centro di cultura Italia-Asia
“L’Islam in Afghanistan”
Giovedì 11 maggio, ore 21.00
Relatore: Emanuele Giordana
curatore del volume “A Oriente del Califfo: la conquista dello Stato islamico dell’islam non arabo”, collettanea di Lettera22 per Rosenberg&Sellier in libreria a maggio
“L’Islam in Indonesia”
Martedì 16 maggio, ore 21.00
Relatore: Antonio Cuciniello
“Sufismo e confraternite in Turchia nel XX secolo”
Giovedì 25 maggio, ore 18.00
Relatrice: Anna Maria Martelli
Sede degli incontri: Casa della Cultura – Via Borgogna 3, Milano
MM1 San Babila – Ingresso libero
Per informazioni: 02 79.55.67 – 02 76.00.53.83 – [email protected]
Siti web di riferimento
Centro di cultura Italia-Asia: www.italia-asia.it
Casa della Cultura: www-casadellacultura.it
Associazione Casa della Cultura – Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MM1 – San Babila)
02 795567 – 02 76005383 – fax 02 76008247
e-mail: [email protected] – www-casadellacultura.it
C.F. 80115850150 – P.IVA 13307640154
I segreti della bomba
 Dopo una settimana ora anche i militari afgani possono visitare il sito dove è esplosa Moab. Mentre i talebani assaltano una base dell’esercito e fanno strage di soldati. Viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Dopo una settimana ora anche i militari afgani possono visitare il sito dove è esplosa Moab. Mentre i talebani assaltano una base dell’esercito e fanno strage di soldati. Viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Soltanto venerdi l’esercito afgano ha potuto entrare nell’area dove, giovedi scorso, è stata sganciata la bomba da 11 tonnellate di esplosivo che gli americani hanno sganciato nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangarhar. Ma alcuni video girati nei dintorni a due giorni dallo scoppio e i primi che ora cominciano a girare dopo che gli americani hanno tolto i sigilli dall’area del bombardamento, mostrano le prime distruzioni e gli effetti di un ordigno considerato secondo solo alla bomba atomica: il più potente ordigno non nucleare i cui effetti sono ancora segreti e probabilmente tali rimarranno. Conditi da dichiarazioni, dati e simil certezze – tra cui le “scuse” di un alto comandante americano per possibili vittime civili – che conviene continuare a prendere con le molle. Ma mentre i primi soldati afgani ricevevano il permesso di vistare l’aera, cinquecento chilometri più a Nord, nella provincia di Balkh, i talebani mettevano a segno il più sanguinoso attacco contro un obiettivo militare nazionale. Lasciando sul terreno oltre cento soldati morti.
La dinamica che ricostruisce l’attacco di venerdi alla base militare dove si trova il 209 Shaheen Corps nella provincia di Balkh, città circondata da una cintura della guerriglia in turbante ormai da diversi anni, è ancora oggetto di ricostruzione. Quel che è certo è che la guerriglia, che ha rivendicato l’attacco condotto con kamikaze e un commando armato (una decina tra loro sono stai uccisi), ha atteso che i militari fossero alla preghiera del venerdi e dunque in un momento di riposo alla una e mezza mentre altri commilitoni erano in pausa pranzo. Sono riusciti a passare i check point, probabilmente aiutati da spie interne, e hanno fatto strage a colpi di kalashnikov sparati da mezzi militari che hanno forse indotto in errore i controlli dell’ingresso. I morti ufficialmente sarebbero un centinaio ma diverse fonti fissano il bilancio tra i 130 e i 140 morti con almeno una sessantina di feriti. Nelle prime ore le cifre erano molto più basse: una decina si era detto all’inizio, forse stimando che nascondere la verità avrebbe ridotto l’effetto dell’azione.
Mezze bugie, aperte falsità e propaganda di guerra
Le mezze bugie, quando non le aperte falsità, sono una costante della propaganda di guerra e l’Afghanistan non fa eccezione. E eccezione non fa la vicenda della GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Moab), la madre di tutte le bombe. Il refrain, in attesa di un rapporto ufficiale definitivo sugli effetti della bomba, è stato fin dall’inizio che l’ordigno non ha causato vittime civili, dato certificato anche dal ministero della Sanità. Ma alcuni video girati fuori dall’area recintata dagli americani e immediatamente vicini alla zona della deflagrazione, mostrano cadaveri con segni evidenti di ustioni, case distrutte e un terreno violentato dal calore e da uno spostamento d’aria che, dicono le cronache di quella bomba, può uccidere anche a grande distanza. Venerdi scorso però, a poche ore dall’esplosione, gli americani hanno sentito il bisogno di un’excusatio anticipata nel caso di “possibili vittime civili”. Lo racconta Luca Lo Presti, presidente della Onlus Pangea, una delle poche organizzazioni italiane (con Emergency) rimaste ad operare in Afghanistan e che, a Kabul, ha progetti di microcredito e protezione di bambini e donne. “La notizia della bomba l’ho avuta dall’Italia la sera di giovedi – dice Lo Presti – nonostante fossi a Kabul dove quella sera ho dormito da una famiglia afgana. Sentivo una pena incredibile a vedere i fragili corpi di quei bambini riposare ignari nei loro letti. Poi, il giorno dopo, vedo in televisione un alto grado dell’esercito americano chiedere scusa nel caso la bomba avesse prodotto effetti collaterali sui civili…”. Ma di civili morti non si parla e dall’area blindata escono notizie col contagocce mentre l’ex presidente Karzai – l’unico ad alzare la voce – accusa il governo (che ora dice addirittura che la bomba è stata sganciata sotto la sua supervisione) di aver rinunciato alla sua sovranità territoriale per consentire a Trump di testare nuovi ordigni.
Ma quel che più appare comico, se non del tutto tragico, è che le autorità hanno fatto nomi, cognomi, origine etnica e ruolo nelle organizzazioni eversive (tra cui i talebani pachistani) di alcuni tra i novanta cadaveri di appartenenti allo Stato islamico rimasti sotto la bomba sganciata sul villaggio fantasma di Assadkhil nell’area conosciuta come Mohmand Dara. Come abbiano ritrovato corpi o anche solo ossa, e dunque il Dna, di queste vittime è un vero mistero che gli effetti della bomba, da quel poco che si vede nei primi video che circolano, rendono ancora più che tragicomico.
E mentre la guerra infuria viene da chiedersi come mai nessuno abbia ancora invocato una commissione di indagine indipendente in questa terra martoriata da quello che appare, più che una bomba giustiziera, un crimine contro l’umanità e il pianeta.
Corsa al rialzo
In Afghanistan c’è una corsa al rialzo: a chi, si potrebbe dire, la spara più grossa. Con la differenza che qui non sono battute e boutade ma proiettili veri che uccidono e feriscono in una terra dove il “Nuovo Grande Gioco” sembra non solo ritornato prepotentemente alla ribalta ma vicino al punto più basso della sua tragica storia. Una storia centenaria se il Grande Gioco tra lo Zar di tutte le russie e la Corona britannica iniziò nell’800 per poi proseguire, nel secolo scorso, con la Guerra Fredda e adesso con un nuovo episodio il cui terreno di conquista è sempre quello: l’Afghanistan e la porta maledetta tra l’Asia centrale, il Medio oriente e il subcontinente indiano. La riedizione di un gioco condotto con l’usuale brutalità e meschinità che l’ha sempre contraddistinto.
La corsa al rialzo ha come protagonisti diversi attori: l’azione di venerdi a Balkh da parte dei talebani sembra indicare il tentativo non solo di affermare la superiorità militare nei confronti del governo e dell’esercito nazionali, ma anche di dimostrare agli affiliati al Califfato di Al-Bagdadi (che sei settimane fa hanno ucciso 50 soldati nell’ospedale militare di Kabul a due passi dall’ambasciata americana) che il jihad contro l’invasore stranieri e i suoi alleati afgani è roba loro e non di questi nuovi guerriglieri in parte stranieri, in parti desunti da ex talebani spesso espulsi dalle file del movimento che fa capo a mullah Akhundzada.
 Ma i due veri protagonisti sembrano al momento ancora i vecchi attori della Guerra Fredda che, cambiati di poco gli abiti di allora, si contendono la scena centroasiatica e dunque l’Afghanistan, il suo boccone più succulento. La bomba sganciata giovedi, prima ancora dei militanti del Califfato, è sembrata in realtà diretta altrove per affermare la supremazia degli Stati Uniti nei confronti della Russia di Putin che, in quelle ore, stava preparando il punto di arrivo di una maratona diplomatica durata almeno quattro anni. Venerdì mattina infatti, i delegati di Cina, India, Pakistan, Afghanistan e delle cinque repubbliche centroasitiche dell’ex Urss dovevano incontrarsi per una conferenza internazionale proprio sul futuro dell’Afghanistan cui anche Washington era stata inviata e a cui aveva sdegnosamente rifiutato di partecipare. Questa offensiva russa, iniziata negli ultimi anni dell’era Karzai e proseguita pur con molte difficoltà, nell’era Ghani-Abdullah (i due “copresidenti” attuali), ha molto infastidito gli americani. La bomba non sembra dunque una coincidenza ma, come l’attacco ieri dei talebani per mostrare i pugni a Daesh, la sottolineatura di una primogenitura sul Paese dell’Hindukush. “Roba nostra, sembra aver detto la GBU-43/B Moabc on i suoi 11mila chili di esplosivo.
Ma i due veri protagonisti sembrano al momento ancora i vecchi attori della Guerra Fredda che, cambiati di poco gli abiti di allora, si contendono la scena centroasiatica e dunque l’Afghanistan, il suo boccone più succulento. La bomba sganciata giovedi, prima ancora dei militanti del Califfato, è sembrata in realtà diretta altrove per affermare la supremazia degli Stati Uniti nei confronti della Russia di Putin che, in quelle ore, stava preparando il punto di arrivo di una maratona diplomatica durata almeno quattro anni. Venerdì mattina infatti, i delegati di Cina, India, Pakistan, Afghanistan e delle cinque repubbliche centroasitiche dell’ex Urss dovevano incontrarsi per una conferenza internazionale proprio sul futuro dell’Afghanistan cui anche Washington era stata inviata e a cui aveva sdegnosamente rifiutato di partecipare. Questa offensiva russa, iniziata negli ultimi anni dell’era Karzai e proseguita pur con molte difficoltà, nell’era Ghani-Abdullah (i due “copresidenti” attuali), ha molto infastidito gli americani. La bomba non sembra dunque una coincidenza ma, come l’attacco ieri dei talebani per mostrare i pugni a Daesh, la sottolineatura di una primogenitura sul Paese dell’Hindukush. “Roba nostra, sembra aver detto la GBU-43/B Moabc on i suoi 11mila chili di esplosivo.
Pachistani afgani, i tradizionali protagonisti di questa guerra locale, sembrano invece, in questo momento, del tutto in sordina. Al netto dei litigi tra le due capitali, all’ordine del giorno con vigore ormai da due anni, entrambi sembrano aver ormai perso del tutto il controllo della situazione. Islamabad è stata bypassata da russi e americani che trattano, più o meno segretamente direttamente con la guerriglia, e Kabul è ormai così schiacciata sulle posizioni di Washington (da cui spera di ricevere altro denaro e nuove forze militari) che sembra ormai davvero solo una marionetta in mani altrui. Quanto alla Nato, anche l’Alleanza di volenterosi (tra cui mille soldati italiani di stanza a Herat) sembra aver ormai totalmente lasciato agli americani ogni strategia senza nemmeno salvare le apparenze, come ai tempi della missione Isaf. Ora la missione Resolute Support sembra solo la misera foglia di fico su decisioni che si prendono a Washington e assai poco a Bruxelles. Dove al massimo è richiesto di rispondere soltanto “Signorsì”.
Trump vs Putin via Kabul
La bomba americana GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Moab), sganciata giovedì 13 aprile, ha colpito sì il distretto di Achin della provincia orientale afgana del Nangarhar, ma lo sguardo degli osservatori vi ha colto un messaggio rivolto ad altri. In particolare, alla Corea del Nord, uno dei punti di tensione più elevati del continente asiatico.
Una serie di apparenti coincidenze invita però a una riflessione d’altro tipo che forse può essere utile considerare. E che fa dell’Afghanistan, ancora una volta, non solo uno dei maggiori terreni di scontro col terrorismo di matrice islamica – obiettivo dell’azione – ma anche il teatro di un confronto tra due potenze in contrapposizione su varie caselle dello scacchiere geopolitico internazionale: gli Stati Uniti e la Russia.
Il 13 aprile non era infatti un giorno come un altro, ma la vigilia della terza Conferenza sul futuro dell’Afghanistan organizzata dal Cremlino nella capitale russa. Nelle due tornate precedenti la diplomazia di Vladimir Putin aveva convocato solo alcuni attori regionali ed era assente il protagonista principale – l’Afghanistan. Il 14 aprile doveva invece segnare il vero e proprio rientro sulla scena afgana della Russia – dopo l’uscita dell’URSS da quel Paese nel 1989, dieci anni dopo l’invasione e nel momento in cui l’impero sovietico si avviava alla disintegrazione.
Per diversi anni i russi hanno tenuto un profilo molto basso sull’Afghanistan, limitandosi a criticare in qualche intervista l’intervento della Nato e, soprattutto, a mettere in guardia l’Occidente sui rischi insiti nella “tomba degli imperi”, come l’Afghanistan è stato più volte soprannominato per la capacità di infliggere sconfitte militari agli eserciti più forti. Ma negli ultimi tre-quattro anni Mosca ha tentato, con qualche successo, di riaffaccciarsi sulla scena: promesse d’aiuto e regali di armamenti hanno accompagnato una morbida e sottile offensiva diplomatica con le autorità di Kabul….(segue)
Questo articolo prosegue su Aspeniaonline
Effetti della bomba: off limits anche per gli afgani
 A quasi una settimana dal lancio della “madre di tutte le bombe”, sganciata il 13 aprile nel distretto Achin – provincia orientale del Nangarhar -, l’area resta completamente sigillata sia per i giornalisti
A quasi una settimana dal lancio della “madre di tutte le bombe”, sganciata il 13 aprile nel distretto Achin – provincia orientale del Nangarhar -, l’area resta completamente sigillata sia per i giornalisti
ficcanaso sia per lo stesso esercito afgano, escluso da un perimetro guardato a vista dalle forze americane di stanza in Afghanistan.
Nonostante l’acquiescenza generalizzata con cui la bomba è stata accolta sia dal governo (che l’ha anzi definita una giusta azione in appoggio agli operativi dell’esercito afgano) sia dalla stampa locale, qualche sospetto si è fatto strada ad esempio tra i giornalisti di ToloNews, un’emittente privata a larga diffusione, che ha tentato di andar oltre la versione ufficiale che a oggi attesta un successo con 99 cadaveri di membri dello Stato islamico spazzati via dalla bomba sganciata sul villaggio di Assadkhil nell’area conosciuta come Mohmand Dara. Il giornalista Karim Amini, che ha pubblicato anche una foto della “frontiera” attorno al cratere causato da un ordigno da 11 tonnellate di esplosivo, sostiene che lo Stato islamico è ancora attivo nella zona da cui spara razzi sull’esercito afgano che, in mancanza di una presa di visione di quanto è successo nella zona colpita, deve accontentarsi della reazione rabbiosa dei jihadisti.
Ma la domanda vera cui per ora non c’è risposta riguarda le vittime civili. Il raid puntava a una serie di tunnel costruiti dai mujaheddin con soldi della Cia durante gli anni dell’invasione sovietica e poi diventati alloggio dei jihadisti d’importazione del Califfato, attivi soprattutto nella provincia del Nangarhar, al confine col Pakistan. E qualche sospetto arriva dalle parole di un membro del Consiglio provinciale che dice al giornalista che dovrebbe esserci libero accesso alle organizzazioni umanitarie per consentire alle popolazioni sfollate di far ritorno nei loro villaggi. Amini non approfondisce così che non è chiaro se si tratti solo delle famiglie sfollate per la presenza dello Stato islamico, noto per la sua brutalità, o anche per gli effetti della guerra: sia per gli operativi militari afgani e americani nell’area, sia anche per effetto della bomba. La versione ufficiale è che non ci sono state vittime civili ma si sono trovati solo militanti jihadisti tra i cadaveri rinvenuti (resta da capire come si è arrivati al conteggio e al riconoscimento visto che la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast è in grado di uccidere un uomo col solo spostamento d’aria ed è in grado di perforare cemento armato sino a 100 metri di profondità). La versione ufficiale sosteneva anche che nell’aera bombardata viveva una sola famiglia, evacuata prima del raid. E’ però inevitabile far mente locale non solo sulle vittime civili di questa guerra (in aumento rispetto agli anni precedenti da quando, dal 2009, la missione Onu a Kabul ha iniziato a tenerne il bilancio): tra i tanti episodi c’è quello dell’ottobre 2016 quando un drone ha bombardato alle tre del mattino una guest house nel villaggio di Shadal Bazar, distretto di Achin, uccidendo almeno 15 persone convenute per celebrare un anziano di ritorno dalla Mecca. Allora l’Onu disse che erano civili mentre le autorità locali li avevano bollati come islamisti tra cui non c’erano né donne né bambini anche se un giornalista del Guardian, che aveva fatto vista ai feriti dell’ospedale di Jalalabad, trovò tra loro un ragazzino di 12 anni e due anziani.
Le attività dei droni sono segrete e anche sui bombardamenti in atto nel Sud del Paese da mesi c’è una cortina di silenzio. Identico a quello che ora circonda gli effetti della prima bomba di Donald Trump.
Il successo di Mosca
 |
| Il mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa. L’Orso russo torna in scena |
Se la cosa farà strada si vedrà ma intanto Mosca, la bestia nera dell’Afghanistan, incassa un successo. E offre, durante la terza conferenza sull’Afghanistan organizzata dai russi nella loro capitale, di fare di Mosca la sede di un possibile negoziato tra talebani e governo afgano. Incassa anche toni amichevoli dagli afgani stessi (pur se la strategia dei due Paesi è assai diversa), tanto che la bomba americana sganciata giovedi scorso sull’Afghanistan orientale – se doveva essere una dimostrazione di forza anche contro l’Orso russo – non sembra aver portato a casa risultati politici soddisfacenti. Le note ufficiali dicono che quasi cento affiliati allo Stato islamico sono stati uccisi dall’ordigno ma il risultato definitivo è che intanto Mosca rientra in scena proprio sul territorio nel quale si pensava non avrebbe mai rimesso piedi. Una notizia che oscura il colpaccio contro il Califfato ammesso che venga confermato che la bomba non ha fatto danno ai civili (al di là della distruzione di pascoli, terreni e probabilmente abitazioni).
Usa/Urss/Afghanistan. Messaggio da undici tonnellate di esplosivo
 |
| Moab Gbu-43, il più potente ordigno convenzionale. Sganciato giovedi in Afghanistan |
Il giorno dopo la “madre di tutte le bombe” elicotteri da combattimento americani continuano l’operazione di pulizia iniziata nella provincia di Nangarhar giovedi sera nel distretto di Achin, dove tunnel costruiti dai mujaheddin durante la guerra contro i sovietici (con soldi americani ha denunciato ieri con un tweet Edward Snowden) sarebbero adesso i rifugi tattici dello Stato islamico in Afghanistan. Il distretto è abbastanza disabitato e, stando alle dichiarazioni del governo, nella zona del bombardamento (il villaggio di Mohmand Dara) viveva una sola famiglia afgana evacuata per tempo. Secondo Kabul infatti non ci sarebbero state vittime civili nell’attacco dell’altro ieri ma solo militanti del Califfato. I morti sarebbero quasi una quarantina su settanta (il Califfato smentisce) possibili obiettivi ma il bilancio è probabilmente provvisorio come provvisorie potrebbero essere le notizie sulle vittime civili che, male che vada, devono aver perso raccolti e abitazioni nell’operazione che ha visto il lancio di una bomba da 11 tonnellate di esplosivo costata al contribuente americano 15 milioni di dollari.
Le reazioni all’operazione, avvenuta alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan voluta dalla Russia e che si sta svolgendo a Mosca, sono di tipo diverso: il governo è compatto e compiaciuto. E’ ormai da tempo schiacciato sulle scelte americane e del resto appoggia l’escalation di raid aerei in corso da oltre un anno tanto che dal palazzo presidenziale si è appreso che la bomba americana serviva come appoggio alle operazioni dell’esercito nazionale. Infine non è un mistero che l’esecutivo a due teste di Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah stia aspettando l’arrivo del consigliere per la sicurezza di Trump con la speranza che gli americani (che hanno ora in Afghanistan 8.500 soldati accanto a poco meno di 5mila militari Nato di cui 1000 italiani) decidano, in controtendenza con Obama, di aumentare il contingente militare. Per Ghani sarebbe un sollievo, più che per la guerra, per l’iniezione di denaro fresco che l’arrivo di un nuovo contingente verrebbe a significare in un’economia sempre più asfittica dopo che la Nato se n’è andata lasciando solo il ricordo dei bei tempi in cui nel Paese stazionavano oltre 100mila soldati stranieri.
L’opposizione più violenta al raid viene dal vecchio presidente Hamid Karzai che ha usato parole durissime sostenendo che per gli americani l’Afghanistan è solo un territorio dove testare nuove armi. Gli ha fatto eco l’inviato speciale per il Pakistan Umar Zakehlwal che ha bocciato la bomba come “riprovevole e controproducente”.
Le reazioni della gente della strada infine – raccolte dalla stampa locale – sono diverse: chi è d’accordo, chi pensa che in realtà gli americani abbiano bombardato per i loro fini e non per aiutare gli afgani, chi invece pensa – ha detto uno studente di Kabul – che la bomba fosse diretta a Mosca. Quella del giovane studente sembra in effetti la lettura più interessante: alla Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta oggi a Mosca gli americani avevano opposto un secco diniego all’invito russo in un clima di nervosismo per le avance dei russi verso il vecchio Paese occupato nel 1979. Mosca di conferenze ne ha già organizzate altre due ma questa, a differenza delle altre più in sordina, è una cosa seria: ci sono tutti, dall’Iran alla Cina, dall’India al Pakistan passando per le cinque repubbliche dell’ex Urss in Asia centrale. E c’è naturalmente Kabul che, pur se sostiene Washington e la sua politica, ha accettato di buon grado alcune iniziative di sostegno da parte russa. Questa parte del mondo sembra dunque tornare a essere, come ai tempi del “Great Game” e della Guerra Fredda, la pedina da giocare tra due giganti. Se Washington e i suoi militari sono preoccupati dal ritorno sula scena dell’Orso russo, Mosca è allarmata dall’accerchiamento sul suo lato Sud che gli americani, dopo aver preso il controllo dell’Afghanistan, hanno allargato corteggiando le repubbliche dell’Asia centrale, tradizionali alleate di Mosca.
Lo schiaffo di Trump all’Afghanistan (e a Mosca)
 Gli avieri statunitensi delle Forze speciali, impegnati da mesi in una campagna di bombardamenti aerei in Afghanistan, hanno sganciato ieri un ordigno da undici tonnellate di esplosivo nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangharhar al confine col Pakistan e considerata la base dello Stato islamico nel Paese.
Gli avieri statunitensi delle Forze speciali, impegnati da mesi in una campagna di bombardamenti aerei in Afghanistan, hanno sganciato ieri un ordigno da undici tonnellate di esplosivo nel distretto di Achin, nella provincia orientale di Nangharhar al confine col Pakistan e considerata la base dello Stato islamico nel Paese.
La bomba Gbu-43, nota anche come “Moab” ( massive ordnance air blast bomb ma in gergo mother of all bombs) è la più grande bomba non nucleare mai sganciata. Il primo test dell’ordigno è del marzo e poi nel novembre del 2003 e, a parte i test, non si aveva mai avuto notizia di altri lanci. Quello di eri, alle sette di sera, è dunque un duplice messaggio. Allo Stato Islamico ma indirettamente anche a Mosca che, proprio in queste ore, sta ultimando i preparativi di una conferenza sull’Afghanistan in agenda da mesi. Al meeting, cui saranno presenti oltre agli afgani i delegati di Cina, India, Pakistan, Iran e delle repubbliche centroasiatiche dell’ex Urss, era stata invitata anche Washington che aveva però opposto un diniego. Convitato di pietra, Trump si è invece auto invitato ieri mettendo a segno un colpo clamoroso proprio nel Paese di cui si sta per discutere a Mosca. E non è l’unica notizia di un rinnovato attivismo americano in Afghanistan (da cui a breve sapremo l’entità del danno provocato dall’ordigno). Sempre alla vigilia del meeting organizzato da Putin, Trump ha annunciato l’arrivo imminente a Kabul del suo National Security Adviser, il generale McMaster. Il presidente ha annunciato il suo invio – è il funzionario di Stato più alto in grado a visitare Kabul da che Trump si è insediato – durante una conferenza stampa ma si è limitato a dire che il viaggio – di cui per ora non si conoscono né la data né altri dettagli – servirà a capire “che progressi si potranno fare con i nostri partner afgani e i nostri alleati della Nato”. Nel giro di boa che Trump sta facendo rispetto alle sue promesse elettorali (tra cui quella di lasciare l’Afghanistan) non c’è solo la nuova apertura nei confronti di una Nato “non più obsoleta” ma anche la possibilità, sostengono gli osservatori, che la Casa Bianca decida per un aumento delle sue truppe, come peraltro richiesto dal generale John Nicholson, comandante delle forze straniere nel Paese. La bomba sembra esserne il biglietto da visita.
L’Afghanistan conosce dunque una nuova escalation anche se di fatto una campagna di bombardamenti aerei nel Sud del Paese è in atto da mesi. Ancora non si conoscono gli effetti di questa massiccia operazione ma i dati del solo anno trascorso parlano chiaro: l’anno passato le vittime civili sono state oltre 11mila: 3512 morti (tra cui 923 bambini) e 7.920 feriti (di cui 2.589 bambini), con un aumento del 24% rispetto al periodo precedente. Ma il rapporto di Unama, la missione Onu a Kabul, spiegava anche che i bombardamenti aerei – afgani e internazionali – pur se responsabili “solo” del 5% delle vittime nel 2016, rispetto al 2015 hanno raddoppiato il loro bilancio: 250 morti e 340 feriti, i numeri più elevati dal 2009. Forse per difetto, perché – ad esempio – i bombardamenti coi droni non sono calcolati in quanto operazioni secretate. Le manifestazioni di protesta si susseguono e anche se spesso si manifesta contro la guerriglia, non meno spesso gli afgani manifestano contro le bombe che da un anno a questa parte cadono sempre più frequentemente.
Il lato oscuro delle nostre scarpe
«L’etichetta Made in Italy o Made in EU ha sempre suggerito qualità del lavoro e degli standard ma se le scarpe sono solo progettate nella UE e poi prodotte in Serbia, Albania, Birmania o Indonesia da lavoratori stranieri in condizioni miserabili, oppure in Italia da parte di terzisti che pagano salari contrattati al di sotto del salario vivibile, dove sta il valore aggiunto del Made in EU o Made in Italy?». Se lo chiede un’inchiesta della Campagna Abiti Puliti e di Change your Shoes – progetto di 15 organizzazioni europee e 3 asiatiche – che è un viaggio nel lato oscuro delle nostre scarpe. Proprio “nostre” perché Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive di tre marchi globali delle calzature, studio realizzata dal Centro Nuovo Modello Di Sviluppo e FAIR, racconta il percorso compiuto lungo le filiere produttive di tre grandi marchi italiani (Tod’s, Geox, Prada), mostrando quanto si sia ancora lontani dal rispettare i diritti umani e sindacali di chi confeziona le loro-nostre scarpe.
 Nel mondo si fabbricano ogni anno circa 23 milioni di paia di scarpe e qualche barlume di consapevolezza sulle condizioni di lavoro in cui vengono assemblate attraverso una filiera che agisce su diversi Paesi (prodotto base, tomaia, design, distribuzione etc) ci aveva mostrato processi ad alta intensità di manodopera sottoposti a rapidi tempi di consegna e prezzi ridotti all’osso soprattutto in Cina, India, Bangladesh, Pakistan e Indonesia. Ma oggi – spiega il rapporto – dopo la delocalizzazione si assiste alla rilocalizzazione o reshoring, ossia al trasferimento in direzione contraria delle attività produttive precedentemente delocalizzate in Asia grazie al basso costo del lavoro. «L’aumento di produttività, unito a una politica di moderazione salariale, maggiore flessibilità del lavoro, maggior libertà di licenziamento, relazioni industriali soft affiancate da incentivi e sussidi per attrarre gli investimenti – dice l’inchiesta – sta rendendo di nuovo appetibile anche la vecchia Europa che presenta il vantaggio di una mano d’opera ad alta tradizione manifatturiera. Ad essere più interessati al fenomeno sono i Paesi dell’Europa dell’Est con salari a volte più bassi di quelli asiatici». Spesso anche grazie a incentivi locali.
Nel mondo si fabbricano ogni anno circa 23 milioni di paia di scarpe e qualche barlume di consapevolezza sulle condizioni di lavoro in cui vengono assemblate attraverso una filiera che agisce su diversi Paesi (prodotto base, tomaia, design, distribuzione etc) ci aveva mostrato processi ad alta intensità di manodopera sottoposti a rapidi tempi di consegna e prezzi ridotti all’osso soprattutto in Cina, India, Bangladesh, Pakistan e Indonesia. Ma oggi – spiega il rapporto – dopo la delocalizzazione si assiste alla rilocalizzazione o reshoring, ossia al trasferimento in direzione contraria delle attività produttive precedentemente delocalizzate in Asia grazie al basso costo del lavoro. «L’aumento di produttività, unito a una politica di moderazione salariale, maggiore flessibilità del lavoro, maggior libertà di licenziamento, relazioni industriali soft affiancate da incentivi e sussidi per attrarre gli investimenti – dice l’inchiesta – sta rendendo di nuovo appetibile anche la vecchia Europa che presenta il vantaggio di una mano d’opera ad alta tradizione manifatturiera. Ad essere più interessati al fenomeno sono i Paesi dell’Europa dell’Est con salari a volte più bassi di quelli asiatici». Spesso anche grazie a incentivi locali.
Uno tra gli esempi citati dal rapporto riguarda ad esempio 11 milioni di euro messi a disposizione da
Belgrado nel gennaio 2016 grazie ai quali Geox ha aperto un impianto a Vranje, in Serbia. L’estate seguente, il marchio è stato oggetto di contestazioni sulla stampa locale per diverse irregolarità: condizioni sanitarie e di sicurezza insoddisfacenti, offese verbali ai lavoratori, forme di assunzione non regolari, straordinari eccessivi e altre violazioni. Anche se le denunce, la pressione dei media e l’attività sindacale e degli attivisti hanno migliorato le cose, le preoccupazioni non sono cessate.
La pratica del “terzismo” è comune: «I terzisti capofiliera utilizzati da Geox si trovano tutti all’estero, prevalentemente in Estremo Oriente, anche se non manca l’Europa dell’Est. Tod’s, invece – scrive il rapporto – li ha prevalentemente in Italia distribuiti fra Marche, Abruzzo e Puglia. Tuttavia dispone di terzisti capofiliera anche in Romania per la produzione di scarpe a marchio Hogan Rebel. Quanto a Prada, fino al 2015 intratteneva rapporti produttivi anche col gruppo cinese Stella International Holding, che dispone di stabilimenti calzaturieri in Cina, Vietnam, Indonesia e Bangladesh, ma vista la progressiva perdita di competitività dell’Asia, oggi la politica di Prada è di abbandonare l’Asia per tornare a produrre in Italia e Paesi dell’Europa dell’Est, principalmente Romania, Serbia, Bosnia Erzegovina, oltre alla Turchia». Questa diversificazione consente ai marchi di pagare prezzi differenti ai loro fornitori in base all’area geografica.
Ciò fa si che il “mercato del lusso” metta in evidenza una crescente sproporzione tra prezzi e valore reale dei beni. Un surplus di valore che però «non è distribuito equamente fra coloro che partecipano alla sua produzione ed è assorbito per la maggior parte da due fasi della catena:la distribuzione e il marchio, che si appropriano di circa il 60% del prezzo finale. Con questo meccanismo si attiva una spirale crescente per cui chi detiene più ricchezza e potere nella catena del valore finirà per detenerne sempre di più, potendo accrescere a dismisura il proprio potere di vendita attraverso il marketing e così mantenere il proprio controllo sui fornitori che denunciano prezzi troppo bassi e tempi di consegna troppo rapidi».
La presenza di consumatori informati e reti di solidarietà internazionali, secondo Abiti Puliti e Change your Shoes, sono le condizioni per ottenere dalle imprese comportamenti conformi alle tutele previste dalle leggi nazionali, dalle convenzioni internazionali e dai principi guida dell’Onu. Le Campagne chiedono ai marchi (compresi Tod’s, Prada e Geox) di garantire trasparenza sulla catena di fornitura e il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui un salario dignitoso; ai governi nazionali e alla UE chiedono di rafforzare i controlli sull’applicazione delle leggi sul lavoro. Il 14 aprile Abiti Puliti organizza a Genova al Teatro Altrove l’evento 13600HZ Concerto per macchine da cucire, progetto dell’artista concettuale Sara Conforti. Verrà proiettato anche il video-documentario “In My Shoes” dopo un dibattito pubblico sui temi dell’inchiesta.
Usa/Russia: Afghanistan, il fronte nascosto
C’è un altro fronte di scontro tra russi e americani in Asia. Un fronte nascosto e dimenticato ma
dove la guerra infuria con continuità e, per numero di decessi, più di prima. E’ il fronte afgano, la porta che dal Medio oriente e dall’Asia centrale arriva al subcontinente indiano. Un fronte di guerra che l’anno scorso ha contato 11mila vittime civili e dove si sta assistendo a un’escalation dei bombardamenti americani nel Sud e alla possibilità che Trump, in campagna elettorale favorevole al ritiro, aumenti le truppe nel Paese. Come anche il governo di Ashraf Ghani gli chiede.
L’Afghanistan fu terreno di scontro durante il “Grande Gioco” tra Impero zarista e Inghilterra nell’800 e divenne il confine della guerra guerreggiata durante la Guerra Fredda quando l’Urss invase l’Afghanistan e gli Usa armarono, con sauditi e pachistani, l’armata mujaheddin: i primi “combattenti della fede” manovrati anche dall’Occidente come da lì a poco sarebbe avvenuto anche per la guerra in Bosnia.
I sovietici lasciarono l’Afghanistan con le ossa rotte nel 1989, dopo dieci anni e migliaia di morti, poco prima che la Perestrojka desse il colpo di grazia all’Unione delle Repubbliche socialiste. L’Afghanistan fu il detonatore di una crisi profonda e la carta che Washington aveva giocato, assieme a molte altre, per combattere i comunisti nel mondo. Poi fu la volta degli americani. Dopo l’attacco alle Torri gemelle del 2001, prima gli Stati Uniti e poi la Nato (quindi ancora gli Stati Uniti), presero il controllo del Paese per far presto i conti con le tribù afgane adesso col turbante nero dei talebani. Mosca intanto si era ritirata dalla scena, alle prese con la ricomposizione di un impero ormai spezzettato. Se aveva perso l’Afghanistan, Mosca stava soprattutto perdendo influenza in Asia centrale e nel Caucaso dove, oltre alla protesta islamista, c’era da far i conti con la perdita di giacimenti di gas e petrolio, cotone, minerali.
Ma da qualche tempo a questa parte ecco che Mosca ricomincia a occuparsi del piccolo Paese crocevia perché le preoccupazioni crescono. Sul fronte afgano ci sono almeno tre grossi problemi: la presenza di truppe Nato e soprattutto il controllo delle basi aeree afgane da parte degli Usa, una cintura pericolosa sul suo lato sudorientale. Il narcotraffico, che porta in Russia vagoni di eroina. Lo Stato Islamico, che ha creato una testa di ponte sui porosi confini tra Afghanistan e Pakistan. Gli americani e la Nato hanno deciso di lasciare? Bene, è il momento di farsi avanti. A Kabul c’è ancora Karzai e Mosca fa le prime avance. Regali, offerte di training militare, aiuti economici. E’ un avvicinamento lento portato avanti dall’ambasciata a Kabul e dall’inviato speciale Zamir Kabulov. Kabulov conosce il Paese: ci ha lavorato dal 1983 all’87 come secondo segretario d’ambasciata (e, per gli americana, come spia del Kgb) e poi è stato ambasciatore a Kabul sino al 2009. E’ un uomo che ha conosciuto mullah Omar e ha trattato con lui, nel 1995, per il rilascio di prigionieri russi. La carta da giocare è diplomatica. Mosca organizza un incontro in Russia sul futuro dell’Afghanistan ma non invita né Kabul né Washington. Intanto tratta coi talebani. E mentre i comandanti americani e afgani cominciano ad accusare Mosca di vendere armi alla guerriglia, la Russia organizza per il prossimo 14 aprile una nuova conferenza internazionale cui invita Kabul, Teheran, Islamabad, Pechino, Delhi e le repubbliche centroasiatiche. Fa la sua offerta anche a Washington che declina l’invito. I nervi sono tesi anche se quel fronte sembra apparentemente ininfluente e lontano. La conferenza si svolgerà proprio mentre il segretario di Stato Usa Tillerson sarà Mosca.
“I rohingya possono tornare”
Per la prima volta la Nobel birmana si difende ma prende posizione: “Non è pulizia etnica. Se
rientrano sono i benvenuti”
 Nella prima dichiarazione pubblica da che il dramma dei rohingya birmani si è trasformato in un
Nella prima dichiarazione pubblica da che il dramma dei rohingya birmani si è trasformato in un
esodo di massa verso il Bangladesh dopo gli incidenti alla frontiera nell’ottobre scorso, Aung San Suu Kyi, in un’intervista alla Bbc, nega la “pulizia etnica” e non prende posizione sulla campagna militare ma sostiene però che il suo Paese è pronto ad accogliere chi vorrà tornare e che gli sarà garantita la sicurezza necessaria. “Chi torna è il benvenuto”, dice la signora in giallo, che questa volta sfoggia un elegante abito verde (il colore dell’islam per paradosso): riceve il giornalista della Bbc Fergal Keane con cui affronta le difficoltà della transizione, il processo di pace e, dopo qualche minuto, le vicenda rohingya. Suu Kyi si difende dall’accusa di aver taciuto sostenendo al contrario di aver preso misure incaricando Kofi Annan di una missione specifica e di avere, col suo governo, iniziato un percorso di verifica sulla cittadinanza. Nega che si possa usare il termine “pulizia etnica” (che lo stesso Annan si è rifiutato di utilizzare) e, non condannandoli, la Nobel finisce per giustificare l’operato dei militari (accusati di stupri, violenze, uccisioni e incendi di villaggi) ma, in più di un passaggio, torna sul concetto di cittadinanza. Non dice direttamente che spetti ai rohingya ma insistere su questo punto diventa rilevante: qualche giorno fa infatti, i militari hanno preso posizione proprio sul tasto più controverso: la nazionalità dei musulmani rohingya in Myanamr.
Dopo che la missione di Kofi Annan, voluta da Aung San Suu Kyi per metter fine alle polemiche sull’espulsione dei rohingya, è stata resa pubblica con la richiesta di svuotare i campi profughi nello stato del Rakhine, un’indispettita casta militare che, benché al governo ci siano i civili pare aver sempre l’ultima parola, ha detto la sua. In risposta al rapporto dell’ex segretario generale il capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing, ha sottolineato con parole chiare che i rohingya in Myanmar non ci sono e che quelli che ci sono, restano degli “immigrati bangladesi” senza diritto di cittadinanza birmana. E’ la parola fine cui segue il silenzio di sempre a cominciare dalla leadership civile nel Paese, oppressa dal timore di un colpo di coda degli uomini in divisa. Nonostante le prese di posizione forti alle Nazioni Unite (il rapporto di Annan è piuttosto blando ma le denunce dell’Onu non sono mancate specie dalla Commissione diritti umani e dall’Unhcr), le parole del generale sembrano chiudere il capitolo in modo definitivo. Ma ecco che, a distanza di una settimana Suu Kyi puntualizza. Lo fa in punta di coltello, attenta a non dire una parola di troppo ma sottolinea il ruolo del governo civile e, seppur senza attaccarli direttamente, risponde ai militari. Si difende ma apre: “Pulizia etnica – dice – è una parola troppo forte… è una questione di persone su diversi lati dello spartiacque e questo divario stiamo cercando di chiuderlo… saremo felici se faranno ritorno”. C’è da capire se da cittadini o no.
The True Cost
Terra Equa Bologna (vedi il programma intero)
Terra Equa quest’anno ha dedicato il suo Festival del Commercio Equo e dell’Economia Solidale al tema della moda, del tessile, dell’abbigliamento, degli accessori.
Per toccare con mano che cosa significa Made in Dignity, Fashion Revolution, Slow Fashion, Abiti Puliti.
Ore 18 Sala cinema e parole
The True Cost
“Uno dei più bei film che ho avuto occasione di guardare al Festival di Cannes 2015” – Huffington Post / “Questo film sconvolgerà tutto il mondo della moda” – The Guardian
Proiezione del documentario The True Cost (versione originale, sottotitoli in italiano), presentato al Festival di Cannes nel 2015, che racconta le storie delle persone che producono i nostri vestiti, l’impatto dell’industria della moda sul nostro mondo e qual è il vero costo della maglietta da 10 € che indosso.
Intervengono:
Linda Triggiani (C’è un mondo – Terra Equa)
David Cambioli (altraQualità)
Deborah Lucchetti (Fair Coop. Soc. – Campagna Abiti Puliti)
Emanuele Giordana (giornalista, saggista e direttore di Lettera22)
In collaborazione con “Tutti nello stesso piatto”, Festival Internazionale di cinema e videodiversità
Per l’occasione saranno presentate le campagne internazionali in corso per la difesa dei diritti dei lavoratori del settore.
Le mire di Mosca e l’islam radicale in Asia Centrale
| Samarcanda, piazza Registan. Sotto una mappa dell’Uzbekistan |
L’ondata di arresti seguita ai fatti di San Pietroburgo porta dritta a una pista che dalla tradizionale rotta ceceno-daghestana arriva in Asia Centrale, la nuova frontiera da cui Mosca teme adesso un’ondata di violenze dirette o meno che siano dal Califfato di Raqqa. Un progetto che peraltro non ha fatto molta strada nell’Azerbaijan o nelle cinque repubbliche dell’ex Urss ai confini orientali di quel che fu l’Impero zarista e poi l’Unione sovietica. Eppure, se un timore islamista esiste, sono proprio le turbolente aree caucasiche ancora sotto diretto dominio russo a impaurire gli Stati orientali che temono un contagio dal Daghestan o dalla Cecenia anche se pubblicamente non lo ammettono. La bestia nera delle cinque repubbliche dell’Asia centrale è invece, pubblicamente, l’Afghanistan, la terra dei talebani, agitata come uno spauracchio per reprimere il dissenso islamista e non. Per Mosca l’Asia centrale resta comunque una preoccupazione perché il controllo di quelle terre gli è ormai in gran parte sfuggito di mano anche se gli accordi con la Russia prevedono la difesa militare dei confini in caso di conflitto. Lo si è visto con la presa di Kunduz in Afghanistan per alcuni giorni nel 2015. Sui confini è scattata l’allerta e una massiccia presenza di militari russi.
I Paesi dell’Asia centrale hanno un’antica tradizione islamica ma è solo l’Uzbekistan il Paese che potrebbe temere, a ragione, la pressione dei gruppi radicali armati. Naturalmente, come altrove, i conflitti in Afghanistan/Pakistan e nel vicino Caucaso settentrionale – e così la più recente guerra siriana e, a suo tempo, la guerra in Iraq – sono stati il motore di un revivalismo radicale che sembra aver assecondato la diffusione di movimenti salafiti e wahabiti e infine la partenza di foreign fighter verso l’estero per aderire alle brigate islamiche internazionali in vari Paesi. A volte i numeri hanno una certa rilevanza ma il fenomeno sembra abbastanza ridotto. L’Uzbekistan è un caso a parte: l’obiettivo del governo è sempre stato quello di far terra bruciata attorno al Movimento islamico dell’Uzbekistan (Mui), al punto che si era arrivati a proporre ai talebani, agli inizi del 2001, persino un riconoscimento dell’Emirato in cambio dell’espulsione dei militanti Mui dall’Afghanistan. Creato nel 1998 con l’obiettivo di rovesciare il regime e instaurare una forma di governo conforme alle leggi islamiche, il Mui si è alleato con i Talebani e Al Qaeda. Nel 2015 ha espresso fedeltà al Califfato di Al-Bagdadi creando una spaccatura tra i suoi membri, molti dei quali non hanno aderito alla svolta. I suoi combattenti sono attivi soprattutto in Pakistan. Oltre 1500 uzbechi militerebbero all’estero in gruppi come il Mui o la Jamaat Imam Bukhari. Lontano però dai confini russi.
Se all’epoca sovietica il controllo su moschee e madrase era ferreo, le cose cambiano con la “liberazione” dal tallone di Mosca ma l’enfasi sul nazionalismo e un ambiguo atteggiamento verso la religione intesa soprattutto come stampella del potere, hanno finito per rivitalizzare l’islam centroasiatico favorendo la nascita di sezioni locali anche di movimenti transnazionali islamici. La risposta dei governi è stata soprattutto repressiva e con la tendenza a fare di ogni erba un fascio senza grandi distinzioni. Secondo diversi analisti le preoccupazioni che riguardano la sicurezza sono in realtà da leggersi, in molti casi, in chiave interna: preoccupazioni insomma che derivano più da un timore per la stabilità dei governi – in una situazione di povertà crescente per la crisi del greggio e del rublo e per l’incertezza nella successione interna delle leve di potere – che non per la paura reale di un contagio o di un’espansione dell’islamismo esogeno armato. In sostanza i Paesi centroasiatici avrebbero cioè utilizzato e utilizzerebbero il “pericolo jihadista” anche per contenere le spinte dal basso che possano mettere in difficoltà (come già avvenuto in passato) il sistema di potere locale. Lo stesso per il narcotraffico, attività economica sotto traccia che consente il transito di oppio e oppiacei prodotti in Afghanistan anche se, scrivono i due ricercatori C. Bleuer e S. Kazemi, «Il rischio in termini di sicurezza che lega l’Afghanistan alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale viene di frequente altamente esagerato e così il presunto collegamento tra narcotraffico e gruppi radicali islamisti. In realtà in tutta l’Asia Centrale i principali attori del narcotraffico sono impiegati governativi, agenti della sicurezza e personaggi legati alla mafia…». Anche qui c’è ovviamente uno zampino dei russi, destinatari dell’eroina afgana. Naturalmente un rischio islamista, benché sovrastimato, esiste ma, avvertono gli studiosi, in quest’area si fa più affidamento alla repressione che al dialogo. Un metodo che in Asia Centrale hanno imparato da Mosca.
La nuova Guerra Fredda nel Nuovo Grande Gioco
Amici o non amici, Trump e Putin se la devono forse vedere con una nuova Guerra Fredda tra Usa ed ex Urss che manco a dirlo passa per Kabul. Il generale Joseph Votel – generale a 4 stelle e già a capo del Comando centrale – ha detto all’ Armed Services Committee del Congresso che suppone che Mosca fornisca i talebani di armi. Accusa grave e senza prove, come lui stesso ammette, ma che esce dalla bocca di un top general benché uscente dalla sua posizione di comandante in capo. Votel (classe 1958, nella foto a sinistra) è un four stars general che è stato comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti dal marzo 2016 e che ha già prestato servizio come comandante degli Stati Uniti Special Operations Command. Non una voce qualsiasi. Gli Stati Uniti sono preoccupati dall’attivismo diplomatico di Mosca che cerca di recuperare posizioni e che sta tenendo nella capitale russa colloqui multilaterali sull’Afghanistan cui non ha mai invitato Washington. Troppo impegnati a seguire le vicende dei collegamenti russi di Trump rischiamo di prendere lucciole per lanterne. Più che un’alleanza tra i due colossi (vedi Siria apparentemente) sta montando una nuova Guerra Fredda, vedi un po’, nel Nuovo Grande Gioco in Asia centrale.
Rohingya: la parola fine
 |
| L’Onu condanna Myanmar ma nessuno pensa a prendere provvedimenti |
Dopo che la missione di Kofi Annan, voluta da Aung San Suu Kyi per metter fine alle polemiche sull’espulsione dei rohingya birmani, un’indispettita casta militare che, benché al governo ci siano i civili, pare aver sempre l’ultima parola, ha detto la sua. Tombale.
In risposta al rapporto dell’ex segretario generale che chiedeva la chiusura dei campi profughi nello stato birmano del Rakhine, il capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing, ha detto con parole chiare che i Rohingya in Myanmar non ci sono e che quelli che ci sono, restano degli immigrati bangladesi senza diritto di cittadinanza birmana. E’ la parola fine cui segue il silenzio di sempre a cominciare dalla leadership civile nel Paese, oppressa dal timore di un colpo di coda degli uomini in divisa.
Ci sono state alcune prese di posizione forti alle Nazioni Unite (il rapporto di Annan è piuttosto blando ma le denunce dell’Onu non sono mancate) ma sembra di capire che non ci sarà alcun seguito. Il caso è chiuso.
Cooperazione dolce
 |
| Un’ape “carica” dell’apicoltore Hatem Ait Ali |
In Algeria c’è un’associazione di produttori di miele di qualità che sfrutta tutte le sfumature climatiche producendo anche nel Sahara. E che lavora con gli standard proposti dalla “Carta dei mieli del Mediterraneo”. Un progetto europeo che ha un’anima umbra. Un reportage dalle nuove frontiere della biodiversità.
Si racconta che negli anni Sessanta, subito dopo l’indipendenza dalla Francia, il tunisino Bourghiba e l’algerino Boumedienne avessero qualche preoccupazione sulle mire espansionistiche dell’Egitto. Per evitare scomode ingerenze Bourghiba propose che la dizione Maghreb riguardasse solo i tre Paesi che avevano in comune… il cous cous, piatto tipico di Marocco, Algeria e Tunisia. Vero o non vero, questi tre Paesi hanno in comune anche l’apis mellifera intermissa o ape nera, un insetto prezioso e diffuso soprattutto in Algeria e Tunisia con colonie in Marocco e qualche puntata in Libia e nel Sud della Spagna. Ignorata per molti anni e con la fama (ingiustificata) di essere molto aggressiva, l’ape nera sta conoscendo un momento di splendore. Le università locali ne studiano le peculiarità e lavorano alla selezione e alla salvaguardia della specie. Ma questo lavoro è soprattutto diffuso in una nuova generazione di apicultori che, abbandonato il sistema tradizionale di allevamento, si è rapidamente messa al passo con le tecniche più recenti di selezione e cura delle api con l’obiettivo di trasformare l’apicoltura magrebina in un segmento produttivo che mira alla qualità del miele e che contribuisce alla biodiversità. E sì perché le api non producono solo miele, propoli, polline e pappa reale. Stimolano, con l’impollinazione, nuove colonizzazioni agricole che possono rendere verde anche il deserto.
 |
| Tahar Souna al lavoro |
Il viaggio comincia nei dintorni di Algeri nell’azienda famigliare dei Souna dove Tahar, che ha solo 36 anni, ci accoglie con grande cordialità. Tahar, il cui padre è morto l’anno scorso in un incidente, ha ereditato coi suoi tre fratelli, l’azienda paterna figlia di una grande ambizione. Per inseguire le fioriture naturali infatti, Tahar, come quasi tutti gli apicultori algerini, a maggio si sposterà nel Sahara dove suo padre aveva acquistato ben 400 ettari. Il sogno del vecchio Souna era rendere fertile una porzione di quelle terre aridi dove, se c’è acqua, cresce benissimo una specie della famiglia delle Ramnacee, lo jujubier che noi chiamiamo giuggiolo (Zizyphus vulgaris). Quest’albero da frutto è coltivato nella regione mediterranea per il frutto carnoso e dolce che può essere consumato crudo o essiccato. Ma adesso vien messo a dimora soprattutto per i suoi fiori gialli di cui le api sono ghiotte. Tahar ha scavato un pozzo a 400 metri di profondità e ha iniziato a trapiantare le pianticelle che ora crescono alla periferia di Algeri in una serra che mostra con orgoglio. “I semi – dice – li ha presi mio padre in Yemen” dove la tradizione vuole che lo jujubier raggiunga il massimo splendore. Tra qualche anno il nomadismo sahariano di Tahar si rivolgerà alle sue terre dove le pianticelle già iniziano a fruttificare. Niente discussioni dunque con altri apicultori, ghiotti, come le loro api, di questo fiore che dà un miele dolcissimo e ricercatissimo soprattutto sui mercati arabi e nel Golfo.
 |
| Giuggiolo o jujubier |
“Effettivamente – spiega Mohammed Hamzaoui, un apicoltore di Blida, alle porte di Algeri – c’è ormai molta concorrenza nelle regioni sahariane dove fioriscono diverse specie quando nella zona costiera, quella dove risiedono i produttori, i fiori sono caduti. Anche per questo abbiamo creato Anap, l’Associazione degli apicoltori professionisti, in modo tale che ci si possa mettere d’accordo”. Ma non è solo una questione di posti al sole: l’Anap ha sposato l’idea che il miele algerino possa essere alla pari con quelli prodotti in Europa dove gli standard sono elevati e richiedono un’apicoltura tecnicamente avanzata con prodotti garantiti. “Per ora siamo circa 200 soci ma non è il numero che ci preoccupa. Anzi. Chi vuole aderire deve infatti garantire gli standard che applichiamo: una difesa della qualità dei nostri prodotti”. L’evoluzione è recente e la racconta Hocine Difallah mentre ci accompagna nella sua azienda: “Durante l’epoca del terrorismo (gli anni Novanta ndr) l’apicoltura tradizionale ha visto un crollo: la gente scappava dalle campagne e abbandonava sia l’agricoltura sia le api. Ma dal Duemila in avanti, quando le cose hanno iniziato a cambiare, qualcosa si è mosso. Molti giovani hanno visto che col miele si poteva vivere ma anche che bisognava cambiare metodi e mentalità”. Hocine vive del miele e con lui altre tre famiglie. Ma si è “modernizzato”: nella sua azienda si prepara il polline, la pappa reale e si selezionano le “regine” che altri produttori vengono a comprare. C’è una filiera che comprende macchine per smielare ma anche un piccolo laboratorio dove il prodotto viene monitorato con attenzione. Se ne occupa Hassan, suo fratello, che tiene un libro mastro dove ogni arnia (son più di 700) ha un numero, una storia, una funzione. E il risultato si sente.
Hocine, Mohammed, Tahar – così come Jamal Bouazria che sta nella piana di Mitidja o Lounis Touati in Cabilia o ancora Hatem Ait Ali alle porte di Algeri – sono dunque una generazione di apicoltori che sta inaugurando una nuova stagione. Hanno aderito a un progetto promosso da APIMED, un’associazione che rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e che ha promosso la “Carta dei mieli del Mediterraneo” con standard in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiane. Il progetto si chiama Mediterranean CooBEEration ed è finanziato dall’Unione europea in partnership con altri soggetti tra cui il programma Art di Undp. Ma il suo cuore è in Umbria. E’ un’idea nata diversi anni fa nella testa di un apicultore, Vincenzo Panettieri, e che ha trovato il sostegno di Felcos Umbria, un fondo di Enti locali per la cooperazione decentrata. Attraverso quel progetto gli apicoltori algerini hanno avuto accesso a corsi di formazione e a una coscienza del loro lavoro che si è formata con la collaborazione di università e centri di ricerca sia in Europa (l’Università di Torino ad esempio) sia in altri Paesi del Mediterraneo (la Tunisia o la Grecia). Chissà che il miele di jujubier algerino non arrivi un giorno anche sulle nostre tavole.
Questo articolo è uscito su Repubblica Online.
Rohingya: espulsione senza ritorno
 |
| Un’immagine di Mahmud Hossain dal servizio realizzato per Al Jazeera a Cox Bazar (Bangladesh) che si può vedere qui |
Chi ha dovuto lasciare le proprie case in Myanmar per cercare fortuna (e sopravvivenza) altrove potrebbe non poter mai più far ritorno a casa. Lo sostiene Yanghee Lee, UN special rapporteur on human rights in Myanmar, davanti all’UN rights Council di Ginevra. Quella dei Rohingya non è dunque una punizione temporanea ma un’espulsione totale o almeno un tentativo di farla. Lee chiede un intervento urgente e vorrebbe l’istituzione di una Commissione d’inchiesta ma il suo allarme sembra cadere nel vuoto. Le reazioni al suo rapporto, ha detto lei stessa ai cornisti, ha ricevuto reazioni tiepide per il difficile equilibrio tra potere militare e civile in Myanmar e per l’effetto destabilizzante che i risultati di un’inchiesta potrebbe avere.
Un business dal cuore umano
 Il dibattito sul modello di sviluppo sta conoscendo una crescita febbrile. In America impazza inclusive capitalism, che ad alcuni sembra un nuovo modo di intendere la responsabilità d’impresa e ad altri sembra il belletto su un sistema in crisi specie dopo che, da produttore di merci, ha iniziato a fabbricare spazzatura finanziaria tossica. L’Ocse ci ha provato, sin dagli anni Settanta, che normative e regole che però sono appunto regole: non cambiano né il sistema di produrre, né la logica del profitto, anima e bestia nera del capitalismo. Un gruppo di ricercatori del Global Forum on Law Justice and Development, un organismo che fa capo alla Banca Mondiale, ha messo a punto qualcosa di diverso. Un progetto solo teorico per ora ma il cui nome già ne racconta l’essenza: “Human-Centered Business Model” è infatti un modello d’impresa centrato sull’essere umano e non (solo) sul profitto. E’ stato presentato alla World Bank a porte chiuse nel dicembre scorso e poi a Roma, in febbraio, al pubblico internazionale. Nella bella cornice di Palazzo Aldobrandini, sede di Unidroit uno dei partner dell’iniziativa.
Il dibattito sul modello di sviluppo sta conoscendo una crescita febbrile. In America impazza inclusive capitalism, che ad alcuni sembra un nuovo modo di intendere la responsabilità d’impresa e ad altri sembra il belletto su un sistema in crisi specie dopo che, da produttore di merci, ha iniziato a fabbricare spazzatura finanziaria tossica. L’Ocse ci ha provato, sin dagli anni Settanta, che normative e regole che però sono appunto regole: non cambiano né il sistema di produrre, né la logica del profitto, anima e bestia nera del capitalismo. Un gruppo di ricercatori del Global Forum on Law Justice and Development, un organismo che fa capo alla Banca Mondiale, ha messo a punto qualcosa di diverso. Un progetto solo teorico per ora ma il cui nome già ne racconta l’essenza: “Human-Centered Business Model” è infatti un modello d’impresa centrato sull’essere umano e non (solo) sul profitto. E’ stato presentato alla World Bank a porte chiuse nel dicembre scorso e poi a Roma, in febbraio, al pubblico internazionale. Nella bella cornice di Palazzo Aldobrandini, sede di Unidroit uno dei partner dell’iniziativa.
Il Progetto. Lo spiega Marco Nicoli, uno dei suoi ideatori: il progetto intende contribuire a sviluppare, per poi sperimentare sul campo, un nuovo modello d’impresa economicamente sostenibile, rispettoso dei diritti umani, dell’ambiente e delle comunità locali in cui s’inserisce. L’idea è quella di fornire una risposta concreta a quegli imprenditori che vogliano lavorare in modo etico e sostenibile e che non trovano risposta nei modelli economico/giuridici e nei meccanismi di mercato esistenti. Il nuovo modello d’impresa che il progetto vuol definire – a differenza di altre soluzioni unicamente “profit” – comprende caratteristiche comuni sia al settore profit sia a quello non-profit. Rispetto al modello profit, continua Nicoli, aggiunge obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Rispetto al non-profit prevede invece una forte identità attraverso un insieme comune di obiettivi d’impresa e misuratori di risultato. Ma la grande differenza tra le regole e le regolette per rendere più etiche le aziende sta nel fatto che il Progetto propone un nuovo modo di essere impresa sin dalla nascita. Una nascita non sotto il segno del profitto ma dove il profitto e’ solo una parte del tutto.
Un ecosistema d’impresa. Dal punto di vista operativo, intende identificare – in un ecosistema d’impresa – nuovi obiettivi e strumenti ossia nuove forme di governance, sistemi di finanziamento specifici o l’adattamento di quelli esistenti. Ma anche particolari strutture di tassazion
Il progetto in sei pilastri
Il Progetto si struttura attorno a sei pilastri (“Pillars”) che ne costituiscono le linee guida, una specie di statuto per queste nuove imprese
1 – “Guiding Principles” si occuperà dei principi, nel campo del funzionamento delle imprese centrate sull’essere umano, per guidare le imprese che vogliano produrre nel rispetto degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile.
2 – “Legal Framework and Corporate Governance” si occuperà di delineare (proponendone una disciplina) nuove forme giuridiche e di governo delle imprese.
3 – “Financial” elaborerà modalità innovative di finanziamento che possano sostenere le imprese che adottano questo modello.
4 – “Fiscal” proporrà soluzioni fiscali che riconoscano i costi aggiuntivi sostenuti da tali imprese virtuose ed incentivino il loro funzionamento socialmente e ambientalmente responsabile.
5 – “Procurement” presenterà politiche d’impresa e forme agevolate di acquisti pubblici, nel rispetto della concorrenza, premiando le imprese rispettose della legalità, e degli standard ambientali ed etici.
6 – “Capacity Building and Mentoring Support” si occuperà infine di iniziative formative e sistemi di sostegno tecnico specializzati.
Ascolta la trasmissione di oggi su Radio Vaticana
Mario Dondero, semplicemente fotografo
 |
| Algeria 1986 “Il lettore”, una delle mie immagini preferite |
Essenziale e schiva come il personaggio di cui parla, la copertina del catalogo della mostra che si è aperta ieri a Bergamo alla Galleria Ceribelli, racchiude un volume prezioso e anche alcuni inediti di Mario Dondero, scomparso un anno fa – ça va sans dire – troppo presto. Lo dico perché le mostre fotografiche mi distraggono o meglio, mi distrae la gente, i commenti, i saluti che vi si fanno intorno. Anzi, direi che alle inaugurazioni vado per quello: incontrare e rivedere le persone che conosco e conoscerne di nuove, l’attività umana più fertile che esista, come Mario sapeva assai bene. Distratto dal vocio, dai pasticcini o dagli affetti – o ancora da qualche viso che suscita un’immediata curiosità o da un’assenza che segna un vuoto – ho visto più che guardato le immagini di Mario, molte delle quali conosco già. Ma a casa, con calma, caffè e toscano e la silente compagnia del mio amatissimo cane, ecco che il catalogo restituisce il lavoro e l’essenza della mostra: il lavoro di Mario ovviamente – ben stampato in Francia e tecnicamente organizzato da Philippe Bretelle per SilvanaEditoriale – ma anche di tutte le persone che hanno contribuito alla scelta e alle chiavi di lettura: la figlia Maddalena, Tatiana Agliani, Walter Guadagnini per non dire di Arialdo Ceribelli, uomo generoso e attento, di una squisita eleganza umana che molto piaceva a Mario (che me lo fece conoscere) e che è lo schivo architetto di questa operazione.
La scelta delle foto ripercorre la vita fotografica di Mario con ripescaggi attenti e singolari: molte cose si conoscono, altre meno, altre ancora si eran mai viste. Lavoro che si deve alle scelte di Maddalena e Tatiana, alla Fototeca di Altidona e all’inesauribile passione di Pacifico D’Ercoli e del suo staff (stiamo parlando di 350-400mila scatti!!!!). Rubo qui e là qualche brano dalle introduzioni che mi ha colpito: “Mario – scrive Maddalena Fossati Dondero – è stato un padre difficile, assente, luminoso, leggendario e itinerante e non sono sicura che questi aggettivi siano nell’ordine giusto”.
“E’ per questo – scrive Guadagnini – che Dondero è potuto apparire a tratti come un fotografo senza stile, mentre forse è stato, proprio come voleva il manifesto di alcuni suoi colleghi, contro lo stile“.
“Dai fotogrammi 35mm dei provini a contatto – suggerisce Agliani – dalle campiture nere e bianche di negativi ancora non provinati, osservati in trasparenza davanti alla luce di una finestra, si delineano gli orizzonti etici, morali, politici, la sensibilità e la poetica di un uomo che è stato un irriducibile esponente e interprete di quell’impegno civile, di quella tensione morale che ha segnato il pensiero del secondo Novecento”. Fa vedere, guardare, leggere.
Alcune immagini della mostra e un bell’articolo di Marco Belpoliti potete vedere e leggere qui
Mario Dondero a Bergamo (sabato 11 marzo)
Attacco al “nemico vicino”
 Lo Stato islamico in Afghanistan cambia strategia. Per scippare la scena ai talebani. Trenta morti all’ospedale militare di Kabul ( a dx in un’immagine di Tolonews)
Lo Stato islamico in Afghanistan cambia strategia. Per scippare la scena ai talebani. Trenta morti all’ospedale militare di Kabul ( a dx in un’immagine di Tolonews)
Sono le nove del mattino davanti all’ospedale militare Daud Khan, uno dei nosocomi più grandi della capitale con 400 posti letto e una sede nel cuore di Kabul, poco distante dal quartiere generale Nato e dall’ambasciata Usa. Un uomo si fa esplodere e consente così ad altri tre del commando di farsi strada nell’ospedale. Sono vestiti da paramedici e dunque, fino a quel momento, non hanno dato nell’occhio. Appena entrati iniziano a sparare su dottori, pazienti, tecnici e su chiunque si aggiri nei corridoi: oltre 40 vittime e decine di feriti. La gente cerca rifugio sul tetto e c’è chi salta dai piani alti per salvarsi. Alla fine, e sono ormai oltre le tre del pomeriggio, le forze di sicurezza hanno ragione del commando che si è ritirato sul tetto. Ma non sono talebani. Questa volta, con un’azione militare eclatante e in un edifico simbolico, la rivendicazione – sul sito di Amaq – è dello Stato islamico. E’ un salto di qualità. Uno schiaffo alla Nato e all’esercito afgano, al presidente Ghani ma anche alla guerriglia talebana cui ora il Califfato cerca di levare il primato nella guerra. La Croce rossa internazionale – già entrata nel mirino del Califfato anche in Afghanistan – denuncia l’ennesimo crimine contro l’umanità e la violazione di ogni regola umanitaria che impedisce di colpire gli ospedali.
C’è una scelta strategica nuova. Non più – o non solo – sparare nel mucchio di “takfir”, dei musulmani devianti come sono per Al Bagdadi sciiti, sufi o minoranze: è un’azione di guerra militare che si accoppia alle stragi finora condotte soprattutto contro chi non segue la corretta via delle scritture così come i salafiti le interpretano. I talebani sono costretti a prender subito le distanze: la guerriglia in turbante di mullah Akhundzada, dove c’è chi guarda anche al negoziato politico, viene spinta tra i “revisionisti”, tra gli incapaci non solo di seguire correttamente il Corano ma nemmeno più di avere la supremazia nella guerra di liberazione. Che per i talebani è guerra all’invasore e per Al Bagdadi guerra ai “crociati”.
La tecnica è quella del terrore puro come raccontano i resoconti di medici e pazienti. Una tecnica che lo Stato islamico associa alle stragi di sciiti di cui ha già nel carniere un buon numero. Ma questa è però la prima grossa azione militare “pura” dove il nemico è lo stesso che combattono i talebani per i quali, invece, gli sciiti sono sì dei devianti ma non devono essere colpiti. Fu proprio sull’atteggiamento da tenere con gli sciiti che maturarono le prime divisioni tra l’allora giovanissimo militante giordano al Zarkawi e Osama bin Laden che guardava con sospetto questa brillante recluta di Al Qaeda che però stava già maturando un progetto diverso. Progetto che applicherà poi in Medio Oriente preparando la strada al suo allievo più capace: Abu Bakr Al Bagdadi. Ora che il Califfo è in difficoltà sulle strade mediorientali e nelle città di cui perde i pezzi ecco che la guerra si sposta altrove e con altri metodi. Attaccando comunque (e anche questa è una delle linee guida di Al Bagdad) il “nemico vicino” ossia l‘esercito afgano, ancor più colpevole dei suoi alleati crociati.
Come reagiranno adesso governo e alleati è difficile dire. I talebani serreranno i ranghi perché non possono consentire che il vessillo della liberazione del Paese venga scippato dagli “stranieri” del Califfo. E forse gli americani manterranno la promessa di un aumento consistente delle truppe come vorrebbe, e Trump potrebbe ascoltarlo, il generale Nicholson che comanda Usa e Nato nel Paese. Ma i bombardamenti continui, che sono la nuova tattica americana, non hanno per ora prodotto che più vittime civili né hanno allontanato la sfida del Califfo che intanto – nemico comune di governo, alleati, talebani e qaedisti – dimostra di avere la forza per colpire.
Donderiana: a Bergamo l’11 marzo
 A poco più di un anno dalla scomparsa di Mario Dondero, la mostra propone un viaggio nella
A poco più di un anno dalla scomparsa di Mario Dondero, la mostra propone un viaggio nella
poetica e nell’universo di storie raccontate da questo fotografo, inguaribile freelance che ha da sempre rifiutato il legame stabile con un giornale per viaggiare e raccontare il mondo in totale libertà.
La mostra – spiegano alla Galleria di Arialdo Ceribelli, grande amico e sostenitore di Mario – intreccia momenti e aspetti del suo suo lungo percorso di vita: l’appassionante ritratto costruito negli anni sul mondo della cultura europea del secondo Novecento, con la sua ricchezza di idee, il fermento di sperimentazioni e la tensione morale che lo attraversa, a Roma, a Milano, a Parigi, come a Londra; le immagini di importanti momenti storici come il maggio francese, la caduta del muro di Berlino, i conflitti del Medio Oriente, ma soprattutto il racconto della “storia minuta”, della vita quotidiana della gente comune. , la vita che scorre per tutti”, come scriveva Dondero. Ecco allora le fotografie dei villaggi del Mali, del Senegal, del Niger, dove Dondero torna ripetutamente soprattutto nel corso degli anni settanta, delle famiglie contadine in Portogallo, Italia, Spagna, di Cuba, negli anni più duri dell’embargo, della vita nella Russia di Putin. Volti, ritratti di uo mini e donne, frammenti di vite che ci guardano e ci parlano attraverso l’obiettivo del fotografo, coinvolgendoci nel dialogo appassionato che Mario Dondero ha intessuto per tutta la sua vita con il mondo e la realtà.
GALLERIA CERIBELLI
MARIO DONDERO
un uomo, un racconto
11 MARZO – 13 MAGGIO 2017
Catalogo in galleria, testi di Walter Guadagnini, Tatiana Agliani Lucas.
Galleria Ceribelli – Via San Tomaso 86 – 24121 Bergamo tel.035 231332
Orario 10.00-12.30 – 16.00 19.30 chiuso domenica e lunedì
www.galleriaceribelli.com – [email protected]
Appuntamenti jihadisti il 1 marzo (a Milano)

————— Milano ore 18 ——
Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda
domani a 1 marzo, 2017@18:00–19:30
un libro di i Giuliano Battiston
Quartiere Isola, in via Carmagnola 4 angolo via Pepe.
con Andrea Carati, Università degli Studi di Milano
Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore freelance
Emanuele Giordana, giornalista e saggista
ed Elisa Giunchi, Università degli Studi di Milano
Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore freelance, scrive per quotidiani e periodici tra cui “l’Espresso”, “il manifesto”, “pagina99” e “Lo straniero”. Esperto di Afghanistan, si occupa di islamismo armato, politica internazionale e globalizzazione. Per le edizioni dell’Asino ha pubblicato i libri-intervista Zygmunt Bauman. Modernità e globalizzazione (2009) e Per un’altra globalizzazione (2010).
—————– …più tardi a Seregno ————-
Incontro “Dentro il Jihadistan”
Perchè l’islam, non è il nemico
1 marzo 2017
Sala Minoretti
Circolo Culturale San Giuseppe
Via Cavour 25, Seregno
L’incontro verrà introdotto da Alberto Rossi (Pres. Il Caffè Geopolitico), e moderato in maniera
attiva da Lorenzo Nannetti (Resp. Scientifico Il Caffè Geopolitico).
Relatori: Emanuele Giordana (Giornalista e scrittore) e Arturo Varvelli (Analista, ISPI)
Gli orari verranno gestiti in maniera flessibile dai relatori e dal moderatore
21.00 – 21.15 Presentazioni e introduzione ospiti (A. Rossi)
21.15 – 22.15 interventi (circa 25 minuti totali per relatore)
Moderatore della serata sarà Alberto Rossi
La sala dove si svolge l’incontro è all’interno di una zona chiusa al traffico, è possibile parcheggiare
comunque nei pressi di via Cavour, nei pressi dell’incrocio con Corso Matteotti.
Talebani confermano: ucciso il "liberatore" di Kunduz
Un lungo comunicato ufficiale dei talebani ha confermato oggi la morte di Al-Haj Mullah Abdul Salam Akhund, ucciso da un drone il 26 febbraio scorso nel distretto di Dasht-e-Archi (Kunduz). Otto guerriglieri sono stati uccisi con llui.
Il sito della guerriglia dedica ampio spazio, numerosi elogi e un’immagine (a destra) al martirio dell’uomo che i talebani chiamano il “liberatore di Kunduz”. Governatore ombra della provincia del Nord, si deve infatti a lui la presa per due volte della città. Per il governo e i suoi alleati (la paternità dell’azione è americana) è un colpo importante che potrebbe riflettersi sul morale della truppa in turbante.
Logiche di mercato: scatti con velo cercasi
 Spesso si pensa che non ci sia nulla di più vero di una fotografia, lo scatto che immortala un momento e che fa della cronaca realtà. Più della parola scritta, che immagini tutt’al più suggerisce, e meglio della televisione che ormai, lo sanno anche i bambini, è quanto di più artefatto esista. Ho fatto questa prima riflessione in Bangladesh sul confine birmano. Mi aveva colpito l’immenso numero di donne velate che affollano le campagna bangladese ma, arrivato ai campi profughi dei rohyngya, immaginavo di vederne senza velo perché tutte le foto che avevo guardato le dipingevano così, come mostra l’immagine postata sopra a sinistra. Donne svelate però non ne vedo nemmeno nel centro sanitario di Msf. Chiedo lumi: come posso riconoscere una donna o un uomo rohingya? In nessun modo, mi risponde uno del team. Nemmeno noi del Bangladesh, mi dice, le distinguiamo poiché sono del tutto simili a noialtri. Dal che discendono due cose: la prima è l’affinità strettissima tra le due comunità divise, solo per convenzione, da una frontiera. La seconda è che le donne son velate. Come le loro colleghe del Bangladesh.
Spesso si pensa che non ci sia nulla di più vero di una fotografia, lo scatto che immortala un momento e che fa della cronaca realtà. Più della parola scritta, che immagini tutt’al più suggerisce, e meglio della televisione che ormai, lo sanno anche i bambini, è quanto di più artefatto esista. Ho fatto questa prima riflessione in Bangladesh sul confine birmano. Mi aveva colpito l’immenso numero di donne velate che affollano le campagna bangladese ma, arrivato ai campi profughi dei rohyngya, immaginavo di vederne senza velo perché tutte le foto che avevo guardato le dipingevano così, come mostra l’immagine postata sopra a sinistra. Donne svelate però non ne vedo nemmeno nel centro sanitario di Msf. Chiedo lumi: come posso riconoscere una donna o un uomo rohingya? In nessun modo, mi risponde uno del team. Nemmeno noi del Bangladesh, mi dice, le distinguiamo poiché sono del tutto simili a noialtri. Dal che discendono due cose: la prima è l’affinità strettissima tra le due comunità divise, solo per convenzione, da una frontiera. La seconda è che le donne son velate. Come le loro colleghe del Bangladesh.
Ed ecco (foto a destra) che vedo pubblicata un’immagine di rohingya col velo. La prima! E perché ? L‘articolo che la ospita è dedicato all’estremismo radicale islamico tra i rohingya del Myanmar e dunque il velo è di rigore. In poche parole, se serve svelata (commuove di più, appare più simile a noi) eccola senza velo. Se serve invece a farci paura (anche li, tra quei poveretti, c’è la terribile spada vendicatrice dell’islam) eccola velata. E con tanto di niqab (diffusissimo per latro nelle campagne del Bangladesh che ho visto).
Dove sta la verità? Non lo so ma non certo negli scatti che ho visto. O meglio, è una verità parziale, tanto quanto quello che scrivo io. E segue la logica di mercato. Come per altro faccio anch’io cannando in pieno, visto che ho i miei pezzi nel cassetto: a gran parte della stampa del mio Paese non interessano. Forse però con una bella immagine di donna col niqab e un articolo un tantino allarmista… chissà. Scatti con velo cercasi.
Pakistan contabilità del terrore
 |
| Jinnah, il fondatore del Pakistan. Musulmano ma non integralista |
Il bilancio dell’ultimo attacco terroristico in Pakistan è ancora incerto: cinque le vittime secondo alcune fonti, sette secondo altre. Quel che è certo è che i tre attentatori della Jamaat-ul-Ahraar (JuA) – una fazione che si è scissa nel 2014 dal fronte dei talebani pachistani del Tehreek-e-Taleban (Ttp) – volevano compiere una strage e ci sono riusciti solo in parte.
L’obiettivo, come già in passato, è un tribunale di Charsadda, una cittadina capoluogo di distretto a una trentina di chilometri da Peshawar, capitale della provincia del Khyber Pakhtunkhwa, e vicina al confine con l’Afghanistan. Secondo le prime ricostruzioni, i tre attentatori si sono avvicinati come normali cittadini al tribunale ma appena il primo militante è stato fermato dagli agenti, ha lanciato una granata. E’ stato ucciso subito dopo. Stressa fine per il secondo, freddato sull’ingresso mentre il terzo è riuscito a farsi esplodere. In totale i kamikaze hanno potuto comunque lanciare sei granate ma senza riuscire però a mettere a segno la strage che dovevano avere in animo se fossero entrati nella corte di giustizia, affollata di avvocati e civili.
 |
| Bacha Khan con Gandhi. Pacifisti Sotto: arte del gandhara |
Charsadda non è nuova ad attacchi terroristici: un’altra corte di giustizia era entrata nel mirino nel marzo scorso quando un suicida – sempre di Jamaat-ul-Ahraar – era riuscito a farsi esplodere dentro il tribunale. Nel gennaio 2016 invece, l’Università Bacha Khan di Charsadda era stata l’obiettivo dell’attacco di un commando che aveva gettato nel panico i duecento studenti dell’ateneo dedicato a una nobile figura del pacifismo pashtun (Bacha Khan, appunto, noto anche come “Il Gandhi della Frontiera”). Allora i morti furono 22 e l’attacco venne rivendicato dalla Tariq Geedar Afridi, una fazione del Ttp, il cui vertice aveva però poi smentito di aver dato luce verde alla strage.
Charsadda è uno dei tanti luoghi simbolo di un Paese con una storia complessa e antica alle spalle: non solo Charsadda ha dedicato una scuola a un pacifista che usava il Corano come strumento di pace ma è anche il luogo che ospita le rovine dell’antico sito di Pushkalavati – la Città del loto – capitale del regno del Gandhara dal sesto secolo Ac al secondo Dc. Secondo il Ramayana, testo sacro hindu, il nome deriva dal fondatore Pushkala, figlio di Bharat e nipote di Rama. Fu una città zoroastriana, animista e in seguito buddista. E’ una delle culle – con l’Afghanistan – della civiltà greco-buddista e cioè dell’antichissimo legame tra Oriente e Occidente. Ha dunque tutti i requisiti per essere in odio all’islamismo più radicale che, per non farsi mancare nulla, ha aggiunto la supposta apostasia di Bacha Khan, un uomo che forse solo i soldati britannici avevano odiato di più (era contrario tra l’altro alla spartizione del Raj tra India e Pakistan).
Tutto farebbe pensare a un’azione dello Stato islamico cui la JuA (Assemblea della fede) aveva inizialmente garantito il suo sostegno nell’agosto del 2014 salvo poi nel marzo 2015 – ma è difficile seguire le geometrie variabili della galassia jihadista – tornare sotto il cappello del Ttp. E’ invece da imputarsi allo Stato islamico – che l’ha rivendicata – la strage di giovedi scorso al tempio sufi di Lal Shahbaz Qalander, a Sehwan, nel Sindh, con un bilancio che potrebbe arrivare a contare 90 morti e che ha fatto reagire con veemenza gli alti comandi dell’esercito, ora sotto la guida del generale Qamar Javed Bajwa che, tanto per cambiare, ha accusato l’Afghanistan di essere il retrovia per le operazioni del Califfo. La reazione si è risolta anche nella chiusura della frontiera afgano pachistana con l’ordine di “sparare a vista” e in un momento di altissima tensione tra i due Paesi, dal momento che Islamabad sta espellendo un milione di afgani “indocumentati” (ma in molti casi con lo status di rifugiati) e ne ha già mandati in Afghanistan 600mila. Quanto al quadro interno, la cronaca racconta di oltre cento morti nel solo giro di dieci giorni: il 13 febbraio un kamikaze del Ttp uccide a Lahore 13 persone. Lo stesso giorno due sminatori vengono uccisi a Quetta. Il 15 JuA firma un attentato kamikaze nell’agenzia tribale di Mohmand uccidendo cinque persone mentre a Peshawar il Ttp cerca di uccidere un giudice ma fredda il suo autista. Il 16 febbraio, govedi, è la volta del tempio sufi di Lal Shahbaz Qalandar, nel Sud del Paese mentre un Ied (bomba sporca) uccide nel Belucistan tre agenti della sicurezza. Ieri Charsadda.
Vale la pena di notare, al di là dei numeri, che la violenza politica (non sempre e solo attribuibile ai talebani e ai loro sodali più o meno alleati) si è ormai espansa a macchia d’olio in tutto il Paese e che la promessa del pugno di ferro con i gruppi islamisti – a lungo coccolati da governi e servizi – è tardiva. Dopo una macabra luna di miele forse definitivamente tramontata.
Questo articolo è uscito oggi su il manifesto
Frontiere e terrore: "sparate a vista"
 Dopo la strage di venerdi scorso al tempio sufi di Lal Shahbaz nel Sindh (il bilancio attuale dice che
Dopo la strage di venerdi scorso al tempio sufi di Lal Shahbaz nel Sindh (il bilancio attuale dice che
le vittime sono già 90 con 340 feriti) le autorità pachistane hanno chiuso la frontiera con l’Afghanistan sul passo Khyber: la “Porta dell’amicizia”, per dirla tutta. Una misura comprensibile anche se un terrorista può benissimo scegliere altra strade (l’attentato è stato rivendicato dallo Stato islamico).
Ma quel che invece non si capisce è l’ordine di “sparare a vista” che le autorità di Islamabad hanno dato alle proprio forze dell’ordine di guardia al passo. Non si capisce se non come un’ulteriore escalation nelle incomprensioni (per usare un eufemismo) tra i due Paesi. Il Pakistan fa la faccia dura mentre da quella frontiera ha già espulso 600mila afgani. Se uno cercasse di tornare indietro? “Sparate a vista”-
La guerra infinita. Espulsi dal Pakistan e sotto le bombe degli alleati
 Espulsi dal Pakistan in 6oomila in un Paese – il loro, che in molti non vedono da quarant’anni o non hanno mai visto – dove l’ennesimo raid aereo della coalizione alleata al governo di Kabul ha ucciso almeno 18 persone. Civili. In maggioranza donne e bambini.
Espulsi dal Pakistan in 6oomila in un Paese – il loro, che in molti non vedono da quarant’anni o non hanno mai visto – dove l’ennesimo raid aereo della coalizione alleata al governo di Kabul ha ucciso almeno 18 persone. Civili. In maggioranza donne e bambini.
Tra le due notizie, che hanno un tragico nesso, è difficile stabilire qual è la più grave: da una parte il Pakistan continua il suo programma di rimpatrio forzato di un milione di afgani, dall’altro, in Afghanistan, si continua a morire mentre il comandante della Nato e delle truppe Usa nel Paese, il generale statunitense John Nicholson, invoca più truppe – Nato e americane – e accusa Russia e Iran di appoggiare i talebani. Il risultato è quello di un innalzamento dei toni in questa guerra silente che nel 2016 ha mietuto più vittime da quando la missione Onu a Kabul (Unama) ha iniziato nel 2009 a tenerne il bilancio.
Ed è proprio un rapporto preliminare di Unama ad esprimere «grave preoccupazione» per i raid aerei che, tra il 9 e il 10 febbraio, avrebbero ucciso almeno 18 persone nel distretto di Sangin (Helmand); Resolute Support, la missione Nato in Afghanistan, avrebbe aperto un’inchiesta. Altre sette civili sarebbero invece stati uccisi dai talebani l’11 febbraio durante un attacco a militari afgani a Lashkargah, capitale della provincia. Sangin è una delle aree più guerreggiate e nel solo 2016 l’Helmand ha visto morire 891 civili, una delle percentuali più elevate della guerra. In un Paese dove l’anno scorso le vittime civili sono state oltre 11mila: 3512 morti (tra cui 923 bambini) e 7.920 feriti (di cui 2.589 bambini) con un aumento del 24% rispetto al periodo precedente.

Secondo Unama il raid è stato condotto da forze internazionali ma un ufficiale Usa confida ad Al Jazeera che i raid aerei sono peculiarità americana. Un altro funzionario afgano dice invece che i morti sarebbero molto più di 18, dopo un attacco iniziato alle tre del mattino (la stessa ora del famoso raid di Kunduz sull’ospedale di Msf) con un bombardamento «indiscriminato» in un’area densamente abitata. I raid della scorsa settimana in Helmand sarebbero stati una trentina. Nel suo ultimo rapporto sulle vittime civili, Unama indicava che i bombardamenti aerei – afgani e internazionali – sono responsabili del 5% delle vittime nel 2016 ma, rispetto al 2015, la cifra è raddoppiata: 250 morti e 340 feriti, il bilancio più elevato dal 2009. Forse per difetto.
E’ questo dunque il Paese della guerra infinita dove stanno tornando i rifugiati afgani che, dalla guerra contro l’Urss negli anni Ottanta, avevano cercato asilo nel Paese vicino. Ieri Human Rights Watch – la campagna di monitoraggio internazionale – ha denunciato che la campagna di espulsioni, iniziata nel luglio scorso, è già arrivata a quota 600mila e ha diffuso un video – con testimonianze agghiaccianti e postato qui sotto – di quest’esodo di massa che Islamabad vorrebbe completato in pochi mesi sino a raggiungere un milione di espulsi.
(a sinistra nell’immagine, un grafico che mostra il flusso di profughi afgani espulsi dalle autorità pachistane dal 2009. Fonte Hrw).
Ma il fatto già grave di per sé, lo è ancora di più dal momento che tra questi 600mila – in teoria afgani senza documenti quindi “illegali” – ci sarebbero 365mila profughi con lo status di rifugiati: «La più ampia campagna di espulsione di rifugiati – dice Hrw – degli ultimi anni». In un rapporto di 76 pagine – Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees – si documentano gli abusi di Islamabad ma anche «il ruolo dell’Unhcr nel promuovere l’esodo … che ne fa un complice degli abusi pachistani». L’Unhcr avrebbe pattuito 400 dollari a testa per “ritorni volontari” ma, dice Hrw, in una situazione di completa insicurezza. La stessa che si trovano ad affrontare gli afgani espulsi dall’Europa.
Intanto è stata resa nota la terza iniziativa russa sull’Afghanistan, che si tiene a Mosca il 15 febbraio: è un incontro tra India, Russia, Iran, Pakistan, Cina e Afghanistan. E’ il secondo incontro ma al primo Kabul non era stata invitata. Sebbene i rapporti tra Trump e Putin sembrino ottimi, la notizia ha sollevato le ire americane, in particolare del generale Nicholson che, qualche giorno fa, ha detto al Congresso che Iran e Russia sostengono i talebani e che Mosca sta lavorando a «legittimarli». Il generale ha anche detto, riportava la stampa afgana, che occorrono più truppe perché la guerra in Afghanistan è a un punto morto e, per rompere il cerchio, dovrebbero essere dispiegati in Afghanistan migliaia di nuovi soldati americani e della Nato. Trump, che ha appena avuto una seconda telefonata col presidente afgano Ghani – e che in campagna elettorale era per il ritiro – potrebbe ascoltarlo.
Great Game a Teatro. Da non perdere
 |
| Otima regia e bravi attori |
Se per caso abitate a Modena e avete perso a Milano
l’appuntamento
(che si ripeterà pèerò a Napoli), non fatevi sfuggire “Afghanistan: il grande gioco” in scena alle Passioni Eventi nella città emiliana. Lo spettacolo, tratto in gran parte ma non solo dal classico di Hopkirk, vale quel che promette. Bravi attori, ottima regia, ricostruzione rigorosa e prima puntata di due, la seconda delle quali si aspetta con desiderio. Ho visto lo spettacolo a Milano e, a parte qualche piccolo segmento che non mi ha convinto, ne sono uscito entusiasta. E’ diviso in cinque episodi: il primo (e il meno convincente) riguarda la prima guerra anglo afgana. Il secondo (eccellente) il negoziato per la frontiera (bravissimi i due attori), il terzo le vicende intime di re Amanullah e la moglie Soraya al momento dell’esilio (con un’ottimo equilibrio tra fantasia e storia), il quarto la Cia, i pachistani e i mujahedin e l’ultimo, la fine di Najibullah (ottimi entrambi). Davvero un bel lavoro con un’unica minore sbavatura: i costumi. Marocchini e non afgani. E quando in Pakistan i due protagonisti bevono il te…è il classico te alla menta di Tangeri con tanto di bicchiere e teiera marocchine anziché, obviously, te al latte in tazza. Sciocchezze. Compensate dal cappello dell’emiro Abdur Rahman, un “karakuli” molto particolare svasato in alto e normalmente introvabile. Spettacolo da non perdere per gli amanti del genere e non solo. Il te si può fare a casa.
“Afghanistan: il grande gioco” in scena alle Passioni (Modena)
Dal 07/02/2017 al 18/02/2017
di Stephen Jeffreys, Ron Hutchinson, Joy Wilkinson, Lee Blessing, David Greig
regia FERDINANDO BRUNI e ELIO DE CAPITANI
traduzione Lucio De Capitani
con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Leonardo Lidi, Michele Radice, Emilia Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri
scene e costumi Carlo Sala
video Francesco Frongia
luci Nando Frigerio
suono Giuseppe Marzoli
TEATRO DELL’ELFO ED EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
in collaborazione con NAPOLI TEATRO FESTIVAL“
Ma quali negoziati! Più uomini e più bombe
 |
| John Nicholson: muscolare |
Il 15 febbraio si tiene a Mosca, su iniziativa russa, un incontro tra sei nazioni: India, Russia, Iran, Pakistan, Cina e Afghanistan. E’ il terzo incontro sull’Afghanistan ma con una differenza sostanziale: al primo Kabul non era stata invitata. Sebbene i rapporti tra Trump e Putin sembrino ottimi, la notizia ha sollevato le ire americane, in particolare del generale John Nicholson, che comanda le truppe Usa in Afghanistan (10mila) e quelle della missione Nato Resolute Support (4mila).
Nicholson ha detto a un comitato del Congresso che Iran e Russia sostengono i talebani e che Mosca sta lavorando a “legittimarli”. Il che sarebbe una buona notizia che però al generale – responsabile dell’aumento dei raid aerei e delle vittime connesse da che ha preso il comando di Resolute Support (febbraio 2016) – non piace. Ha anzi detto, riporta sempre la stampa afgana, che occorrono più truppe. Nicholson ha detto nella notte di giovedi scorso, che la guerra in Afghanistan è a un punto morto e che, per rompere il cerchio, migliaia di nuovi soldati americani e della Nato dovrebbero essere dispiegati in Afghanistan. Il vice portavoce del presidente Ashraf Ghani, Shahhussain Murtazawi ha aggiunto che venerdi Ghani e Trump si sono parlati al telefono pèer la seconda volta e hanno discusso i modi per combattere i terroristi. Dopo che Trump si era dichiarato contrario a impiegare uomini e mezzi nel Paese, ora la musica potrebbe cambiare. La scarsa lungimiranza politica di Trump potrebbe prestare orecchie a Nicholson i cui risultati nella guerra al terrore si possono leggere nell’ultimo rapporto Onu sulle vittime civili.
Dondero tra Milano e Parigi
| Mario negli studi di Radio3. Foto di Mario Boccia |
Grazie agli archivi di Mario Dondero custoditi e selezionati al Centro di Altidona, una nuova mostra rene omaggio al grande fotografo e amico scomparso nel dicembre del 2015. A Parigi, con un’esposizione aperta al pubblico fino a lunedì 27 febbraio all’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Castaldi Partners.
A ospitare gli scatti di Dondero i saloni dell’Hôtel de Galliffet: situati tra Rue de Varenne 50 e rue de Grenelle 73, nel VII arrondissement, sono la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. “Dondero – Milano/Parigi” raccoglie una selezione di un centinaio di foto di Mario in bianco e nero, scattate nel 2010 nelle due città in cui l’autore ha abitato e lavorato: Milano e Parigi.
Una rosa e una spina a Kabul per il presidente
 Ci sono anche una rosa e una spina afgani nella nuova amministrazione americana di Donald Trump. La rosa è Ashraf Ghani che Trump ha avuto come professore quando il presidente era esule negli States. L’Afghanistan non figura nella lista dei sette Paesi maledetti e la rituale telefonata tra Trump e Ghani è stata amichevole. Anche perché, benché in campagna elettorale Trump fosse per il disimpegno, adesso le cose sono cambiate. L’Afghanistan e soprattutto il controllo delle sue basi aeree restano un baluardo formidabile in caso di guerra con l’Iran e, comunque, un fortino verso le mire russe, che Putin sia amico o no. Le spine sono invece quelle della guerra infinita e portano il nome “taleban”. L’emirato, che ne dà notizia sul suo sito, ha scritto a Trump una lettera invitandolo a fare le valigie. Dopo 15 anni, scrive la guerriglia in turbante, la lezione è chiara e, conclude il messaggio non senza ironia: «Forse alcuni contenuti di questa lettera si riveleranno amari per il vostro gusto. Ma dal momento che sono realtà e fatti tangibili, devono essere accettati e trattati come una amara medicina che viene assunta dai pazienti per evitare che la loro condizione peggiori».
Ci sono anche una rosa e una spina afgani nella nuova amministrazione americana di Donald Trump. La rosa è Ashraf Ghani che Trump ha avuto come professore quando il presidente era esule negli States. L’Afghanistan non figura nella lista dei sette Paesi maledetti e la rituale telefonata tra Trump e Ghani è stata amichevole. Anche perché, benché in campagna elettorale Trump fosse per il disimpegno, adesso le cose sono cambiate. L’Afghanistan e soprattutto il controllo delle sue basi aeree restano un baluardo formidabile in caso di guerra con l’Iran e, comunque, un fortino verso le mire russe, che Putin sia amico o no. Le spine sono invece quelle della guerra infinita e portano il nome “taleban”. L’emirato, che ne dà notizia sul suo sito, ha scritto a Trump una lettera invitandolo a fare le valigie. Dopo 15 anni, scrive la guerriglia in turbante, la lezione è chiara e, conclude il messaggio non senza ironia: «Forse alcuni contenuti di questa lettera si riveleranno amari per il vostro gusto. Ma dal momento che sono realtà e fatti tangibili, devono essere accettati e trattati come una amara medicina che viene assunta dai pazienti per evitare che la loro condizione peggiori».
La guerra continua, non risparmia nessuno e non si ferma nemmeno durante l’inverno: ieri sei membri dello staff dell’Icrc (il Comitato della Croce rossa, per antonomasia l’organo più neutrale che esista) sono stati uccisi da un uomo armato nella provincia di Jawzian mentre andavano a consegnare aiuti umanitari. Due i dispersi. I talebani hanno smentito un loro coinvolgimento. L’Icrc ha sospeso le attività nel Paese dopo il grave attentato che potrebbe ascriversi a un’impresa dello Stato islamico. Stato islamico che ha rivendicato intanto oggi l’attentato dell’altro ieri quando un kamikaze si è fatto esplodere nel parcheggio della Corte suprema e ha ucciso 21 persone tra cui 17 funzionari del tribunale. I feriti sono una quarantina. Quattro sono cittadini di passaggio. Tutte vittime civili.
Sulle vittime civili Unama, la missione Onu a Kabul, ha pubblicato il suo ultimo rapporto. Il peggiore da che monitora l’andamento della guerra (dal 2009) e un refrain ormai abituale visto che ogni anno sembra peggio del precedente. Il rapporto documenta 11.418 incidenti con vittime civili: 3.498 i morti e 7.920 feriti. Di questi, rispettivamente, i bambini sono 923 e 2.589, con un aumento del 24% rispetto al bilancio precedente più alto. In sostanza, dice il rapporto, i dati del 2016 sono i peggiori in assoluto dal 2009, quando gli incidenti registrati furono “solo” 5.969 (di questi 2.412 i morti e 3.557 i feriti). Da allora il bilancio si è praticamente raddoppiato.
 |
| Vittime civili: raddoppiate dal 2009 (Fonte Unama) |
Unama accusa i talebani di essere responsabili di un terzo degli incidenti contro un quarto imputabile alle forze filogovernative. Il rapporto nota che le battaglie di terra, che spesso avvengono in aree densamente popolate, sono la prima causa di morte e che la seconda sono gli Ied (bombe “sporche”) piazzate dalla guerriglia in luoghi pubblici. I bombardamenti aerei – sia afgani sia internazionali – sono invece responsabili del 5% delle vittime ma, rispetto al 2015, la cifra è raddoppiata: 250 morti e 340 feriti, il bilancio più elevato dal 2009. Va infine notato che, come già ammesso dai funzionari dell’Onu, non è possibile dare conto delle missioni segrete dei droni, gli aerei senza pilota che “selezionano” obiettivi mirati ma molto spesso colpiscono civili. Il bilancio, nemmeno quello ufficiale, non è mai stato messo in chiaro dagli americani (dei droni – anche se ufficialmente solo a scopo ricognitivo – fanno comunque uso tutte le truppe straniere, Italia compresa che ne ha appena comprati da Finmeccanica) nonostante le promesse di Obama (si veda il caso del nostro connazionale Giovanni Lo Porto, il cooperante ucciso da un drone americano in Pakistan nel gennaio del 2015).
I talebani contestano il rapporto: la loro campana dice che il 77,1% degli incidenti si deve alle forze filogovernative e il 12,42% a loro. Un altro 17,48% si deve allo Stato islamico. Un bilancio che secondo Unama è stato di 209 morti e 690 feriti soprattutto tra gli sciiti, gli obiettivi preferiti dal Califfato.
La guerra è finita. Andate in pace
 L’ultimo rapporto di Unama sembra la copia del precedente. Ogni anno che passa vede aumentare le vittime civili. Ma la guerra non era finita?
L’ultimo rapporto di Unama sembra la copia del precedente. Ogni anno che passa vede aumentare le vittime civili. Ma la guerra non era finita?
Nel 2016 ci sono stati 11.418 casi di incidenti che includono, tra i civili, 3512 morti (tra cui 923 bambini) e 7.920 feriti (di cui 2.589 bambini) con un aumento del 24% rispetto al 2015. E’ il bilancio più grave da che nel 2009 Unama ha iniziato a monitorare quanto costa la guerra ai civili afgani. Oltre al conflitto di terra si segnala una potente ripresa di quello dall’aria, imputabile alla Nato o agli Stati Uniti: 250 morti e 340 feriti (come si vede gli aerei uccidono di più) con un aumento del doppio rispetto agli anni precedenti. E manca ovviamente il bilancio dei droni, operazioni coperte su cui gli americani non rilasciano cifre.
L’Afghanistan nel 1972
Devo ad Alessandro De Pascale la segnalazione di questo preziosissimo video, postato su Youtube dal suo autore Vittorio Mangilis che sulle orme di Marco Polo lungo la Via della seta scala arriva a Kabul per scalare il Noshaq (7.400 metri), la vetta più alta vetta del Paese. Un super8 davvero eccezionale
Domenica a Milano il progetto orientale dell’Isis al Salone della Cultura
 |
| L’idea del Califfato in una mappa diffusa da un’organizzazione islamista. Lo Stato islamico ci si è ispirato? |
Sappiamo tutto o quasi del progetto dello Stato islamico di Al Baghdadi per la Siria e l’Irak o per l’espansione del suo progetto in Libia e per l’esportazione del terrore in Europa o in Turchia. Ma esiste un progetto anche per il mondo non arabo? Esiste un progetto di espansione a Est dove il mondo musulmano è più numeroso? Elisa Giunchi (Afghanistan e Pakistan) e Guido Corradi (Indonesia) parleranno degli elementi caratteristici del messaggio del Califfato nell’estremo Est del Sudest asiatico e nell’area della guerra permanente lungo il confine afgano pachistano. Emanuele Giordana coordinerà l’incontro e parlerà dello sviluppo dello Stato islamico in Bangladesh (dove in luglio vennero uccise 23 persone tra cui 17 stranieri di cui 9 italiani) da dove è appena tornato.
Guido Corradi – è un esperto dell’area malese indonesiana. Ha insegnato all’IsMeo Isiao e attualmente collabora con l’Università Bicocca a Milano. Con Emanuele Giordana ha scritto “La scommessa indonesiana” e sta collaborando alla collettanea “A Oriente del Califfo. Il progetto dello Stato islamico a Est di Raqqa” in uscita per Rosemberg&Sellier
Elisa Giunchi – docente all’Università degli Studi di Milano, è un’esperta di storia e istituzioni del mondo musulmano. Ha scritto diversi saggi tra cui due dedicati a Pakistan e Afghanistan (Carocci)
Rohingya: vietato guardare
 Yanghee Lee è una docente universitaria coreana attualmente incaricata come Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, la persone che per le Nazioni Unite dovrebbe fare chiarezza su quanto avviene nello Stato di Rakhine, abitato (o dovremmo dire ormai “disabitato”) dai Rohingya (pronuncia Roinga). Ma nei dodici giorni della sua missione nel Paese, di cui solo tre nel Rakhine, a Lee è stato vietato andare dove le pareva per “motivi di sicurezza”. Ha potuto solo visitare alcuni luoghi approvati dal governo, o meglio dai militari, e parlare con testimoni anche quelli approvati dal regime.
Yanghee Lee è una docente universitaria coreana attualmente incaricata come Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, la persone che per le Nazioni Unite dovrebbe fare chiarezza su quanto avviene nello Stato di Rakhine, abitato (o dovremmo dire ormai “disabitato”) dai Rohingya (pronuncia Roinga). Ma nei dodici giorni della sua missione nel Paese, di cui solo tre nel Rakhine, a Lee è stato vietato andare dove le pareva per “motivi di sicurezza”. Ha potuto solo visitare alcuni luoghi approvati dal governo, o meglio dai militari, e parlare con testimoni anche quelli approvati dal regime.
Cosa può aver capito se non ciò che si sa da alcune riprese fatte dall’alto che testimoniano di 1500 villaggi distrutti e dalle testimonianze non approvate. Gli ultimi dati sulla fuga dei rohingya dal Myanmar danno un bilancio di 65milaprofughi, il doppio di quanti se ne contavano ufficialmente a fine dicembre. Per ora le pressioni internazionali non sembrano aver sortito grandi effetti.
L’Isis a Est di Raqqa: a Milano il 22 gennaio
Elisa Giunchi (Afghanistan e Pakistan) e Guido Corradi (Indonesia) parleranno degli elementi caratteristici del messaggio del Califfato nell’estremo Est del Sudest asiatico e nell’area della guerra permanente lungo il confine afgano pachistano. Emanuele Giordana coordinerà l’incontro e parlerà dello sviluppo dello Stato islamico in Bangladesh (dove in luglio vennero uccise 23 persone tra cui 17 stranieri di cui 9 italiani) da dove è appena tornato.
Grande Gioco: un week end di Passioni
“Passioni – Sulle orme del Grande Gioco”, in onda il 14-15 gennaio 2017 alle ore 14.30 sulle frequenze di Radio3 (terza e quarta puntata)
Il Grande Gioco, the Great Game per gli inglesi e Turniry Teney o Torneo delle ombre per i russi, fu una specie di grande guerra fredda del 19mo secolo. Una guerra mai dichiarata che opponeva Londra a San Pietroburgo, passando per Calcutta, la sede della Compagnia delle Indie – la East India Company – che doveva governare de facto l’India e tutti i possedimenti di oltremare sino al 1860 per essere infine sciolta nel 1874. Il nostro viaggio sulle tracce del Grande Gioco ci porta allora per forza a San Pietroburgo, fondata dallo zar Pietro il Grande sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia omonima nel golfo di Finlandia E’ stata a lungo la capitale dell’Impero russo e la sede della corte degli zar. Ci faremo aiutare da Lucia Sgueglia, giornalista che vive a Mosca da molti anni e che ha girato in lungo e in largo l’Asia centrale ex sovietica. Ma anche da letture di storici dell’epoca o di scrittori eccezionali come Dostoevskij che diede alle stampe il suo famoso Le notti bianche nel 1848. In pieno Grande gioco
Sulle orme del Grande Gioco – Passioni del 15 gennaio 2017
E siamo arrivati alla nostra ultima tappa nel viaggio che ci ha fatto ripercorrere le tappe del Great Game, del Grande Gioco, di quella guerra combattuta non solo con le armi ma con le spie, gli informatori, i diplomatici, gli avventurieri, i mercanti. Torniamo a Kabul, alla Kabul di allora e alla Kabul di oggi. Sentiremo, grazie agli storici dell’epoca, riesumati dai saggi di Peter Hopkirk e William Dalrymple, com’era la Kabul ottocentesca e poi ce la racconterà, com’è oggi, Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore che ha appena pubblicato per Gli Asini Arcipelago Jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda, una ricerca su due dei principali attori sulla scena di un Nuovo Grande Gioco che, dal Medio oriente, è arrivato fino all’Afghanistan.
Libri di testo tra Storia e Memoria
Ieri alla Casa della Memoria a Milano è stata inaugurata la mostra Different Wars: la II Guerra Mondiale vista attraverso i libri di scuola di 6 differenti Paesi. Gli organizzatori – la mostra, curata dal gruppo “Historical Memory and Education” dell’EU-Russia Civil Society Forum, è organizzata dall’associazione Memorial Italia in collaborazione con la Casa della Memoria, l’Istituto Lombardo per la Storia contemporanea e il Comune di Milano – spiegano che: “Le prime impressioni del passato, quelle che si formano con l’educazione scolastica e i libri di testo, sono tra le più forti. I libri di testo contengono la conoscenza che ciascuna società vuole trasmettere alle generazioni future. Gli Stati li utilizzano come strumenti per l’educazione civica, costruendo narrazioni che favoriscono le identità, rafforzano la coesione civile o legittimano il potere dominante…. I libri di testo comunicano infatti lo spirito del loro tempo e esprimono la cultura in cui vengono scritti“.
La mostra resterà aperta fino al 26 gennaio e racconta le differenze nel modo di raccontare e nella percezione della Storia della Seconda Guerra Mondiale: libri di testo delle scuole superiori di Germania, Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Polonia e Russia. I visitatori hanno l’occasione di “sfogliare” le pagine e conoscere i metodi di insegnamento dei manuali di storia dei Paesi presenti.
Informazioni pratiche
Mostra aperta dall’11 al 26 gennaio 2017
Orario d’apertura: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 17.00 | Ingresso libero
Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, Milano
Fantasmi alla frontiera
 Attraversando l’estuario del fiume Naf, che lungo 35 chilometri segna la
Attraversando l’estuario del fiume Naf, che lungo 35 chilometri segna la
frontiera tra Myanmar e Bangladesh, le barche devono scivolare silenziose e leggere. Il fiume si allarga in un braccio di mare che corre lungo i distretti di Cox Bazar in Bangladesh e dello Stato di Rakhine in Myanmar e le barche di chi scappa si confondono con quelle di chi pesca. Al di qua del confine, pochi chilometri più a Nord, ci sono i campi profughi risorti come funghi dal 9 ottobre scorso, quando è cominciata una violentissima repressione nello Stato birmano del Rakhine. Al di là, in Myanmar, c’è l’area di Maungdaw, l’estremo Nord del Rakhine. E’ da qui che si scappa al ritmo di cento, duecento, cinquecento persone al giorno. «Il picco sembra sia stato raggiunto in questi giorni – dice un funzionario addetto ai campi profughi – e adesso sembra si sia stabilizzato. Ma non sappiamo se è perché l’emergenza è finita, oppure se al di là della frontiera c’è ancora chi aspetta il momento migliore per andarsene»….
Continua su Internazionale
Afghanistan. L’Italia torna in prima linea
Benché ufficialmente si tratti di una missione di una settimana con scopi addestrativi, la Nato ha deciso l’invio di 200 soldati a Farah (Afghanistan occidentale) che, in gran parte, saranno italiani di stanza nella base di Camp Arena a Herat, dove Roma ha 950 soldati. Come sottolinea Al Jazeera, anche se il numero è esiguo, l’impegno segna un nuovo coinvolgimento delle truppe straniere nella guerra afgana che segue la decisione americana per altri 300 marine destinati nell’Helmand. Dopo la diffusione di voci, alla fine dell’anno scorso, di un coinvolgimento di aerei italiani nei cieli dell’Afghanistan (voci non confermate), l’invio dei militari a Sud non è un buon segno e sembra anche poco credibile che la missione sia “non combat”. Qualcosa sta accadendo nel Paese, con una nuova fase della guerra sulla quale abbiamo poche e frammentarie notizie. Quel che appare certo è che Trump non intende lavarsene le mani come aveva detto in campagna elettorale. Seguirà le indicazioni di Obama che ha chiesto che l’impegno Usa resti tale. Sembre che anche Roma conserverà questo atteggiamento.
C‘è intanto un’emergenza profughi che non accenna a diminuire. Anzi. Secondo il governo afgano, 200mila sono a rischio per freddo e fame nel Paese e 1500 fra loro, nel 2016, han perso la vita. La situazione attuale segna un bilancio di circa un milione di sfollati interni cui si è aggiunto l’anno scorso un altro milione di afgani rientrati in Afghanistan – in molti casi perché cacciati – dal Pakistan e dall’Iran.
Passioni (Radio3): sulle orme del Grande Gioco
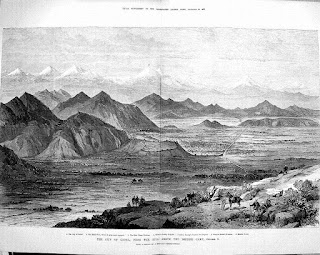 “Passioni – Sulle orme del Grande Gioco”
“Passioni – Sulle orme del Grande Gioco”
In onda per due fine settimana il 7-8 gennaio e il 14-15 gennaio 2017 alle ore 14.30 sulle frequenze di Radio3
Lungo tutto il 1800 il Regno Unito, o meglio l’Impero britannico, e la Russia, o meglio l’Impero degli Zar, combatterono una guerra molto particolare che ha preso il nome di Grande Gioco, Great Game o, alla russa, Torneo delle Ombre. Fu una guerra strana e in molti casi “fredda” e non solo perché si battagliava anche nelle steppe gelate dell’Asia centrale – come nelle torride pianure afgane – ma perché non venne mai combattuta direttamente e le battaglie furono spesso a colpi di spiate, tradimenti, complotti e non solo al suono delle trombe degli eserciti. La guerra si faceva comunque attraverso gli altri – gli afgani, gli uzbechi, i tagichi – e mai con uno scontro frontale. I due Imperi si spiavano con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar pensavano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse invadere, con soldati e commercianti, le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Est. In mezzo c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o – più a Nord – i canati dell’Asia centrale: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il viaggio sulle orme del Grande Gioco attraverserà dunque alcune delle principali città che furono il teatro di questo scontro tra titani. Cercando i segni di quella strana guerra combattuta in conto terzi e guardando anche a cosa sono diventate oggi: cosa c’è ancora di quel fascino che fece innamorare gentiluomini russi e mercanti inglesi, agenti indiani e funzionari della Compagnia delle indie, militari zaristi e fedeli ufficiali di Sua Maestà britannica? Un viaggio a Bukhara e Samarcanda, nel cuore dell’Asia Centrale; da Peshawar attraverso il passo di Khyber a Kabul, Herat, Jalalabad, città afgane oggi preda di un Nuovo Grande Gioco; e infine Pietroburgo, dove gli zar e i loro consiglieri studiavano ogni singola mossa di quel Torneo la cui ombra sembra sopravvivere al suo passato.
Sulle orme del Grande Gioco – Passioni del 7 gennaio 2017
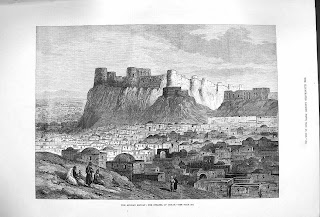 Durante tutto l’Ottocento L’Impero britannico e quello zarista si spiarono con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar temevano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse mangiarsi le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Oriente. In mezzo a questo Grande Gioco c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o i canati del Nord: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il nostro viaggio sulle orme del Grat Game comincia proprio da Samarcanda, una città su cui Marco Buttino, il più importante studioso italiano dell’Asia Centrale, ha da poco dato alle stampe un saggio per i tipi di Viella che si intitola proprio Samarcanda.
Durante tutto l’Ottocento L’Impero britannico e quello zarista si spiarono con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar temevano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse mangiarsi le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Oriente. In mezzo a questo Grande Gioco c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o i canati del Nord: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il nostro viaggio sulle orme del Grat Game comincia proprio da Samarcanda, una città su cui Marco Buttino, il più importante studioso italiano dell’Asia Centrale, ha da poco dato alle stampe un saggio per i tipi di Viella che si intitola proprio Samarcanda.
Ci faremo anche aiutare con letture tratte da Il Grande Gioco di Peter Hopkirk e da Il ritorno di un re di William Dalrymple usciti in Italia per Adelphi
Sulle orme del Grande Gioco – Passioni dell’8 gennaio 2017
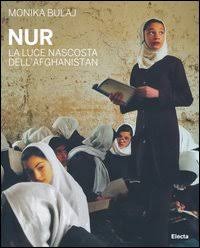 Ripercorrendo le tante strade del Grande Gioco, quella guerra “fredda”combattuta a migliaia di chilometri da casa da britannici e russi nell’Ottocento, l’Afghanistan è la tappa per eccellenza. Da Herat a Ovest o da Peshawar a Est – attraversando il passo di Khyber – eserciti, agenti segreti, spie camuffate da commercianti o viandanti, cercavano di guadagnare Kabul, il nodo del controllo delle grandi vie di accesso dall’Asia centrale all’India. Come sono oggi queste città? Ce lo racconta la principessa e Soraya Malek, nipote di quel re Amanullah che fu l’ultimo monarca afgano a subire la maledizione del Great Game. Ma ci faremo aiutare anche da scritti di storici dell’epoca e da due giornalisti: la fotografa e antropologa Monika Bulaj, che al Paese ha dedicato il volume Nur, la luce nascosta dell’Afghanistan, e dall’inviato de Il Messaggero Valerio Pellizzari che visse a Kabul durante l’occupazione sovietica negli anni Ottanta. E da due sacerdoti italiani, Caspani e Cagnacci, che scrissero un bellissimo saggio negli anni Cinquanta.
Ripercorrendo le tante strade del Grande Gioco, quella guerra “fredda”combattuta a migliaia di chilometri da casa da britannici e russi nell’Ottocento, l’Afghanistan è la tappa per eccellenza. Da Herat a Ovest o da Peshawar a Est – attraversando il passo di Khyber – eserciti, agenti segreti, spie camuffate da commercianti o viandanti, cercavano di guadagnare Kabul, il nodo del controllo delle grandi vie di accesso dall’Asia centrale all’India. Come sono oggi queste città? Ce lo racconta la principessa e Soraya Malek, nipote di quel re Amanullah che fu l’ultimo monarca afgano a subire la maledizione del Great Game. Ma ci faremo aiutare anche da scritti di storici dell’epoca e da due giornalisti: la fotografa e antropologa Monika Bulaj, che al Paese ha dedicato il volume Nur, la luce nascosta dell’Afghanistan, e dall’inviato de Il Messaggero Valerio Pellizzari che visse a Kabul durante l’occupazione sovietica negli anni Ottanta. E da due sacerdoti italiani, Caspani e Cagnacci, che scrissero un bellissimo saggio negli anni Cinquanta.
Quel silenzio color zafferano
 Fece scalpore anni fa un articolo su Aung San Suu Kyi, allora icona della resistenza ai militari, uscito sull’autorevole e paludato Journal de Geneve. Il quotidiano della città svizzera tagliava a fette la Signora in giallo, rea di esser la figlia di un’élite che, come altrove nel mondo, poteva educare i suoi pargoli nelle università britanniche per poi farli giocare alla rivoluzione. Ma Aung San, non ancora Nobel per la pace e con un futuro di perenni arresti domiciliari, era si figlia dell’élite (suo padre era stato l’eroe della resistenza antigiapponese) ma alla rivoluzione proprio non giocava. Nel 1988, i militari birmani al potere dal 1962, ancorché richiamandosi a un vago principio socialista, avevano annegato nel sangue l’ennesima rivolta e Aung San iniziava a essere molto di più che la semplice icona di una resistenza al regime. La donna aveva coraggio da vendere e una volontà di ferro mascherati da un sorriso disarmante. Nobel dal 1991, li doveva dimostrare nel 1999 quando il marito inglese giaceva moribondo in un letto europeo. I militari le diedero il permesso di espatriare per l’ultimo saluto ma lei rifiutò. Sapeva che uscire significava mai più rientrare.
Fece scalpore anni fa un articolo su Aung San Suu Kyi, allora icona della resistenza ai militari, uscito sull’autorevole e paludato Journal de Geneve. Il quotidiano della città svizzera tagliava a fette la Signora in giallo, rea di esser la figlia di un’élite che, come altrove nel mondo, poteva educare i suoi pargoli nelle università britanniche per poi farli giocare alla rivoluzione. Ma Aung San, non ancora Nobel per la pace e con un futuro di perenni arresti domiciliari, era si figlia dell’élite (suo padre era stato l’eroe della resistenza antigiapponese) ma alla rivoluzione proprio non giocava. Nel 1988, i militari birmani al potere dal 1962, ancorché richiamandosi a un vago principio socialista, avevano annegato nel sangue l’ennesima rivolta e Aung San iniziava a essere molto di più che la semplice icona di una resistenza al regime. La donna aveva coraggio da vendere e una volontà di ferro mascherati da un sorriso disarmante. Nobel dal 1991, li doveva dimostrare nel 1999 quando il marito inglese giaceva moribondo in un letto europeo. I militari le diedero il permesso di espatriare per l’ultimo saluto ma lei rifiutò. Sapeva che uscire significava mai più rientrare.
A trent’anni di distanza Aung San, per anni beniamina di ogni amante della libertà e dei diritti, è ancora nel mirino. Davanti al dramma di una minoranza bistrattata nel Paese di cui è alla guida (non è premier ma è come se lo fosse) è rimasta zitta. Non una parola o meglio qualche farfugliamento sbrigativo. Tutti le hanno dato addosso e, certamente, con motivo. Perché tace? Calcolo politico? Odio atavico per i musulmani? Condivisione del peggior istinto di alcuni monaci (tra cui il noto Ashin Wirathu)?
 |
| Ashin Wirathu monaco |
Un funzionario della diplomazia italiana allarga le braccia: «Fa quello che può, perché dall’altra parte c’è il rischio di un colpo di Stato». Non solo dunque uno scontro con potere politico ancora fortissimo ma il rischio di un colpo di coda sempre in agguato. Un segnale, e i soldatini uscirebbero dalle caserme. Quando nel 2015 la sua lega per la democrazia vince le elezioni si apre inevitabilmente una transizione difficile, caratterizzata da una coabitazione forzata da leggi che garantiscono ai militari un quarto dei parlamentari e da un braccio di ferro che imporrà per gli uomini in mimetica Interni, Difesa e Frontiere, tre ministeri chiave per gestire un Paese ormai in mano ai civili.
Aung San ottiene il governo (anche se è ufficialmente solo “Consulente di Stato”) ma non il potere effettivo con cui deve fare i conti. Nonostante la vittoria elettorale, il suo partito ha a che fare con una legislatura che si basa su due camere – elette per la prima volta in un clima democratico – ma che prevedono una quota di parlamentari in automatico ai militari: la Camera delle Nazionalità (Amyotha Hluttaw) ha 224 seggi e la Camera dei Rappresentanti (Pyithu Hluttaw) 440. Ma nella prima 56 e nella seconda 110 sono appannaggio delle Forze armate. Certo, la Lega ha la presidenza della Repubblica e diversi ministeri, ma politica interna e di difesa restano in mano ai soldati. In questo braccio di ferro scoppia il caso rohingya, per la verità già deflagrato – in tempi recenti – più volte: nel 1978, nel 1992, nel 2012 e nell’ottobre scorso. Durante il pogrom del 2012 Aung San non prende posizione. E, durante le elezioni, non spende una parola sul fatto che i rohingya non possano correre la scommessa elettorale. Ma non è ancora al potere. Il suo silenzio è imbarazzante ma le viene perdonato.
Dire che non abbia fatto nulla sarebbe ingiusto. Ha chiamato Kofi Annan e lo ha promosso inviato speciale per la questione. Ma Annan ha finito per giustificare il suo silenzio criticando chi, come il governo malaysiano, ha trattato l’affaire rohingya come un “genocidio”. Il suo governo ha anche promosso una commissione di inchiesta i cui risultati son però molto più che discutibili. Pare abbia anche mandato ai militari una sorta di questionario per saperne di più quando, un mese fa, la vicenda aveva già raggiunto dimensioni enormi. Ma non avrebbe ricevuto risposta. Insomma un braccio di ferro sotto traccia. Che non la giustifica ma getta luce su un negoziato impossibile coi militari proprio mentre c’è in ballo l’intero processo di pace con le minoranze armate nel resto del Paese. Quel silenzio resta pesante. Una macchia difficile da cancellare sul suo vestito zafferano.
Uccisi a Dacca altri due terroristi del N-Jmb
 Due figure di rilievo dell’organizzazione terroristica Neo-Jmb, tra cui uno dei capi dell’organizzazione, sono stati uccisi alle tre del mattino di ieri in un quartiere di Dacca. I due erano in motorino è sono stati i protagonisti di una fitta sparatoria. Ancora non è chiaro se i due siano stati fermati a un posto di blocco e abbiano reagito o se abbiano aperto il fuoco quando hanno capito che la polizia li aveva notati. Nurul Islam alias Marjan alias Shakil, di 22 anni, e considerato uno dei più giovani comandanti dell’organizzazione, avrebbe avuto un ruolo chiave nell’assalto del 1 luglio 2016 quando cinque membri del Neo Jmb attaccarono l’Holey Artisan Bakery a Gulsham, un ristorante della zona bene di Dacca frequentato da stranieri che furono presi in ostaggio: in totale vennero uccise 23 persone tra cui 17 stranieri tra i quali 9 italiani. L’altro militante ucciso è Saddam Hossain, alias Rahul alias Sabuj alias Chanchal alias Robi – accusato di almeno dieci casi di omicidio incluso quello del cittadino giapponese Hoshi Kunio nell’ottobre del 2015. Mmarjan, che si crede fosse il coordinatore della strage di Gulsham, avrebbe ereditato il vertice dell’organizzazione dopo la morte di alcuni leader di punta: l’ex militare Murad alias Zahi, Tamim Ahmed Chowdhury, e Faridul Islam alias Akash. Un altro leader, Musa, è invece appena sfuggito alla cattura.
Due figure di rilievo dell’organizzazione terroristica Neo-Jmb, tra cui uno dei capi dell’organizzazione, sono stati uccisi alle tre del mattino di ieri in un quartiere di Dacca. I due erano in motorino è sono stati i protagonisti di una fitta sparatoria. Ancora non è chiaro se i due siano stati fermati a un posto di blocco e abbiano reagito o se abbiano aperto il fuoco quando hanno capito che la polizia li aveva notati. Nurul Islam alias Marjan alias Shakil, di 22 anni, e considerato uno dei più giovani comandanti dell’organizzazione, avrebbe avuto un ruolo chiave nell’assalto del 1 luglio 2016 quando cinque membri del Neo Jmb attaccarono l’Holey Artisan Bakery a Gulsham, un ristorante della zona bene di Dacca frequentato da stranieri che furono presi in ostaggio: in totale vennero uccise 23 persone tra cui 17 stranieri tra i quali 9 italiani. L’altro militante ucciso è Saddam Hossain, alias Rahul alias Sabuj alias Chanchal alias Robi – accusato di almeno dieci casi di omicidio incluso quello del cittadino giapponese Hoshi Kunio nell’ottobre del 2015. Mmarjan, che si crede fosse il coordinatore della strage di Gulsham, avrebbe ereditato il vertice dell’organizzazione dopo la morte di alcuni leader di punta: l’ex militare Murad alias Zahi, Tamim Ahmed Chowdhury, e Faridul Islam alias Akash. Un altro leader, Musa, è invece appena sfuggito alla cattura.
Sia l’attacco al ristorante sia l’uccisione di Hoshi furono rivendicati dallo Stato Islamico anche se i rapporti tra il “Califfato” e i gruppi islamisti del Bangladesh non è chiaro. Il Neo Jmb – fazione del gruppo “madre” Jammatul Mujahedin Bangladesh – ha probabilmente legami con gli emissari di Raqqa (anche se il governo ha sempre negato la presenza di Daesh in Bangladesh) che pure hanno rivendicato diverse azioni tra cui l’uccisione dell’italiano Cesare Tavella, che lavorava in una Ong e che venne freddato nel settembre del 2015 mentre faceva jogging sempre nella zona di Gulsham. Da allora funzionari e umanitari stranieri sono sotto stretta sorveglianza e limitati negli spostamenti da ferree regole di comportamento. Il ministro dell’Interno Asaduzzaman Khan Kamal, che ha reiterato il messaggio di tolleranza zero del governo, ha detto che ormai la rete si sta stringendo attorno ai 14 leader del gruppo ancora in fuga.
L’ennesima uccisione di militanti rientra in quadro di operativi delle forze di sicurezza che già in dicembre avevano compiuto parecchi arresti e smantellato diversi covi di militanti. Ma avviene anche in una cornice politica delicata, sia a livello dei partiti – già in campagna elettorale – sia a livello sociale, con scioperi nel settore tessile che hanno visto circa 3mila licenziamenti e arresti di sindacalisti. Il segretario generale della Lega Awami Obaidul Quader ha detto ieri che un gruppo starebbe tramando per rovesciare il governo e uccidere il primo ministro Sheikh Hasina. Propaganda? Alcuni giorni fa – e non è certo il primo – è stato ucciso da un commando Manzurul Islam Liton, un politico della Lega Awami.
Rohingya: una foto e un video
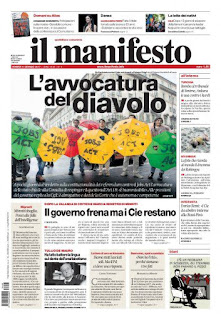 Un video dove le forze di sicurezza birmane prendono a calci un poveraccio che si nasconde la testa tra le mani e la foto di un bimbo riverso sulla sabbia a faccia in giù e senza più vita fanno il giro del mondo e risollevano la questione di una minoranza bistrattata e selvaggiamente perseguitata. Il piccolo Mohammed e il povero contadino preso a calci, divenuti virali sui social media finora attenti alla tragedia di Aleppo, sono due rohingya. Appartengono a un popolo in fuga che, dagli inizi di ottobre, scappa dall’ennesima persecuzione ai suoi danni.
Un video dove le forze di sicurezza birmane prendono a calci un poveraccio che si nasconde la testa tra le mani e la foto di un bimbo riverso sulla sabbia a faccia in giù e senza più vita fanno il giro del mondo e risollevano la questione di una minoranza bistrattata e selvaggiamente perseguitata. Il piccolo Mohammed e il povero contadino preso a calci, divenuti virali sui social media finora attenti alla tragedia di Aleppo, sono due rohingya. Appartengono a un popolo in fuga che, dagli inizi di ottobre, scappa dall’ennesima persecuzione ai suoi danni.
Questa volta a scatenarla è stato l’eccidio di alcuni poliziotti birmani attribuito a un gruppo islamista radicale alla frontiera. Altre volte, e a più riprese, questa comunità musulmana di un milione di persone che abitano nello Stato
occidentale birmano del Rakhine, è stata oggetto di violenze che l’hanno costretta alla fuga. Si stima che la metà dei Rohingya viva ormai fuori dal Myanmar mentre un quinto di chi è rimasto vive nei campi profughi nel Rakhine. Oltre trentamila sono invece la colonna infame dell’ultima fuga che, tra ottobre e dicembre, ha raggiunto le coste del Bangladesh. Un esodo che non si è fermato.
Finora, le pressioni sul governo birmano sono state praticamente inutili. Né ha ancora sortito effetti la lettera che una dozzina di Nobel per la pace e altrettanti personaggi pubblici hanno scritto all’Onu perché si faccia qualcosa. L’unica cosa certa è che Naypyidaw manderà a Dacca un suo inviato per “discutere” della questione. Poco quando le accuse sono di stupro, esecuzioni sommarie, violenze, incendio di villaggi…
… (continua su il manifesto oggi in edicola)
Terrorismo: il governo di Dacca canta vittoria
 Dopo il raid della vigilia di Natale che sabato 24 ha sgomberato il covo di uno dei due gruppi più pericolosi del Paese (Jamaat ul MujahedinBangladesh – Jmb), i giornali locali hanno dato la notizia dell’arresto di una ennesima fazione del gruppo terroristico che aveva progettato, secondo quanto ammesso dagli arrestati, un attentato la notte di capodanno. Con gli arrestati sono stati sequestrati 30 chili di esplosivo. Ma il colpo vero all’organizzazione, nota anche come Neo-Jmb (fondato nel 1998 il gruppo è stato messo al bando e la sua azione più nota risale ormai al 2005 ma avrebbe originato diverse fazioni), è stata l’operazione di sabato scorso definita Ripple 24.
Dopo il raid della vigilia di Natale che sabato 24 ha sgomberato il covo di uno dei due gruppi più pericolosi del Paese (Jamaat ul MujahedinBangladesh – Jmb), i giornali locali hanno dato la notizia dell’arresto di una ennesima fazione del gruppo terroristico che aveva progettato, secondo quanto ammesso dagli arrestati, un attentato la notte di capodanno. Con gli arrestati sono stati sequestrati 30 chili di esplosivo. Ma il colpo vero all’organizzazione, nota anche come Neo-Jmb (fondato nel 1998 il gruppo è stato messo al bando e la sua azione più nota risale ormai al 2005 ma avrebbe originato diverse fazioni), è stata l’operazione di sabato scorso definita Ripple 24.
Gli agenti hanno circondato il covo alle prime ore del mattino e ingaggiato una lunga battaglia durata sin quasi al pomeriggio nel corso della quale una donna si è fatta esplodere con una bambina in braccio (che è ferita ma si è salvata). Nello scontro a fuoco è stato ucciso anche un ragazzo di 14 anni. Azione controversa. Non era invece li Maynul Musa, che sarebbe il capo del Neo -Jmb e tra gli ispiratori dell’attacco alla alla Holey Artisan Backery di Dacca dove vennero uccisi nel luglio scorso 17 stranieri tra cui nove italiani. Dopo l’operativo l’antiterrorismo canta vittoria sostenendo che il Bangladesh controlla ormai le reti islamiste. Non sono chiari i rapporti del Neo-Jmb con lo Stato islamico.
Buon anno a Dacca
 Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.
Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.
Ti assale – in questi luoghi tentacolari – un panico sconfortante a metà tra l’idea che non si riuscirà a combinare nulla e l’idea che le ore passeranno inesorabili nello sconforto di una città senza volto. Ma quel volto c’è. C’è un’identità e persino un carisma.C’è un fascino. Perdersi è l’unica strada. Mi metto in tasca la Lonely Planet (davvero ben fatta per quel che ho visto e scritta da un viaggiatore attento e profondo) e mi aiuto con le mappe, percorsi consigliati, qualche buona dritta. Poi mi lascio trascinare. Prendo la barca sul fiume che attraversa Old Dhaka e poi, dopo un tè, la riprendo all’indietro. Dietro la puzza c’è un profumo. Dietro un’umanità che appare disperata c’è un sorriso e una curiosità che si riflette in gentilezza. Una gentilezza delicata e mai invasiva. Un modo di fare che a tutta prima sembra chiuso e scortese e invece è rispetto per gli estranei. Immaginavo una città violenta e oscura. E’ solare e gentile. Inquinata, certo, e sporca e con una densità tale che si ha sempre l’impressione di essere sul filobus che va in stazione nelle ore di punta. Eppure nessuno si tocca. Tutti e tutto ti sfiorano.
 |
| In città ci sono pochissimi semafori e, soprattutto, sono spenti. Come facciano a guidare senza scontrarsi di continuo resta un mistero glorioso |
Questo fascino nascosto della città forse più caotica al mondo non si può spiegare. Né si può spiegare perché io preferisca il caos del centro città ai quartieri di Banani o Gulsham dove una piccola Londra, passando per l’India, è sbarcata anche qui: viali ordinati, alberi e negozi come li vedi ovunque. Capisco chi ci vive perché lavora qui, ma per un viaggiatore sono non luoghi senza senso. Ma che senso abbia il resto, il quartiere di Shantinagar dove sto io, non saprei dire. Non c’è un palazzo antico, un parco pubblico, un ristorante degno di questo nome. Eppure passano queste seducenti ragazze con la carnagione scura e gli occhi a mandorla nei loro abiti eleganti e piccole taverne di strada offrono succulenti banchetti. Mi spiace solo non poter bere quell’intruglio di una specie di scorzonera mescolata con foglie di agave che deve fare benissimo ma è condita con acqua di dubbia provenienza. Guardo il maestro di tanta pozione prepararla con cura accovacciato all’incrocio dove sfrecciano autobus sfregiati e tutt’intorno sfrigolano fritture di pasta e patate. Più in là, venditori di ogni bendiddio in una città che è un bazar perenne di oggetti e rumori. Baccano che diventa colonna sonora di sottofondo. Diamine, ecco perché sono venuto. Ecco la sorpresa. Anche se non posso bere la tua acqua magica, maestro, potrò ben raccontare di averla vista preparare.
Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta

Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.
Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta.
 |
| 500 Tk:Il costo di un pranzo in un ristorante di lusso. Ma con dieci volte questa cifra una famiglia operaia deve vivere un mese |
Comincia tutto il 12 dicembre ad Ashulia, una zona suburbana di Dacca a una ventina di chilometri a Nord dal centro città. Tra gli operai delle fabbriche girano volantini che rivendicano un nuovo minimo sindacale. L’ultimo, è stato fissato tre anni fa e ammonta a 5300 Taka ossia circa 65 euro al mese. Visto che un terzo del salario se ne va in affitto, un chilo di riso costa 50 tk e il trasporto pubblico è quasi inesistente, la rivendicazione – un aggiustamento al triplo – sembra una richiesta più che legittima. Alla Windy cominciano le prime agitazioni spontanee che in pochi giorni si estendono a macchia d’olio: o ci date l’aumento o incrociamo le braccia. Il 14 la patata e già bollente e la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea), l’associazione di settore degli imprenditori, va in fibrillazione. Ci sono i primi incontri con le associazioni dei lavoratori ma la linea rossa, ribadita nei giorni a seguire, è che il salario minimo non è in discussione. La Bgmea, il cui obiettivo è arrivare a fatturare – dagli attuali 30 – 50 miliardi di dollari l’anno con l’export del tessile, non ne vuole sapere. Col passare dei giorni la tensione aumenta: il 21 dicembre l’agitazione coinvolge 59 fabbriche e centinaia di lavoratori. E mentre viene decisa la serrata (terminata il 26 su richiesta della premier Sheikh Hasina) si accende la macchina della repressione. Uno per tutti, il caso di Ibrahim, della Bangladesh Garments and Industrial Workesr Fderation. Il sindacalista viene arrestato con tre altri leader sindacali e per tre giorni sparisce. Quando finalmente colleghi e famiglia sanno qualcosa di lui, il caso è passato alla magistratura con cinque capi di imputazione e per adesso nessuna cauzione possibile per farlo uscire. Non lo hanno picchiato – spiega un suo collega – ma «è stato sottoposto a minacce e avvertimenti», pressioni psicologiche esercitate, come le foto del loro licenziamento, anche verso gli operai. Se i leader sindacali sono in manette almeno altre duecento denunce pendono sul capo di altrettanti lavoratori. La legge usata per arrestarli o accusarli è un vecchio residuo legislativo del 1974, la Special Law, varata (dopo l’indipendenza del Bangladesh dal Pakistan (1971) e mai emendata o abolita.
 |
| Una pubblicità di Benetton. Fu coinvolta nella vicenda del Rana Plaza e fece una pessima figura. Ora che farà? |
Parliamo con uno dei leader sindacali di cui è meglio, in queste ore, non fare il nome. Spiega che i sindacati stanno offrendo a governo e padroni un ramoscello d’olivo. «Ma – dice – devono accettare di sedersi al tavolo e negoziare e non vogliono farlo». Il problema, aggiunge un altro sindacalista, è che «il governo non è un mediatore terzo. In parlamento non ci sono lavoratori e così alla fine l’esecutivo fa quel che dicono i padroni». Questi ultimi hanno lamentato perdite in questi giorni di agitazione per oltre un miliardo di euro e non ne vogliono sapere di discutere del minimo anche se deve essere rinegoziato, per legge, ogni cinque anni. I diversi sindacati di categoria invece, hanno eletto un Comitato proprio per definire correttamente il valore del salario garantito: un paniere che contenga calorie, bisogni sanitari, costo degli alimenti. «Una cifra dignitosa – dice una collega – dovrebbe essere almeno 200 dollari al mese». Ma da questo orecchio nessuno ci sente.
 |
| Un Paese ignorato dai media e anche dall’Accademia, salvo rare eccezioni. Eppure vestiamo tutti…. Made in Bangladesh |
I lavoratori però ci sentono eccome anche se la loro provenienza è extra urbana, mancano di istruzione e hanno il terrore di perdere il posto di lavoro. Un esercito solitamente di fantasmi silenziosi il cui unico vantaggio rispetto al lavoro informale, è che in fabbrica si lavora otto ore, anche se ti vengono scalati i minuti per andare in bagno. Chi è questo lavoratore del tessile lo spiega David Lewis, docente della London School che al Bangladesh ha dedicato nel 2011 uno dei rari libri* su questo Paese: “E’ una giovane donna appena arrivata da un villaggio, che vive in affitto negli slum vicino a una fabbrica o un’area speciale (Export Processing Zone) dove lavora a macchina per circa un dollaro e mezzo al giorno…la fabbrica la mette faccia a faccia con le contraddizioni e la complessità di un’economia globalizzata: può esser di proprietà coreana, con tessuto di Taiwan, filo indiano e imballaggi cinesi. Ma ma i capi prodotti portano tutti l’etichetta Made in Bangladesh».
Il prodotto finito arriva a Seul o a Taipei ma anche a Londra, Parigi, Milano. E’ il motivo per cui è nata la Campagna Clean Clothes (Abiti Puliti in Italia) che dopo il Rana Plaza – quando il mondo ha cominciato ad accorgersi del Bangladesh – è riuscita a far fare qualche passo avanti sul piano della sicurezza. Ora denuncia gli arresti e le intimidazioni. Deborah Lucchetti di Abiti Puliti si unisce al coro: «Chiediamo alle imprese italiane che operano nel Paese di chiedere immediatamente al governo del Bangladesh il rilascio dei sindacalisti arrestati, di comunicare dove sono detenuti, di ritirare le accuse infondate nei loro confronti e di cessare ogni ulteriore forma di repressione nei confronti di chi legittimamente esercita il diritto fondamentale di espressione e organizzazione».
 |
| Dieci Taka: nemmeno 15 centesimi di euro Ci si beve un tè con una pastella fritta ripiena di patate. C’è chi sopravvive così |
Il clima a Dacca è di paura. I sindacalisti con cui parliamo sono stati intimiditi, minacciati, avvertiti che non devono organizzare riunioni né muoversi dai loro uffici. Ma, chiediamo, è una questione di prezzi troppo bassi sul mercato internazionale? «No – sorride il sindacalista – se il prezzo delle merci fosse più alto il guadagno non verrebbe redistribuito. Ci sarebbe solo più profitto per i proprietari».
Nel piccolo ristorante su una strada iperaffollata, alcuni minorenni servono ai tavoli. Guadagnano 230 tk al giorno che, al mese, fa circa 6mila tk, più del salario di un tessile. Ma, anziché andare a scuola, lavorano 16 ore al giorno e per sette giorni su sette. Lavoro informale e senza le garanzie di una fabbrica. Garanzie? La “sospensione temporanea” è solo un modo per dire che d’ora in poi la fabbrica non ha più bisogno di te.
* Lewis D., Bangladesh Politics, Economy and Civil Society, Cambridge University Press, 2011
Questo reportage è uscito oggi su il manifesto
Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta
 Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto
Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto
Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.
Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta…
(continua. In edicola domani su il manifesto)
Com’è dura rompere il silenzio
 Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.
Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.
Ma anche una lettera – un’autorevole lettera – è rompere il silenzio. Anche un articolo, nel suo piccolo, può farlo anche se oggi un settimanale italiano mi ha risposto che no, grazie, non interessa. E tanti auguri di buon anno. Due righe per dire che questi 34mila disperati che solo negli ultimi tre mesi son stati spinti via dalla loro terra non sono un pane appetibile per te, lettore italiano. La Raggi vale di più. Bersani pure. Non mi stupisco. Nessun giornale del mio Paese si è scandalizzato per l’espulsione annunciata di 80mila afgani dalla sacra terra europea. Né fa scalpore quel milione di afgani che, a centinaia per volta, il Pakistan sta espellendo dalla sua terra, che la geopolitica val più della solidarietà. Dunque 34mila rohingya possano soffrire in silenzio. Non meritano la tua attenzione, lettore italiano.
Varcano il fiume che separa le due frontiere e che diventa un braccio di mare. Ma è riparato e dunque tranquillo e la stagione è buona. Cento, duecento, cinquecento al giorno. Dicono che ora il loro arrivo si è stabilizzato. Non cresce più. Ma non sappiamo, non possiamo saperlo, quanti vorrebbero fuggire e non possono farlo. In Myanmar, su quel confine non si può andare. Anche in Bangladesh il confine è off limits. Ma si può venire qui a Ukhia, trenta chilometri da Cox Bazar, la Rimini del Paese, a vedere dove vive questa gente. Teloni neri di plastica appoggiati su aste di bambù. E la solidarietà quotidiana di chi non è molto più povero di loro ma condivide un pasto, un posto per la tenda. Durerà? La pressione è forte anche se i rohingya son del tutto simili ai bengali. Pare siano circa 300mila i rohingya in Bangladesh, un terzo della loro popolazione totale. Dispersi qui e là, su fino a Chittagong e forse anche a Dacca. Lavori stagionali e, immagino, un senso di ingiustizia, di precarietà, una sofferenza che non valgono questo silenzio. Grazie, non interessa. Abbiamo altro cui pensare.
Il fronte caldo del Bangladesh (e del Myanmar)
Il corpo decapitato di un contadino senza vita è stato trovato in un fosso nello Stato di Rakhine, in Birmania. Ma questa volta non c’entrerebbe la polizia, accusata di aver messo a ferro e fuoco quest’aera abitata da musulmani rohingya, la piccola minoranza senza diritti del Myanmar in fuga vero il Bangladesh.
Non si sa chi l’abbia ucciso ma si sa che l’uomo – un rohingya di nome Shu Nar Myar – aveva parlato il giovedi con alcuni giornalisti birmani invitati dal governo a visitare i luoghi ora sotto i riflettori (si fa per dire) della cronaca. L’uomo aveva negato – riporta Al Jazeera – che nella zona si fossero verificati arresti indiscriminati, incendi e stupri, cosa di cui sono accusati i militari birmani (finora un’ottantina di morti). Dunque potrebbe essere stato ucciso da chi lo ha bollato probabilmente come “informatore collaborazionista”. Le ipotesi corrono al gruppo radicale islamista Harakah al-Yaqin (che il governo chiama genericamente Aqa Mul Mujahidin o comunità di combattenti), che secondo International Crisis Group, sarebbe all’origine della strage di appartenenti alle forze di sicurezza di inizio ottobre che dato la stura alla repressione dei rohingya nella zona Nord del Rakhine dove il gruppo è attivo (il governo birmano aveva invece fatto riferimento al gruppo qadista Aqa Mul Mujahidin). Intanto il numero “ufficiale” di coloro che sono già fuggiti qui in Bangladesh, nella zona di Cox Bazar, è salito a circa 34mila.
Anche a Dacca il fronte è caldo. Dalle due di stamattina era in corso un’operazione di polizia che aveva già portato all’arresto di appartenenti al gruppo Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb), gruppo che pare affiliato allo Stato islamico e che è stato accusato di essere dietro alla strage di luglio quando furono uccisi una ventina di ostaggi (tra cui 9 italiani) in un bar di Gulsham, la zona “bene” della città. Nel primo pomeriggio poi, una donna si è fatta esplodere ma senza far vittime oltre a se stessa mentre altre con bambini si sono arrese. Un ragazzo di 14 anni è stato falciato: la polizia sostiene che fosse armato e pericoloso… Il raid si è concluso.
Dacca. Annusare una città
La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.
Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.
Dacca. Annusare una città
La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.
Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.
Il sole sorge sempre a Est
Afghanistan, cade anche l’ultimo mito
| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |
Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.
Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.
Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.
Afghanistan, cade anche l’ultimo mito
| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |
Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.
Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.
Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Un anno fa
Foto di Monika Bulaj
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quesito
Agricoltori pachistani – scrive il Dawn – si son scontrati con la polizia in un distretto di Bhakkar (Punjab) per via dei danni al raccolto causati da membri della famiglia reale del Qatar a caccia di otarde (Chlamydotis undulata o Houbara bustard).
La domanda è, chi sono gli animali?
1) l’otarda
2) i contadini
3) la famiglia reale
Per aiutarvi se avete dubbi e volete saperne di più, potete cliccare qui
Un bel video sulle otarde
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Quando il silenzio non è d’oro
 |
| Lo Stato di Rakhine al confine occidentale |
Una situazione insostenibile con oltre 20mila profughi ammassati in Bangladesh. Denunce ripetute di
violenze e omicidi a danni di civili in un clima di caccia all’uomo. E divieto per le organizzazioni umanitarie di rifornire i campi profughi allestiti nello Stato occidentale birmano del Rakhine (Arakan). E’ la storia che da ottobre avvolge l’ennesima epopea dei Rohingya e su cui grava il silenzio della paladina dei diritti per eccellenza: Aung San Suu Kyi.
Vijay Nambiar, consigliere del segretario generale dell’Onu per il Myanmar, l’ha invitata ieri a recarsi di persona a Maungdaw e Buthidaung, le due zone calde del Nordest del Rakhine, lo Stato dove vive la minoranza dei Rohingya da diversi mesi sotto il tallone di ferro dell’esercito birmano. E’ solo l’ultima delle voci che tentano quella che appare ormai come un’impossibile mediazione tra le legittime ragioni della minoranza musulmana nel Paese buddista per eccellenza, le aspirazioni democratiche del primo governo civile del Paese e la tradizione della casta militare che di fatto continua a decidere in tema di sicurezza e repressione.
Le ultime vicende risalgono all’ottobre del 2016 quando sono stati uccisi alcuni militari per mano di gruppi secessionisti locali, episodio cui è seguita una reazione spropositata dell’esercito birmano sotto accusa per stupri, violenze e uccisioni extra giudiziarie. Reazione tanto spropositata che quasi 22mila Rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh mentre molti altri si sono aggiunti alla popolazione dei campi profughi allestiti all’epoca di pogrom anti musulmani del 2012. E’ in questo quadro di violenze, tensioni, migrazioni e fuga dal Paese che da ottobre si sta consumando quello che, alcuni giorni fa, il premier della Malaysia Najib Razak ha definito genocidio e pulizia etnica. La Malaysia è un Paese a maggioranza musulmana ma con una lunga tradizione di tolleranza verso cinesi e indiani che costituiscono quasi la metà della popolazione del Paese. Ma a Kuala Lumpur sono anche preoccupati di una possibile ondata di nuovi profughi (nel 2015 almeno 25mila Rohingya hanno cercato rifugio all’estero migrando verso Sud via mare per raggiungere Filippine, Malaysia o Indonesia), un peso per ora retto soprattutto dal Bangladesh, anche se Dacca sta ora cercando di sigillare le sue frontiere. Ha sempre offerto sostegno ai rohingya (anche ai separatisti) che per il Myanamr non sarebbero veri cittadini birmani ma immigrati bangladesi cui infatti non viene riconosciuta né la cittadinanza birmana né lo status di minoranza.
Il governo birmano, che pur non avendo Aung San Suu Kyi come premier è di fatto guidato dalla Nobel (che è ministro degli Esteri), è in difficoltà. Al suo minimo storico dal momento in cui ha vinto le elezioni ed è sotto tiro in casa e all’estero. In casa perché, oltre alla questione rohingya – cui ai birmani importa poco – parte della guerriglia secessionista in alcune parti del Paese ha ripreso a combattere. Infine perché la gente ha fretta di vedere mantenute le promesse, soprattutto economiche, dell’era post militare. Fuori di casa invece, la Nobel e il suo governo – una difficile alleanza con la casta militare che ha fatto un passo indietro ma può contare su tre ministri e 110 seggi alla Camera attribuiti per default – sono sotto tiro per i Rohingya. Sotto tiro ma fino a un certo punto. A far la voce grossa ci sono solo l’Onu, Amnesty e le Ong. Cina e India non han preso posizione e così il Giappone. Anche Stati Uniti e Ue sembrano aver altro cui pensare. Solo la Malaysia ha alzato il tiro e chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale. Quanto agli indonesiani, il presidente Jokowi ne ha parlato proprio l’altro ieri con Kofi Annan, incaricato da Aung San di occuparsi del problema. Ma per Kofi Annan, reduce da una visita nell’area rohingya, la parola “genocidio” non va ancora usata. Sembra che ci si debba accontentare del rapporto, atteso per il 30 gennaio, della commissione nominata dal presidente U Htin Kyaw il 1 dicembre. Per Annan ci vuole «tempo e pazienza». E’ probabilmente al corrente delle difficoltà di Aung San con i militari birmani di cui può essere un buon esempio il fatto che il generale Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito, abbia evocato due volte in novembre la possibilità dello stato di emergenza. Ma né una condizione politica critica, né le parole di Annan, contraddette già a metà novembre da un altro responsabile dell’Onu che aveva definito la situazione «inaccettabile», riescono a giustificare il suo silenzio. Pesante come un macigno.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Le telefonate del presidente
 Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
Quando settimana scorsa, nel suo giro di telefonate asiatiche, Donald Trunp ha parlato anche con il suo omologo di Manila, la nota ufficiale diceva che il presidente americano aveva augurato al capo di Stato filippino di avere successo con la sua campagna contro spacciatori e malavitosi. Ma poi Rodrigo Duterte, un uomo come Trump poco avvezzo alla diplomazia felpata, non ha potuto fare a meno di rivelare i dettagli dell’amichevole conversazione.
 |
| Somiglianze. Duterte in una foto tratta dal SunStar, sopra Trump |
Secondo Duterte, Trump gli ha detto di non preoccuparsi delle critiche americane per l’azione delle sue forze dell’ordine che hanno già collezionato 4mila esecuzioni sommarie, aggiungendo che: «…presidente Duterte, dovremmo risolvere i nostri cattivi rapporti… Stai andando alla grande… stai facendo bene, devi andare avanti». I cattivi rapporti sono quelli tra Washington e Manila dopo gli insulti di Duterte a Obama e lo strappo filocinese di qualche settimana fa (poi un po’ rientrato). Il commento del Trump filippino alla battute del Duterte americano è stato che quella telefonata lo ha fatto sentire «come un santo». Dopo la polemica su Taipei, chissà cosa pensano a Pechino di un riavvicinamento (telefonico) anche con Manila. Discretamente rozzo per altro, come i suoi due protagonisti.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Il barbuto col cuore rock
 |
| Studioso e filantropo: Junaids Jamshed in una foto tratta da The Dawn |
Guardate la faccia di quest’uomo. Si chiama Junaid Jamshed ed è tra le persone morte ieri nell’incidente aereo in Pakistan avvenuto dalle parti di Abbottabad. Che ne pensate? Un “barbuto” di meno? Il suo profilo dice tutt’altro e cioè che sotto la barba batteva un cuore d’oro non una cartucciera. Ai suoi esordi musicali, questo figlio di un militare che aveva rifiutato la sicura carriera paterna, suonava nei Vital Signs, i “Beatles” pachistani. Poi aveva deciso di dedicarsi all’islam. Allo studio dell’islam ma anche alle pratiche umanitarie della sua applicazione pratica migliore. Islam rock? O semplicemente una faccia che dovrebbe consigliarci di uscire dagli stereotipi?
Ecco Dil Dil Pakistan (che si potrebbe forse tradurre con Cuore pachistano o Pakistan del mio cuore), una canzone del 1987 che fece furore nel Paese dei puri e che resta ancora una delle grandi favorite. Junaid era il cantante.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Macerie di una guerra infinita: il rapporto di Asia Foundation
 Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Ogni anno anno dal 2004 Asia Foundation fa un sondaggio sulla percezione della realtà in Afghanistan. I sondaggi sono sondaggi ma c’è sempre un’indicazione reale anche perché il lavoro è per tutte e 34 le province afgane e ormai AF ha una certa dimestichezza con questa inchiesta. I dati di quest’anno sono sconfortanti: AF conferma il più basso livello di ottimismo registrato per via di insicurezza in aumento, morti civili, sfide economiche. Una traiettoria discendente dell’umore nazionale – dice il rapporto – che ha avuto inizio nel 2013: solo il 29,3% degli afgani intervistati nel settembre 2016 dice che il Paese si sta muovendo nella giusta direzione, il livello più basso di ottimismo da quando l’indagine ha avuto inizio. Un marcato aumento delle vittime civili e la violenza contribuiscono al più alto livello di paura registrato in più di un decennio: il 69,8% degli afgani ha paura per la sua sicurezza personale. La paura è ancora più pronunciata nella regione Sudoccidentale (82%) e raggiunge nell’Helmand il 92,3%. Allo stesso tempo, anche se la consapevolezza generale di ISIS / Daesh è aumentata dal 74,3% nel 2015 al 81,3% nel 2016, la percezione che ISIS / Daesh sia una minaccia alla sicurezza è diminuito dal 54,2% nel 2015 per 47,9% di quest’anno.
Nonostante la disoccupazione, un minor numero di afgani sembrano però interessati a migrare. In mezzo a un afflusso di rimpatriati e mutevoli politiche di accoglienza di altri paesi, la percentuale di afgani che esprime il desiderio di migrare è diminuito in modo significativo, dal 39,9% nel 2015 al 29,6% quest’anno, il più grande calo registrato nel censimento. Ciò si è verificato anche se i tassi di disoccupazione restano elevati e per la maggioranza degli afgani è proprio la disoccupazione, specie quella giovanile, a spingere i ragazzi ad andarsene.
La fiducia nelle istituzioni pubbliche e nelle Ong è al minimo storico. Gli afgani si sentono rassicurati in primo luogo dai loro capi religiosi (66,1%) e poi dai media (64,5%). La radio è ancora la fonte più popolare di informazioni, con il 70,5% degli intervistati che ricevono notizie e informazioni via onde radiofoniche, seguita dalla televisione al 66,4%. Infine accesso all’assistenza sanitaria e il cibo rimangono preoccupazioni centrali.
C’è anche qualche luce: un numero record di afghani pensa che le donne dovrebbero essere in grado di lavorare fuori casa (74,0%), ma il rapporto sottolinea che il dato appare legato alla economia depressa e alla necessità per le famiglie di un doppio reddito.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Il genocidio dei Rohingya e il silenzio della Nobel
 C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
C’è voluto l’intervento di un primo ministro, il premier malaysiano Najib Razak, per pronunciarla
quella parola: genocidio. E per usare quell’altra locuzione, pulizia etnica, che avevamo ascoltato per la crisi nei Balcani e poi in quella dei Grandi Laghi. Questa volta l’oggetto è un popolo di un milione di persone a cui il Paese in cui vive nega persino la cittadinanza e il riconoscimento come comunità. Sono i Rohyngya del Myanmar, un Paese a maggioranza buddista governato dal connubio tra la casta militare e un governo civile uscito vittorioso dalle elezioni e rappresentato dalla Nobel Aung San Suu Kyi. Ma i Rohyngia sono musulmani e poveri. Per i birmani, sono solo immigrati bangladesi.
Razak è musulmano come loro e sa anche come vive la minoranza musulmana in Thailandia, quindi non si stupisce. Ma per esser franchi non è solo un problema umanitario e politico (ha chiesto l’intervento del Tribunale penale internazionale). E’ che i profughi rohingya, quando scappano vanno verso Sud e tra i Paesi sulla rotta c’è proprio la Malaysia anche perché è un Paese in gran parte musulmano. Subito dopo c’è l’Indonesia. C’è già stata una crisi dei profughi oltre un anno fa e la Malaysia, una piccola mecca asiatica dove il livello di vita è alto, teme una nuova invasione. Anche perché Bangkok non scherza: non prende profughi e li rispedisce in mare, semmai li “accompagna” a Sud. Attualmente, i Rohyngia sono i siriani dall’Asia (o gli iracheni, o gli afgani se preferite). Ma a differenza di Bashar al Assad, un criminale patentato, il loro primo ministro (in realtà facente funzioni e ministro degli Esteri) è Aung San Suu Kyi. Che sulla pulizia etnica chiude occhi, bocca e orecchie per salvare il difficile equilibrio in cui si trova impantanato il suo governo.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Una chiamata per Donald Trump
 La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
La telefonata tra Taipei e Washington ha sollevato un putiferio. Pechino si è arrabbiata e ha chiamato Washington. Bollette bollenti.
Nell’epoca dei cellulari, e archiviato il telefono rosso della Guerra fredda, un coup de fil risulta essere ancora un mezzo efficace della diplomazia.
Se di quelle chiamatine han parlato tutti, han fatto meno rumore le telefonate di Trunp con il Pakistan (con seguito polemico nazionale) e in Afghanistan (eppoi, dei due chi avrà chiamato per primo?).
Mi chiedo cosa il neo presidente americano abbia detto ad Ashraf Ghani, la cui stabilità è sorretta dalle baionette americane. E cosa il presidente afgano abbia chiesto all’uomo che in campagna elettorale ha promesso il ritiro dei soldati dal suo Paese. Si sa che han parlato di terrorismo (che è ormai come parlare del tempo metereologico) e ne deduco quindi che Trump avrà rassicurato Ghani: restiamo, magari anzi rilanciamo. Meglio prenderla con ironia.
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
Benazir, la signora del Sindh
Il 2 dicembre 1988 Benezir Bhutto diventa la prima donna a capo di un governo in un Paese musulmano. Icona? Eroina, Figura controversa? Cosa resta della sua eredità ? Un profilo andato in onda ieri a Wikiradio
Il suono delle sirene. Le grida della gente. Polizia, ambulanze, soldati. Gente straziata dalle esplosioni che il 27 dicembre del 2007, dopo che un cecchino le ha sparato, esplodono accanto all’auto blindata d Benazir Bhutto, della donna due volte premier del Pakistan e che forse potrebbe vincere le elezioni che si devono svolgere all’inizio dell’anno.
La sua storia, la storia dell’erede di una dinastia che ha già dato un primo ministro al Pakistan e che governa un grande partito popolare, finisce quel giorno. E bisogna allora andare a un altro dicembre, quasi vent’anni prima, quando Benazir Bhutto entra nella politica pachistana e la sconvolge. E’ la prima donna premier in un Paese musulmano ed è la prima donna a capo di un governo civile in un Paese che ha una lunga storia di dittature militari. Il 2 dicembre del 1988, Benazir, a capo di un partito importante ed erede del messaggio politico di suo padre Zulfikar, riempie le pagine dei giornali e inonda le televisioni di tutto il mondo.
E’ un caso politico straordinario, è bellissima e ha un carattere d’acciaio. Dirà di sé: Ho sempre avuto fiducia in me stessa e ho sempre pensato che sarei diventata primo ministro se lo avessi voluto. All’epoca ha solo 35 anni che manifesta con una voce suadente e gentile in un ottimo inglese imparato ad Harvard e a Oxford
Il video dell’assassionio di Benazir di Global Daily News
Quell’inizio di dicembre del 1988 sembra segnare una nuova era in un’epoca che vede questa parte dell’Asia in preda a convulsioni pericolose: da quasi dieci anni si combatte in Afghanistan contro i russi. Il Pakistan, che ha appena subito la feroce dittatura del generale Zia Ul Haq, ha già combattuto tre guerre con l’India e nel 1971 ha perso la sua costola orientale, diventata Bangladesh, in uno scontro tra Islamabad e i secessionisti bengalesi sostenuti da Nuova Delhi. E’ uno strappo mai digerito e che, con la questione mai risolta del Kashmir, ancora oggi rende nemiche queste due sorelle – l’India e il Pakistan –, sorelle nate dalla Partiton del Raj britannico nel 1947. UN parto gemellare bizzarro quanto gravido di conseguenze.
Ma prima di vedere le promesse di Benazir e quel che davvero riesce a realizzare il suo governo,
dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare proprio a quel 1971 quando Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir, ricopre per la prima volta la carica di presidente del Pakistan. A capo dello Stato dal ‘71 al ‘73 e poi premier dal ‘73 al ‘77, anche Zulfikar è una speranza. E’ un civile e non un militare. E’ un socialista, visto con timore e sospetto a Washington ma anche indigesto a Mosca proprio perché il Pakistan guarderà con sempre maggior simpatia alla Cina. E’ a capo del Partito popolare del Pakistan, il PPP, ed è un oratore appassionato e instancabile che ama i bagni di folla e che sa entusiasmare la sua platea
Ma la sua carriera politica, nella miglior tradizione del Paese, viene fermata da un generale. Un generale – il generale Zia Ul Haq – cui non piace il socialismo di Bhutto e che vorrebbe un ritorno all’islam che per Zia deve essere il collante del Paese dei puri. Molto, molto più che per quel proprietario terriero del Sindh troppo laico per i suoi gusti e che parla di religione senza praticarla veramente. Bhutto in realtà, popolare tra i poveri, piace poco anche a molti uomini del suo partito. Personaggi che gli remano contro e che dopo le elezioni legislative che lo vedono primeggiare decretano illegittima la sua vittoria. La situazione di caos giustifica agli occhi dell’esercito il ritorno al potere delle divise e nel luglio del 1977 Bhutto viene arrestato. Ma Zia non si ferma qui. Lo vuole morto. Giustizia, dice va fatta: senza distinzioni, dall’uomo della strada al premier. Zia, che ribalterà la politica di nazionalizzazioni di Bhutto privatizzando le aziende nazionalizzate, nel 79 lo fa condannare a morte per omicidio. Giustizia va fatta
Benazir racconterà nella sua autobiografia intitolata “Figlia del destino” le ultime ore di suo padre
prima dell’impiccagione. Anche lei è in prigione perché Zia ha fatto terra bruciata. A quell’epoca ha solo 26 anni ma già si sente investita dell’eredità politica di suo Padre. Si sente appunto la figlia del destino. Un destino che per adesso deve aspettare. Fino al dicembre del 1988 quando viene eletta e scelta a guidare il governo
La forza politica di Benazir sta in realtà anche nell’ondata emotiva che ha travolto il Paese con la morte di suo padre e quando nell’agosto del 1988, l’aereo che trasporta il dittatore Zia si schianta per motivi mai realmente appurati, arriva l’occasione. Casualità? Attentato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che il PPP riprende vigore e la casta militare fa un passo indietro. Il partito popolare vuole giocare la carta Benazir. La roccaforte del Ppp è quella dei Bhutto, la provincia agricola e meridionale del Sindh, ma quel cognome è una carta che si può spendere dal Punjab al Belucistan, da Lahore a Peshawar. Benazir, che intanto si è sposata con Asif Zardari, viene candidata. La tela è stata tessuta tra Islamabad, la capitale, Karachi, la grande metropoli del Sindh e città natale di Benazir, Lahore, il capoluogo della provincia più importante – il Punjab – e Londra, dove Benazir è andata a vivere con la famiglia. Il Pakistan è un posto pericoloso per i Bhutto: nel 1985 suo fratello Shahnawaz è stato avvelenato, forse proprio su ordine di Zia. Prigione, arresti domiciliari, intimidazioni e minacce continue l’hanno costretta all’esilio. Non sarà l’unica volta.
Il primo gabinetto Bhutto non dura 500 giorni. Nell’agosto del 1990 il governo cade e Benazir affronta per la prima volta il peso di accuse che si ripeteranno per lei e per suo marito che il popolino chiama mister 10%. Asif Zardari è un imprenditore, due anni più giovane di Benazir, e non è affatto amato in Pakistan. Lei piace, lui assai meno. I detrattori di Benazir ne approfittano e il confine tra verità e persecuzione politica diventa labile in un Paese dove il sistema giudiziario è sottoposto a forti pressioni politiche. Ciò non impedirà poi a Zardari di diventare presidente del Pakistan e copresidente del PPP, carica che ancora riveste, Ma la sua carriera nel partito e nel governo si deve a sua moglie più che alle sue doti politiche. Nel 1993 infatti Benazir ci riprova e vince nuovamente le elezioni. Forse anche per proteggere il marito, lo coopta nel governo come ministro federale per gli investimenti, un posto chiave nell’economia del Paese. Diventa anche responsabile della protezione ambientale e controlla i servizi segreti civili. Non tutti digeriscono.
Tra quelli che non digeriscono c’è anche il fratello della signora Bhutto, Murtaza, che nella storia di Benazir e nella politica del Pakistan ha un ruolo importante. Classe 1954, un anno più giovane di lei, Ghulam Murtaza è un personaggio particolare: coraggioso, spericolato, vendicativo. La prima vendetta la vorrebbe fare per vendicare la morte di suo padre e durante la dittatura di Zia si macchia di due delitti: viene infatti accusato della morte di un politico conservatore da sempre nemico di suo padre e poi del sequestro di un aereo sul quale uccide un ostaggio. Scappa in Afganistan. Viene condannato a morte in contumacia da una corte militare.
Murtaza torna in Pakistan nel 1993 quando sua sorella è al governo ma lei lo fa arrestare anche se il periodo in prigione dura poco. Murtaza paga, esce e comincia la sua campagna politica. Prima tenta un abboccamento con la sorella: vuole un ritorno alle origini del Ppp a patto però che Zardari esca di scena. Ma quando Benazir rifiuta, Murtaza diventa uno dei più fieri critici del suo governo: diventa un ostacolo imbarazzante e nel 1996 viene ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. E’ uno dei motivi, accanto alle reiterate accuse di corruzione, che faranno decidere al presidente Farooq Leghari di sfiduciare nuovamente il governo di Benazir. E’ la seconda volta e in questa occasione pesa anche l’accusa che ci possa essere un legame tra la morte di Murtaza e Zardari, il marito di Benazir, che viene accusato di omicidio ma non sarà mai condannato perché il suo coinvolgimento non viene provato.
La storia, l’eredità politica, i legami con la famiglia di origine, la fedeltà alla nuova famiglia creata con Asif Zardari pesano e continueranno a pesare su Benazir. Esautorata dal presidente e diventata impopolare per la morte del fratello e per gli scandali che riguardano il marito, Benazir deve affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Problemi con la giustizia, accuse, ombre e una macchina politica che cerca di liberarsi di lei. Ma cosa ha fatto intanto nei suoi tre anni di governo? Cosa si lascia alle spalle? Il suo mandato è stato continuamente turbato dalle accuse a lei e al marito di aver usato la macchina dello Stato a fini personali. Governo e economia sono in affanno e inoltre alle Nazioni Unite vengono decise sanzioni contro il programma nucleare pachistano. Nei circoli militari e nei servizi segreti, dove restano forti le simpatie per l’ex dittatore Zia ul Haq e per Nawaz Sharif, il leader conservatore più volte premier e attuale primo ministro, ebbene in quei circoli si morde il freno. Nel 1995 alcuni settori delle forze armate tentano l’ennesimo golpe che però fallisce. Non è un buon segno.
E’ il segno che in Pakistan i governi civili sono deboli e c’è chi decide per loro, chi dietro le quinte minaccia e dà consigli che si devono seguire. E’ il caso dei talebani, il movimento guerrigliero afgano che proprio nel settembre 1996 prenderà Kabul mentre Benazir è ancora al governo. Ma i talebani sono attivi in Afghanistan dal 1994 e ancor prima sono stati allevati e ospitati nelle madrase lungo il confine pachistano afgano. Benazir lo sa e approva. Il suo è uno dei pochi governi a riconoscere ufficialmente l’emirato islamico di mullah Omar. Dell’eredità di suo padre non le resta molto se non una politica estera che vede con favore l’alleanza con alcuni Paesi socialisti, esclusa però l’Unione sovietica contro cui il Pakistan ha combattuto in Afghanistan sostenendo i mujaheddin durante l’invasione di Mosca.
In economia segue la politica di privatizzazioni del suo predecessore Nawaz Sharif e resiste solo su due imprese pubbliche nazionali che restano nelle mani dello Stato: ferrovie e acciaierie. Anche il bilancio delle sue promesse elettorali in favore delle donne è negativo. Molte parole, pochi fatti. Così come con i talebani. Se Benazir è laica, si scaglia contro il fanatismo religioso, è a favore delle donne, non ha esitato però a servirsi degli islamisti, una vecchia scelta dei politici pachistani che ancora oggi avvelena quel Paese.
Eppure Benazir resta una figura di riferimento. Resta l’icona di un Pakistan guidato da un governo  civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
civile, di un Paese islamico dove al potere è andata una donna. Il mito resiste e la prova è che, dal suo nuovo esilio tra Dubai e Londra, mentre suo marito è finito in carcere e ogni giorno ha a che fare con nuovi guai giudiziari, Benazir non smette di lottare. Ha buon gioco nel farlo perché in Pakistan le accuse di omicidio o corruzione sono spesso solo il modo per impadronirsi del potere mettendo nei guai il rivale. Dagli slum di Karachi, dalle periferie di Peshawar, dal cuore del Sindh rurale, i diseredati credono ancora in lei. La donna è abile. Anche se in esilio, governa da Dubai l’opposizione al premier Nawaz Sharif nuovamente tornato in auge. Lo accusa di una politica poco aggressiva, di non essere capace di rispondere alle provocazioni nucleari dell’India.
L’ennesima guerra in Kashmir, il cosiddetto incidente di Kargil, affonda la popolarità di Nawaz Sharif e fa brillare la stella di Benazir. Bhutto riesce a giocare anche col nuovo protagonista in divisa che nel 1999 deporrà Sharif con un colpo di stato, il generale Pervez Musharraf. Lo sfida e riesce a ottenere da lui, che la comunità internazionale ha messo al bando, il rientro in patria. Sa inoltre che il generale golpista, senza volerlo, le ha spianato la strada: ha eliminato dalla scena il rivale più pericoloso e ha indebolito il suo partito. Inoltre Musharraf non gode dell’appoggio popolare. E’ il momento di tornare anche perché il dittatore, in cerca di consensi, è pronto a firmare un’amnistia che proscioglie lei e suo marito da ogni accusa.
Il 19 ottobre 2007, dopo otto anni di esilio, il ritorno a casa nella sua Karachi è l’ennesimo trionfo. Le accuse contro suo marito sono cadute e alla fine la sua famiglia da carnefice è diventata vittima. E’ una donna che è già sfuggita a più di un attentato, a persecuzioni e accuse. Ha ancora coraggio da vendere, sa come scaldare cuori e passioni. Incarna ancora una promessa di riscatto. Ma è un trionfo che non durerà. Nel dicembre del 2007, vent’anni dopo quel dicembre del 1988, questa volta ad aspettarla non c’è lo scranno da primo ministro. C’è la morte che la colpisce dopo il suo ultimo discorso.
Ironia della sorte vuole che a ucciderla saranno proprio i talebani pachistani anche se nessuno saprà mai esattamente chi ha armato veramente quelle mani. Il Paese dei puri, il Paese di Benazir, è anche il Paese di molti misteri irrisolti.
Il podcast (regia di Marco Motta)
Audio Rai.TV – Wikiradio – Benazir Bhutto – Wikiradio del 02/12/2016
Le immagini: dall’alto: Benazir, suo padre Zulfikar, il generale Zia, il marito Zardari e il generale Musharraf
La guerra fredda tra Kabul e Islamabad
 Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Non è la prima volta che si sentono accuse simili. Una sorta di gara a dimostrare – non senza qualche ragione – che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio “rifugio” sicuro. Il santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese confinante. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 – quando una serie di attentati in Afghanistan ha fatto da corollario al naufragio di un neonato tentativo negoziale – e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione: aspra e dai tratti durissimi. Non solo nei toni. Pakistan e Afghanistan si creano problemi alla frontiera per il transito delle rispettive mercanzie; i servizi segreti anziché collaborare nascondono le informazioni; i governi si accusano vicendevolmente di ospitare e proteggere i terroristi; il Pakistan infine ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. La cosa (le espulsioni hanno già raggiunto quota 400mila) mette in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani senza visto che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi.
Benché raramente si metta l’accento sull’importanza dei rapporti tra Islamabad e Kabul, in questi mesi la tensione tra i due Paesi è così elevata da costituire forse il principale macigno sul futuro di un processo di pace che dovrebbe portare a negoziare il governo d Ashraf Ghani coi talebani di mullah Akhundzada. Come abbiamo visto c’è un primo elemento di contenzioso che riguarda i “santuari”. Il Pakistan ne ha sempre forniti ai talebani (a Quetta, nel Waziristan e in genere nelle aree tribali) e l’Afghanistan sta facendo adesso la stessa cosa, ad esempio con mullah Fazlullah, il leader dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan/ Ttp), che sarebbe “tollerato” oltrefrontiera. L’altro problema riguarda il processo negoziale in sé. Islamabad vorrebbe controllarlo e, se non aver l’ultima parola, garantirsi a Kabul un governo amico (non, come ora, un esecutivo in buoni rapporti con l’India).
Se sul primo punto siamo a bocce ferme (e l’espulsione di 400mila afgani lo conferma) sul secondo andiamo ancora peggio. Il processo negoziale che nell’estate di un anno fa era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni al movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte sembrava aver affossato ogni possibile apertura negoziale e aveva visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader.
Il negoziato coi talebani (il governo ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyaar) avrebbero però marciato sotto traccia tanto che, in ottobre, il quotidiano britannico The Guardian ha dato notizia di due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” del movimento guerrigliero. I talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano Mohammad Hanif Atmar, National Security Advisor del presidente Ashraf Ghani, e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche il figlio di Omar, Mohammad Yaqub. Infine sarebbe stato presente un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan. Insomma c’erano tutti tranne i pachistani. Poi però i talebani hanno inviato una delegazione ufficiale in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” Islamabad su quanto avvenuto a Doha.
Se la missione diplomatica talebana abbia ricucito non è chiaro né è chiaro cosa riserverà il futuro. Lo spiraglio è ancora debole e compromesso da troppe frizioni, interrogativi, tensioni. Vale la pena di aggiungere al quadro la lettera che ha scritto a mullah Akhundzada l’ex portavoce di mullah Omar, Tayyeb Agha, già responsabile dell’ufficio di Doha prima di dimettersi dall’incarico per contrasti con Mansur. Tayyeb Aga scrive al capo talebano che dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e che persino la qualifica Emirato andrebbe sostituita da un termine più modesto: “movimento”, dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Aga chiede alla leadership, che rimprovera di stare per lo più oltre frontiera, di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland” (la traduzione inglese dal pashto è di Radio Free Europe). La lettera è importante perché dà conto di un dibattito interno che tende ad allargarsi a temi non solo prettamente militari. Tayyeb Agha – che resta una figura di rilievo – critica infatti anche i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani e mette il dito nella piaga degli “stranieri”: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e anche per i talebani pachistani del Ttp.
Questo quadro è purtroppo sempre accompagnato da una preoccupante cornice: Unama, la missione Onu a Kabul, ha reso noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015: 11.002 (3.545 morti, 7.457 feriti). I dati mostrano un incremento complessivo del 4% rispetto al 2014 con un trend impressionante di crescita (nel 2009 i morti erano stati 2.412). Quanto ai soldati dell’esercito afgano, anche qui le cifre sono pesanti: tra gennaio e agosto 2016 – secondo fonti americane – sono stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti e i feriti sono stati 9.665. Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi. A completare il quadro, sono stati pubblicati i dati sulla produzione di oppio, fonte di finanziamento dei talebani ma anche zoccolo duro della criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine (Unodc), il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero (da 74mila ettari a oltre 81.300). La produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 quest’anno.
A questo quadro si può aggiungere il costo della guerra che il governo, solo negli ultimi due mesi, ha stimato a oltre 26 milioni di euro: a farne le spese 300 scuole, 41 centri sanitari, 7mila case, 50 moschee, 170 ponti e cento chilometri di strada.
La guerra fredda tra Kabul e Islamabad
 Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Non è la prima volta che si sentono accuse simili. Una sorta di gara a dimostrare – non senza qualche ragione – che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio “rifugio” sicuro. Il santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese confinante. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 – quando una serie di attentati in Afghanistan ha fatto da corollario al naufragio di un neonato tentativo negoziale – e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione: aspra e dai tratti durissimi. Non solo nei toni. Pakistan e Afghanistan si creano problemi alla frontiera per il transito delle rispettive mercanzie; i servizi segreti anziché collaborare nascondono le informazioni; i governi si accusano vicendevolmente di ospitare e proteggere i terroristi; il Pakistan infine ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. La cosa (le espulsioni hanno già raggiunto quota 400mila) mette in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani senza visto che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi.
Benché raramente si metta l’accento sull’importanza dei rapporti tra Islamabad e Kabul, in questi mesi la tensione tra i due Paesi è così elevata da costituire forse il principale macigno sul futuro di un processo di pace che dovrebbe portare a negoziare il governo d Ashraf Ghani coi talebani di mullah Akhundzada. Come abbiamo visto c’è un primo elemento di contenzioso che riguarda i “santuari”. Il Pakistan ne ha sempre forniti ai talebani (a Quetta, nel Waziristan e in genere nelle aree tribali) e l’Afghanistan sta facendo adesso la stessa cosa, ad esempio con mullah Fazlullah, il leader dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan/ Ttp), che sarebbe “tollerato” oltrefrontiera. L’altro problema riguarda il processo negoziale in sé. Islamabad vorrebbe controllarlo e, se non aver l’ultima parola, garantirsi a Kabul un governo amico (non, come ora, un esecutivo in buoni rapporti con l’India).
Se sul primo punto siamo a bocce ferme (e l’espulsione di 400mila afgani lo conferma) sul secondo andiamo ancora peggio. Il processo negoziale che nell’estate di un anno fa era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni al movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte sembrava aver affossato ogni possibile apertura negoziale e aveva visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader.
Il negoziato coi talebani (il governo ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyaar) avrebbero però marciato sotto traccia tanto che, in ottobre, il quotidiano britannico The Guardian ha dato notizia di due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” del movimento guerrigliero. I talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano Mohammad Hanif Atmar, National Security Advisor del presidente Ashraf Ghani, e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche il figlio di Omar, Mohammad Yaqub. Infine sarebbe stato presente un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan. Insomma c’erano tutti tranne i pachistani. Poi però i talebani hanno inviato una delegazione ufficiale in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” Islamabad su quanto avvenuto a Doha.
Se la missione diplomatica talebana abbia ricucito non è chiaro né è chiaro cosa riserverà il futuro. Lo spiraglio è ancora debole e compromesso da troppe frizioni, interrogativi, tensioni. Vale la pena di aggiungere al quadro la lettera che ha scritto a mullah Akhundzada l’ex portavoce di mullah Omar, Tayyeb Agha, già responsabile dell’ufficio di Doha prima di dimettersi dall’incarico per contrasti con Mansur. Tayyeb Aga scrive al capo talebano che dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e che persino la qualifica Emirato andrebbe sostituita da un termine più modesto: “movimento”, dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Aga chiede alla leadership, che rimprovera di stare per lo più oltre frontiera, di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland” (la traduzione inglese dal pashto è di Radio Free Europe). La lettera è importante perché dà conto di un dibattito interno che tende ad allargarsi a temi non solo prettamente militari. Tayyeb Agha – che resta una figura di rilievo – critica infatti anche i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani e mette il dito nella piaga degli “stranieri”: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e anche per i talebani pachistani del Ttp.
Questo quadro è purtroppo sempre accompagnato da una preoccupante cornice: Unama, la missione Onu a Kabul, ha reso noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015: 11.002 (3.545 morti, 7.457 feriti). I dati mostrano un incremento complessivo del 4% rispetto al 2014 con un trend impressionante di crescita (nel 2009 i morti erano stati 2.412). Quanto ai soldati dell’esercito afgano, anche qui le cifre sono pesanti: tra gennaio e agosto 2016 – secondo fonti americane – sono stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti e i feriti sono stati 9.665. Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi. A completare il quadro, sono stati pubblicati i dati sulla produzione di oppio, fonte di finanziamento dei talebani ma anche zoccolo duro della criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine (Unodc), il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero (da 74mila ettari a oltre 81.300). La produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 quest’anno.
A questo quadro si può aggiungere il costo della guerra che il governo, solo negli ultimi due mesi, ha stimato a oltre 26 milioni di euro: a farne le spese 300 scuole, 41 centri sanitari, 7mila case, 50 moschee, 170 ponti e cento chilometri di strada.
La guerra fredda tra Kabul e Islamabad
 Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Non è la prima volta che si sentono accuse simili. Una sorta di gara a dimostrare – non senza qualche ragione – che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio “rifugio” sicuro. Il santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese confinante. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 – quando una serie di attentati in Afghanistan ha fatto da corollario al naufragio di un neonato tentativo negoziale – e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione: aspra e dai tratti durissimi. Non solo nei toni. Pakistan e Afghanistan si creano problemi alla frontiera per il transito delle rispettive mercanzie; i servizi segreti anziché collaborare nascondono le informazioni; i governi si accusano vicendevolmente di ospitare e proteggere i terroristi; il Pakistan infine ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. La cosa (le espulsioni hanno già raggiunto quota 400mila) mette in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani senza visto che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi.
Benché raramente si metta l’accento sull’importanza dei rapporti tra Islamabad e Kabul, in questi mesi la tensione tra i due Paesi è così elevata da costituire forse il principale macigno sul futuro di un processo di pace che dovrebbe portare a negoziare il governo d Ashraf Ghani coi talebani di mullah Akhundzada. Come abbiamo visto c’è un primo elemento di contenzioso che riguarda i “santuari”. Il Pakistan ne ha sempre forniti ai talebani (a Quetta, nel Waziristan e in genere nelle aree tribali) e l’Afghanistan sta facendo adesso la stessa cosa, ad esempio con mullah Fazlullah, il leader dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan/ Ttp), che sarebbe “tollerato” oltrefrontiera. L’altro problema riguarda il processo negoziale in sé. Islamabad vorrebbe controllarlo e, se non aver l’ultima parola, garantirsi a Kabul un governo amico (non, come ora, un esecutivo in buoni rapporti con l’India).
Se sul primo punto siamo a bocce ferme (e l’espulsione di 400mila afgani lo conferma) sul secondo andiamo ancora peggio. Il processo negoziale che nell’estate di un anno fa era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni al movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte sembrava aver affossato ogni possibile apertura negoziale e aveva visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader.
Il negoziato coi talebani (il governo ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyaar) avrebbero però marciato sotto traccia tanto che, in ottobre, il quotidiano britannico The Guardian ha dato notizia di due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” del movimento guerrigliero. I talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano Mohammad Hanif Atmar, National Security Advisor del presidente Ashraf Ghani, e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche il figlio di Omar, Mohammad Yaqub. Infine sarebbe stato presente un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan. Insomma c’erano tutti tranne i pachistani. Poi però i talebani hanno inviato una delegazione ufficiale in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” Islamabad su quanto avvenuto a Doha.
Se la missione diplomatica talebana abbia ricucito non è chiaro né è chiaro cosa riserverà il futuro. Lo spiraglio è ancora debole e compromesso da troppe frizioni, interrogativi, tensioni. Vale la pena di aggiungere al quadro la lettera che ha scritto a mullah Akhundzada l’ex portavoce di mullah Omar, Tayyeb Agha, già responsabile dell’ufficio di Doha prima di dimettersi dall’incarico per contrasti con Mansur. Tayyeb Aga scrive al capo talebano che dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e che persino la qualifica Emirato andrebbe sostituita da un termine più modesto: “movimento”, dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Aga chiede alla leadership, che rimprovera di stare per lo più oltre frontiera, di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland” (la traduzione inglese dal pashto è di Radio Free Europe). La lettera è importante perché dà conto di un dibattito interno che tende ad allargarsi a temi non solo prettamente militari. Tayyeb Agha – che resta una figura di rilievo – critica infatti anche i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani e mette il dito nella piaga degli “stranieri”: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e anche per i talebani pachistani del Ttp.
Questo quadro è purtroppo sempre accompagnato da una preoccupante cornice: Unama, la missione Onu a Kabul, ha reso noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015: 11.002 (3.545 morti, 7.457 feriti). I dati mostrano un incremento complessivo del 4% rispetto al 2014 con un trend impressionante di crescita (nel 2009 i morti erano stati 2.412). Quanto ai soldati dell’esercito afgano, anche qui le cifre sono pesanti: tra gennaio e agosto 2016 – secondo fonti americane – sono stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti e i feriti sono stati 9.665. Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi. A completare il quadro, sono stati pubblicati i dati sulla produzione di oppio, fonte di finanziamento dei talebani ma anche zoccolo duro della criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine (Unodc), il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero (da 74mila ettari a oltre 81.300). La produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 quest’anno.
A questo quadro si può aggiungere il costo della guerra che il governo, solo negli ultimi due mesi, ha stimato a oltre 26 milioni di euro: a farne le spese 300 scuole, 41 centri sanitari, 7mila case, 50 moschee, 170 ponti e cento chilometri di strada.
La guerra fredda tra Kabul e Islamabad
 Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Non è la prima volta che si sentono accuse simili. Una sorta di gara a dimostrare – non senza qualche ragione – che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio “rifugio” sicuro. Il santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese confinante. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 – quando una serie di attentati in Afghanistan ha fatto da corollario al naufragio di un neonato tentativo negoziale – e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione: aspra e dai tratti durissimi. Non solo nei toni. Pakistan e Afghanistan si creano problemi alla frontiera per il transito delle rispettive mercanzie; i servizi segreti anziché collaborare nascondono le informazioni; i governi si accusano vicendevolmente di ospitare e proteggere i terroristi; il Pakistan infine ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. La cosa (le espulsioni hanno già raggiunto quota 400mila) mette in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani senza visto che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi.
Benché raramente si metta l’accento sull’importanza dei rapporti tra Islamabad e Kabul, in questi mesi la tensione tra i due Paesi è così elevata da costituire forse il principale macigno sul futuro di un processo di pace che dovrebbe portare a negoziare il governo d Ashraf Ghani coi talebani di mullah Akhundzada. Come abbiamo visto c’è un primo elemento di contenzioso che riguarda i “santuari”. Il Pakistan ne ha sempre forniti ai talebani (a Quetta, nel Waziristan e in genere nelle aree tribali) e l’Afghanistan sta facendo adesso la stessa cosa, ad esempio con mullah Fazlullah, il leader dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan/ Ttp), che sarebbe “tollerato” oltrefrontiera. L’altro problema riguarda il processo negoziale in sé. Islamabad vorrebbe controllarlo e, se non aver l’ultima parola, garantirsi a Kabul un governo amico (non, come ora, un esecutivo in buoni rapporti con l’India).
Se sul primo punto siamo a bocce ferme (e l’espulsione di 400mila afgani lo conferma) sul secondo andiamo ancora peggio. Il processo negoziale che nell’estate di un anno fa era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni al movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte sembrava aver affossato ogni possibile apertura negoziale e aveva visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader.
Il negoziato coi talebani (il governo ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyaar) avrebbero però marciato sotto traccia tanto che, in ottobre, il quotidiano britannico The Guardian ha dato notizia di due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” del movimento guerrigliero. I talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano Mohammad Hanif Atmar, National Security Advisor del presidente Ashraf Ghani, e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche il figlio di Omar, Mohammad Yaqub. Infine sarebbe stato presente un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan. Insomma c’erano tutti tranne i pachistani. Poi però i talebani hanno inviato una delegazione ufficiale in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” Islamabad su quanto avvenuto a Doha.
Se la missione diplomatica talebana abbia ricucito non è chiaro né è chiaro cosa riserverà il futuro. Lo spiraglio è ancora debole e compromesso da troppe frizioni, interrogativi, tensioni. Vale la pena di aggiungere al quadro la lettera che ha scritto a mullah Akhundzada l’ex portavoce di mullah Omar, Tayyeb Agha, già responsabile dell’ufficio di Doha prima di dimettersi dall’incarico per contrasti con Mansur. Tayyeb Aga scrive al capo talebano che dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e che persino la qualifica Emirato andrebbe sostituita da un termine più modesto: “movimento”, dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Aga chiede alla leadership, che rimprovera di stare per lo più oltre frontiera, di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland” (la traduzione inglese dal pashto è di Radio Free Europe). La lettera è importante perché dà conto di un dibattito interno che tende ad allargarsi a temi non solo prettamente militari. Tayyeb Agha – che resta una figura di rilievo – critica infatti anche i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani e mette il dito nella piaga degli “stranieri”: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e anche per i talebani pachistani del Ttp.
Questo quadro è purtroppo sempre accompagnato da una preoccupante cornice: Unama, la missione Onu a Kabul, ha reso noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015: 11.002 (3.545 morti, 7.457 feriti). I dati mostrano un incremento complessivo del 4% rispetto al 2014 con un trend impressionante di crescita (nel 2009 i morti erano stati 2.412). Quanto ai soldati dell’esercito afgano, anche qui le cifre sono pesanti: tra gennaio e agosto 2016 – secondo fonti americane – sono stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti e i feriti sono stati 9.665. Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi. A completare il quadro, sono stati pubblicati i dati sulla produzione di oppio, fonte di finanziamento dei talebani ma anche zoccolo duro della criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine (Unodc), il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero (da 74mila ettari a oltre 81.300). La produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 quest’anno.
A questo quadro si può aggiungere il costo della guerra che il governo, solo negli ultimi due mesi, ha stimato a oltre 26 milioni di euro: a farne le spese 300 scuole, 41 centri sanitari, 7mila case, 50 moschee, 170 ponti e cento chilometri di strada.
La guerra fredda tra Kabul e Islamabad
 Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Il generale Qamar Javed Bajwa ha preso il posto del generale Raheel Sharif a capo delle forze armate pachistane in un momento di grandi tensioni con India e Afghanistan. Prende il comando dopo l’ultima querelle tra Kabul e Islamabad che riguarda il recente attacco del gruppo settario pachistano Lashkar-i-Jhangvi (LJ) all’accademia di polizia di Quetta il 25 ottobre scorso con un bilancio di oltre sessanta morti. Benché l’attentato sia stato rivendicato dallo Stato Islamico e messo in atto da un gruppo radicale nato nel Punjab pachistano e con un passato settario e sanguinario soprattutto in Belucistan (provincia di cui Quetta è la capitale), l’intelligence di Islamabad ha, seppur indirettamente, accusato Kabul. Le intercettazioni telefoniche dei membri del commando avrebbero rivelato, secondo Islamabad, che il cervello dell’operazione stava in Afghanistan.
Non è la prima volta che si sentono accuse simili. Una sorta di gara a dimostrare – non senza qualche ragione – che i gruppi che si muovono sul poroso confine tra i due Stati trovano, ora in Afghanistan ora soprattutto in Pakistan, il proprio “rifugio” sicuro. Il santuario da cui muovere o coordinare gli attentati nel Paese confinante. Questa tensione è andata crescendo nel tempo dall’agosto del 2015 – quando una serie di attentati in Afghanistan ha fatto da corollario al naufragio di un neonato tentativo negoziale – e accuse, ritorsioni, minacce tra i due Paesi hanno conosciuto una nuova stagione: aspra e dai tratti durissimi. Non solo nei toni. Pakistan e Afghanistan si creano problemi alla frontiera per il transito delle rispettive mercanzie; i servizi segreti anziché collaborare nascondono le informazioni; i governi si accusano vicendevolmente di ospitare e proteggere i terroristi; il Pakistan infine ha iniziato l’espulsione di un milione di afgani indocumentati che vivono oltre frontiera da decenni. La cosa (le espulsioni hanno già raggiunto quota 400mila) mette in difficoltà Kabul che ha già a che fare con oltre un milione di sfollati interni e ha appena firmato un accordo con l’Unione europea sui rimpatri forzati di afgani senza visto che prevede l’arrivo a Kabul di almeno 80mila persone nei prossimi sei mesi.
Benché raramente si metta l’accento sull’importanza dei rapporti tra Islamabad e Kabul, in questi mesi la tensione tra i due Paesi è così elevata da costituire forse il principale macigno sul futuro di un processo di pace che dovrebbe portare a negoziare il governo d Ashraf Ghani coi talebani di mullah Akhundzada. Come abbiamo visto c’è un primo elemento di contenzioso che riguarda i “santuari”. Il Pakistan ne ha sempre forniti ai talebani (a Quetta, nel Waziristan e in genere nelle aree tribali) e l’Afghanistan sta facendo adesso la stessa cosa, ad esempio con mullah Fazlullah, il leader dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan/ Ttp), che sarebbe “tollerato” oltrefrontiera. L’altro problema riguarda il processo negoziale in sé. Islamabad vorrebbe controllarlo e, se non aver l’ultima parola, garantirsi a Kabul un governo amico (non, come ora, un esecutivo in buoni rapporti con l’India).
Se sul primo punto siamo a bocce ferme (e l’espulsione di 400mila afgani lo conferma) sul secondo andiamo ancora peggio. Il processo negoziale che nell’estate di un anno fa era cominciato faticosamente a Murree in Pakistan sotto l’egida di Islamabad, si è poi arenato dopo l’annuncio della morte di mullah Omar sostituito, con diversi problemi interni al movimento talebano, da mullah Mansur (considerato molto filo pachistano), ucciso poi da un drone americano nel maggio del 2016. La sua morte sembrava aver affossato ogni possibile apertura negoziale e aveva visto una recrudescenza degli attacchi talebani – al cui comando è adesso mullah Akhundzada – volti a vendicare la morte dei due suoi leader.
Il negoziato coi talebani (il governo ha già firmato un accordo col gruppo guerrigliero di Gulbuddin Hekmatyaar) avrebbero però marciato sotto traccia tanto che, in ottobre, il quotidiano britannico The Guardian ha dato notizia di due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” del movimento guerrigliero. I talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano Mohammad Hanif Atmar, National Security Advisor del presidente Ashraf Ghani, e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche il figlio di Omar, Mohammad Yaqub. Infine sarebbe stato presente un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata statunitense in Afganistan. Insomma c’erano tutti tranne i pachistani. Poi però i talebani hanno inviato una delegazione ufficiale in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” Islamabad su quanto avvenuto a Doha.
Se la missione diplomatica talebana abbia ricucito non è chiaro né è chiaro cosa riserverà il futuro. Lo spiraglio è ancora debole e compromesso da troppe frizioni, interrogativi, tensioni. Vale la pena di aggiungere al quadro la lettera che ha scritto a mullah Akhundzada l’ex portavoce di mullah Omar, Tayyeb Agha, già responsabile dell’ufficio di Doha prima di dimettersi dall’incarico per contrasti con Mansur. Tayyeb Aga scrive al capo talebano che dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e che persino la qualifica Emirato andrebbe sostituita da un termine più modesto: “movimento”, dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Aga chiede alla leadership, che rimprovera di stare per lo più oltre frontiera, di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland” (la traduzione inglese dal pashto è di Radio Free Europe). La lettera è importante perché dà conto di un dibattito interno che tende ad allargarsi a temi non solo prettamente militari. Tayyeb Agha – che resta una figura di rilievo – critica infatti anche i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani e mette il dito nella piaga degli “stranieri”: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e anche per i talebani pachistani del Ttp.
Questo quadro è purtroppo sempre accompagnato da una preoccupante cornice: Unama, la missione Onu a Kabul, ha reso noto il bilancio complessivo delle vittime civili nel 2015: 11.002 (3.545 morti, 7.457 feriti). I dati mostrano un incremento complessivo del 4% rispetto al 2014 con un trend impressionante di crescita (nel 2009 i morti erano stati 2.412). Quanto ai soldati dell’esercito afgano, anche qui le cifre sono pesanti: tra gennaio e agosto 2016 – secondo fonti americane – sono stati uccisi 5.523 tra soldati e poliziotti e i feriti sono stati 9.665. Cifre cui bisogna aggiungere i caduti tra la guerriglia di cui non ci sono dati certi. A completare il quadro, sono stati pubblicati i dati sulla produzione di oppio, fonte di finanziamento dei talebani ma anche zoccolo duro della criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Secondo l’Agenzia per la droga e il crimine (Unodc), il 2016 vede un incremento del 10% delle aree coltivate col papavero (da 74mila ettari a oltre 81.300). La produzione dovrebbe invece registrare un aumento addirittura del 43%: da 3.300 metri cubi nel 2015 a 4.800 quest’anno.
A questo quadro si può aggiungere il costo della guerra che il governo, solo negli ultimi due mesi, ha stimato a oltre 26 milioni di euro: a farne le spese 300 scuole, 41 centri sanitari, 7mila case, 50 moschee, 170 ponti e cento chilometri di strada.
Ho un’ape (marocchina) per la testa
 |
| La città marocchina dalle montagne sotto il video del progetto Coobeeration |
Chefchaouen è una città del Marocco famosa per la sua medina – la città vecchia – motivo per il quale è diventata nel 2010 un patrimonio dell’umanità. La cosa è stata possibile attraverso un passaggio singolare ossia la presenza di questa città, che ha un sindaco abile quanto attivo e simpatico, nel percorso della Dieta mediterranea della quale questo villaggione marocchino
rappresenta uno dei fulcri meridionali. Ma da qualche giorno la città si è impegnata – nella persona del suo sindaco, Mohammed Sefiani – a essere la prima città marocchina “amica delle api”. Non solo: si è anche impegnata a coinvolgere due associazioni tra città marocchine di cui ha la presidenza, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, perché ancor più municipalità del regno diventino “amiche delle api”. L’occasione è stato il Forum degli apicultori del Mediterraneo, organizzato in Marocco dall’Associazione ApiMed, a pochi giorni dalle conclusioni di COOP22. Al Forum hanno partecipato 200 delegati che rappresentano i diversi Paesi aderenti all’associazione transnazionale (Marocco, Italia, Francia, Egitto, Palestina, Giordania, Iraq, Algeria, Libano, Tunisia) con università e centri di ricerca, enti locali, organizzazioni internazionali (Undp) e attori di cooperazione oltre a moltissimi apicoltori soprattutto marocchini.
Dal Forum è uscito anche molto altro: una vera sorpresa per chi, come me, mangia volentieri il miele ma ne sa davvero poco.
Intanto un concorso internazionale tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che selezioni il miglior miele prodotto sulle rive del mare che abbracci Europa, Africa e Medio Oriente. E poi una giornata di sensibilizzazione su apicoltura, biodiversità e sicurezza alimentare in tutte le città aderenti all’iniziativa “Comuni amici delle api”. “L’idea – mi spiega Vincenzo Panettieri Presidente di ApiMed – parte dal rilancio della Carta dei mieli del Mediterraneo approvata l’anno scorso a Tunisi. Il concorso infatti vuole mettere alla prova la qualità e gli standerd degli apicoltori mediterranei, varcando i confini nazionali ed entrando in contatto con una realtà produttiva più ampia”. Tuti collaboreranno per determinare il vincitore. Dai laboratori tunisini alle università italiane, ai centri di ricerca di Grecia o Marocco. Lucia Maddoli, di FELCOS (il fondo dei comuni umbri per la cooperazione) e coordinatrice del progetto Mediterranean CooBEEration, aggiunge che però “è anche importante creare per la prossima primavera una giornata internazionale di informazione ai cittadini per spiegare il valore dell’apicoltura come bene comune e perché l’ape è un alleato fondamentale per la difesa della biodiversità”.
In effetti sul reale valore delle api come attori primari della biodiversità sappiamo poco. Eppure si stima che l’impollinazione delle specie vegetali – di cui l’ape garantisce la continuità nella riproduzione – equivalga, in termini alimentari, a un terzo di quanto arriva sulle nostre tavole. ApiMed rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e decine di migliaia di apicoltori che producono un miele che rispetta standard definiti in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiani. Ma non c’è solo un obiettivo “produttivo”. Qualcuno al Forum ha fatto notare che le api che hanno le loro arnie a Gerusalemme o nei Territori occupati di Palestina, si fanno un baffo del muro. Fanno il loro lavoro in nome del miele e, senza saperlo, di un mondo senza confini.
Ho un’ape (marocchina) per la testa
 |
| La città marocchina dalle montagne sotto il video del progetto Coobeeration |
Chefchaouen è una città del Marocco famosa per la sua medina – la città vecchia – motivo per il quale è diventata nel 2010 un patrimonio dell’umanità. La cosa è stata possibile attraverso un passaggio singolare ossia la presenza di questa città, che ha un sindaco abile quanto attivo e simpatico, nel percorso della Dieta mediterranea della quale questo villaggione marocchino
rappresenta uno dei fulcri meridionali. Ma da qualche giorno la città si è impegnata – nella persona del suo sindaco, Mohammed Sefiani – a essere la prima città marocchina “amica delle api”. Non solo: si è anche impegnata a coinvolgere due associazioni tra città marocchine di cui ha la presidenza, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, perché ancor più municipalità del regno diventino “amiche delle api”. L’occasione è stato il Forum degli apicultori del Mediterraneo, organizzato in Marocco dall’Associazione ApiMed, a pochi giorni dalle conclusioni di COOP22. Al Forum hanno partecipato 200 delegati che rappresentano i diversi Paesi aderenti all’associazione transnazionale (Marocco, Italia, Francia, Egitto, Palestina, Giordania, Iraq, Algeria, Libano, Tunisia) con università e centri di ricerca, enti locali, organizzazioni internazionali (Undp) e attori di cooperazione oltre a moltissimi apicoltori soprattutto marocchini.
Dal Forum è uscito anche molto altro: una vera sorpresa per chi, come me, mangia volentieri il miele ma ne sa davvero poco.
Intanto un concorso internazionale tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che selezioni il miglior miele prodotto sulle rive del mare che abbracci Europa, Africa e Medio Oriente. E poi una giornata di sensibilizzazione su apicoltura, biodiversità e sicurezza alimentare in tutte le città aderenti all’iniziativa “Comuni amici delle api”. “L’idea – mi spiega Vincenzo Panettieri Presidente di ApiMed – parte dal rilancio della Carta dei mieli del Mediterraneo approvata l’anno scorso a Tunisi. Il concorso infatti vuole mettere alla prova la qualità e gli standerd degli apicoltori mediterranei, varcando i confini nazionali ed entrando in contatto con una realtà produttiva più ampia”. Tuti collaboreranno per determinare il vincitore. Dai laboratori tunisini alle università italiane, ai centri di ricerca di Grecia o Marocco. Lucia Maddoli, di FELCOS (il fondo dei comuni umbri per la cooperazione) e coordinatrice del progetto Mediterranean CooBEEration, aggiunge che però “è anche importante creare per la prossima primavera una giornata internazionale di informazione ai cittadini per spiegare il valore dell’apicoltura come bene comune e perché l’ape è un alleato fondamentale per la difesa della biodiversità”.
In effetti sul reale valore delle api come attori primari della biodiversità sappiamo poco. Eppure si stima che l’impollinazione delle specie vegetali – di cui l’ape garantisce la continuità nella riproduzione – equivalga, in termini alimentari, a un terzo di quanto arriva sulle nostre tavole. ApiMed rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e decine di migliaia di apicoltori che producono un miele che rispetta standard definiti in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiani. Ma non c’è solo un obiettivo “produttivo”. Qualcuno al Forum ha fatto notare che le api che hanno le loro arnie a Gerusalemme o nei Territori occupati di Palestina, si fanno un baffo del muro. Fanno il loro lavoro in nome del miele e, senza saperlo, di un mondo senza confini.
Ho un’ape (marocchina) per la testa
 |
| La città marocchina dalle montagne sotto il video del progetto Coobeeration |
Chefchaouen è una città del Marocco famosa per la sua medina – la città vecchia – motivo per il quale è diventata nel 2010 un patrimonio dell’umanità. La cosa è stata possibile attraverso un passaggio singolare ossia la presenza di questa città, che ha un sindaco abile quanto attivo e simpatico, nel percorso della Dieta mediterranea della quale questo villaggione marocchino
rappresenta uno dei fulcri meridionali. Ma da qualche giorno la città si è impegnata – nella persona del suo sindaco, Mohammed Sefiani – a essere la prima città marocchina “amica delle api”. Non solo: si è anche impegnata a coinvolgere due associazioni tra città marocchine di cui ha la presidenza, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, perché ancor più municipalità del regno diventino “amiche delle api”. L’occasione è stato il Forum degli apicultori del Mediterraneo, organizzato in Marocco dall’Associazione ApiMed, a pochi giorni dalle conclusioni di COOP22. Al Forum hanno partecipato 200 delegati che rappresentano i diversi Paesi aderenti all’associazione transnazionale (Marocco, Italia, Francia, Egitto, Palestina, Giordania, Iraq, Algeria, Libano, Tunisia) con università e centri di ricerca, enti locali, organizzazioni internazionali (Undp) e attori di cooperazione oltre a moltissimi apicoltori soprattutto marocchini.
Dal Forum è uscito anche molto altro: una vera sorpresa per chi, come me, mangia volentieri il miele ma ne sa davvero poco.
Intanto un concorso internazionale tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che selezioni il miglior miele prodotto sulle rive del mare che abbracci Europa, Africa e Medio Oriente. E poi una giornata di sensibilizzazione su apicoltura, biodiversità e sicurezza alimentare in tutte le città aderenti all’iniziativa “Comuni amici delle api”. “L’idea – mi spiega Vincenzo Panettieri Presidente di ApiMed – parte dal rilancio della Carta dei mieli del Mediterraneo approvata l’anno scorso a Tunisi. Il concorso infatti vuole mettere alla prova la qualità e gli standerd degli apicoltori mediterranei, varcando i confini nazionali ed entrando in contatto con una realtà produttiva più ampia”. Tuti collaboreranno per determinare il vincitore. Dai laboratori tunisini alle università italiane, ai centri di ricerca di Grecia o Marocco. Lucia Maddoli, di FELCOS (il fondo dei comuni umbri per la cooperazione) e coordinatrice del progetto Mediterranean CooBEEration, aggiunge che però “è anche importante creare per la prossima primavera una giornata internazionale di informazione ai cittadini per spiegare il valore dell’apicoltura come bene comune e perché l’ape è un alleato fondamentale per la difesa della biodiversità”.
In effetti sul reale valore delle api come attori primari della biodiversità sappiamo poco. Eppure si stima che l’impollinazione delle specie vegetali – di cui l’ape garantisce la continuità nella riproduzione – equivalga, in termini alimentari, a un terzo di quanto arriva sulle nostre tavole. ApiMed rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e decine di migliaia di apicoltori che producono un miele che rispetta standard definiti in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiani. Ma non c’è solo un obiettivo “produttivo”. Qualcuno al Forum ha fatto notare che le api che hanno le loro arnie a Gerusalemme o nei Territori occupati di Palestina, si fanno un baffo del muro. Fanno il loro lavoro in nome del miele e, senza saperlo, di un mondo senza confini.
Ho un’ape (marocchina) per la testa
 |
| La città marocchina dalle montagne sotto il video del progetto Coobeeration |
Chefchaouen è una città del Marocco famosa per la sua medina – la città vecchia – motivo per il quale è diventata nel 2010 un patrimonio dell’umanità. La cosa è stata possibile attraverso un passaggio singolare ossia la presenza di questa città, che ha un sindaco abile quanto attivo e simpatico, nel percorso della Dieta mediterranea della quale questo villaggione marocchino
rappresenta uno dei fulcri meridionali. Ma da qualche giorno la città si è impegnata – nella persona del suo sindaco, Mohammed Sefiani – a essere la prima città marocchina “amica delle api”. Non solo: si è anche impegnata a coinvolgere due associazioni tra città marocchine di cui ha la presidenza, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, perché ancor più municipalità del regno diventino “amiche delle api”. L’occasione è stato il Forum degli apicultori del Mediterraneo, organizzato in Marocco dall’Associazione ApiMed, a pochi giorni dalle conclusioni di COOP22. Al Forum hanno partecipato 200 delegati che rappresentano i diversi Paesi aderenti all’associazione transnazionale (Marocco, Italia, Francia, Egitto, Palestina, Giordania, Iraq, Algeria, Libano, Tunisia) con università e centri di ricerca, enti locali, organizzazioni internazionali (Undp) e attori di cooperazione oltre a moltissimi apicoltori soprattutto marocchini.
Dal Forum è uscito anche molto altro: una vera sorpresa per chi, come me, mangia volentieri il miele ma ne sa davvero poco.
Intanto un concorso internazionale tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che selezioni il miglior miele prodotto sulle rive del mare che abbracci Europa, Africa e Medio Oriente. E poi una giornata di sensibilizzazione su apicoltura, biodiversità e sicurezza alimentare in tutte le città aderenti all’iniziativa “Comuni amici delle api”. “L’idea – mi spiega Vincenzo Panettieri Presidente di ApiMed – parte dal rilancio della Carta dei mieli del Mediterraneo approvata l’anno scorso a Tunisi. Il concorso infatti vuole mettere alla prova la qualità e gli standerd degli apicoltori mediterranei, varcando i confini nazionali ed entrando in contatto con una realtà produttiva più ampia”. Tuti collaboreranno per determinare il vincitore. Dai laboratori tunisini alle università italiane, ai centri di ricerca di Grecia o Marocco. Lucia Maddoli, di FELCOS (il fondo dei comuni umbri per la cooperazione) e coordinatrice del progetto Mediterranean CooBEEration, aggiunge che però “è anche importante creare per la prossima primavera una giornata internazionale di informazione ai cittadini per spiegare il valore dell’apicoltura come bene comune e perché l’ape è un alleato fondamentale per la difesa della biodiversità”.
In effetti sul reale valore delle api come attori primari della biodiversità sappiamo poco. Eppure si stima che l’impollinazione delle specie vegetali – di cui l’ape garantisce la continuità nella riproduzione – equivalga, in termini alimentari, a un terzo di quanto arriva sulle nostre tavole. ApiMed rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e decine di migliaia di apicoltori che producono un miele che rispetta standard definiti in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiani. Ma non c’è solo un obiettivo “produttivo”. Qualcuno al Forum ha fatto notare che le api che hanno le loro arnie a Gerusalemme o nei Territori occupati di Palestina, si fanno un baffo del muro. Fanno il loro lavoro in nome del miele e, senza saperlo, di un mondo senza confini.
Ho un’ape (marocchina) per la testa
 |
| La città marocchina dalle montagne sotto il video del progetto Coobeeration |
Chefchaouen è una città del Marocco famosa per la sua medina – la città vecchia – motivo per il quale è diventata nel 2010 un patrimonio dell’umanità. La cosa è stata possibile attraverso un passaggio singolare ossia la presenza di questa città, che ha un sindaco abile quanto attivo e simpatico, nel percorso della Dieta mediterranea della quale questo villaggione marocchino
rappresenta uno dei fulcri meridionali. Ma da qualche giorno la città si è impegnata – nella persona del suo sindaco, Mohammed Sefiani – a essere la prima città marocchina “amica delle api”. Non solo: si è anche impegnata a coinvolgere due associazioni tra città marocchine di cui ha la presidenza, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, perché ancor più municipalità del regno diventino “amiche delle api”. L’occasione è stato il Forum degli apicultori del Mediterraneo, organizzato in Marocco dall’Associazione ApiMed, a pochi giorni dalle conclusioni di COOP22. Al Forum hanno partecipato 200 delegati che rappresentano i diversi Paesi aderenti all’associazione transnazionale (Marocco, Italia, Francia, Egitto, Palestina, Giordania, Iraq, Algeria, Libano, Tunisia) con università e centri di ricerca, enti locali, organizzazioni internazionali (Undp) e attori di cooperazione oltre a moltissimi apicoltori soprattutto marocchini.
Dal Forum è uscito anche molto altro: una vera sorpresa per chi, come me, mangia volentieri il miele ma ne sa davvero poco.
Intanto un concorso internazionale tra tutti gli apicoltori del Mediterraneo che selezioni il miglior miele prodotto sulle rive del mare che abbracci Europa, Africa e Medio Oriente. E poi una giornata di sensibilizzazione su apicoltura, biodiversità e sicurezza alimentare in tutte le città aderenti all’iniziativa “Comuni amici delle api”. “L’idea – mi spiega Vincenzo Panettieri Presidente di ApiMed – parte dal rilancio della Carta dei mieli del Mediterraneo approvata l’anno scorso a Tunisi. Il concorso infatti vuole mettere alla prova la qualità e gli standerd degli apicoltori mediterranei, varcando i confini nazionali ed entrando in contatto con una realtà produttiva più ampia”. Tuti collaboreranno per determinare il vincitore. Dai laboratori tunisini alle università italiane, ai centri di ricerca di Grecia o Marocco. Lucia Maddoli, di FELCOS (il fondo dei comuni umbri per la cooperazione) e coordinatrice del progetto Mediterranean CooBEEration, aggiunge che però “è anche importante creare per la prossima primavera una giornata internazionale di informazione ai cittadini per spiegare il valore dell’apicoltura come bene comune e perché l’ape è un alleato fondamentale per la difesa della biodiversità”.
In effetti sul reale valore delle api come attori primari della biodiversità sappiamo poco. Eppure si stima che l’impollinazione delle specie vegetali – di cui l’ape garantisce la continuità nella riproduzione – equivalga, in termini alimentari, a un terzo di quanto arriva sulle nostre tavole. ApiMed rappresenta 24 organizzazioni apistiche in 12 Paesi del Mediterraneo e decine di migliaia di apicoltori che producono un miele che rispetta standard definiti in difesa del consumatore e dell’ecosistema di cui le api sono inestimabili guardiani. Ma non c’è solo un obiettivo “produttivo”. Qualcuno al Forum ha fatto notare che le api che hanno le loro arnie a Gerusalemme o nei Territori occupati di Palestina, si fanno un baffo del muro. Fanno il loro lavoro in nome del miele e, senza saperlo, di un mondo senza confini.
L’umorismo degli afgani ovvero quel che nemmeno la guerra riesce a uccidere
 Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
l’Undp di Kabul ha pensato di indire un festival di aquiloni. La cosa divertente, visto che per errore la mail è stata mandata in copia visibile a tutti, è che qualcuno ha commentato con ironia. E non sembra che l’inizio. Ecco la suggestione della prima risposta all’invito, cui già ne son seguite altre:
Hi UNDP with 50 years of experience in development,
Could you please explain the relations between Sustainable Development Goals and kite running and that how you made such an excellent scientific developmental discovery to promote sustainable development goals among the young generation through kite running?! Kite running festival becomes so cliche in Afghanistan. I recommend you guys to hold a festival of “ tushla” in Afghanistan. Tushla is more nostalgic for us and we love it more than kite running. I promise to come to your Tushla bazi festival.
Direi che la traduzione non serve ma bisogna dire cos’è un torneo di Tushla Bazi, cosa che faccio fare a un fotografo afgano, Nasim Fekrat. A voi lascio la risata dopo aver aperto il link e ripescato nella vostra memoria anche un’italica usanza….
L’umorismo degli afgani ovvero quel che nemmeno la guerra riesce a uccidere
 Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
l’Undp di Kabul ha pensato di indire un festival di aquiloni. La cosa divertente, visto che per errore la mail è stata mandata in copia visibile a tutti, è che qualcuno ha commentato con ironia. E non sembra che l’inizio. Ecco la suggestione della prima risposta all’invito, cui già ne son seguite altre:
Hi UNDP with 50 years of experience in development,
Could you please explain the relations between Sustainable Development Goals and kite running and that how you made such an excellent scientific developmental discovery to promote sustainable development goals among the young generation through kite running?! Kite running festival becomes so cliche in Afghanistan. I recommend you guys to hold a festival of “ tushla” in Afghanistan. Tushla is more nostalgic for us and we love it more than kite running. I promise to come to your Tushla bazi festival.
Direi che la traduzione non serve ma bisogna dire cos’è un torneo di Tushla Bazi, cosa che faccio fare a un fotografo afgano, Nasim Fekrat. A voi lascio la risata dopo aver aperto il link e ripescato nella vostra memoria anche un’italica usanza….
L’umorismo degli afgani ovvero quel che nemmeno la guerra riesce a uccidere
 Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
l’Undp di Kabul ha pensato di indire un festival di aquiloni. La cosa divertente, visto che per errore la mail è stata mandata in copia visibile a tutti, è che qualcuno ha commentato con ironia. E non sembra che l’inizio. Ecco la suggestione della prima risposta all’invito, cui già ne son seguite altre:
Hi UNDP with 50 years of experience in development,
Could you please explain the relations between Sustainable Development Goals and kite running and that how you made such an excellent scientific developmental discovery to promote sustainable development goals among the young generation through kite running?! Kite running festival becomes so cliche in Afghanistan. I recommend you guys to hold a festival of “ tushla” in Afghanistan. Tushla is more nostalgic for us and we love it more than kite running. I promise to come to your Tushla bazi festival.
Direi che la traduzione non serve ma bisogna dire cos’è un torneo di Tushla Bazi, cosa che faccio fare a un fotografo afgano, Nasim Fekrat. A voi lascio la risata dopo aver aperto il link e ripescato nella vostra memoria anche un’italica usanza….
L’umorismo degli afgani ovvero quel che nemmeno la guerra riesce a uccidere
 Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
l’Undp di Kabul ha pensato di indire un festival di aquiloni. La cosa divertente, visto che per errore la mail è stata mandata in copia visibile a tutti, è che qualcuno ha commentato con ironia. E non sembra che l’inizio. Ecco la suggestione della prima risposta all’invito, cui già ne son seguite altre:
Hi UNDP with 50 years of experience in development,
Could you please explain the relations between Sustainable Development Goals and kite running and that how you made such an excellent scientific developmental discovery to promote sustainable development goals among the young generation through kite running?! Kite running festival becomes so cliche in Afghanistan. I recommend you guys to hold a festival of “ tushla” in Afghanistan. Tushla is more nostalgic for us and we love it more than kite running. I promise to come to your Tushla bazi festival.
Direi che la traduzione non serve ma bisogna dire cos’è un torneo di Tushla Bazi, cosa che faccio fare a un fotografo afgano, Nasim Fekrat. A voi lascio la risata dopo aver aperto il link e ripescato nella vostra memoria anche un’italica usanza….
L’umorismo degli afgani ovvero quel che nemmeno la guerra riesce a uccidere
 Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
Per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) tra la gioventù afgana,
l’Undp di Kabul ha pensato di indire un festival di aquiloni. La cosa divertente, visto che per errore la mail è stata mandata in copia visibile a tutti, è che qualcuno ha commentato con ironia. E non sembra che l’inizio. Ecco la suggestione della prima risposta all’invito, cui già ne son seguite altre:
Hi UNDP with 50 years of experience in development,
Could you please explain the relations between Sustainable Development Goals and kite running and that how you made such an excellent scientific developmental discovery to promote sustainable development goals among the young generation through kite running?! Kite running festival becomes so cliche in Afghanistan. I recommend you guys to hold a festival of “ tushla” in Afghanistan. Tushla is more nostalgic for us and we love it more than kite running. I promise to come to your Tushla bazi festival.
Direi che la traduzione non serve ma bisogna dire cos’è un torneo di Tushla Bazi, cosa che faccio fare a un fotografo afgano, Nasim Fekrat. A voi lascio la risata dopo aver aperto il link e ripescato nella vostra memoria anche un’italica usanza….
Una tegola per Trump dalla Corte penale internazionale (aggiornato)
Arriva dall’Aja, sede del Tribunale penale internazionale, la prima tegola sulla testa del neo presidente Donald Trump. Una tegola che si chiama Afghanistan – Paese da cui Trump ha detto di voler ritirare le truppe – e che è contenuta nel Report on Preliminary Examination Activities della Procura internazionale, ossia quel che in sostanza si intende fare nel prossimo futuro. Il documento prende in esame vari Paesi e, tra questi, individua gli Usa per i quali vi sono «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che nel Paese dell’Hindukush avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Al momento non c’è dunque ancora un procedimento aperto ma solo le risultanze di un esame di oltre un centinaio di segnalazioni sulla guerra afgana che tirano in ballo tre protagonisti del conflitto: i talebani e la Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (National Directorate for Security), e gli americani. Il testo del rapporto dice che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Central Intelligence Agency, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram. Passaggio che, prima che Ghani si insediasse come presidente nel settembre del 2014, si era verificato non senza problemi e meline nell’ultima fase del mandato di Hamid Karzai.
![]() Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
una tegola politica non di poco conto anche se gli Usa non aderiscono alla Carta di Roma costitutiva della Corte (anzi, dopo averla inizialmente firmata Washington si è ritirata, come Sudan e Israele) mentre l’Afghanistan, che non l’aveva firmata, l’ha poi fatto ratificando l’accordo internazionale nel 2003. Il rapporto della procuratrice generale
Essendosi ritirati dalla Corte e non riconoscendone la giurisdizione, gli Stati Uniti molto probabilmente non collaboreranno né riconosceranno indagini ed eventuale verdetto tant’è che oggi hanno respinto al mittente definendo ingiustificata e inappropriata un’indagine di questo tipo sul loro operato anche perché, dicono, gli Stati Uniti hanno un apparato di giustizia “robusto”, in grado quindi di sistemare da solo le cose di casa. Sono comunque in buona compagnia: accusando la Corte di aver troppo focalizzato il suo lavoro sull’Africa, Sud Africa, Burundi e Gambia hanno fatto sapere di voler abbandonare il consesso penale (il Burundi è stato il pirmo, in ottobre). E oggi si è aggiunta pure la Russia dopo una risoluzione Onu che condanna le violazioni in Crimea. La firma sul decreto è di Vladimir Putin.
In effetti la Corte è sempre stata sotto tiro per una sorta di doppio standard – colpire i deboli e lasciar stare i potenti – questa volta le cose vanno diversamente. La fase procedurale per l’incriminazione o il proscioglimento potrebbe partire nel giro di giorni o settimane. Ma potrebbe però anche durare anni.
Una tegola per Trump dalla Corte penale internazionale (aggiornato)
Arriva dall’Aja, sede del Tribunale penale internazionale, la prima tegola sulla testa del neo presidente Donald Trump. Una tegola che si chiama Afghanistan – Paese da cui Trump ha detto di voler ritirare le truppe – e che è contenuta nel Report on Preliminary Examination Activities della Procura internazionale, ossia quel che in sostanza si intende fare nel prossimo futuro. Il documento prende in esame vari Paesi e, tra questi, individua gli Usa per i quali vi sono «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che nel Paese dell’Hindukush avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Al momento non c’è dunque ancora un procedimento aperto ma solo le risultanze di un esame di oltre un centinaio di segnalazioni sulla guerra afgana che tirano in ballo tre protagonisti del conflitto: i talebani e la Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (National Directorate for Security), e gli americani. Il testo del rapporto dice che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Central Intelligence Agency, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram. Passaggio che, prima che Ghani si insediasse come presidente nel settembre del 2014, si era verificato non senza problemi e meline nell’ultima fase del mandato di Hamid Karzai.
![]() Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
una tegola politica non di poco conto anche se gli Usa non aderiscono alla Carta di Roma costitutiva della Corte (anzi, dopo averla inizialmente firmata Washington si è ritirata, come Sudan e Israele) mentre l’Afghanistan, che non l’aveva firmata, l’ha poi fatto ratificando l’accordo internazionale nel 2003. Il rapporto della procuratrice generale
Essendosi ritirati dalla Corte e non riconoscendone la giurisdizione, gli Stati Uniti molto probabilmente non collaboreranno né riconosceranno indagini ed eventuale verdetto tant’è che oggi hanno respinto al mittente definendo ingiustificata e inappropriata un’indagine di questo tipo sul loro operato anche perché, dicono, gli Stati Uniti hanno un apparato di giustizia “robusto”, in grado quindi di sistemare da solo le cose di casa. Sono comunque in buona compagnia: accusando la Corte di aver troppo focalizzato il suo lavoro sull’Africa, Sud Africa, Burundi e Gambia hanno fatto sapere di voler abbandonare il consesso penale (il Burundi è stato il pirmo, in ottobre). E oggi si è aggiunta pure la Russia dopo una risoluzione Onu che condanna le violazioni in Crimea. La firma sul decreto è di Vladimir Putin.
In effetti la Corte è sempre stata sotto tiro per una sorta di doppio standard – colpire i deboli e lasciar stare i potenti – questa volta le cose vanno diversamente. La fase procedurale per l’incriminazione o il proscioglimento potrebbe partire nel giro di giorni o settimane. Ma potrebbe però anche durare anni.
Una tegola per Trump dalla Corte penale internazionale (aggiornato)
Arriva dall’Aja, sede del Tribunale penale internazionale, la prima tegola sulla testa del neo presidente Donald Trump. Una tegola che si chiama Afghanistan – Paese da cui Trump ha detto di voler ritirare le truppe – e che è contenuta nel Report on Preliminary Examination Activities della Procura internazionale, ossia quel che in sostanza si intende fare nel prossimo futuro. Il documento prende in esame vari Paesi e, tra questi, individua gli Usa per i quali vi sono «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che nel Paese dell’Hindukush avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Al momento non c’è dunque ancora un procedimento aperto ma solo le risultanze di un esame di oltre un centinaio di segnalazioni sulla guerra afgana che tirano in ballo tre protagonisti del conflitto: i talebani e la Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (National Directorate for Security), e gli americani. Il testo del rapporto dice che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Central Intelligence Agency, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram. Passaggio che, prima che Ghani si insediasse come presidente nel settembre del 2014, si era verificato non senza problemi e meline nell’ultima fase del mandato di Hamid Karzai.
![]() Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
una tegola politica non di poco conto anche se gli Usa non aderiscono alla Carta di Roma costitutiva della Corte (anzi, dopo averla inizialmente firmata Washington si è ritirata, come Sudan e Israele) mentre l’Afghanistan, che non l’aveva firmata, l’ha poi fatto ratificando l’accordo internazionale nel 2003. Il rapporto della procuratrice generale
Essendosi ritirati dalla Corte e non riconoscendone la giurisdizione, gli Stati Uniti molto probabilmente non collaboreranno né riconosceranno indagini ed eventuale verdetto tant’è che oggi hanno respinto al mittente definendo ingiustificata e inappropriata un’indagine di questo tipo sul loro operato anche perché, dicono, gli Stati Uniti hanno un apparato di giustizia “robusto”, in grado quindi di sistemare da solo le cose di casa. Sono comunque in buona compagnia: accusando la Corte di aver troppo focalizzato il suo lavoro sull’Africa, Sud Africa, Burundi e Gambia hanno fatto sapere di voler abbandonare il consesso penale (il Burundi è stato il pirmo, in ottobre). E oggi si è aggiunta pure la Russia dopo una risoluzione Onu che condanna le violazioni in Crimea. La firma sul decreto è di Vladimir Putin.
In effetti la Corte è sempre stata sotto tiro per una sorta di doppio standard – colpire i deboli e lasciar stare i potenti – questa volta le cose vanno diversamente. La fase procedurale per l’incriminazione o il proscioglimento potrebbe partire nel giro di giorni o settimane. Ma potrebbe però anche durare anni.
Una tegola per Trump dalla Corte penale internazionale (aggiornato)
Arriva dall’Aja, sede del Tribunale penale internazionale, la prima tegola sulla testa del neo presidente Donald Trump. Una tegola che si chiama Afghanistan – Paese da cui Trump ha detto di voler ritirare le truppe – e che è contenuta nel Report on Preliminary Examination Activities della Procura internazionale, ossia quel che in sostanza si intende fare nel prossimo futuro. Il documento prende in esame vari Paesi e, tra questi, individua gli Usa per i quali vi sono «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che nel Paese dell’Hindukush avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Al momento non c’è dunque ancora un procedimento aperto ma solo le risultanze di un esame di oltre un centinaio di segnalazioni sulla guerra afgana che tirano in ballo tre protagonisti del conflitto: i talebani e la Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (National Directorate for Security), e gli americani. Il testo del rapporto dice che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Central Intelligence Agency, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram. Passaggio che, prima che Ghani si insediasse come presidente nel settembre del 2014, si era verificato non senza problemi e meline nell’ultima fase del mandato di Hamid Karzai.
![]() Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
una tegola politica non di poco conto anche se gli Usa non aderiscono alla Carta di Roma costitutiva della Corte (anzi, dopo averla inizialmente firmata Washington si è ritirata, come Sudan e Israele) mentre l’Afghanistan, che non l’aveva firmata, l’ha poi fatto ratificando l’accordo internazionale nel 2003. Il rapporto della procuratrice generale
Essendosi ritirati dalla Corte e non riconoscendone la giurisdizione, gli Stati Uniti molto probabilmente non collaboreranno né riconosceranno indagini ed eventuale verdetto tant’è che oggi hanno respinto al mittente definendo ingiustificata e inappropriata un’indagine di questo tipo sul loro operato anche perché, dicono, gli Stati Uniti hanno un apparato di giustizia “robusto”, in grado quindi di sistemare da solo le cose di casa. Sono comunque in buona compagnia: accusando la Corte di aver troppo focalizzato il suo lavoro sull’Africa, Sud Africa, Burundi e Gambia hanno fatto sapere di voler abbandonare il consesso penale (il Burundi è stato il pirmo, in ottobre). E oggi si è aggiunta pure la Russia dopo una risoluzione Onu che condanna le violazioni in Crimea. La firma sul decreto è di Vladimir Putin.
In effetti la Corte è sempre stata sotto tiro per una sorta di doppio standard – colpire i deboli e lasciar stare i potenti – questa volta le cose vanno diversamente. La fase procedurale per l’incriminazione o il proscioglimento potrebbe partire nel giro di giorni o settimane. Ma potrebbe però anche durare anni.
Una tegola per Trump dalla Corte penale internazionale (aggiornato)
Arriva dall’Aja, sede del Tribunale penale internazionale, la prima tegola sulla testa del neo presidente Donald Trump. Una tegola che si chiama Afghanistan – Paese da cui Trump ha detto di voler ritirare le truppe – e che è contenuta nel Report on Preliminary Examination Activities della Procura internazionale, ossia quel che in sostanza si intende fare nel prossimo futuro. Il documento prende in esame vari Paesi e, tra questi, individua gli Usa per i quali vi sono «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che nel Paese dell’Hindukush avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Al momento non c’è dunque ancora un procedimento aperto ma solo le risultanze di un esame di oltre un centinaio di segnalazioni sulla guerra afgana che tirano in ballo tre protagonisti del conflitto: i talebani e la Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (National Directorate for Security), e gli americani. Il testo del rapporto dice che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Central Intelligence Agency, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram. Passaggio che, prima che Ghani si insediasse come presidente nel settembre del 2014, si era verificato non senza problemi e meline nell’ultima fase del mandato di Hamid Karzai.
![]() Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
Per i talebani la denuncia di crimini di guerra non è una novità. Ma per Washington, e per Kabul, è Fatou Bensouda (nella foto in alto a sinistra), una giurista del Gambia, sostiene che durante interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania (quelli delle extraordinary rendition n.d.r.) tra il dicembre 2002 e il marzo 2008. Il documento chiarisce che «Questi presunti crimini non sono stati abusi di pochi individui isolati. Piuttosto, sembrano siano stati commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… L’Ufficio ritiene che vi sia una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli volti a sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan». Quanto alla polizia e intelligence afgana, la tortura sarebbe un fatto sistematico e, al momento, si stima che tra il 35 e il 50% dei detenuti vi siano stati sottoposti.
una tegola politica non di poco conto anche se gli Usa non aderiscono alla Carta di Roma costitutiva della Corte (anzi, dopo averla inizialmente firmata Washington si è ritirata, come Sudan e Israele) mentre l’Afghanistan, che non l’aveva firmata, l’ha poi fatto ratificando l’accordo internazionale nel 2003. Il rapporto della procuratrice generale
Essendosi ritirati dalla Corte e non riconoscendone la giurisdizione, gli Stati Uniti molto probabilmente non collaboreranno né riconosceranno indagini ed eventuale verdetto tant’è che oggi hanno respinto al mittente definendo ingiustificata e inappropriata un’indagine di questo tipo sul loro operato anche perché, dicono, gli Stati Uniti hanno un apparato di giustizia “robusto”, in grado quindi di sistemare da solo le cose di casa. Sono comunque in buona compagnia: accusando la Corte di aver troppo focalizzato il suo lavoro sull’Africa, Sud Africa, Burundi e Gambia hanno fatto sapere di voler abbandonare il consesso penale (il Burundi è stato il pirmo, in ottobre). E oggi si è aggiunta pure la Russia dopo una risoluzione Onu che condanna le violazioni in Crimea. La firma sul decreto è di Vladimir Putin.
In effetti la Corte è sempre stata sotto tiro per una sorta di doppio standard – colpire i deboli e lasciar stare i potenti – questa volta le cose vanno diversamente. La fase procedurale per l’incriminazione o il proscioglimento potrebbe partire nel giro di giorni o settimane. Ma potrebbe però anche durare anni.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Il brando divino terrore filippino
C’è il gruppo islamista Abu Sayyaf dietro il sequestro di un cittadino tedesco e l’uccisione della sua compagna che sono avvenuti nei giorni scorsi nel Sud delle Filippine. La zona del sequestro del settantenne tedesco e dell’omicidio della sua compagna cinquantenne, il cui corpo è stato ritrovato dai pescatori della zona, è l’area di Pegasus Reef, 40 miglia dall’isola di Taganak nelle Tawi Tawi, il cosiddetto “arcipelago delle tartarughe” composto da dieci isole (sette filippine e tre malaysiane) all’interno della più vasta area insulare delle Sulu, santuario e terreno di caccia di Abu Sayyaf. Un paradiso tropicale diventato un inferno.
Il sequestro è stato rivendicato da un portavoce del gruppo, Muammar Askali, che domenica ha chiamato il quotidiano Inquirer cui ha spiegato che la compagna di Juegen Kantner, così si chiama l’ostaggio, aveva tentato di sparare ai sequestratori e pertanto era stata uccisa. Kantner ha potuto anche lui parlare con l’Inquirer, spiegando, ma non è chiaro come, che la coppia aveva chiesto aiuto all’ambasciata tedesca a Manila. Alla vicenda mancano diverse conferme e i fatti sono ancora da determinare nei dettagli. La stessa domenica il corpo della donna ormai senza vita è stato trovato dai residenti sulla barca dei tedeschi.
Abu Sayaff è attivo ormai da oltre un decennio nelle acque dell’arcipelago di Sulu dove il gruppo, autore di sequestri estorsivi ammantati di retorica jihadista, è famoso per la sua ferocia: il 25 aprile scorso, solo per ricordare un caso, la testa di un ostaggio canadese, per cui non era stato pagato il riscatto, venne ritrovata in un sacchetto di plastica nelle strade di Jolo, la capitale delle Sulu.
Metà jihadisti, metà banditi, gli uomini di Abu Sayyaf (brando divino) terrorizzano la piccola enclave insulare da anni facendosi beffe dei tentativi dell’esercito di far piazza pulita come promesso anche dall’ultimo presidente appena eletto, il controverso Rodrigo Duterte. Qualche tempo fa Abu Sayyaf ha promesso fedeltà ad Al Bagdadi, andando a ingrossare le fila degli adepti del califfato a Est di Raqqa.
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Marcia indietro per Sharbat Gula: non sarà espulsa (aggiornato)
Sharbat Gula resterà in Pakistan. La donna che doveva essere espulsa in Afghanistan settimana prossima, ha visto una marcia indietro delle autorità di Islamabad (vedi articolo precedente), dopo che il caso ha iniziato a girare. Resterà come rifugiata in Pakistan. La scelta, spiegano i media afgani, si deve anche alle pressioni interne e non solo al clamore internazionale.
Alla fine le è servito essere il viso simbolo della guerra afgana anche se la sua vita da rifugiata non sembra proprio essere un premio per quegli occhi che fecero il giro del mondo nelle immagini del fotografo McCurry.
Amici afgani mi dicono che il presidente Ghani le ha offerto casa in Afghanistan. La popolarità fotografica alla fine ha sortito un effetto…
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Espulsa dal Pakistan la "ragazza copertina" della guerra afgana (e con lei 400mila meno famosi)
A Sharbat Gula è andata forse meglio che ad altri afgani che, come lei, vivono in Pakistan da anni e che adesso Islamabad ha deciso di espellere obbligandoli a far ritorno a casa dove spesso casa non hanno più. Sharbat Gula, arrestata a fine ottobre con documenti contraffatti, è stata condannata a una multa, quindici giorni di carcere e all’espulsione. Ma non è una rifugiata qualsiasi. E’ la donna che divenne l’icona della guerra afgana conquistando la copertina di National Geographic con una foto di Steve McCurry, che rese famosa lei e ancor più famoso lui che l’aveva utilizzata come modella nel 1984 quando aveva 12 anni nel campo profughi di Nasir Bagh a Peshawar, capitale della provincia di confine dove vive la maggior parte dei 2,6 milioni di afgani fuggiti dalla guerra. Nel giugno del 1985 Sharbat Gula ebbe il suo momento di gloria mediatica senza neppure saperlo. Solo sette anni dopo si seppe di chi era il volto anonimo di quella ragazzina ormai diventata donna. Ora è anche madre. Forse la sua notorietà le ha risparmiato pene maggiori.
Degli oltre 2 milioni e mezzo di afgani che vivono in Pakistan, un milione e 600 mila sono registrati ma un milione è senza documenti come nel caso di Sharbat Gula. Mettersi a posto non è semplice specie per chi vive da decenni nei campi. Nel 2009 il Pakistan ha cercato di dar via a un piano di rimpatrio ma alla fine le cose non sono andate molto avanti. L’accelerazione è recente. Negli ultimi mesi la polizia pachistana ha cominciato gli sgomberi: per chi vuole andare c’è un incentivo. Per chi non vuole c’è uno spintone. Nel giro di pochi mesi sono stati espulsi 400mila afgani ed entro dicembre Islamabad ne voleva rimpatriare altri 600mila. Poi, dopo le pressioni dell’Onu, ha rinviato a marzo. Ma pare che voglia rispettare la data. Un milione di afgani che rientrano in casa si aggiungeranno a un altro milione e duecentomila sfollati interni cui si sommeranno gli 80mila afgani che la Ue, che ha fatto firmare a Kabul un accordo capestro in tal senso, vuole espellere dalle frontiere europee. Una goccia se paragonati al milione del Pakistan ma, al netto della quantità, con modalità che ci apparentano a un Paese sempre alla berlina: chi vuole tornare sarà infatti aiutato ma chi non vuole – e l’accordo appena firmato tra Bruxelles e Kabul parla chiaro – verrà accompagnato su aerei di linea dove nei prossimi mesi ci saranno 50 posti riservati agli espulsi. Il parlamentare Giulio Marcon ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Che per ora tace.
Il Pakistan ha una lunga storia di ospitalità: nel 2002 ha firmato un accordo con l’Alto commissariato dell’Onu (Acnur) per i rimpatri volontari e circa 3 milioni di afgani hanno fatto volontariamente ritorno ma per altri è davvero dura: molti di coloro che sono tornati non hanno più trovato le loro terre, confiscate da signori della guerra e banditi locali e per altri il ritorno è impossibile proprio perché sanno che la loro casa non c’è più, che in Afghanistan c’è ancora guerra e scarse occasioni di lavoro. Quanto al Pakistan è ormai per la linea dura: c’è chi suggerisce che i rifugiati sono un problema economico e chi aggiunge che il Pakistan ha già i suoi sfollati interni per guerra o carestie. Ma c’è anche una ripicca con Kabul che Islamabad accusa di dare asilo ai talebani pachistani oltre al fatto che l’Afghanistan manovra per escludere il Pakistan dal negoziato con la guerriglia.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Rohyniga, un mese di silenzio
 La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
La situazione che ormai da un mese ha fatto un inferno del confine birmano bangladese, dove vive la minoranza musulmana dei Rohyngia, sta letteralmente esplodendo nelle mani di Aug san Suu Kyi, la Nobel birmana che è formalmente una consulente del governo e ministro degli Esteri ma de facto la protagonista della politica civile in un Paese che sta facendo i conti con la difficile transizione da regime militare a nuovo modello di democrazia asiatica. In Giappone in questi giorni e appena tornata da un viaggio in India (e, prima, da un incontro con Barack Obama), la donna diventata famosa per il suo coraggio nella difesa dei diritti viene adesso accusata di un eccessivo attivismo diplomatico, volto a trovare finanziamenti per il suo Paese, che sembra però allontanarla dai problemi interni: più o meno sottovoce c’è chi la accusa – sul dossier Rohyngia – di girarsi dall’altra parte o, peggio, di sostenere la linea dei militari con cui il suo partito, la Lega per la democrazia, condivide il potere in una difficile convivenza.
Proprio durante il suo viaggio americano Suu Kyi aveva detto al Washington Post che la situazione nello stato di Rakhine «richiedeva tempo», ma ormai le operazioni militari in quest’area del Paese hanno praticamente sigillato la zona da un mese, impedendo non solo aiuti umanitari agli sfollati Rohyngia (già vittime di pogrom anti musulmani in passato) ma vietando a giornalisti o attivisti di monitorare quanto accade. All’agenzia Reuters, diversi testimoni hanno confermato violenze e intimidazioni, stupri e minacce. Tutto è cominciato quando un gruppo islamista ha attaccato il 9 ottobre una postazione militare. Da quel momento si è scatenata una repressione furiosa per dare la caccia agli islamisti ma con diverse decine di morti, arresti e patenti violazioni. Suu Kyi ha inizialmente sostenuto la tesi dei militari e cioè quella di una giusta reazione contro le incursioni oltre frontiera di jihadisti allenati all’estero, ma poi – mentre scarse ma puntuali notizie denunciavano l’aggravarsi della situazione – si è chiusa in un pesante silenzio.
In realtà non ha fatto finta di nulla. Fonti di stampa sostengono che almeno dieci giorni fa, il governo – dunque la signora in giallo – abbia mandato ai militari una lista di 13 domande sulla vicenda ma a tutt’oggi non avrebbe ricevuto risposta. L’equilibrio è difficile e i militari hanno una lunga tradizione di impunità e totale indipendenza. Suu Kyi, dicono i delusi, spingerebbe però troppo poco e anzi tollererebbe – per la quieta sopravvivenza del suo governo – non solo le scorribande belliche ma anche il dominio nell’economia dei militari. Momento difficile insomma e proteste internazionali, dall’Onu e dagli Stati Uniti. Silenzio invece dagli indiani e, naturalmente, dai cinesi, entrambi impegnati a sistemare il loro puzzle di alleanze nel Sudest asiatico. Quanto al Giappone, non è soltanto un antico sostenitore del Myanmar anche quand’era solidamente in mano alla Giunta, ma non è un Paese solito prender pozioni nette sulle scelte politiche interne dei suoi alleati.
Nel mirino dell’esercito c’è il gruppo Aqa Mul Mujahidin, formazione armata che conterebbe circa 400 combattenti e che si è già scontrato con le forze di sicurezza. Sarebbe legata alla Rohingya Solidarity Organization – un gruppo armato smantellato in passato – e guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
I Rohyngia, popolazione autoctona dello Stato di Rakhine (o Arakan) o, secondo altre fonti, originaria del Bengala, sono circa un milione e 300mila individui di cui oltre 100mila vivono in campi per sfollati. Il Myanmar non riconosce loro lo status di minoranza e rappresentanza. Sono solo “gente che professa l’islam”.
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Jamu e altra medicina tra le cipolle di un ortolano
 A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
A metà degli anni Ottanta, prima che cadesse la dittatura di Suharto nel 1998, accompagnammo una collega in un meandro di viuzze di Solo, a Giava centrale, in cerca di un medico cinese. La bottega, in virtù dei ferrei divieti indonesiani contro la comunità della diaspora cinese che si pensava sodale con la Repubblica popolare e comunista, era ben dissimulato e così il medico, una dottoressa ottuagenaria dai lineamenti fini ed esile come un giunco. La bottega di un ortolano, che esponeva carote e cipolle che fungevano da copertura, dava poi, attraverso una porticina nel retro, su un lungo corridoio ingombro di libri, scatolette, bottiglie e bottigliette per arrivare infine al luogo dove la dottoressa esercitava. Tutti sapevano ma, nel più puro stile giavanese, si faceva finta di nulla: il medico cinese svolgeva un ruolo fondamentale e bastava solo che non desse nell’occhio per via di quella legge che vietava l’importazione di qualsiasi cosa scritta in cinese – dalla propaganda alle etichette delle medicine – e puniva l’esercizio dell’arte sinica della scienza medica Esposto il suo problema, la difficoltà di avere figli, la collega si vide affidare la ricetta di una confezione di ossa triturate di gallo nero che, raccolte in ovuli impacchettati in una deliziosa scatoletta con dragoni e ideogrammi, venne poi acquistata a Singapore. La dottoressa le affidò anche una ricetta in cinese dicendole che a Milano, nel quartiere “giallo” di Via Paolo Sarpi, avrebbe trovato senza difficoltà i principi attivi senza dover ricorre alle pillole. Per vostra curiosità, la collega ebbe poi due splendidi figli. Grazie alle ossa triturate del gallo nero.
Oggi in Indonesia molte delle vessazioni contro i cinesi indonesiani, compresa l’importazione di materiale scritto con ideogrammi, sono caduti come più in generale è caduta nel mondo la diffidenza verso l’altra medicina, dall’omeopatica all’ayurvedica, dall’agopuntura al Jamu. Jamu? Si, l’erboristeria medica tradizionale indonesiana che nel suo Paese d’origine non è mai stata dimenticata e che adesso conosce – come in ogni parte del mondo l’altramedicina- un vero e proprio boom. In effetti l’Asia, tra i tanti primati, è il continente che ha prodotto in assoluto altrettanta arte medica quanta ne han praticata i fedeli di Ippocrate: basta citare quella cinese e quella indiana e il conto è presto fatto.
In Asia e nel mondo
Secondo le stime dell’Oms, che ha inserito la medicina tradizionale e complementare (MT&C) nei suoi parametri e che la considera «il cardine dell’assistenza sanitaria o il suo complemento», la MT&C è in «crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet». Il 76% degli abitanti di Singapore e l’86% in Corea la usano e un sondaggio sulle visite di medicina tradizionale cinese in Cina nel 2008 dava un bilancio di 907 milioni, il 18% di tutte le visite mediche nelle istituzioni intervistate; il numero di pazienti ricoverati per cure con la MTC era di 13,6 milioni, pari al 16% del totale dei ricoveri di tutti gli ospedali interrogati. In Laos, oltre 18mila medici tradizionali forniscono gran parte del servizio di assistenza sanitaria per l’80% delle cure della popolazione. In Arabia Saudita si spendono in media 560 dollari l’anno a cranio per servizi di MT&C. La produzione relativa alla «Materia Medica Cinese» è stata stimata nel 2012 a oltre 83 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. In Corea la spesa annuale per la MT è stata di 4,4 miliardi di dollari nel 2004, salita a 7,4 nel 2009. In India esistono oltre 1 milione e 800mila medici “ayush” (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).
Nel resto del mondo? Negli Stati Uniti, la cifra per il solo acquisto di prodotti naturali pagati a proprie spese dai cittadini ammontava nel 2008 a 14,8 miliardi di dollari. In Italia è in continua crescita e oggi circa la metà dei Paesi del pianeta riconosce ufficialmente l’agopuntura. Le prestazioni della MT&C nell’Unione Europea sono erogate approssimativamente da 160mila professionisti non medici e da 145mila medici.
In Indonesia
L’Indonesia, come ogni Paese asiatico, ha la “sua” medicina tradizionale. Si chiama Jamu ed è stata dichiarata “marchio indonesiano” dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono il 27 maggio 2007. E’ il riconoscimento ufficiale di una pratica antichissima soprattutto a Giava ma molto diffusa in tutto l’arcipelago. Tra il 70 e l’80% degli indonesiani ne fa uso e il suo sviluppo e utilizzo è entrato a far parte della strategia sanitaria nazionale. Ci sono cliniche all’interno di ospedali e corsi universitari con diploma per chi la somministra. Lo Stato ha cominciato a seguire la produzione e lo stoccaggio delle erbe che compongono le cure a base prevalentemente di vegetali: parti di piante (radici, cortecce, fiori, semi, foglie, frutti) ma anche prodotti animali, come miele, pappa reale, latte e uova. L’industria del Jamu nel 2014 ha totalizzato vendite per oltre 70 milioni di dollari. Altro che altramedicina.
————————————————————-
Cosa dice l’Oms
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la Medicina tradizionale (MT) è la somma di «conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed esperienze autoctoni di culture diverse, corredate o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il miglioramento o per il trattamento delle malattie fisiche e mentali». Medicina complementare (MC) o “medicina alternativa” si riferisce a «un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno parte della tradizione propria di un determinato Paese o della sua medicina convenzionale e non sono pienamente integrate nel sistema sanitario vigente».
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
Leggo dunque comprendo. Da sabato a Roma il Salone dell’Editoria sociale
 Salone dell’editoria sociale
Salone dell’editoria sociale
Mediterraneo oggi
29 ottobre – 1 novembre 2016
Porta Futuro, Via Galvani 108 Roma
Ingresso libero
Comincia sabato 29 ottobre l’ottava edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziativa promossa dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria in collaborazione con Redattore sociale e Comunità di Capodarco. Ecco il calendario con circa 50 incontri tra tavole rotonde, presentazioni di libri, video e dibattiti promossi da 30 tra case editrici e organizzazioni del terzo settore, ospitate negli spazi di Porta Futuro a Roma fino a martedì 1 novembre.
Il tema scelto è “Mediterraneo oggi”: un’occasione per riflettere sulle «mutazioni sociali, culturali, economiche e geopolitiche di un’area che sempre più ci interroga sulle contraddizioni del nostro tempo», ma che offre anche «una speranza di rinnovamento», spiegano Goffredo Fofi e Giulio Marcon, ideatori del Salone, introducendo la nuova edizione.
“Per una mappa del Mediterraneo” è il titolo della lectio magistralis con cui sabato 29 ottobre il geografo Franco Farinelli inaugura idealmente il programma, ricco di incontri sui temi di politica estera: la “Libia, paese allo sbando” con lo studioso Francesco Strazzari e i giornalisti Alberto Negri, Francesca Mannocchi e Daniele Raineri; “la Turchia dopo il tentato golpe” con Lea Nocera, Fazila Mat e Luigi Spinola; la discussione su genesi e futuro dello Stato islamico con Marina Calculli, Emanuele Giordana e Fulvio Scaglione, in occasione dell’uscita del libro di Giuliano Battiston Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda.
Del Mediterraneo come spazio narrativo e luogo di attraversamenti e respingimenti parleranno tra gli altri Vittorio Giacopini, Alessandro Leogrande, Matteo Nucci e Matteo Tacconi. Isabella Camera d’Afflitto discuterà della letteratura araba vista dal Cairo con lo scrittore egiziano Ezzat El Kamhawi, mentre Goffredo Fofi e Nicola Villa intervisteranno la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci.
Molti gli incontri dedicati ai temi dell’immigrazione, tra cui la tavola rotonda sull’accoglienza promossa dall’associazione Lunaria e quella sui limiti e le buone pratiche dei media con i giornalisti Giovanni Maria Bellu, Tommaso Di Francesco, Marina Forti e Marco Tarquinio.
Le proposte sulle politiche locali della campagna Sbilanciamoci! e poi i diritti, il terzo settore, l’inclusione sociale e l’educazione finanziaria, discussi da ospiti come Andrea Baranes, Roberta Carlini, Francesca Fornario, Luigi Manconi, Grazia Naletto, Mario Pianta. E ancora l’attualità della Costituzione, con Gaetano Azzariti, Luigi Ferrajoli ed Elena Paciotti; il rapporto tra democrazia e sovranità popolare secondo lo storico Emilio Gentile; l’innovazione digitale tra capitalismo e beni comuni con Francesca Bria e l’atteso intervento dello studioso Evgenij Morozov.
Al rapporto tra arte e società sono dedicati molti eventi: gli incontri con il fotografo Ferdinando Scianna, con l’artista Mimmo Paladino e con l’illustratore Maurio Biani, oltre alla conferenza-spettacolo di Sergio Bustric sull’arte dell’inganno.
Da segnalare, infine, alcuni appuntamenti serali. Il monologo di Antonio Fazzini tratto da un racconto della scrittrice algerina Assia Djebar, introdotto da Maria Nadotti e Roberta Mazzanti; l’omaggio al regista Mario Monicelli, con Margherita Buy, Chiara Rapaccini e Wilma Labate, in occasione della pubblicazione del libro curato da Anna Antonelli Così parlò Monicelli. Infine il dibattito con il celebre attore e cantautore Nino D’Angelo sulla musica e le arti mediterranee.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
La pace sempre in salita tra detto e non detto (aggiornato)
A oggi sul sito ufficiale dei talebani non c’è traccia dei colloqui di pace che si sono tenuti in Qatar. Silenzio (*vedi aggiornamento fondo pagina). E silenzio anche da parte pachistana dopo la diffusione di notizie (qui un sunto del Wp) su un viaggio di tre notabili in Pakistan (mullah Salam Hanifi e mullah Jan Mohammed, già ministri dell’emirato di Omar, con maulvi Shahabuddin Dilawar, ex ambasciatore talebano) per “informare” su quanto avvenuto a Doha.
Sartaj Aziz dice di non saperne nulla e non si tratta dell’ultimo arrivato: il vecchio ottuagenario della politica estera pachistana – un uomo che ha cavalcato tutte le stagioni – è il consigliere numero uno del primo ministro ed è l’uomo che di solito ha l’ultima parola. Perché nega? Certo se i talebani hanno mandato una missione semi ufficiale in Pakistan il segnale dice che, nonostante Islamabad non fosse presente agli incontri di Doha, si vuole ricucire ed evitare rotture coi pachistani, finora i più stretti alleati dei talebani che hanno comunque esteso la loro rete di relazioni, dal Golfo a Pechino passando per Teheran. Le cose dunque restano confuse eppure qualcosa si muove.
 |
| Sartaj Aziz. Sotto Tayyeb Agha già a capo dell’ufficio di Doha. Sopra mullah Akhundzada |
E’ necessario dar della lettera di Tayyeb Agha (in pashto ma riportata in inglese da Radio Free Europe che l’ha ottenuta da Radio Mashaal), ex sodale di mullah Omar di cui era capo gabinetto e che è stato a lungo il rappresentante dell’ala politica dei talebani (era il responsabile dell’ufficio di Doha), salvo dimettersi poi nell’estate del 2015 dopo la morte di Omar e l’ascesa di Mansur di cui contestava la legittimità. Il giovane Tayyeb (classe 1976) scrive a mullah Akhundzada, il nuovo leader dei talebani, per dargli qualche consiglio. E la lettera la fa girare, tanto che arriva persino sull’emittente del nemico numero uno. Scrive che, tanto per cominciare, Akhundzada dovrebbe abbandonare il titolo di Amir al-Muminin e persino il termine Emirato da sostituirsi con un più blando “movimento” dal momento che per ora i talebani non controllano né tutto il Paese né la capitale. Insomma, un atto di pragmatismo e un passo indietro visto che, scrive, la leadership del movimento sta per lo più oltre frontiera. Gli chiede anche di rinunciare alla violenza e alla coercizione che, dice Tayyeb, viene utilizzata per compattare i ranghi. Ma è l’escalation di violenza in generale, che produce troppi morti tra gli afgani, che va rifiutata: “All the mujahedin fighters should be ordered to cease killing our opponents inside mosques and stop killing prisoners… Stop killing people under suspicion traveling on roads. Stop bombing bridges, roads, and other similar places. Stop killing aid and construction workers who are helping our nation and building our homeland”.
 |
| T |
Se la prende Tayyeb Agha anche con i troppi legami coi servizi segreti pachistani e iraniani: un monito a preservare purezza e indipendenza, a star lontani dai giochetti degli Stati confinanti. E torna su un altro punto dolente: gli stranieri: “It is imperative to stop the flow of non-Afghan fighters and control their activities”. Ce n’è per lo Stato islamico ma anche per ceceni o uzbeki e forse anche per PakTalebani. Un manifesto moderato da parte di un uomo forse ancora politicamente influente ma nullo militarmente? Una lettera ispirata? Un segnale, soprattutto, che le cose sono in movimento.
* Dopo un’iniziale smentita dopo l’uscita della notizis, Il 27 ottobre i talebani hanno categoricamente affermato che la stessa era priva di basi. Vero non vero, la smentita si può leggere qui.
Ribadiscono il solito concetto: We have reiterated time and again that the issue of Afghanistan has two dimensions, the external and the internal. As to external dimension, the end of occupation is the main problem…ma la nota contiene anche spunti interessanti tra cui questo: Hence, the Islamic Emirate wants an all Afghan inclusive Islamic system in a sovereign Afghanistan and do not want monopoly of power. Rigidi sul governo islamico ma non il monopolio del loro potere.
Strappo filippino (con retormarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Strappo filippino (con retromarcia)
 |
| Il segretario di Stato americano Kerry: buon viso a cattivo gioco |
Il vice premier cinese Zhang Gaoli ha appena parlato e lascia il microfono al neo eletto presidente filippino Rodrigo Duterte. La sala è gremita e l’occasione questa volta, nonostante l’ospite sia un piccolo arcipelago del Sudest asiatico finora ferreo alleato degli Stati uniti dal 1946, è davvero ghiotta.
Duterte è chiaro e limpido com’è nella sua natura di oratore schietto fino alla maleducazione: «Annuncio in questo incontro – dice senza star a pesar le parole – la mia separazione dagli Stati Uniti, non solo in termini militari ma anche economici». Poi ci mette qualche battuta che solleva risate in platea. Il dado è tratto. Uno strappo era largamente annunciato ma non così. Non così netto e non in una cornice – la grande sala in piazza Tienanmen e dopo aver incontrato il suo omologo Xi Jinping – dalla quale un colosso in via d’espansione – economica, militare e politica – ha steso la sua rete da tempo per pesci piccoli e grossi. Poi però, una volta a casa (oggi) Duterte ha fatto una discreta marcia indietro dichiarando che sepzzare l’asse con gli Usa è nell’interesse di Manila. Tnat’è, la dichiarazione di Pechino non è di quelle che si possono dimenticare facilmente, al di là delle acrobazie diplomatiche del giorno dopo o del giorno prima.
Duterte va più in là: «Mi sono spostato nel vostro vostro flusso ideologico e forse dovrò anche andare in Russia per parlare con Putin e dirgli che ci sono tre di noi contro il mondo. La Cina, le Filippine e la Russia». Cosa significhi questo riallineamento ideologico nell’ex campo socialista non è chiaro anche se è vero che Duterte ha cooptato nei suoi ministeri uomini dell’opposizione, ha deciso la riapertura del dialogo con i gruppi armati maoisti e si è dichiarato socialista durante la campagna elettorale («Socialista, non comunista. Noi socialisti siamo per il popolo»). Non è chiaro perché il profilo del socialista umanitario certo gli manca (nota la sua campagna di esecuzioni sommarie di criminali) e non è chiaro quanto di socialista rimanga in personaggi come Putin. Ma la scelta di campo, per ora solo dichiarata, mette sicuramente in difficoltà il vecchio alleato e fa sorridere i suoi nemici. Pechino incassa. Mosca ha già risposto con un gradimento che gli apre le porte. Duterte mette anche nel congelatore il problema delle isolette nel Mar cinese meridionale, da anni una delle cartine al tornasole delle relazioni tra gli Stati dell’area, la Cina e i grandi protettori occidentali, gli Stati uniti. Duterte sembra voler ridisegnare le alleanze in un pianeta – il Sudest asiatico – dove in cinesi han fatto passi avanti ma dove Washington resta il dominus e da cui la Russia appare oggi abbastanza distante. Le reazioni non mancano.
In casa prima di tutto: alcuni politici locali agitano lo spettro di un rischio troppo grosso considerato che gli Usa spendono nelle Filippine fior di milioni e che un recente sondaggio vede la popolazione più favorevole agli americani che ai cinesi, a dispetto delle manifestazioni di piazza a sostegno della svolta di Duterte. In ballo c’è molto: l’accordo di cooperazione militare, firmato col suo predecessore, che consente agli Usa di utilizzare cinque basi aeree e navali nell’arcipelago, le imminenti esercitazioni militari congiunte non ancora cancellate ma soprattutto un asse strategico pensato proprio per contenere la Cina. Infine i 4,7 miliardi di dollari attualmente investiti da Washington. Il capo del Pentagono Ashton Carter si limita a dire che gli Usa intendono conservare il loro alleato e anche il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby – che ha dovuto incassare gli insulti a Obama definito da Duterte “figlio di buonadonna” – getta acqua sul fuoco limitandosi a dire che verranno chieste spiegazioni su questa separation annunciata. Spiegazioni che saranno richieste da un assistente di Kerry – Daniel Russel – che ha in agenda a breve una visita a Manila. Ma a Washington sono preoccupati. La leva del denaro non può bastare se è vero che Pechino ha promesso accordi per 13,5 miliardi di dollari: c’è chi dice che bisogna puntare sui diritti umani, facendo la voce grossa su quei tremila tra spacciatori e e malviventi fatti fuori dalla polizia di Duterte da quando a giugno si è insediato. La partita è aperta.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Rohyngia nel mirino: niente cibo per i musulmani birmani
 |
| Anche la Nobel discrimina la minoranza musulmana del Myanmar |
Non c’è pace per i Rohyngia del Myanmar. La piccola comunità (un milione di persone) – che lo Stato a maggioranza buddista ha deciso di chiamare non col loro nome ma definendoli solo “gente che professa l’islam” – è oggetto di una nuova discriminazione da quando l’esercito ha circondato un’area dove si nasconderebbe un gruppo islamico armato ma impedendo di fatto alle agenzie umanitarie di prestare soccorso e aiuti alimenti ad almeno 80mila persone, sfollate dopo gli incidenti settari del 2012.
L’escalation contro la comunità, che non ha diritto di cittadinanza e rappresentanza in parlamento e verso la quale anche la Nobel Aung San Suu Kyi non dimostra alcuna attenzione, data dalle recenti azioni di Aqa Mul Mujahidin, un gruppo armato di circa 400 combattenti che si è già scontrato con le forze di sicurezza che ora gli danno la caccia nel Nord dello Stato di Rakhine, al confine col Bangladesh. L’organizzazione che secondo il governo sarebbe legata al Rohingya Solidarity Organization – gruppo armato smantellato – sarebbe guidata dal 45enne Havistoohar, di un villaggio dell’area di Maungdaw, che sarebbe stato in Pakistan con i talebani e riceverebbe finanziamenti dal Medio Oriente.
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Cronache di Afgania: il ngoziato forse, ma più migranti e disturbi mentali. I talebani e Daesh (aggiornato)
 Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
Nonostante l’Afghanistan sia uscito dai riflettori del mainstream qualcosa continua ad accadere nel Paese della guerra infinita con un aumento continuo di vittime civili : i talebani hanno smentito che vi siano stati colloqui di pace col governo ma la notizia, data l’altro ieri dal Guardian, è stata poi confermata da Kabul anche se in forma ufficiosa. Le notizie nella notizia (due incontri a settembre e ottobre a Doha, dove ha sede l'”ambasciata” dell’emirato del movimento guidato da Haibatullah Akhundzada – nella foto a destra tratta da ToloNews) sono anche altre.
A quanto si sa a questi incontri avrebbe partecipato per il governo afgano il National Security Advisor del presidente Ghani, Mohammad Hanif Atmar e Mohammad Masum Stanekzai, a capo del National Directorate of Security (NDS, i servizi afgani). Per i talebani vi sarebbe stato tra gli altri mullah Abdul Manan Akhund, fratello di mullah Omar e in futuro vi potrebbe partecipare anche Mohammad Yaqoob, il figlio del vecchio leader sostituito da mullah Mansur fatto fuori da un drone americano mesi fa in Pakistan: una mossa che fece fallire un inizio di negoziato sponsorizzato da Islamabad. Infine ci sarebbe stato un diplomatico americano, cosa indirettamente confermata dall’ambasciata a Kabul.*
Se gli incontro sono avvenuti, come pare, ci sono due fatti molto rilevanti: il primo è che i pachistani erano assenti, per Islamabad una pessima notizia e foriera di chissà quali future pessime novità. La seconda è che a rappresentare Kabul non c’era l’Alto consiglio di pace ma i servizi. Quantomeno bizzarro.
Su un altro fronte – e c’è forse un legame tra queste cose o quantomeno rispetto alla posizione sempre più antipachistana presa da Kabul – le Nazioni unite hanno fatto sapere che le espulsioni di afgani dal Pakistan continuano e che siamo già a quota 400mila. Non è gente che lascia volontariamente un Paese per far ritorno nel proprio paradiso. Un dato di quanto l’Afghanistan sia una terra di incubi lo racconta lo stato di chi soffre di disturbi mentali: secondo il ministero della Sanità ci sono 10 milioni di afgani (uno su quattro) che soffrono di disturbi che vanno dalla perdita di memoria a continui incubi notturni. L’utilizzo di psicofarmaci è in forte aumento.
| Akhundzada in una rara immagine |
Resta da segnalare una presa di posizione dei talebani sulle recenti stragi di sciiti rivendicate da Daesh. Scrivono sul loro sito: “In Afghanistan, Sunnis and Shias have co-existed for centuries. They live communal lives and participate in their mutual festivities. And for centuries they have fought shoulder to shoulder against foreign invaders….The foreign occupiers seek to ignite the flames of communal hatred and violence between Sunnis and Shias in Afghanistan… Once the flames of communal violence are ignited, the Afghans will cannibalize each other, weaken their unity, actively seek foreign assistance, and ultimately welcome any foreign intervention that helps in repressing the opposition forces”. E fin qui sembrerebbe che la colpa ricada sugli invasori, ma c’è un passaggio interessante sbito dopo:
“It is said that humans usually only understand that which they can see with their eyes or sense with any of their five senses. Even then we don’t have to look very far to see the destructive effects of such divisive politics. Looking at the current situation of the Middle East or Western Asia, one can easily grasp the destruction caused by this Sunni-Shia divide”. Qui il riferimento a Daesh è ovvio ma è anche abbastanza noto che chi soffia sul fuoco della divisione settaria è l’Arabia saudita, vecchio sponsor dei talebani, in guerra più o meno fredda con Teheran con cui la shura di Quetta è invece attualmente in buoni rapporti. Mansur, quando fu ucciso, veniva dall’Iran.
* Il presidente Ghani ha emesso un decreto che dà il via all’accordo di pace con Hekmatyar e l’Hezb-e-Islami. I nove punti si possono leggere in questo articolo di Pajhwok
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Afghanistan, rimpatrio forzato: qualcuno ci pensa
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14498
presentato da
MARCON Giulio
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692
MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
recentemente l’Unione europea ha intrapreso una strada che potrebbe segnare un grave precedente e un punto di non ritorno nelle politiche migratorie: rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Il riferimento è al recente nuovo accordo tra Unione europea ed Afghanistan, il « Joint way forward on migration issues between Afghanistan and EU» firmato a Kabul, al Palazzo presidenziale il 2 ottobre e il suo nesso con la Conferenza internazionale sull’Afghanistan che si è chiusa il 6 ottobre, con la promessa di nuovi sussidi economici al Paese (altri 15,2 miliardi di euro);
per la prima volta infatti si fa un accordo di riammissione forzata con un Paese in una situazione di conflitto conclamato. Nello specifico, l’intesa dice che i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in uno Stato membro dell’Unione, verranno rimpatriati nel loro Paese d’origine: si prediligerà il «ritorno volontario» altrimenti si procederà con i «rimpatri forzati» anche di massa;
gli afghani sono il secondo gruppo per numero di richiedenti asilo giunti nell’Unione europea – sia nel 2015 che nei primi otto mesi del 2016, ora si trovano al centro di un accordo su rimpatri, riammissioni e reintegri;
l’Afghanistan è classificato come quartultimo nel Global Peace Index 2016: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L’Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che sia secondo solo all’Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all’interno del Paese (Global Terrorism Index 2016). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell’Easo, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati nel 2015 11 mila civili vittime di violenza. Prevedere in un Paese come questo un rimpatrio forzato è un pericolosissimo precedente e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé drammatica;
sebbene entrambe le parti neghino che vi sia un nesso diretto tra la firma dell’accordo e la concessione degli aiuti, osservatori e fonti giornalistiche rivelano che un collegamento in effetti vi sarebbe, e che sarebbe stata la Germania a imporre come condizione per l’elargizione di aiuti la firma dell’accordo. In due diversi sessioni parlamentari, il 29 settembre e il 2 ottobre 2016, autorevoli esponenti del Governo afghano come il Ministro degli affari esteri, Salahuddin Rabbani, e quello delle finanze, Eklil Hakimi, hanno fatto esplicito riferimento al legame tra la concessione degli aiuti e l’accordo sui rimpatri. Una condizionalità che di certo era nell’aria da tempo e che appare in linea con la tendenza europea dell’ultimo periodo ad esternalizzare la gestione di una crisi migratoria apparentemente senza soluzione, fornendo in cambio aiuti economici (si vedano il caso del recente accordo con la Turchia, nonché i processi di Rabat e Khartoum) –:
quale sia la posizione del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
se il Governo intenda firmare un accordo bilaterale e se questo prevedrà anche il rimpatrio forzato;
se non ritenga una contraddizione quanto previsto nell’accordo in merito ai rimpatri, alla luce delle condizioni di sicurezza dell’Afghanistan e della circostanza che la cooperazione italiana non ha recentemente ammesso, sulla base di un giudizio dell’ambasciata, confermato anche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), due progetti sull’Afghanistan proprio a causa delle condizioni di sicurezza e delle norme internazionali che dispongono che si possono fare rimpatri solo se il Paese di rimpatrio è sicuro. (4-14498)
Si legga sul tema anche Giuliano Battiston sul suo blog Talibanistan
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
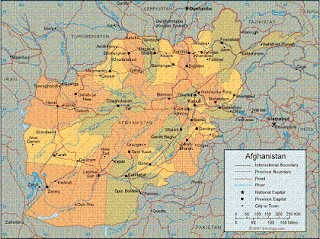 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
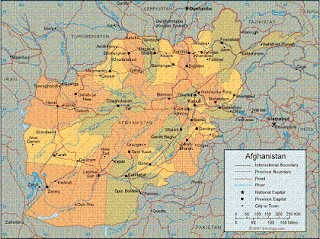 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
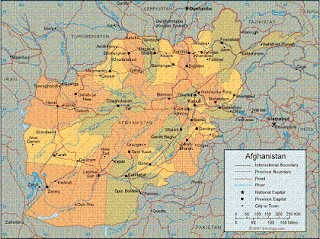 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
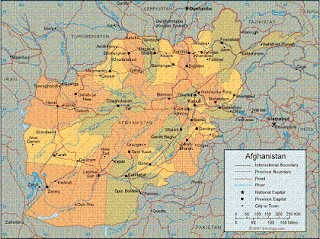 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Non solo guerra: Le ombre del futuro afgano
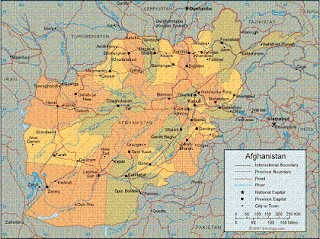 Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nel gennaio del 2015, a sei mesi dalle ultime elezioni presidenziali, un sondaggio di Acso-Lra (Afghan Center for socio economic and opinion research con Langer Research Associates) rivelava un atteggiamento positivo sulle aspettative prodotte dalla nuova tornata elettorale, pur se per il 53% degli intervistati le elezioni erano state fraudolente e solo il 44% le aveva valutate trasparenti. Inoltre la bizzarra alchimia istituzionale, che ha posto accanto al presidente un capo dell’esecutivo che ha quasi gli stessi poteri, era ritenuta accettabile dall’87% del campione. Una percentuale elevatissima. Ma soltanto 11 mesi dopo, nel novembre del 2015, i risultati di Asia Foundation (Af) – che conduce sondaggi da diversi anni in Afghanistan studiando soprattutto il consenso – rivelava quasi esattamente il contrario: il 57% del campione di Af sosteneva che il Paese andava nella direzione sbagliata e il 75,3% di consenso guadagnato dalle promesse della campagna elettorale del 2014 (come abbiamo visto salite all’87% dopo la tornata elettorale) erano calate al 57,8%. Più della metà degli intervistati, il 56,3%, oltre a esprimere paura per la crescente insicurezza del Paese (le vittime civili sono in costante aumento), era fortemente insoddisfatto dei servizi erogati in quasi tutti i settori pubblici: elettricità, strade, acqua potabile, sanità, agricoltura e persino dello stato dell’istruzione, realtà che, dall’inizio della guerra nel 2001, ha visto un rilevante salto in avanti. Unica vera luce nel tunnel della guerra afgana.
Nondimeno la percentuale di chi crede nelle elezioni come forma per eleggere i propri leader sembra restare elevata ( l’80% del campione Acso-Lra) anche se la rilevazione di Af rivelava che sempre più afgani vogliono lasciare il Paese (oggi il 39,9% rispetto al 22,8% del 2011). Una spia rilevante del fatto che le aspettative restano deluse: il Paese è in panne e oltre al persistere della guerra si allargano le ombre che ipotecano il futuro. Si fugge da conflitto – come ben raccontano i dati sull’emigrazione clandestina o le richieste d’asilo – ma anche da un’economia che va sempre peggio.
 |
| Il palazzo presidenziale di Arg Doppio comando e molta confusione |
L’Afghanistan, in cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti in un mercato del lavoro largamente informale, è in recessione. La sua economia, sostenuta per oltre due terzi da finanziamenti esteri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor: la ricchezza nazionale (Pnl), che nel 2011 cresceva al 6,1%, nel 2014 era calata all’1,3 e allo 0,8 l’anno seguente, con una stima della World Bank addirittura dello 0,5% per il 2016. Benché la Banca mondiale preveda un futuro più roseo nei prossimi anni (la Conferenza di Bruxelles di inizio ottobre ha promesso circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020) le prospettive continuano quantomeno a essere molto fragili. La caduta della moneta afgana (afghanis), che per anni è stata la più forte della regione (rispetto ad esempio alle divise di Pakistan, Iran o delle ex repubbliche sovietiche) può probabilmente favorire le esportazioni ma è un segnale che difficilmente richiamerà investitori. La capacità produttiva industriale è debolissima, l’agricoltura è in affanno e la bolla speculativa che negli anni scorsi ha letteralmente avvolto la corsa edilizia della capitale (anche in previsione della costruzione di un nuovo centro direzionale) si è arrestata, sia per la contrazione della domanda interna sia perché instabilità e insicurezza continuano ad essere due fattori di rischio ineludibili. Le divisioni interne al governo infine paralizzano le riforme, la lotta alla corruzione e una programmazione condivisa e l’unico risultato che Kabul può vantare è solo una più virtuosa politica fiscale e più ordine nei conti pubblici. Poco.
In questa situazione non è difficile capire come il desiderio di lasciare il Paese sia tra le opzioni considerate sia da chi ha i mezzi per farlo sia da chi spera nell’asilo politico. Ma il recente accordo con Bruxelles, che prevede il rimpatrio di almeno 80mila afgani nei prossimi mesi (anche con rientri non volontari) e la minaccia del Pakistan di espellere entro marzo 2017 un milione di afgani indocumentati residenti nel Paese dei puri (250mila sono già stati espulsi) – che si andranno ad aggiungere al milione di sfollati interni – non compensa i pochi benefici acquisti: una seppur fragile democrazia, il diritto all’istruzione (da un milione di studenti nel 2002 agli attuali 8.7, di cui il 36% ragazze), una maggior coscienza del ruolo della donna e la nascita di diverse organizzazioni della società civile che godono di largo consenso (almeno fino a quando la comunità internazionale continuerà a sostenere queste giovani forme associative) e che in gran parte suppliscono allo scarso welfare nazionale. Un’ultima menzione merita la circolazione di notizie e la nascita di network televisivi e radiofonici anche se in gran parte dipendono da finanziamenti esteri (occidentali, pachistani, iraniani) che spesso dunque rispondono a logiche ed agende non esattamente indipendenti.
Questo articolo è uscito all’interno di un dossier Afghanistan dell’Ispi a cura di Annalisa Perteghella sul sito de LaRivistaIlMulino
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
Strage di sciiti in Afghanistan firmata Daesh
 Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
Sono due nel giro di 24 ore gli attacchi alla minoranza sciita dell’Afghanistan che hanno ucciso oltre una trentina di persone e ne hanno ferite a decine durante la vigilia e la festa dell’Ashura, che segna l’inizio del primo mese del calendario islamico (Muharram) e commemora la morte di Husain ibn Ali, il nipote del profeta Maometto. L’ultima strage in ordine di tempo avviene ieri con una bomba che esplode fuori da un tempio sciita a venti chilometri da Mazar-i-Sharif, la capitale della provincia settentrionale di Balkh. I morti erano già saliti a 15 nel pomeriggio di ieri, mentre i feriti sono oltre una ventina. La sera prima invece è la volta di Kabul dove un cecchino uccide almeno 18 persone e ne ferisce una cinquantina tra i fedeli che si stanno recando ala moschea Cart-i-Sakhi (nell’immagine un particolare del tempio) in un distretto della capitale. Tra loro c’è anche Sumaia Mohammadi, un membro del Coniglio provinciale della provincia di Daikundi, ma non è lei l’obiettivo. La strategia, già testata dallo Stato Islamico, è colpire nel mucchio come ha già fatto in luglio, sempre a Kabul, uccidendo oltre 80 hazara (sciiti) che protestavano per un progetto governativo che li penalizzava. Daesh infatti ha rivendicato la strage di martedì notte ed è molto probabile, se non certo, che sia da attribuire ai sodali di Raqqa in Afghanistan anche il massacro di Mazar.
L’effetto degli attentati è quello di dare al presidente Ashraf Ghani, che con altri membri del governo ha partecipato ieri a una manifestazione di pubblica celebrazione dell’Ashura, la possibilità di ribadire l’unita degli afgani al di là del tipo di appartenenza religiosa e di chiedere agli ulema di entrambe le correnti – sciiti e sunniti – di unirsi contro il terrorismo. Ma è anche quello di far capire che una nuova stagione di violenza è cominciata anche se Daesh appare isolato ma comunque in grado di sparare nel mucchio e far crescere la tensione in un Paese quotidianamente vittima di un conflitto che dura ormai da oltre 35 anni.
Sciopero: se 150 milioni di persone che protestano non bucano il video
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi
Iphone e cortei
 Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
C’è chi fa le pulci
 |
| Asia Ramazan Antar nelle due immagini più note che, secondo gran parte dei media, mettono in rilievo la somiglianza con l’attrice Angiolina Jolie |
Fair, un’associazione americana che dal 1968 si occupa di censura, accuratezza e parzialità dei media, ha fatto le pulci anche ai giornali non indiani: non una menzione dai network americani Abc, Cbs, Nbc, Cnn, Fox, Msnbc. Npr. Anche giornali importanti come New York Times, Washington Post o USA Today si sono limitati a riprendere note d’agenzia, per altro scarse. Nessuno aveva sentito il bisogno di far muovere inviati o corrispondenti. In Italia? Lasciamo perdere.
Se si esclude qualche sito specializzato (anche italiano), 150 milioni di persone in sciopero semplicemente non c’erano. Oscurate. Da cosa? Fair fa un parallelo con la notizia dell’imminente uscita dell’ultimo iPhone di Apple. «Questo – scrive il direttore di Fair.org, Jim Naureckas – fa notizia»: per Cbs nel suo programma Money Watch e così per Npr nelle rubriche Morning Edition e All Things Considered. Iphone guadagna un titolo di prima in USA Today e nel Wall Street Journal o nella business section del New York Times.
Bambini in fuga
Anche i minori, nonostante sia un tema che suscita almeno compassione, sono abbastanza oscurati. Poca luce per l’ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” appena pubblicato dal Fondo dell’Onu per l’infanzia che spiega come quasi 50 milioni di ragazzi e bambini attraversino frontiere o scappino dai conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte fra loro proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da due sole nazioni: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci ma dell’Afghanistan assai meno perché quella guerra è ormai uscita dai riflettori. Oscurata dall’indifferenza per un conflitto considerato chiuso. Eppure ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano migliaia di persone, bambini compresi, che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
Sfollati afgani
 |
| L’Afghanistan, la guerra, i morti e gli sfollati sono spariti dai grandi media |
Secondo il sottosegretario generale per gli Affari umanitari (Ocha) Stephen O’Brien è necessario un intervento urgente per far fronte a quello che si pensa potrebbe presto essere il numero degli sfollati che attraversano la frontiera col Pakistan : un milione di persone entro dicembre. L’inverno, ha detto O’Brian, rischia di vedere centinaia di famiglie esposte con un flusso dalla frontiera pachistana di 5mila persone al giorno (già 245mila dall’inizio del 2016) che si aggiungeranno al milione di sfollati interni, in una situazione in cui 2,7 milioni di persone sono malnutrite: fra queste, un milione di bambini sotto i 5 anni. 120mila tra loro rischiano di morire di fame. Uscita se non altro su alcuni giornali locali, la notizia ha fatto rimandare a marzo la scadenza che i pachistani avevano fissato per i rimpatri. Il milione di sfollati è per ora rimandato a primavera.
Talebani sempre cattivi
Se restiamo in Afghanistan c’è anche un’altra notizia che è stata completamente oscurata. Anche dalla stampa locale: la smentita dei talebani sull’azione di commando che lunedi 5 settembre ha semidistrutto un ufficio dell’Ong “Care” a Kabul, dove alcuni militanti, con l’aiuto di un autobomba, avevano preso d’assalto Sharenaw, zona di ambasciate e Ong, sventrando diverse strutture. Care aveva messo le mani avanti sostenendo che a loro avviso l’obiettivo era altro e i talebani hanno chiarito che il target era «un centro di intelligence militare gestito dall’ex capo dell’intelligence dell’amministrazione di Kabul nella quale c’è anche una branca dello spionaggio straniero… la Ong ha sede in una strada della zona militarizzata e non aveva nulla a che vedere col piano. L’obiettivo – scrivono – non era Care International». Vero o falso che sia, la guerra afgana è anche una guerra di bugie visto che per il ministero dell’Interno l’obiettivo era senza dubbio Care pur se la Ong aveva smentito. I talebani hanno polemizzato anche con Amnesty, accusata per aver definito la loro azione un “crimine di guerra”. Amnesty però ha chiesto un’indagine indipendente per chiarire le responsabilità anche se purtroppo questo genere di proposte non vengono mai messe in opera. Restano, con tutte le altre, oscurate.
Incidenti ignoti
Anche l’esplosione alla Tampaco Folis in Bangladesh del 10 settembre è passata quasi inosservata. Come sempre in questi casi, il numero dei morti è andato aumentando sino ad arrivare a 26, un bilancio che potrebbe crescere. Il fuoco è divampato a Tongi, una quindicina di chilometri dalla capitale Dacca e c’erano almeno tre elementi di “notiziabilità”: il numero appunto delle vittime che, nel caso di esplosioni, tende sempre ad aumentare in seguito alle ustioni. Il fatto che la fabbrica lavorava per colossi internazionali come Nestlé o British American Tobacco. Il fatto che si tratta del più grave incidente da quello che nel 2014 uccise oltre mille persone nel collasso del Rana Plaza, un edifico che conteneva diverse fabbrichette tessili e che crollò perché la proprietà aveva deciso di innalzare l’altezza del palazzo. A ben vedere in realtà, nemmeno la vicenda Rana Plaza ebbe, soprattutto in Italia, una grande copertura mediatica. Figurarsi un incendio con “solo” 26 vittime. Fortunatamente del caso di sono occupate diverse associazioni e organizzazioni sindacali locali e internazionali che ormai tengono il Bangladesh sotto stretta sorveglianza. Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network hanno preso subito posizione chiedendo conto a Nestlé e Bat del perché facciano lavorare per loro azienda che non hanno standard adeguati di sicurezza. E’ per altro un caso comune – come nella Tampaco Foils – l’esplosione di boiler e l’incendio che ne consegue che divora rapidamente strutture spesso fragili e inadeguate. Il problema è che che l’accordo sulla prevenzione degli incendi non prevede la prevenzione di queste esplosioni (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Il caso Tampaco potrebbe essere la spinta a rivederlo.
A che serve una campagna
Stampa, televisione, radio possono fare molto. Ma ciò che fa davvero sono le mobilitazioni di associazioni e sindacati. Che a loro volta hanno però bisogno che i media si accorgano delle loro battaglie. I risultati si vedono. Grazie a una campagna durata quattro anni e dopo mesi di negoziato – raccontano alla Campagna “Abiti puliti” – è stato raggiunto finalmente un accordo per il pagamento di altri 5 milioni di dollari di risarcimenti ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime del più grande disastro industriale del Pakistan, avvenuto l’11 settembre 2012. Vi persero la vita più di 255 lavoratori e oltre 50 rimasero feriti nell’incendio divampato nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi. Alcuni lavoratori arsero vivi dietro finestre sprangate e porte bloccate mentre altre rimasero inferme dopo essersi lanciate dai piani più alti. Adesso, il distributore tedesco KiK, unico acquirente conosciuto della Ali Enterprises, ha accettato di versare una quota aggiuntiva di 5,15 milioni di dollari nel fondo per la perdita di reddito, cure mediche e costi di riabilitazione per i feriti e i familiari delle vittime. Precedentemente KiK aveva pagato un milione. La nuova decisione si deve alla campagna promossa da National Trade Union Federation, Piler, IndustriALL Global Union, Clean Clothes Campaign e altre alleanze tra cui UNI Global Union. All’accordo hanno contribuito anche IndustriALL, l’International Labour Organization (ILO) e una richiesta del Ministro dello sviluppo e della cooperazione economica tedesco. Poche settimane prima dell’incendio, l’azienda aveva ricevuto la certificazione SA8000 dalla società di revisione Sai (Social Accountability International) che aveva affidato l’incarico all’ente di certificazione italiano Rina: Teoricamente la fabbrica aveva presumibilmente soddisfatto gli standard internazionali in nove aree, compresa salute e sicurezza. Teoricamente.
Sciopero: se 150 milioni di persone che protestano non bucano il video
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi
Iphone e cortei
 Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
Il 2 settembre scorso in India, qualcosa come 150 milioni di lavoratori sono scesi in sciopero. 150 milioni (180 secondo altre fonti) non sono pochi nemmeno per un Paese che conta oltre un miliardo e 250 milioni di anime, considerato che nell’Unione, tra l’altro, i lavoratori sindacalizzati sono solo il 4% della forza lavoro. Il17mo sciopero generale indiano, da che nel 1991 l’economia è stata liberalizzata, sarebbe stato il più numericamente importante nella storia del Paese. Ma, notava il sito Alertnet, la vicenda non ha “bucato il video” come si dice in gergo: «La sensibilità dei singoli giornalisti – scrive il professor Vijay Prashad – solo raramente sfonda il muro di cinismo costituito dai proprietari dei media e dalla cultura che vorrebbero creare… Per loro le lotte dei lavoratori sono un inconveniente… lo sciopero è un disturbo, un fastidio trattato come arcaico, un residuo d’altri tempi e non il mezzo necessario per esprimere frustrazioni e speranze. Bandiere rosse, slogan e discorsi son vissuti con imbarazzo. Ed è come se, girando lo sguardo altrove, in qualche modo si riuscisse a farli sparire». Lo sciopero per altro è andato benissimo: dai lavoratori del Gujarat, dove il premier Narendra Modi ha iniziato la sua scalata politica, ai tessili del Tamil Nadu o ai metalmeccanici del Karnataka; bancari, autisti, operai delle aziende elettriche, impiegati. Ma senza copertura o con giusto qualche richiamo con foto. L’obiettivo non era secondario: a parte le rivendicazioni locali, l’insieme degli scioperanti rivendicavamo maggior democrazia e tutele ambientali sul posto di lavoro e una miglior distribuzione della ricchezza. Con un manifesto in 12 punti di cui, alla viglia dello sciopero, il governo aveva accettato qualche minima richiesta. Non sufficiente a fermare la chiusura delle fabbriche.
C’è chi fa le pulci
 |
| Asia Ramazan Antar nelle due immagini più note che, secondo gran parte dei media, mettono in rilievo la somiglianza con l’attrice Angiolina Jolie |
Fair, un’associazione americana che dal 1968 si occupa di censura, accuratezza e parzialità dei media, ha fatto le pulci anche ai giornali non indiani: non una menzione dai network americani Abc, Cbs, Nbc, Cnn, Fox, Msnbc. Npr. Anche giornali importanti come New York Times, Washington Post o USA Today si sono limitati a riprendere note d’agenzia, per altro scarse. Nessuno aveva sentito il bisogno di far muovere inviati o corrispondenti. In Italia? Lasciamo perdere.
Se si esclude qualche sito specializzato (anche italiano), 150 milioni di persone in sciopero semplicemente non c’erano. Oscurate. Da cosa? Fair fa un parallelo con la notizia dell’imminente uscita dell’ultimo iPhone di Apple. «Questo – scrive il direttore di Fair.org, Jim Naureckas – fa notizia»: per Cbs nel suo programma Money Watch e così per Npr nelle rubriche Morning Edition e All Things Considered. Iphone guadagna un titolo di prima in USA Today e nel Wall Street Journal o nella business section del New York Times.
Bambini in fuga
Anche i minori, nonostante sia un tema che suscita almeno compassione, sono abbastanza oscurati. Poca luce per l’ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” appena pubblicato dal Fondo dell’Onu per l’infanzia che spiega come quasi 50 milioni di ragazzi e bambini attraversino frontiere o scappino dai conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte fra loro proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da due sole nazioni: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci ma dell’Afghanistan assai meno perché quella guerra è ormai uscita dai riflettori. Oscurata dall’indifferenza per un conflitto considerato chiuso. Eppure ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano migliaia di persone, bambini compresi, che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
Sfollati afgani
 |
| L’Afghanistan, la guerra, i morti e gli sfollati sono spariti dai grandi media |
Secondo il sottosegretario generale per gli Affari umanitari (Ocha) Stephen O’Brien è necessario un intervento urgente per far fronte a quello che si pensa potrebbe presto essere il numero degli sfollati che attraversano la frontiera col Pakistan : un milione di persone entro dicembre. L’inverno, ha detto O’Brian, rischia di vedere centinaia di famiglie esposte con un flusso dalla frontiera pachistana di 5mila persone al giorno (già 245mila dall’inizio del 2016) che si aggiungeranno al milione di sfollati interni, in una situazione in cui 2,7 milioni di persone sono malnutrite: fra queste, un milione di bambini sotto i 5 anni. 120mila tra loro rischiano di morire di fame. Uscita se non altro su alcuni giornali locali, la notizia ha fatto rimandare a marzo la scadenza che i pachistani avevano fissato per i rimpatri. Il milione di sfollati è per ora rimandato a primavera.
Talebani sempre cattivi
Se restiamo in Afghanistan c’è anche un’altra notizia che è stata completamente oscurata. Anche dalla stampa locale: la smentita dei talebani sull’azione di commando che lunedi 5 settembre ha semidistrutto un ufficio dell’Ong “Care” a Kabul, dove alcuni militanti, con l’aiuto di un autobomba, avevano preso d’assalto Sharenaw, zona di ambasciate e Ong, sventrando diverse strutture. Care aveva messo le mani avanti sostenendo che a loro avviso l’obiettivo era altro e i talebani hanno chiarito che il target era «un centro di intelligence militare gestito dall’ex capo dell’intelligence dell’amministrazione di Kabul nella quale c’è anche una branca dello spionaggio straniero… la Ong ha sede in una strada della zona militarizzata e non aveva nulla a che vedere col piano. L’obiettivo – scrivono – non era Care International». Vero o falso che sia, la guerra afgana è anche una guerra di bugie visto che per il ministero dell’Interno l’obiettivo era senza dubbio Care pur se la Ong aveva smentito. I talebani hanno polemizzato anche con Amnesty, accusata per aver definito la loro azione un “crimine di guerra”. Amnesty però ha chiesto un’indagine indipendente per chiarire le responsabilità anche se purtroppo questo genere di proposte non vengono mai messe in opera. Restano, con tutte le altre, oscurate.
Incidenti ignoti
Anche l’esplosione alla Tampaco Folis in Bangladesh del 10 settembre è passata quasi inosservata. Come sempre in questi casi, il numero dei morti è andato aumentando sino ad arrivare a 26, un bilancio che potrebbe crescere. Il fuoco è divampato a Tongi, una quindicina di chilometri dalla capitale Dacca e c’erano almeno tre elementi di “notiziabilità”: il numero appunto delle vittime che, nel caso di esplosioni, tende sempre ad aumentare in seguito alle ustioni. Il fatto che la fabbrica lavorava per colossi internazionali come Nestlé o British American Tobacco. Il fatto che si tratta del più grave incidente da quello che nel 2014 uccise oltre mille persone nel collasso del Rana Plaza, un edifico che conteneva diverse fabbrichette tessili e che crollò perché la proprietà aveva deciso di innalzare l’altezza del palazzo. A ben vedere in realtà, nemmeno la vicenda Rana Plaza ebbe, soprattutto in Italia, una grande copertura mediatica. Figurarsi un incendio con “solo” 26 vittime. Fortunatamente del caso di sono occupate diverse associazioni e organizzazioni sindacali locali e internazionali che ormai tengono il Bangladesh sotto stretta sorveglianza. Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network hanno preso subito posizione chiedendo conto a Nestlé e Bat del perché facciano lavorare per loro azienda che non hanno standard adeguati di sicurezza. E’ per altro un caso comune – come nella Tampaco Foils – l’esplosione di boiler e l’incendio che ne consegue che divora rapidamente strutture spesso fragili e inadeguate. Il problema è che che l’accordo sulla prevenzione degli incendi non prevede la prevenzione di queste esplosioni (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Il caso Tampaco potrebbe essere la spinta a rivederlo.
A che serve una campagna
Stampa, televisione, radio possono fare molto. Ma ciò che fa davvero sono le mobilitazioni di associazioni e sindacati. Che a loro volta hanno però bisogno che i media si accorgano delle loro battaglie. I risultati si vedono. Grazie a una campagna durata quattro anni e dopo mesi di negoziato – raccontano alla Campagna “Abiti puliti” – è stato raggiunto finalmente un accordo per il pagamento di altri 5 milioni di dollari di risarcimenti ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime del più grande disastro industriale del Pakistan, avvenuto l’11 settembre 2012. Vi persero la vita più di 255 lavoratori e oltre 50 rimasero feriti nell’incendio divampato nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi. Alcuni lavoratori arsero vivi dietro finestre sprangate e porte bloccate mentre altre rimasero inferme dopo essersi lanciate dai piani più alti. Adesso, il distributore tedesco KiK, unico acquirente conosciuto della Ali Enterprises, ha accettato di versare una quota aggiuntiva di 5,15 milioni di dollari nel fondo per la perdita di reddito, cure mediche e costi di riabilitazione per i feriti e i familiari delle vittime. Precedentemente KiK aveva pagato un milione. La nuova decisione si deve alla campagna promossa da National Trade Union Federation, Piler, IndustriALL Global Union, Clean Clothes Campaign e altre alleanze tra cui UNI Global Union. All’accordo hanno contribuito anche IndustriALL, l’International Labour Organization (ILO) e una richiesta del Ministro dello sviluppo e della cooperazione economica tedesco. Poche settimane prima dell’incendio, l’azienda aveva ricevuto la certificazione SA8000 dalla società di revisione Sai (Social Accountability International) che aveva affidato l’incarico all’ente di certificazione italiano Rina: Teoricamente la fabbrica aveva presumibilmente soddisfatto gli standard internazionali in nove aree, compresa salute e sicurezza. Teoricamente.
Oggi la Marcia Perugia Assisi per la pace: il programma
della pace e della fraternità
9 ottobre 2016
PROGRAMMA
Ore 7.00 – Perugia, Messa alla Basilica di San Pietro
Ore 7.30 Perugia, Giardini del Frontone
Accoglienza dei partecipanti
Ore 8.30 Perugia, Porta San Girolamo
Interventi di apertura
Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica
Andrea Romizi, Sindaco di Perugia
Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia
Famiglia Galasso
Don Pierluigi di Piazza, Centro di Accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano
Taisir Masrieh, Musicista palestinese
La Famiglia di Raffaella Presta
Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
studenti e insegnanti della scuola di Amatrice
Intervento musicale della Marching Band #AssaltoRitmico
Ore 9.00: Partenza della Marcia da Perugia
Dalle ore 10.00 A Santa Maria degli Angeli,… in attesa della Marcia:
Interventi musicali dei D.E.C. e dei Maram Oriental Ensemble
Interventi delle scuole partecipanti alla Marcia
Padre Kizito, Missionario comboniano
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni
Konstantinos Polikronopoulos, organizzatore della Cucina Sociale “L’altro uomo” di Atene
Mohamed Dachan Nour, Ucoi
Don Renato Sacco, Coordinatore Pax Christi
Pietro Suber, Carta di Roma
Enea Discepoli, fotografo
Giovani provenienti da paesi in guerra – Associazione Rondine Cittadella della pace di Arezzo
Caschi Bianchi operazione Colomba (Cile e Zambia)
Associazione Como senza confini
Intervento teatrale del gruppo Our Voice, giovani di Funima International e Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Conducono Mario Mirabassi, Guido Barbera e Piero Piraccini
Ore 14.00: Arrivo della Marcia nella Piazza inferiore di San Francesco
Saluti di
p. Egidio Canil e p. Enzo Fortunato del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi
Mons. Vincenzo Sorrentino, Vescovo
Ore 15.00 Assisi, Rocca Maggiore
“Manifestazione conclusiva”
Interventi musicali del Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
Intervento musicale di Erica Boschiero
Messaggi e interventi di:
gli studenti e gli insegnanti che partecipano alla PerugiAssisi
gli Enti Locali e le Regioni che partecipano alla PerugiAssisi
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi
Nando Mismetti, Presidente della Provincia di Perugia
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria
Andrea Ferrari, Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Nadia Bouzekri, Presidente Giovani Musulmani d’Italia
Kamal Abbas, Coordinatore del CTUWS, Egitto
Cecile Kyenge, Parlamentare europea
p. Alex Zanotelli, Missionario comboniano
Paolo Borrometi, giornalista Agi
Vittorio Di Trapani, segretario UsigRai
Giuseppe Giulietti, presidente FNSI
Jean Fabre, esperto Onu
Sergio Bassoli, Coordinatore della Rete della pace
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi
Coordina: Elisa Marincola
Ore 16.30 Conclusione della Marcia
Oggi la Marcia Perugia Assisi per la pace: il programma
della pace e della fraternità
9 ottobre 2016
PROGRAMMA
Ore 7.00 – Perugia, Messa alla Basilica di San Pietro
Ore 7.30 Perugia, Giardini del Frontone
Accoglienza dei partecipanti
Ore 8.30 Perugia, Porta San Girolamo
Interventi di apertura
Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica
Andrea Romizi, Sindaco di Perugia
Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia
Famiglia Galasso
Don Pierluigi di Piazza, Centro di Accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano
Taisir Masrieh, Musicista palestinese
La Famiglia di Raffaella Presta
Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
studenti e insegnanti della scuola di Amatrice
Intervento musicale della Marching Band #AssaltoRitmico
Ore 9.00: Partenza della Marcia da Perugia
Dalle ore 10.00 A Santa Maria degli Angeli,… in attesa della Marcia:
Interventi musicali dei D.E.C. e dei Maram Oriental Ensemble
Interventi delle scuole partecipanti alla Marcia
Padre Kizito, Missionario comboniano
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni
Konstantinos Polikronopoulos, organizzatore della Cucina Sociale “L’altro uomo” di Atene
Mohamed Dachan Nour, Ucoi
Don Renato Sacco, Coordinatore Pax Christi
Pietro Suber, Carta di Roma
Enea Discepoli, fotografo
Giovani provenienti da paesi in guerra – Associazione Rondine Cittadella della pace di Arezzo
Caschi Bianchi operazione Colomba (Cile e Zambia)
Associazione Como senza confini
Intervento teatrale del gruppo Our Voice, giovani di Funima International e Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Conducono Mario Mirabassi, Guido Barbera e Piero Piraccini
Ore 14.00: Arrivo della Marcia nella Piazza inferiore di San Francesco
Saluti di
p. Egidio Canil e p. Enzo Fortunato del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi
Mons. Vincenzo Sorrentino, Vescovo
Ore 15.00 Assisi, Rocca Maggiore
“Manifestazione conclusiva”
Interventi musicali del Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma
Intervento musicale di Erica Boschiero
Messaggi e interventi di:
gli studenti e gli insegnanti che partecipano alla PerugiAssisi
gli Enti Locali e le Regioni che partecipano alla PerugiAssisi
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi
Nando Mismetti, Presidente della Provincia di Perugia
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria
Andrea Ferrari, Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Nadia Bouzekri, Presidente Giovani Musulmani d’Italia
Kamal Abbas, Coordinatore del CTUWS, Egitto
Cecile Kyenge, Parlamentare europea
p. Alex Zanotelli, Missionario comboniano
Paolo Borrometi, giornalista Agi
Vittorio Di Trapani, segretario UsigRai
Giuseppe Giulietti, presidente FNSI
Jean Fabre, esperto Onu
Sergio Bassoli, Coordinatore della Rete della pace
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi
Coordina: Elisa Marincola
Ore 16.30 Conclusione della Marcia
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
 |
| Soldi in cambio di uomini? |
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati. E nella capitale si prevede un nuovo scalo solo per loro
Dalla Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, dopo le buone notizie arriva la doccia fredda. E se la borsa è piena per circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020 che consentiranno al malridotto governo di Ashraf Ghani di tirare il fiato, gli aiuti sono stati condizionati all’accettazione di un piano segreto che riguarda i migranti afgani costato sei mesi di trattative. Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato una strategia per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Della cosa però non si era più saputo nulla e, addirittura, si era detto che la questione migranti non sarebbe stata vincolata agli aiuti elargiti dal vertice di Bruxelles. Ma la vicenda invece è saltata fuori proprio a Bruxelles che è stata la cornice dell’accettazione del piano da parte di Kabul: un piano che prevede che chiunque si veda rifiutato il diritto di asilo, una volta verificato che non vi siano altre possibilità di accettazione in un Paese membro, venga rispedito a casa. Lo voglia o no. In altre parole una deportazione concordata. A che ritmo? Per i prossimi sei mesi almeno 50 persone per aereo su voli diretti a Kabul o ad altro aeroporto afgano anche se il numero dei voli non viene quantificato. Si capisce però che non saranno pochi, tanto che le parti si sono accordate per un eventuale nuovo terminal dedicato agli espulsi nell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan che accetta di riceverli e integrarli, ossia farli semplicemente rientrare nel Paese.
 |
| La vignetta spiega bene come la vedono gli afgani: soldi in cambio del tutti a casa |
Sino ad ora solo 5mila migranti afgani hanno fatto ritorno volontario a casa su 178mila che, nel 2015, hanno fatto richiesta d’asilo nella Ue: quattro volte di più che nel 2014 e arrivando a costituire il secondo gruppo di migranti dopo i siriani. Kabul deve fare buon viso a cattivo gioco con oltre un milione di sfollati interni e la minaccia di Islamabad di rimandare a casa entro marzo un milione di afgani, un terzo dei quali è già stato espulso dal Pakistan.
Benché i funzionari di Bruxelles neghino che sia sia utilizzata la leva degli aiuti per far deglutire a Kabul l’amaro calice, è davvero difficile pensare che non sia stato così: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, è stato chiaro quando ha spiegato che la Ue sosterrà Kabul con denaro e programmi per nuovi posti di lavoro in Afghanistan e già da giorni per altro i tedeschi erano stati ancora più chiari: o l’Afghanistan si riprende i migranti o si chiude la borsa.
Tutti a casa. Accordo Ue Kabul per espellere i migranti
 |
| Soldi in cambio di uomini? |
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette aiuti ma li vincola al ritorno degli afgani indesiderati. E nella capitale si prevede un nuovo scalo solo per loro
Dalla Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, dopo le buone notizie arriva la doccia fredda. E se la borsa è piena per circa 4 miliardi di dollari l’anno sino al 2020 che consentiranno al malridotto governo di Ashraf Ghani di tirare il fiato, gli aiuti sono stati condizionati all’accettazione di un piano segreto che riguarda i migranti afgani costato sei mesi di trattative. Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato una strategia per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Della cosa però non si era più saputo nulla e, addirittura, si era detto che la questione migranti non sarebbe stata vincolata agli aiuti elargiti dal vertice di Bruxelles. Ma la vicenda invece è saltata fuori proprio a Bruxelles che è stata la cornice dell’accettazione del piano da parte di Kabul: un piano che prevede che chiunque si veda rifiutato il diritto di asilo, una volta verificato che non vi siano altre possibilità di accettazione in un Paese membro, venga rispedito a casa. Lo voglia o no. In altre parole una deportazione concordata. A che ritmo? Per i prossimi sei mesi almeno 50 persone per aereo su voli diretti a Kabul o ad altro aeroporto afgano anche se il numero dei voli non viene quantificato. Si capisce però che non saranno pochi, tanto che le parti si sono accordate per un eventuale nuovo terminal dedicato agli espulsi nell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan che accetta di riceverli e integrarli, ossia farli semplicemente rientrare nel Paese.
 |
| La vignetta spiega bene come la vedono gli afgani: soldi in cambio del tutti a casa |
Sino ad ora solo 5mila migranti afgani hanno fatto ritorno volontario a casa su 178mila che, nel 2015, hanno fatto richiesta d’asilo nella Ue: quattro volte di più che nel 2014 e arrivando a costituire il secondo gruppo di migranti dopo i siriani. Kabul deve fare buon viso a cattivo gioco con oltre un milione di sfollati interni e la minaccia di Islamabad di rimandare a casa entro marzo un milione di afgani, un terzo dei quali è già stato espulso dal Pakistan.
Benché i funzionari di Bruxelles neghino che sia sia utilizzata la leva degli aiuti per far deglutire a Kabul l’amaro calice, è davvero difficile pensare che non sia stato così: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, è stato chiaro quando ha spiegato che la Ue sosterrà Kabul con denaro e programmi per nuovi posti di lavoro in Afghanistan e già da giorni per altro i tedeschi erano stati ancora più chiari: o l’Afghanistan si riprende i migranti o si chiude la borsa.
Bruxelles vs Kabul: doccia fredda sui migranti afgani
Si chiama Joint Way Forward e se n’era parlato già mesi fa quando un memo segreto della Ue aveva delineato un piano per il rimpatrio di almeno 80mila afgani. Ma adesso il memo – nella cornic della Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan – è un accordo che consente di espellere i richiedenti asilo dall’Unione e che Kabul ha dovuto accettare assieme alle elargizioni di aiuti…
continua domani su Great Game
Un po’ meno poveri ma sempre in guerra
 La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
Mentre i talebani hanno lanciato una nuova massiccia offensiva proprio alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta ieri a Bruxelles, nella capitale belga arriva il momento delle promesse per un Paese dove – sono dati Ue – il 40% della popolazione vive sotto la linea di povertà e un terzo degli afgani ancora non sa leggere né scrivere. Mentre scriviamo si combatte a Kunduz, nell’Helmand e in altre aree a Nord e a Sud. E si litiga: in parlamento e nel governo, scaricandosi le responsabilità per l’ennesima battaglia in una città – Kunduz – tenuta un anno fa dalla guerriglia per quasi una settimana. C’è chi dice che l’offensiva finirà per favorire l’apertura della borsa dei Paesi amici. E c’è chi invece pensa che sia l’ennesimo colpo basso a un governo in perenne crisi e a una presenza della Nato che, pur ridotta nel numero dei soldati, è rimasta nel Paese a presidiare soltanto le caserme che proteggono i suoi militari.
 |
| Sempre in guerra: combattenti anti inglesi in una stampa del 1800. Sotto la bandiera Nato |
Ieri l’Unione Europea ha promesso, in aggiunta al suo programma 2014-2020 (circa 1,4 miliardi di euro) oltre 200 milioni annui per due anni dal 2017 per sostenere l’agenda del governo di Ashraf Ghani, il presidente “dimezzato” insediato due anni fa dopo faticose elezioni presidenziali (ora dovremmo essere alla viglia di una nuova corsa elettorale per il parlamento) che alla fine hanno sancito un governo a due teste: quella di Ghani e quella di Abdullah Abdullah, ex mujaheddin cui, in barba alla Costituzione, gli americani, veri artefici della nascita del nuovo governo, hanno ritagliato – per raffreddare le sue accuse di brogli – un ruolo di primo piano che lo apparenta al presidente. Col risultato che il governo a due teste – si sa ma non si dice – non funziona. Oggi, se tutto va secondo i piani, gli americani dovrebbero annunciare altri 3 miliardi di dollari l’anno cui dovrebbero aggiungersi – oltre ai 200 milioni figli dell’accordo Ue per favorire lo “State building” – il miliardo che l’insieme dei Paesi membri* verserà annualmente a Kabul almeno sino al 2020. Poi ci sono altri attori (a Bruxelles siedono settanta Paesi e venti tra organizzazioni e agenzie internazionali) e quindi il piatto si arricchirà. Ma con molti però e legando l’aiuto futuro a quanto gli afgani sapranno e soprattutto vorranno fare. Non è un assegno in bianco né per gli europei né per gli americani.
 Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Ma se Ghani tornerà a casa soddisfatto (un altro accordo prevede che l’aiuto militare continuerà ancora per anni e che il governo avrà i fondi per pagare gli stipendi ai soldati afgani) sul piano della pace, al di là di una retorica che ormai non viene neppure più utilizzata, passi avanti non se ne vedono come ben dimostra un Paese dove aumentano le vittime civili e dove la guerriglia – che si era sempre limitata ad attentati e a qualche azione eclatante – sembra aver cambiato strategia, puntando al cuore delle città. A Bruxelles nessuno si chiederà se abbia senso mantenere ancora una presenza militare dai costi enormi e che per un eventuale negoziato è l’ostacolo maggiore visto che per i talebani l’uscita degli stranieri dal Paese è il primo paletto per sedersi al tavolo della trattativa. Né gli alleati chiederanno conto agli Stati Uniti dell’accordo con Kabul che consente a Washington il controllo di dieci basi militari, ipoteca che ha fatto restare nel Paese 10mila soldati Usa, fermare il piano graduale di ritiro promesso da Obama e obbligare la Nato a rimanere. Un quadro dove, accanto alle nostre responsabilità, si sommano i disegni dei Paesi vicini: il Pakistan naturalmente, ma anche l’India, sempre più muscolare nel suo piano di avvicinamento a Kabul, o la Cina che, silenziosamente e “armoniosamente”, si sta accaparrando gran parte del tesoro minerario nazionale. Ci di dovrà accontentare dei quattrini.
* Ieri è stato approvato dall’Italia il Programma per la riduzione della mortalità infantile nelle province di Kabul e Herat, in Afghanistan, per 4 milioni di euro
Un po’ meno poveri ma sempre in guerra
 La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
La Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan promette nuovi aiuti alla ricostruzione. Ma il Paese è a ferro e fuoco e i veri nodi per pacificarlo restano un tabù
Mentre i talebani hanno lanciato una nuova massiccia offensiva proprio alla vigilia della Conferenza sull’Afghanistan che si è aperta ieri a Bruxelles, nella capitale belga arriva il momento delle promesse per un Paese dove – sono dati Ue – il 40% della popolazione vive sotto la linea di povertà e un terzo degli afgani ancora non sa leggere né scrivere. Mentre scriviamo si combatte a Kunduz, nell’Helmand e in altre aree a Nord e a Sud. E si litiga: in parlamento e nel governo, scaricandosi le responsabilità per l’ennesima battaglia in una città – Kunduz – tenuta un anno fa dalla guerriglia per quasi una settimana. C’è chi dice che l’offensiva finirà per favorire l’apertura della borsa dei Paesi amici. E c’è chi invece pensa che sia l’ennesimo colpo basso a un governo in perenne crisi e a una presenza della Nato che, pur ridotta nel numero dei soldati, è rimasta nel Paese a presidiare soltanto le caserme che proteggono i suoi militari.
 |
| Sempre in guerra: combattenti anti inglesi in una stampa del 1800. Sotto la bandiera Nato |
Ieri l’Unione Europea ha promesso, in aggiunta al suo programma 2014-2020 (circa 1,4 miliardi di euro) oltre 200 milioni annui per due anni dal 2017 per sostenere l’agenda del governo di Ashraf Ghani, il presidente “dimezzato” insediato due anni fa dopo faticose elezioni presidenziali (ora dovremmo essere alla viglia di una nuova corsa elettorale per il parlamento) che alla fine hanno sancito un governo a due teste: quella di Ghani e quella di Abdullah Abdullah, ex mujaheddin cui, in barba alla Costituzione, gli americani, veri artefici della nascita del nuovo governo, hanno ritagliato – per raffreddare le sue accuse di brogli – un ruolo di primo piano che lo apparenta al presidente. Col risultato che il governo a due teste – si sa ma non si dice – non funziona. Oggi, se tutto va secondo i piani, gli americani dovrebbero annunciare altri 3 miliardi di dollari l’anno cui dovrebbero aggiungersi – oltre ai 200 milioni figli dell’accordo Ue per favorire lo “State building” – il miliardo che l’insieme dei Paesi membri* verserà annualmente a Kabul almeno sino al 2020. Poi ci sono altri attori (a Bruxelles siedono settanta Paesi e venti tra organizzazioni e agenzie internazionali) e quindi il piatto si arricchirà. Ma con molti però e legando l’aiuto futuro a quanto gli afgani sapranno e soprattutto vorranno fare. Non è un assegno in bianco né per gli europei né per gli americani.
 Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Questi ultimi, rimbalzano il vecchio refrain sulla lotta alla corruzione e legano l’aiuto, sembra di capire, al fatto che il governo dovrà fare come dice Washington, si tratti di pace o di guerra. Dovrà soprattutto garantire – e questo sembra il non detto più evidente – che le basi militari afgane, di cui gli Stati Uniti hanno il diritto di servirsi come credono, dovranno rispettare l’accordo siglato da Ghani appena eletto presidente che garantisce di fatto agli Usa il controllo dell’intero Paese. I tedeschi invece non hanno usato perifrasi: o Kabul rispetta le regole – e cioè in sostanza pone un freno ai suoi migranti verso la Ue – oppure si rifanno i conti (nel caso di Berlino sono 1,7 milioni di euro per quattro anni). Una posizione già espressa alla viglia della Conferenza.
Ma se Ghani tornerà a casa soddisfatto (un altro accordo prevede che l’aiuto militare continuerà ancora per anni e che il governo avrà i fondi per pagare gli stipendi ai soldati afgani) sul piano della pace, al di là di una retorica che ormai non viene neppure più utilizzata, passi avanti non se ne vedono come ben dimostra un Paese dove aumentano le vittime civili e dove la guerriglia – che si era sempre limitata ad attentati e a qualche azione eclatante – sembra aver cambiato strategia, puntando al cuore delle città. A Bruxelles nessuno si chiederà se abbia senso mantenere ancora una presenza militare dai costi enormi e che per un eventuale negoziato è l’ostacolo maggiore visto che per i talebani l’uscita degli stranieri dal Paese è il primo paletto per sedersi al tavolo della trattativa. Né gli alleati chiederanno conto agli Stati Uniti dell’accordo con Kabul che consente a Washington il controllo di dieci basi militari, ipoteca che ha fatto restare nel Paese 10mila soldati Usa, fermare il piano graduale di ritiro promesso da Obama e obbligare la Nato a rimanere. Un quadro dove, accanto alle nostre responsabilità, si sommano i disegni dei Paesi vicini: il Pakistan naturalmente, ma anche l’India, sempre più muscolare nel suo piano di avvicinamento a Kabul, o la Cina che, silenziosamente e “armoniosamente”, si sta accaparrando gran parte del tesoro minerario nazionale. Ci di dovrà accontentare dei quattrini.
* Ieri è stato approvato dall’Italia il Programma per la riduzione della mortalità infantile nelle province di Kabul e Herat, in Afghanistan, per 4 milioni di euro
Congiura di palazzo: esordio letterario con vendetta
“Orgogliosi di supportare il turismo verso l’Italia”, dice questo manifesto di Ryanair appeso alloscalo romano di Fiumicino. Come, scusi? Supportare? Cosa potrebbe fare al grafico pubblicitario e al responsabile delle campagne di Ryanair Claudia Palazzo, una giovane e brillante scrittrice alla sua prima opera letteraria da qualche mese in libreria? L’autrice di “Morte del piccolo principe e altre vendette” ha infatti una sacrosanta ossessione: l’italiano. E quei maledetti inglesismi di cui è piena la lingua scritta persino più di quella parlata (supportare, implementare o il terribile “di sempre” che ora impazza), Ma non solo; anche quel non meno terribile “piuttosto che” divenuto ormai una delle tante inesplicabili aberrazioni dell’italiano (c’è un’indagine in proposito della Crusca sulla sua origine, pare toscana). Il problema è che Claudia Palazzo non perdona. Non perdona non soltanto il cattivo uso dell’italiano, e dunque l’ignoranza, ma nemmen la supponenza, il potere mal esercitato, la spocchia. le ingiustizie. E, in ogni racconto della sua breve raccolta, punisce. Ferisce mortalmente e nella maniera più feroce. Dissacrando.
 Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Claudia Palazzo
Morte del piccolo principe e altre vendette
Il Palindromo 2016
pp 109
euro 10
Congiura di palazzo: esordio letterario con vendetta
“Orgogliosi di supportare il turismo verso l’Italia”, dice questo manifesto di Ryanair appeso alloscalo romano di Fiumicino. Come, scusi? Supportare? Cosa potrebbe fare al grafico pubblicitario e al responsabile delle campagne di Ryanair Claudia Palazzo, una giovane e brillante scrittrice alla sua prima opera letteraria da qualche mese in libreria? L’autrice di “Morte del piccolo principe e altre vendette” ha infatti una sacrosanta ossessione: l’italiano. E quei maledetti inglesismi di cui è piena la lingua scritta persino più di quella parlata (supportare, implementare o il terribile “di sempre” che ora impazza), Ma non solo; anche quel non meno terribile “piuttosto che” divenuto ormai una delle tante inesplicabili aberrazioni dell’italiano (c’è un’indagine in proposito della Crusca sulla sua origine, pare toscana). Il problema è che Claudia Palazzo non perdona. Non perdona non soltanto il cattivo uso dell’italiano, e dunque l’ignoranza, ma nemmen la supponenza, il potere mal esercitato, la spocchia. le ingiustizie. E, in ogni racconto della sua breve raccolta, punisce. Ferisce mortalmente e nella maniera più feroce. Dissacrando.
 Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Tanto dissacrando che persino il piccolo, tenero principino uscito dalla penna di Saint-Exupéry fa una pessima fine. Ma come, persino lui tanto carino? Si, perché altrettanto viziato, moccioso spocchiosello che non merita pietà. Ed è forse – proprio per la sua carica dissacrante – il racconto più riuscito che apre una piccola galleria di feroci esecuzioni. Favolette moderne ma… attenzione. Molto più feroci di quanto non lo siano le favole dei fratelli Grimm. Dunque lettura consigliata per far addormentare i vostri pargoletti. Dopo la lezione di italiano piuttosto che d’inglese, piuttosto che di matematica, piuttosto che…
Claudia Palazzo
Morte del piccolo principe e altre vendette
Il Palindromo 2016
pp 109
euro 10
Vedo dunque so, la parabola di Asiatica
 Si conclude oggi a Roma uno dei Festival sull’Asia più importanti d’Italia. Un
Si conclude oggi a Roma uno dei Festival sull’Asia più importanti d’Italia. Un
festival di cinema sul continente più popoloso del pianeta che si deve alla caparbietà di un signore romano, e al suo variegato gruppo di amici, che da 17 anni a questa parte si danno da fare per farci raccontare dagli autoctoni come sono, cosa vivono, quel che sognano. Operazione rara in un Paese abituato a guardarsi l’ombelico e rara in un continente- l’Europa – così conscio della sua missione di civiltà da ignorare o quasi tutte le altre. Così che non c’è da stupirsi se la stampa – mainstream e non – gli dedica troppo poca attenzione e se altrettanto fanno i fondi pubblici, buoni per lo Stretto sul canale ma sviati da quel che, anziché farci andare più in fretta da una parte all’altra, ci invita a fermarci per esercitare l’arte della ragione.
Nonostante le difficoltà, quel signore di Roma (Italo Spinelli) e la sua banda di amici ce l’hanno fatta anche questa volta, ricorrendo a sponsor e al crowf, questa nuova forma di sostegno che in qualche modo funziona. Ce l’anno fatta a farci vedere, nella 17ma rassegna di Asiatica Film Mediale, qualcosa come 20 tra film, corti e documentari da 40 Paesi, un record che si aggiunge ai numeri delle edizioni precedenti: 800 titoli provenienti da 40 Paesi diversi, incontri con 420 registi, qualcosa come poco meno di 10mila spettatori. E’ molto, ma è anche poco.
E’ molto perché Asiatica è un faro nella notte come tutte le rassegne che allargano il nostro sguardo sulla diversità. E’ molto perché c’è un team di ricercatori che ci ha fatto scoprire la cinematografia iraniana, gli sforzi di quella pachistana, la nascita di quella progressista afgana e così via. E’ molto perché non c’è molto altro di analogo e comunque nulla che vada così in profondità e a largo raggio sul cinema dell’Asia. Ma è poco perché resta una rarità per collezionisti, scarsamente dotata di fondi e non esibita come di dovrebbe dalla città che la ospita da 17 anni.
Che succederà quando la caparbietà di Spinelli dovesse cedere il passo alla rassegnazione o alla stanchezza? E’ una delle tante domande che andrebbero fatte alla sindaca della capitale che temo però abbia altro a cui pensare. Comunque, per chi non ci fosse andato, il catalogo della mostra è illuminante. Non c’è che da sperare che l’evento si ripeta. E c’è da sperare che dia luogo a un contagio, che emigri anche in qualche sede distaccata in un’altra città italiana. Che magari abbia intenzione di risvegliarsi da un lungo sonno che da vent’anni almeno grava sullo stivaletto senza Ponte sullo stretto.
Vedo dunque so, la parabola di Asiatica
 Si conclude oggi a Roma uno dei Festival sull’Asia più importanti d’Italia. Un
Si conclude oggi a Roma uno dei Festival sull’Asia più importanti d’Italia. Un
festival di cinema sul continente più popoloso del pianeta che si deve alla caparbietà di un signore romano, e al suo variegato gruppo di amici, che da 17 anni a questa parte si danno da fare per farci raccontare dagli autoctoni come sono, cosa vivono, quel che sognano. Operazione rara in un Paese abituato a guardarsi l’ombelico e rara in un continente- l’Europa – così conscio della sua missione di civiltà da ignorare o quasi tutte le altre. Così che non c’è da stupirsi se la stampa – mainstream e non – gli dedica troppo poca attenzione e se altrettanto fanno i fondi pubblici, buoni per lo Stretto sul canale ma sviati da quel che, anziché farci andare più in fretta da una parte all’altra, ci invita a fermarci per esercitare l’arte della ragione.
Nonostante le difficoltà, quel signore di Roma (Italo Spinelli) e la sua banda di amici ce l’hanno fatta anche questa volta, ricorrendo a sponsor e al crowf, questa nuova forma di sostegno che in qualche modo funziona. Ce l’anno fatta a farci vedere, nella 17ma rassegna di Asiatica Film Mediale, qualcosa come 20 tra film, corti e documentari da 40 Paesi, un record che si aggiunge ai numeri delle edizioni precedenti: 800 titoli provenienti da 40 Paesi diversi, incontri con 420 registi, qualcosa come poco meno di 10mila spettatori. E’ molto, ma è anche poco.
E’ molto perché Asiatica è un faro nella notte come tutte le rassegne che allargano il nostro sguardo sulla diversità. E’ molto perché c’è un team di ricercatori che ci ha fatto scoprire la cinematografia iraniana, gli sforzi di quella pachistana, la nascita di quella progressista afgana e così via. E’ molto perché non c’è molto altro di analogo e comunque nulla che vada così in profondità e a largo raggio sul cinema dell’Asia. Ma è poco perché resta una rarità per collezionisti, scarsamente dotata di fondi e non esibita come di dovrebbe dalla città che la ospita da 17 anni.
Che succederà quando la caparbietà di Spinelli dovesse cedere il passo alla rassegnazione o alla stanchezza? E’ una delle tante domande che andrebbero fatte alla sindaca della capitale che temo però abbia altro a cui pensare. Comunque, per chi non ci fosse andato, il catalogo della mostra è illuminante. Non c’è che da sperare che l’evento si ripeta. E c’è da sperare che dia luogo a un contagio, che emigri anche in qualche sede distaccata in un’altra città italiana. Che magari abbia intenzione di risvegliarsi da un lungo sonno che da vent’anni almeno grava sullo stivaletto senza Ponte sullo stretto.
La prima guerra angloafgana e l’inizio del Grande Gioco
 |
| Passo di Bolan, ingresso a Sud per l’Afghanistan |
A metà del 1800 Londra e Calcutta, sede della Compagnia delle Indie, decidono di reinsediare a Kabul un re afgano spodestato anni prima. Per controllare il Paese e contenere la Russia. Ne uscirono con le ossa rotta. Una lezione che sembra restare valida oggi*
Il 30 settembre 1838 Lord Auckland, governatore generale delle Indie, promulga il “Manifesto di Simla” con cui la Gran Bretagna decide ufficialmente di spodestare il re dell’Afghanistan, che teme alleato dei russi, per sostituirlo con un altro monarca che rientra nelle sue simpatie. E’ il punto di partenza della più tragica sconfitta subita dagli inglesi nel Paese dell’Hindukush. Una lezione che, ripetutasi con i sovietici negli anni Ottanta, sembra ricordare in parte anche quanto succede adesso in quel lontano Paese. E’ il vero inizio guerreggiato del “Great Game”, il grande gioco tra l’Impero zarista e quello britannico per la conquista dell’Asia centrale. Un gioco che non è mai finito anche se gli attori sono in parte cambiati.
 |
|||
| Lord Auckland |
Auckland, anche se è soltanto un governatore generale e la “Perla dell’Impero” è ancora amministrata dalla Compagnia delle Indie – un’impresa commerciale con diplomatici, amministratori, mercanti, tribunali e soldati – rappresenta di fatto la Corona. Che col Manifesto dichiara in sostanza guerra all’Afghanistan, allora come oggi un turbolento Paese ma fondamentale crocevia nel cuore dell’Asia. E annuncia l’intenzione di reinsediare sul trono, al momento occupato dal Khan Dost Mohammad, il re Shah Shuja. I britannici temevano le mire sull’Afghanistan dei persiani e soprattutto dei russi e Dost Mohammad – un pashtun Barakzai – prestava troppo orecchio alle blandizie e alle offerte degli emissari dello Zar e stava pensando di rimpossessarsi di Peshawar, caduta nella mani di Ranjit Singh, potente sovrano sikh che godeva delle simpatie inglesi. Shah Shuja – esule in India – era un sovrano Sadozai cacciato da beghe di palazzo afgane e come tale sufficientemente disponibile ad accettare l’aiuto degli inglesi per tornare sul trono. A Shah Shuja, gli inglesi avevano trovato un posto a Ludhiana, nel Punjab, dove viveva un esilio dorato sognando Kabul.
 |
| La corte di Shah Shuja |
Auckland ha dovuto mediare tra i fautori del ritorno di Shah Shuja e quelli che sconsigliano l’avventura. Tra coloro che temono che la campagna afgana non sarà facile e chi la ritene una passeggiata. Tra questi c’è sir William Macnaghten, ascoltato consigliere politico. Ma l’idea piace anche all’artefice della politica estera britannica, il Visconte Palmerston. Quanto a quelli che in teoria son contrari o perplessi, vengono convinti dall’ambizione: è il caso dello stesso Auckland e di Alexander Burnes, che aveva ottimi rapporti col Khan, ma che per l’occasione era stato promosso e nominato baronetto. Macnaghten e Burnes furono dunque inviati a Kabul come rappresentanti britannici alla nuova corte di Shah Shuja e alla testa di un potente esercito.
L’operazione comincia da Sud con destinazione Kandahar. Al comando di Burnes la forza d’occupazione varca il passo di Bolan nel Sind nella primavera del 1839 e il 25 aprile Shah Shuja, accompagnato da Macnaghten, entra in città senza colpo ferire. Poi è la volta di Ghazni, più a Nord sulla strada per la capitale. Ma se l’avanzata militare va bene, i vertici britannici si rendono conto che attraversare l’Afghanistan è tutt’altro che una passeggiata e anche che Shah Shuja non sembra avere il consenso sperato. Si guardano bene dal comunicarlo a Calcutta e a Londra. Il dado è tratto.
La perdita di Ghazni obbliga Dost Mohammad a fuggire. O meglio a temporeggiare per trovare un altro modo di organizzare la resistenza contro un esercito disciplinato e bene armato contro cui in campo aperto avrebbe perso. A luglio il nuovo re riprende possesso della sua capitale che non vede da trent’anni. Scrive Jhon William Kaye, autore nel 1874 di una Storia della guerra in Afghanistan: “Il tintinnio delle borse di monete e il luccichio delle baionette inglesi gli avevano restituito il trono, ma ad accoglierlo c’era quello che sembrava più un corteo funebre che non l’ingresso di un re nella capitale dei suoi restaurati domini”. Il piano iniziale di Macnaghten dunque va rivisto. Insediare Shah Shuja non basta e bisogna presidiare la città e dunque restare. L’invasione si trasforma in occupazione. Nonostante diversi segnali che i consiglieri di Shah Shuja e i più accorti tra gli inglesi o tra le loro guide indiane avevano fatto presente ai capi, il comando britannico sembra ignorare la realtà. Macnaghten sta già pensando al suo prossimo incarico – il governatorato di Bombay – e Burnes se la spassa senza far gran attenzione al fatto che in Afghanistan toccare una donna locale non è uno scherzo che si dimentica. La piccola comunità dei civili al seguito, cresciuta con l’arrivo di mogli, figli e servitù, segue le partite di cricket e sorseggia tè compiacendosi del clima fresco di Kabul dove il caldo può essere feroce in estate ma è sempre secco e spesso mitigato dalle brezze. Non è solo la vita di quegli expat, come oggi li chiameremmo, a dare scandalo: i soldati al comando del generale Elphinstone, un militare già anziano e senza la benché minima idea di quel si va preparando, si erano distinti in azioni punitive contro le tribù circostanti. Gli accantonamenti inglesi inoltre, anziché essere vicini alla fortezza di Bala Hissar, sede del re, erano isolati e periferici rispetto al centro città. Un mondo a parte che stava per essere travolto.
 |
| Kabul tra Londra e Mosca |
Gli inglesi non capiscono che il figlio di Dost Mohammad, il principe
Mohammad Akbar Khan, sta preparando la contromossa. Solo qualcuno se ne rende conto: “L’animosità verso di noi aumenta di giorno in giorno e i loro mullah predicano contro di noi da un capo all’altro del Paese” scrive il maggiore Henry Rawlinson. Ma è una voce nel deserto. Il 1 novembre del 1841 parte il primo attacco che ha per obiettivo la casa di Burnes. L’uomo è praticamente solo perché le truppe, che tra l’altro esitano a muoversi, sono a quattro chilometri da casa sua che presto vien data alle fiamme. Burnes viene ucciso dalla folla inferocita. Mentre la rivolta si estende Macnaghten e Elphinstone perdono tempo prezioso in lunghe discussioni: agire? Punire? Trattare? Decidono di prepararsi a un possibile assedio nel mezzo del quale tenteranno qualche disastrosa sortita. Sotto il comando del principe, diventato poi il simbolo dell’indipendenza afgana, le truppe disomogenee delle tribù hanno mutato il tipico individualismo tribale in un jihad collettivo contro l’invasore. Col consenso di una popolazione che non solo odia gli stranieri, ma li accusa di aver fatto aumentare i prezzi al bazar. Akbar è ormai il dominus della situazione. In dicembre Macnaghten accetta di incontrarlo su una collina poco lontano dal fiume Kabul. Ma è una trappola. Il principe ha saputo che gli inglesi hanno pagato alcuni capi tribù per corromperli e li ripagano della stessa moneta. Nella notte il cadavere di Macnaghten, mutilato di testa, braccia e gambe, penzola a un palo del bazar.
La partita è persa e Elphinstone negozia un salvacondotto e una scorta per far rientro in India attraverso il Kyber Pass, la gola che porta dall’Hindukush alle pianure del Gange. Elphinstone sa che se raggiunge Jalalabad, ai piedi del passo, è salvo. Ma la sua disgraziata missione non ha futuro. Akabar è d’accordo con le tribù che aspettano gli inglesi al varco. La scorta promessa non arriva e un inverno impietoso aggiunge brace al fuoco che sta per divampare. La ritirata si rivela un disastro con assalti e agguati, mentre la penuria di cibo e i geloni falciano i civili aggregati alla truppa. Dopo l’ultima strage a Gandamak, quando ormai la meta sembra vicina, dell’armata inglese non resta quasi più nulla o così almeno sembra perché il 13 gennaio, dei sedicimila partiti da Kabul una settimana prima, arriva a Jalalabad un solo uomo: ferito e stremato che si trascina sul suo cavallo. E’ un medico, il dottor Brydon, il protagonista di uno dei più celebri ritratti di epoca vittoriana: Remnants of an Army di Elizabeth Butler.
 |
| Di 16mila… un uomo solo |
La prima guerra afgana, cominciata nel 1839 e finita nel 1842 si conclude conun bilancio pesantissimo. Oltre a Brydon si è salvato solo qualche inglese fatto prigioniero. Freddo, fame, sciabolate e malattie hanno aiutato gli afgani a espellere l’invasore. Umiliandolo. Alla fine di marzo anche Shah Shuja – tradito – viene assassinato. Chiude la vicenda la morte di un re di comodo che aveva fatto ritorno a casa sulla punta delle lance inglesi e che gli inglesi alla fine avevano abbandonato al suo destino.
Che c’è da leggere
Il grande classico sul Great Game, la guerra di spie, soldati, colpi di mano e spedizioni militari che attraversò tutto l’Ottocento asiatico, è Il Grande Gioco di Peter Hopkirk in cui l’autore mescola fatti e documenti a una grande capacità narrativa in oltre 600 pagine che compongono il puzzle di quello che i russi chiamavano invece “Torneo delle ombre”. Operazione ripetuta poi con Diavoli stranieri sulla Via della Seta (entrambi di Adelphi), ambientato nei primi del ‘900 e che è invece la storia di avventurosi scopritori di quelle antiche civiltà. Il Grande Gioco in Asia centrale lo racconta anche Karl Meyer ne La polvere dell’impero, uscito qualche anno fa per Corbaccio, mentre Antony Wynn sceglie invece di dilungarsi su un frammento di quella storia (La Persia nel Grande Gioco, Il Saggiatore) come fa per altro William Dalrymple, che nel suo recente Il ritorno di un re (Adelphi) si concentra proprio su Shah Shuja, il re che possedeva il Ko-i-nur e che gli inglesi reinsediarono a Kabul. Ma Dalrymple lo fa con una marcia in più e cioè utilizzando moltissime fonti locali: afgane, indiane, persiane e lo stesso diario di Shah Shuja. Gli effetti di un Grande Gioco trascinatosi sino ai giorni nostri si possono invece leggere in Samarcanda. Storie di una città dal 1945 a oggi (Cliopoli), un libro fresco di stampa di Marco Buttino che analizza i cambiamenti di una città chiave nel Grande Gioco. Italiano è anche l’autore de Il cammello battriano (Neri Pozza), piacevolissimo racconto di Stefano Maltesta su una riscoperta tra gli echi del Great Game e della Via della seta.
*In forma più estesa questo racconto si può ascoltare in podcast su Radio3 Wikiradio a cura di Loredana Rotundo. Regia e scelte dei sonori di Antonella Borghi. L’articolo in edicola oggi con il manifesto
** aggiungo anche che, per mia colpa, ho scritto due volte 19… anziché 18… sicché sembra che la guerra anziché qualche anno sia durata un secolo… l’ho corretto nel post ma aihmé non sul giornale
*** qui una lettura odierna di quella crisi segnalatami da un lettore
La prima guerra angloafgana e l’inizio del Grande Gioco
 |
| Passo di Bolan, ingresso a Sud per l’Afghanistan |
A metà del 1800 Londra e Calcutta, sede della Compagnia delle Indie, decidono di reinsediare a Kabul un re afgano spodestato anni prima. Per controllare il Paese e contenere la Russia. Ne uscirono con le ossa rotta. Una lezione che sembra restare valida oggi*
Il 30 settembre 1838 Lord Auckland, governatore generale delle Indie, promulga il “Manifesto di Simla” con cui la Gran Bretagna decide ufficialmente di spodestare il re dell’Afghanistan, che teme alleato dei russi, per sostituirlo con un altro monarca che rientra nelle sue simpatie. E’ il punto di partenza della più tragica sconfitta subita dagli inglesi nel Paese dell’Hindukush. Una lezione che, ripetutasi con i sovietici negli anni Ottanta, sembra ricordare in parte anche quanto succede adesso in quel lontano Paese. E’ il vero inizio guerreggiato del “Great Game”, il grande gioco tra l’Impero zarista e quello britannico per la conquista dell’Asia centrale. Un gioco che non è mai finito anche se gli attori sono in parte cambiati.
 |
|||
| Lord Auckland |
Auckland, anche se è soltanto un governatore generale e la “Perla dell’Impero” è ancora amministrata dalla Compagnia delle Indie – un’impresa commerciale con diplomatici, amministratori, mercanti, tribunali e soldati – rappresenta di fatto la Corona. Che col Manifesto dichiara in sostanza guerra all’Afghanistan, allora come oggi un turbolento Paese ma fondamentale crocevia nel cuore dell’Asia. E annuncia l’intenzione di reinsediare sul trono, al momento occupato dal Khan Dost Mohammad, il re Shah Shuja. I britannici temevano le mire sull’Afghanistan dei persiani e soprattutto dei russi e Dost Mohammad – un pashtun Barakzai – prestava troppo orecchio alle blandizie e alle offerte degli emissari dello Zar e stava pensando di rimpossessarsi di Peshawar, caduta nella mani di Ranjit Singh, potente sovrano sikh che godeva delle simpatie inglesi. Shah Shuja – esule in India – era un sovrano Sadozai cacciato da beghe di palazzo afgane e come tale sufficientemente disponibile ad accettare l’aiuto degli inglesi per tornare sul trono. A Shah Shuja, gli inglesi avevano trovato un posto a Ludhiana, nel Punjab, dove viveva un esilio dorato sognando Kabul.
 |
| La corte di Shah Shuja |
Auckland ha dovuto mediare tra i fautori del ritorno di Shah Shuja e quelli che sconsigliano l’avventura. Tra coloro che temono che la campagna afgana non sarà facile e chi la ritene una passeggiata. Tra questi c’è sir William Macnaghten, ascoltato consigliere politico. Ma l’idea piace anche all’artefice della politica estera britannica, il Visconte Palmerston. Quanto a quelli che in teoria son contrari o perplessi, vengono convinti dall’ambizione: è il caso dello stesso Auckland e di Alexander Burnes, che aveva ottimi rapporti col Khan, ma che per l’occasione era stato promosso e nominato baronetto. Macnaghten e Burnes furono dunque inviati a Kabul come rappresentanti britannici alla nuova corte di Shah Shuja e alla testa di un potente esercito.
L’operazione comincia da Sud con destinazione Kandahar. Al comando di Burnes la forza d’occupazione varca il passo di Bolan nel Sind nella primavera del 1839 e il 25 aprile Shah Shuja, accompagnato da Macnaghten, entra in città senza colpo ferire. Poi è la volta di Ghazni, più a Nord sulla strada per la capitale. Ma se l’avanzata militare va bene, i vertici britannici si rendono conto che attraversare l’Afghanistan è tutt’altro che una passeggiata e anche che Shah Shuja non sembra avere il consenso sperato. Si guardano bene dal comunicarlo a Calcutta e a Londra. Il dado è tratto.
La perdita di Ghazni obbliga Dost Mohammad a fuggire. O meglio a temporeggiare per trovare un altro modo di organizzare la resistenza contro un esercito disciplinato e bene armato contro cui in campo aperto avrebbe perso. A luglio il nuovo re riprende possesso della sua capitale che non vede da trent’anni. Scrive Jhon William Kaye, autore nel 1874 di una Storia della guerra in Afghanistan: “Il tintinnio delle borse di monete e il luccichio delle baionette inglesi gli avevano restituito il trono, ma ad accoglierlo c’era quello che sembrava più un corteo funebre che non l’ingresso di un re nella capitale dei suoi restaurati domini”. Il piano iniziale di Macnaghten dunque va rivisto. Insediare Shah Shuja non basta e bisogna presidiare la città e dunque restare. L’invasione si trasforma in occupazione. Nonostante diversi segnali che i consiglieri di Shah Shuja e i più accorti tra gli inglesi o tra le loro guide indiane avevano fatto presente ai capi, il comando britannico sembra ignorare la realtà. Macnaghten sta già pensando al suo prossimo incarico – il governatorato di Bombay – e Burnes se la spassa senza far gran attenzione al fatto che in Afghanistan toccare una donna locale non è uno scherzo che si dimentica. La piccola comunità dei civili al seguito, cresciuta con l’arrivo di mogli, figli e servitù, segue le partite di cricket e sorseggia tè compiacendosi del clima fresco di Kabul dove il caldo può essere feroce in estate ma è sempre secco e spesso mitigato dalle brezze. Non è solo la vita di quegli expat, come oggi li chiameremmo, a dare scandalo: i soldati al comando del generale Elphinstone, un militare già anziano e senza la benché minima idea di quel si va preparando, si erano distinti in azioni punitive contro le tribù circostanti. Gli accantonamenti inglesi inoltre, anziché essere vicini alla fortezza di Bala Hissar, sede del re, erano isolati e periferici rispetto al centro città. Un mondo a parte che stava per essere travolto.
 |
| Kabul tra Londra e Mosca |
Gli inglesi non capiscono che il figlio di Dost Mohammad, il principe
Mohammad Akbar Khan, sta preparando la contromossa. Solo qualcuno se ne rende conto: “L’animosità verso di noi aumenta di giorno in giorno e i loro mullah predicano contro di noi da un capo all’altro del Paese” scrive il maggiore Henry Rawlinson. Ma è una voce nel deserto. Il 1 novembre del 1841 parte il primo attacco che ha per obiettivo la casa di Burnes. L’uomo è praticamente solo perché le truppe, che tra l’altro esitano a muoversi, sono a quattro chilometri da casa sua che presto vien data alle fiamme. Burnes viene ucciso dalla folla inferocita. Mentre la rivolta si estende Macnaghten e Elphinstone perdono tempo prezioso in lunghe discussioni: agire? Punire? Trattare? Decidono di prepararsi a un possibile assedio nel mezzo del quale tenteranno qualche disastrosa sortita. Sotto il comando del principe, diventato poi il simbolo dell’indipendenza afgana, le truppe disomogenee delle tribù hanno mutato il tipico individualismo tribale in un jihad collettivo contro l’invasore. Col consenso di una popolazione che non solo odia gli stranieri, ma li accusa di aver fatto aumentare i prezzi al bazar. Akbar è ormai il dominus della situazione. In dicembre Macnaghten accetta di incontrarlo su una collina poco lontano dal fiume Kabul. Ma è una trappola. Il principe ha saputo che gli inglesi hanno pagato alcuni capi tribù per corromperli e li ripagano della stessa moneta. Nella notte il cadavere di Macnaghten, mutilato di testa, braccia e gambe, penzola a un palo del bazar.
La partita è persa e Elphinstone negozia un salvacondotto e una scorta per far rientro in India attraverso il Kyber Pass, la gola che porta dall’Hindukush alle pianure del Gange. Elphinstone sa che se raggiunge Jalalabad, ai piedi del passo, è salvo. Ma la sua disgraziata missione non ha futuro. Akabar è d’accordo con le tribù che aspettano gli inglesi al varco. La scorta promessa non arriva e un inverno impietoso aggiunge brace al fuoco che sta per divampare. La ritirata si rivela un disastro con assalti e agguati, mentre la penuria di cibo e i geloni falciano i civili aggregati alla truppa. Dopo l’ultima strage a Gandamak, quando ormai la meta sembra vicina, dell’armata inglese non resta quasi più nulla o così almeno sembra perché il 13 gennaio, dei sedicimila partiti da Kabul una settimana prima, arriva a Jalalabad un solo uomo: ferito e stremato che si trascina sul suo cavallo. E’ un medico, il dottor Brydon, il protagonista di uno dei più celebri ritratti di epoca vittoriana: Remnants of an Army di Elizabeth Butler.
 |
| Di 16mila… un uomo solo |
La prima guerra afgana, cominciata nel 1839 e finita nel 1842 si conclude conun bilancio pesantissimo. Oltre a Brydon si è salvato solo qualche inglese fatto prigioniero. Freddo, fame, sciabolate e malattie hanno aiutato gli afgani a espellere l’invasore. Umiliandolo. Alla fine di marzo anche Shah Shuja – tradito – viene assassinato. Chiude la vicenda la morte di un re di comodo che aveva fatto ritorno a casa sulla punta delle lance inglesi e che gli inglesi alla fine avevano abbandonato al suo destino.
Che c’è da leggere
Il grande classico sul Great Game, la guerra di spie, soldati, colpi di mano e spedizioni militari che attraversò tutto l’Ottocento asiatico, è Il Grande Gioco di Peter Hopkirk in cui l’autore mescola fatti e documenti a una grande capacità narrativa in oltre 600 pagine che compongono il puzzle di quello che i russi chiamavano invece “Torneo delle ombre”. Operazione ripetuta poi con Diavoli stranieri sulla Via della Seta (entrambi di Adelphi), ambientato nei primi del ‘900 e che è invece la storia di avventurosi scopritori di quelle antiche civiltà. Il Grande Gioco in Asia centrale lo racconta anche Karl Meyer ne La polvere dell’impero, uscito qualche anno fa per Corbaccio, mentre Antony Wynn sceglie invece di dilungarsi su un frammento di quella storia (La Persia nel Grande Gioco, Il Saggiatore) come fa per altro William Dalrymple, che nel suo recente Il ritorno di un re (Adelphi) si concentra proprio su Shah Shuja, il re che possedeva il Ko-i-nur e che gli inglesi reinsediarono a Kabul. Ma Dalrymple lo fa con una marcia in più e cioè utilizzando moltissime fonti locali: afgane, indiane, persiane e lo stesso diario di Shah Shuja. Gli effetti di un Grande Gioco trascinatosi sino ai giorni nostri si possono invece leggere in Samarcanda. Storie di una città dal 1945 a oggi (Cliopoli), un libro fresco di stampa di Marco Buttino che analizza i cambiamenti di una città chiave nel Grande Gioco. Italiano è anche l’autore de Il cammello battriano (Neri Pozza), piacevolissimo racconto di Stefano Maltesta su una riscoperta tra gli echi del Great Game e della Via della seta.
*In forma più estesa questo racconto si può ascoltare in podcast su Radio3 Wikiradio a cura di Loredana Rotundo. Regia e scelte dei sonori di Antonella Borghi. L’articolo in edicola oggi con il manifesto
** aggiungo anche che, per mia colpa, ho scritto due volte 19… anziché 18… sicché sembra che la guerra anziché qualche anno sia durata un secolo… l’ho corretto nel post ma aihmé non sul giornale
*** qui una lettura odierna di quella crisi segnalatami da un lettore
La prima guerra angloafgana
 |
|
Il dottor Brydon, l’uomo che si credeva l’unico superstite della guerra,
protagonista del celebre dipinto vittoriano |
A metà del 1800 Londra e Calcutta, sede della Compagnia delle Indie, decidono di reinsediare a Kabul Shah Shuja, un re afgano sadozai spodestato anni prima dai rivali barakzai. Lo vogliono a Kabul per controllare il Paese e contenere la Russia di cui temono l’espansione verso l’India, antica ossessione dell’Impero britannico.
Ne uscirono con le ossa rotta. Una lezione che sembra restare valida ancora oggi….
Il 30 settembre 1838 Lord Auckland, governatore generale delle Indie, promulga il “Manifesto di Simla” con cui la Gran Bretagna decide ufficialmente di spodestare il re dell’Afghanistan, che teme alleato dei russi, per sostituirlo con un altro monarca che rientra nelle sue simpatie. E’ il punto di partenza della più tragica sconfitta subita dagli inglesi nel Paese dell’Hindukush. Una lezione che, ripetutasi con i sovietici negli anni Ottanta, sembra ricordare in parte anche quanto succede adesso in quel lontano Paese. E’ il vero inizio guerreggiato del “Great Game”, il grande gioco tra l’Impero zarista e quello britannico per la conquista dell’Asia centrale. Un gioco che non è mai finito anche se gli attori sono in parte cambiati. Tutto comincia alla vigilia della prima grande operazione guerreggiata del “Grande Gioco”….
Domani a
- alle 14 su Rai3
La prima guerra angloafgana
 |
|
Il dottor Brydon, l’uomo che si credeva l’unico superstite della guerra,
protagonista del celebre dipinto vittoriano |
A metà del 1800 Londra e Calcutta, sede della Compagnia delle Indie, decidono di reinsediare a Kabul Shah Shuja, un re afgano sadozai spodestato anni prima dai rivali barakzai. Lo vogliono a Kabul per controllare il Paese e contenere la Russia di cui temono l’espansione verso l’India, antica ossessione dell’Impero britannico.
Ne uscirono con le ossa rotta. Una lezione che sembra restare valida ancora oggi….
Il 30 settembre 1838 Lord Auckland, governatore generale delle Indie, promulga il “Manifesto di Simla” con cui la Gran Bretagna decide ufficialmente di spodestare il re dell’Afghanistan, che teme alleato dei russi, per sostituirlo con un altro monarca che rientra nelle sue simpatie. E’ il punto di partenza della più tragica sconfitta subita dagli inglesi nel Paese dell’Hindukush. Una lezione che, ripetutasi con i sovietici negli anni Ottanta, sembra ricordare in parte anche quanto succede adesso in quel lontano Paese. E’ il vero inizio guerreggiato del “Great Game”, il grande gioco tra l’Impero zarista e quello britannico per la conquista dell’Asia centrale. Un gioco che non è mai finito anche se gli attori sono in parte cambiati. Tutto comincia alla vigilia della prima grande operazione guerreggiata del “Grande Gioco”….
Domani a
- alle 14 su Rai3
Dissento dunque scrivo. Visioni consigliate
 Si apre oggi all’Università degli Studi di Milano una mostra dedicata alla storia recente del dissenso nell’ex Unione Sovietica attraverso uno dei suoi più famosi strumenti, il Samizdat, protagonista di “Dalla censura e dal samizdat alla libertà di stampa. URSS 1917-1990”, mostra inaugurata a Mosca e poi esposta alla Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Nanterre e alla Biblioteca della Sorbona di Parigi, che da oggi approda a Milano.
Si apre oggi all’Università degli Studi di Milano una mostra dedicata alla storia recente del dissenso nell’ex Unione Sovietica attraverso uno dei suoi più famosi strumenti, il Samizdat, protagonista di “Dalla censura e dal samizdat alla libertà di stampa. URSS 1917-1990”, mostra inaugurata a Mosca e poi esposta alla Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Nanterre e alla Biblioteca della Sorbona di Parigi, che da oggi approda a Milano.
La mostra, organizzata da Memorial Mosca e dalla Biblioteca Statale di Storia della Federazione Russa, a cura di Boris Belenkin e di Elena Strukova (che saranno presenti all’inaugurazione), deve il progetto grafico a Pëtr Pasternak: presenta protagonisti e documenti dell’opposizione al regime sovietico, dando ampio risalto figurativo a un fenomeno storico unico nel suo genere, il Samizdat, canale di distribuzione clandestino e alternativo di scritti illegali, censurati o ostili al regime.
I materiali saranno in mostra sino al 1 ottobre 2016 (Orario d’apertura: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 | Ingresso libero a Milano, Università degli Studi Atrio Aula Magna, via Festa del Perdono 7)
L’inaugurazione è oggi alle ore 11,30 nella Sala Malliani dell’Università degli Studi di Milano.
Interverranno: Laura Rossi (Università degli Studi di Milano), Carlo Montalbetti (Direttore generale Comieco), Elda Garetto (Università degli Studi di Milano), Boris Belenkin (Memorial Russia), Elena Strukova (Biblioteca Statale di Storia della Federazione russa), Sergio Rapetti (traduttore e consulente editoriale), Valentina Parisi (Scuola Traduttori e Interpreti, Milano).
La mostra è organizzata dall’Università di Milano (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali) e da Memorial Italia con il contributo di Comieco e il sostegno della Fondazione Cariplo.In ottobre verrà edito da goWare un ebook con i testi dei pannelli della mostra una introduzione di Sergio Rapetti, un saggio di Boris Belenkin curatore della mostra, e tre saggi tratti da tre importanti libri sul dissenso e sul samizdat.
I materiali della mostra provengono da:
GARF Gosudarstvennyj Archiv Rossijskoj Federacii (Archivio di Stato della Federazione Russa).
Archivio di Memorial-Russia.
GPIB Gosudarstvennaja Publičnaja Istoričeskaja Biblioteka Rossii (Biblioteca storica statale della Federazione Russa).
Collezioni private di Ju.M. Baturin e M.A. Fedotov.
Dissento dunque scrivo. Visioni consigliate
 Si apre oggi all’Università degli Studi di Milano una mostra dedicata alla storia recente del dissenso nell’ex Unione Sovietica attraverso uno dei suoi più famosi strumenti, il Samizdat, protagonista di “Dalla censura e dal samizdat alla libertà di stampa. URSS 1917-1990”, mostra inaugurata a Mosca e poi esposta alla Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Nanterre e alla Biblioteca della Sorbona di Parigi, che da oggi approda a Milano.
Si apre oggi all’Università degli Studi di Milano una mostra dedicata alla storia recente del dissenso nell’ex Unione Sovietica attraverso uno dei suoi più famosi strumenti, il Samizdat, protagonista di “Dalla censura e dal samizdat alla libertà di stampa. URSS 1917-1990”, mostra inaugurata a Mosca e poi esposta alla Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Nanterre e alla Biblioteca della Sorbona di Parigi, che da oggi approda a Milano.
La mostra, organizzata da Memorial Mosca e dalla Biblioteca Statale di Storia della Federazione Russa, a cura di Boris Belenkin e di Elena Strukova (che saranno presenti all’inaugurazione), deve il progetto grafico a Pëtr Pasternak: presenta protagonisti e documenti dell’opposizione al regime sovietico, dando ampio risalto figurativo a un fenomeno storico unico nel suo genere, il Samizdat, canale di distribuzione clandestino e alternativo di scritti illegali, censurati o ostili al regime.
I materiali saranno in mostra sino al 1 ottobre 2016 (Orario d’apertura: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 | Ingresso libero a Milano, Università degli Studi Atrio Aula Magna, via Festa del Perdono 7)
L’inaugurazione è oggi alle ore 11,30 nella Sala Malliani dell’Università degli Studi di Milano.
Interverranno: Laura Rossi (Università degli Studi di Milano), Carlo Montalbetti (Direttore generale Comieco), Elda Garetto (Università degli Studi di Milano), Boris Belenkin (Memorial Russia), Elena Strukova (Biblioteca Statale di Storia della Federazione russa), Sergio Rapetti (traduttore e consulente editoriale), Valentina Parisi (Scuola Traduttori e Interpreti, Milano).
La mostra è organizzata dall’Università di Milano (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali) e da Memorial Italia con il contributo di Comieco e il sostegno della Fondazione Cariplo.In ottobre verrà edito da goWare un ebook con i testi dei pannelli della mostra una introduzione di Sergio Rapetti, un saggio di Boris Belenkin curatore della mostra, e tre saggi tratti da tre importanti libri sul dissenso e sul samizdat.
I materiali della mostra provengono da:
GARF Gosudarstvennyj Archiv Rossijskoj Federacii (Archivio di Stato della Federazione Russa).
Archivio di Memorial-Russia.
GPIB Gosudarstvennaja Publičnaja Istoričeskaja Biblioteka Rossii (Biblioteca storica statale della Federazione Russa).
Collezioni private di Ju.M. Baturin e M.A. Fedotov.
Hei, c’è un cane che ha morso un uomo
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi…. (segue)
Hei, c’è un cane che ha morso un uomo
Ci sono notizie di serie A e notizie ritenute di serie B che non leggeremo mai anche se riguardano milioni di lavoratori indiani nello sciopero quantitativamente più grande del mondo. Milioni di bambini in fuga. Milioni di afgani sfollati. Milioni di risarcimenti che non arrivano. Oscurati dall’arrivo sul mercato del nuovo iPhone o dalla somiglianza con una star
Dice un vecchio adagio che se un cane morde un uomo non è una notizia ma solo un fatto logico e abitudinario. Se invece un uomo morde un cane allora c’è quell’elemento di “notiziabilità” che le fa meritare un titolo. Anche in prima pagina. Ma non è vero. Se, come dicono i manuali di giornalismo, una notizia è tale se è una novità, se è importante per il grande pubblico, curiosa, stimolante e numericamente consistente, allora c’è qualcosa che non va nell’informazione mainstream. Forse è sempre stato così, perché dietro alla pubblicazione di una “notizia”, c’è sempre una scelta umana, ma oggi può bastare la nascita dell’ultimo telefonino per oscurare 150 milioni di indiani in sciopero o la somiglianza con Angiolina Jolie per far apparire la giovane curda Asia Ramazan Antar la clone di una star e non una combattente che ha sacrificato la vita per difendere la sua gente. Moralismo? No, solo senso della realtà e… della notizia. Facciamo qualche esempio. Esempi che hanno – non sempre – scatenato di recente sane e furiose reazioni in Rete, nel mondo virtuale dove girano valanghe di bufale ma anche un’attenzione critica che prima non aveva canali per esprimersi…. (segue)
India e Pakistan: guerra di parole all’Onu
 L’Assemblea generale dell’Onu si è trasformata nella tribuna di violente accuse tra India e Pakistan, definito ieri da Delhi uno «stato terrorista». E se Islamabad, nel discorso del suo premier Nawaz Sharif, aveva usato toni morbidi, lo stesso Nawaz Sharif aveva appena recapitato a Ban ki-moon un dossier sulle violazioni indiane in Kashmir, prontamente sostenuto dai rappresentanti dell’Organizzazione della conferenza islamica. Islamabad intanto – benché la cosa fosse in agenda – ha chiuso ieri lo spazio areo nelle zone vicine al conteso territorio del Kashmir dove aveva previsto esercitazioni aree che, dice la stampa locale, hanno aumentato il sospetto che le forze armate pachistane si stiano preparando a una possibile escalation militare tra i due Paesi. La tensione è alta e, se la cornice è antica da quando i pachistani invasero il Kashmir il cui maraja indu aveva deciso di stare con l’India nonostante una popolazione largamente musulmana, lo sfondo attuale è l’attacco che il 18 settembre, ha visto morire diciotto soldati indiani nella base kashmira di Uri. Lo stato di allerta è diffuso e in alcune zone è stato innalzato (in Maharashtra ad esempio, dove gli indiani hanno denunciato strane manovre vicino a una base della marina). Inutile dire che le frontiere – terreno di scontri continui anche fuori dalla regione kashmira – sono ultra presidiate. Senza contare che è in ballo anche un possibile boicottaggio del meeting della Saarc che si dovrebbe tenere in novembre a Islamabad*.
L’Assemblea generale dell’Onu si è trasformata nella tribuna di violente accuse tra India e Pakistan, definito ieri da Delhi uno «stato terrorista». E se Islamabad, nel discorso del suo premier Nawaz Sharif, aveva usato toni morbidi, lo stesso Nawaz Sharif aveva appena recapitato a Ban ki-moon un dossier sulle violazioni indiane in Kashmir, prontamente sostenuto dai rappresentanti dell’Organizzazione della conferenza islamica. Islamabad intanto – benché la cosa fosse in agenda – ha chiuso ieri lo spazio areo nelle zone vicine al conteso territorio del Kashmir dove aveva previsto esercitazioni aree che, dice la stampa locale, hanno aumentato il sospetto che le forze armate pachistane si stiano preparando a una possibile escalation militare tra i due Paesi. La tensione è alta e, se la cornice è antica da quando i pachistani invasero il Kashmir il cui maraja indu aveva deciso di stare con l’India nonostante una popolazione largamente musulmana, lo sfondo attuale è l’attacco che il 18 settembre, ha visto morire diciotto soldati indiani nella base kashmira di Uri. Lo stato di allerta è diffuso e in alcune zone è stato innalzato (in Maharashtra ad esempio, dove gli indiani hanno denunciato strane manovre vicino a una base della marina). Inutile dire che le frontiere – terreno di scontri continui anche fuori dalla regione kashmira – sono ultra presidiate. Senza contare che è in ballo anche un possibile boicottaggio del meeting della Saarc che si dovrebbe tenere in novembre a Islamabad*.
 |
| L’Asia del Sud con la cerniera afgana: otto Paesi riunti nella Saarc il cui incontro a Islamabad l’India vuole boicottare |
Il nodo del Kashmir resta un bubbone purulento. All’Onu Nawaz Sharif ha sostenuto che una pace tra i due Paesi sarà possibile solo con la risoluzione del contenzioso e ha chiesto la demilitarizzazione dello Stato indiano del Jammu e Kashmir, condizione inaccettabile per chi lamenta infiltrazioni terroristiche dall’area kashmira controllata dai pachistani. Delhi, per altro, non esita a usare il pugno di ferro: settimana scorsa è stato arrestato Khurram Parvez – coordinatore della Jammu Kashmir Coalition of Civil Society – che, appena uscito di prigione, è stato riarrestato grazie al controverso Public Safety Act, una legge speciale che consente la detenzione per sei mesi senza processo. Parvez doveva recarsi a Ginevra per denunciare gli effetti della repressione che si è scatenata dopo la morte nel luglio scorso di un famoso separatista locale, Burhan Wani a capo del più vasto gruppo secessionista locale, l’Hizbul Mujahideen. Le proteste dopo la sua morte e la repressione che ne è seguita hanno lasciato sul terreno decine di vittime civili in un’ondata di violenze che non si vedeva nella regione da almeno cinque anni.
In un momento così teso tra i due Paesi c’è chi getta benzina sul fuoco anche da fuori. E se il segretario di Sato Kerry all’Onu ha condannato l’attacco di Uri ma ha anche espresso preoccupazione per le violenze in Kashmir (gli Usa sono alleati di entrambi i Paesi), due parlamentari americani hanno appena deciso di chiedere al Congresso un voto che definisca il Pakistan «Stato sponsor del terrorismo», rafforzando così la durissima posizione che gli indiani hanno tenuto ieri all’Onu attraverso la replica all’intervento di Sharif affidata al primo segretario della missione permanente a Palazzo di Vetro: Eenam Gambhir ha definito il Pakistan uno Stato terrorista che, sponsorizzando il terrorismo, commette crimini di guerra. Gli han fatto eco le parole di Sarwar Danish, uno dei vicepresidenti afgani che, pur senza nominare il Pakistan, lo ha di fatto accusato di aver allevato i talebani, ospitato Al Qaeda e di dare rifugio alla Rete Haqqani, la più estremista delle fazioni talebane. Anche se proprio in quelle ore in Afghanistan la realpolitik faceva firmare la pace col gruppo combattente Hezb-e-islami che consentirà a Gulbuddin Hekmatyar, il “macellaio di Kabul” di tornare nella capitale.
* La Saarc, Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (South Asian Association for Regional Cooperation), è un’organismo internazionale di cooperazione economica e politica che comprende otto stati membri: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; e sette osservatori: Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Stati Uniti, Unione europea, Australia.
India e Pakistan: guerra di parole all’Onu
 L’Assemblea generale dell’Onu si è trasformata nella tribuna di violente accuse tra India e Pakistan, definito ieri da Delhi uno «stato terrorista». E se Islamabad, nel discorso del suo premier Nawaz Sharif, aveva usato toni morbidi, lo stesso Nawaz Sharif aveva appena recapitato a Ban ki-moon un dossier sulle violazioni indiane in Kashmir, prontamente sostenuto dai rappresentanti dell’Organizzazione della conferenza islamica. Islamabad intanto – benché la cosa fosse in agenda – ha chiuso ieri lo spazio areo nelle zone vicine al conteso territorio del Kashmir dove aveva previsto esercitazioni aree che, dice la stampa locale, hanno aumentato il sospetto che le forze armate pachistane si stiano preparando a una possibile escalation militare tra i due Paesi. La tensione è alta e, se la cornice è antica da quando i pachistani invasero il Kashmir il cui maraja indu aveva deciso di stare con l’India nonostante una popolazione largamente musulmana, lo sfondo attuale è l’attacco che il 18 settembre, ha visto morire diciotto soldati indiani nella base kashmira di Uri. Lo stato di allerta è diffuso e in alcune zone è stato innalzato (in Maharashtra ad esempio, dove gli indiani hanno denunciato strane manovre vicino a una base della marina). Inutile dire che le frontiere – terreno di scontri continui anche fuori dalla regione kashmira – sono ultra presidiate. Senza contare che è in ballo anche un possibile boicottaggio del meeting della Saarc che si dovrebbe tenere in novembre a Islamabad*.
L’Assemblea generale dell’Onu si è trasformata nella tribuna di violente accuse tra India e Pakistan, definito ieri da Delhi uno «stato terrorista». E se Islamabad, nel discorso del suo premier Nawaz Sharif, aveva usato toni morbidi, lo stesso Nawaz Sharif aveva appena recapitato a Ban ki-moon un dossier sulle violazioni indiane in Kashmir, prontamente sostenuto dai rappresentanti dell’Organizzazione della conferenza islamica. Islamabad intanto – benché la cosa fosse in agenda – ha chiuso ieri lo spazio areo nelle zone vicine al conteso territorio del Kashmir dove aveva previsto esercitazioni aree che, dice la stampa locale, hanno aumentato il sospetto che le forze armate pachistane si stiano preparando a una possibile escalation militare tra i due Paesi. La tensione è alta e, se la cornice è antica da quando i pachistani invasero il Kashmir il cui maraja indu aveva deciso di stare con l’India nonostante una popolazione largamente musulmana, lo sfondo attuale è l’attacco che il 18 settembre, ha visto morire diciotto soldati indiani nella base kashmira di Uri. Lo stato di allerta è diffuso e in alcune zone è stato innalzato (in Maharashtra ad esempio, dove gli indiani hanno denunciato strane manovre vicino a una base della marina). Inutile dire che le frontiere – terreno di scontri continui anche fuori dalla regione kashmira – sono ultra presidiate. Senza contare che è in ballo anche un possibile boicottaggio del meeting della Saarc che si dovrebbe tenere in novembre a Islamabad*.
 |
| L’Asia del Sud con la cerniera afgana: otto Paesi riunti nella Saarc il cui incontro a Islamabad l’India vuole boicottare |
Il nodo del Kashmir resta un bubbone purulento. All’Onu Nawaz Sharif ha sostenuto che una pace tra i due Paesi sarà possibile solo con la risoluzione del contenzioso e ha chiesto la demilitarizzazione dello Stato indiano del Jammu e Kashmir, condizione inaccettabile per chi lamenta infiltrazioni terroristiche dall’area kashmira controllata dai pachistani. Delhi, per altro, non esita a usare il pugno di ferro: settimana scorsa è stato arrestato Khurram Parvez – coordinatore della Jammu Kashmir Coalition of Civil Society – che, appena uscito di prigione, è stato riarrestato grazie al controverso Public Safety Act, una legge speciale che consente la detenzione per sei mesi senza processo. Parvez doveva recarsi a Ginevra per denunciare gli effetti della repressione che si è scatenata dopo la morte nel luglio scorso di un famoso separatista locale, Burhan Wani a capo del più vasto gruppo secessionista locale, l’Hizbul Mujahideen. Le proteste dopo la sua morte e la repressione che ne è seguita hanno lasciato sul terreno decine di vittime civili in un’ondata di violenze che non si vedeva nella regione da almeno cinque anni.
In un momento così teso tra i due Paesi c’è chi getta benzina sul fuoco anche da fuori. E se il segretario di Sato Kerry all’Onu ha condannato l’attacco di Uri ma ha anche espresso preoccupazione per le violenze in Kashmir (gli Usa sono alleati di entrambi i Paesi), due parlamentari americani hanno appena deciso di chiedere al Congresso un voto che definisca il Pakistan «Stato sponsor del terrorismo», rafforzando così la durissima posizione che gli indiani hanno tenuto ieri all’Onu attraverso la replica all’intervento di Sharif affidata al primo segretario della missione permanente a Palazzo di Vetro: Eenam Gambhir ha definito il Pakistan uno Stato terrorista che, sponsorizzando il terrorismo, commette crimini di guerra. Gli han fatto eco le parole di Sarwar Danish, uno dei vicepresidenti afgani che, pur senza nominare il Pakistan, lo ha di fatto accusato di aver allevato i talebani, ospitato Al Qaeda e di dare rifugio alla Rete Haqqani, la più estremista delle fazioni talebane. Anche se proprio in quelle ore in Afghanistan la realpolitik faceva firmare la pace col gruppo combattente Hezb-e-islami che consentirà a Gulbuddin Hekmatyar, il “macellaio di Kabul” di tornare nella capitale.
* La Saarc, Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (South Asian Association for Regional Cooperation), è un’organismo internazionale di cooperazione economica e politica che comprende otto stati membri: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; e sette osservatori: Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Stati Uniti, Unione europea, Australia.
Un milione di lacrime. Il prezzo del drone che uccise Giovanni
Gli Stati Uniti “donano” ai Lo Porto un milione di euro per chiudere il caso del cooperante ucciso in Pakistan. E avvertono:“Non è un risarcimento” . Una pratica sempre più diffusa sugli omicidi segreti dal cielo. Ma la famiglia non ci sta
 |
| Giovanni Lo Porto. Alla famiglia il denaro ma non la verità sulla morte |
Con una “donazione” di 1 milione e 185mila euro alla famiglia Lo Porto per compensare la morte del figlio Giovanni, gli Stati Uniti considerano chiuso il caso del cooperante ucciso da un drone americano in Pakistan nel gennaio del 2015. Una donazione “in memoria”, formula ribadita ieri dall’ambasciata americana dopo che il quotidiano La Repubblica aveva rivelato l’accordo siglato l’8 luglio da un diplomatico incaricato di mettere una pietra tombale sulla vicenda. Che resta invece aperta in tutta la sua drammaticità anche se Washington si è tutelata con una formuletta che esclude che la donazione – non dunque un risarcimento ma al massimo un asettico riconoscimento del fatto – possa collegarsi a qualsivoglia futura azione legale: «Ciò non implica il consenso degli Stati Uniti d’America all’esercizio della giurisdizione italiana in eventuali controversie direttamente o indirettamente connesse al presente atto…». Punto e basta.
Ma per i familiari la ferita sanguina perché il denaro non spiega l’errore fatale che si portò via Giovanni e il suo compagno di prigionia Warren Weinstein (detenuti pare da un gruppo qaedista) alla memoria del quale per ora non si sa se l’Amministrazione abbia riconosciuto altrettanto: « Non potrò più rivedere mio figlio e il suo sorriso. Hanno preso il mio prezioso figliolo e hanno ucciso anche me – ha detto la madre di Giovanni – e ora tutto ciò che mi rimane è attendere l’ultimo giorno della mia vita per aver giustizia divina, non certo terrena». Le fa eco Margherita Romanelli della Ong Gvc con cui Lo Porto aveva a lungo collaborato: «Bene i soldi ai genitori di Giovanni, ma non ci arrendiamo. Vogliamo tutta la verità sulla vicenda. Possono mascherare come vogliono ma non ci sarebbe stata donazione senza una responsabilità reale e i soldi sono una chiara dimostrazione di risarcimento. Chiediamo che venga fatta chiarezza per vie legali, con un’inchiesta per far luce sulla vicenda e scoprire cosa sia esattamente successo e quali siano stati gli errori che hanno determinato la morte». E’ quanto ha sempre chiesto anche il senatore Luigi Manconi (lo stesso che segue da vicino il caso Regeni) che proprio alcuni mesi fa, dopo l’ammissione pubblica di Obama sulla morte di Lo Porto e Wallestein, aveva chiesto, con la famiglia, sia il risarcimento sia la verità. Ma quella, rischiando di compromettere la “sicurezza nazionale”, difficilmente verrà fuori.
Quella per Giovanni non è né la prima né sarà forse l’ultima donazione-risarcimento fatta dagli americani per chiudere i casi in cui i droni hanno ucciso civili innocenti. Il caso forse più famoso è quello che vede protagonista Faisal bin Ali Jaber cui un funzionario yemenita aveva messo in mano 100mila dollari in contanti che Faisal aveva rifiutato preferendo rivolgersi al tribunale. Nell’aprile scorso ha impugnato la decisione di un tribunale distrettuale federale di Washington che ha rigettato la sua causa del 2015 con cui voleva determinare se fossero o meno legali gli attacchi dei droni che, nell’agosto 2012, avevano ucciso suo cognato Salem, un imam (tra l’altro anti jihadista), e il nipote Waleed, agente di polizia. Un caso che non smette di far discutere e che vede coinvolti anche tre veterani che hanno lavorato nei programmi speciali militari che utilizzano droni. Gli ex soldati hanno detto alla corte di essere “testimoni di un segreto”, di un sistema che non ha riguardo per i confini e che molto spesso non ti fa sapere chi stai uccidendo. In molti casi infatti si tratta di “signature strike” (quel che di potrebbe definire un “attacco all’impronta”) e che si verifica quando i militari o gli agenti della Cia decidono di colpire non in base all’identità dell’obiettivo ma perché il bersaglio ricalca un’impronta: rientra cioè in un certo schema che automaticamente lo infila in una determinata casella che funziona secondo certi criteri. Naturalmente non sempre è così ma nell’aprile del 2015 (proprio l’anno della morte di Lo Porto) il Wall Street Journal rivelò che il presidente Obama aveva autorizzato a violare le regole piuttosto rigide sui droni approvate nel 2013 per far si che la Cia potesse spingersi a colpire i jihadisti pachistani con maggior “flessibilità”. Quanto alla giustizia americana, segue lo stesso copione che per Faisal: un giudice federale, come nel suo caso, ha rigettato l’azione legale contro l’Amministrazione promossa dopo uno “strike”sempre in Yemen nel 2011 che aveva ucciso tre cittadini americani. In un altro caso yemenita, per evitare azioni legali, gli americani (secondo Reprieve, un’associazione di tutela dei diritti umani) han pagato un milione di dollari ai parenti delle 12 vittime di un attacco di droni durante un matrimonio nel 2013.
 E se per la morte di un solo italiano gli Stati Uniti hanno versato un milione – la cifra più alta pagata per la vittima di un drone – c’è anche uno spiacevole aspetto razzista, di convenienza politica, di equilibri diplomatici e pelosi con gli alleati. Sì perché, come ha scritto un vecchio giornalista di vaglia – Valerio Pellizzari nel suo “In battaglia, quando l’uva è matura” – la vita degli “altri” costa davvero poco: «Un morto afgano vale tremila dollari. Ma è una cifra teorica… non viene pagata in valuta ma in kit, in pacchi di vario genere che possono contenere dai pannelli solari…. ai ferri da stiro elettrici… in villaggi dove la corrente non arriva… Per ricevere queste donazioni c’è da seguire una procedura rigorosa e contorta… umiliante… e il costo del viaggio (per trasportare i kit ndr) spesso supera il valore del materiale trasportato».
E se per la morte di un solo italiano gli Stati Uniti hanno versato un milione – la cifra più alta pagata per la vittima di un drone – c’è anche uno spiacevole aspetto razzista, di convenienza politica, di equilibri diplomatici e pelosi con gli alleati. Sì perché, come ha scritto un vecchio giornalista di vaglia – Valerio Pellizzari nel suo “In battaglia, quando l’uva è matura” – la vita degli “altri” costa davvero poco: «Un morto afgano vale tremila dollari. Ma è una cifra teorica… non viene pagata in valuta ma in kit, in pacchi di vario genere che possono contenere dai pannelli solari…. ai ferri da stiro elettrici… in villaggi dove la corrente non arriva… Per ricevere queste donazioni c’è da seguire una procedura rigorosa e contorta… umiliante… e il costo del viaggio (per trasportare i kit ndr) spesso supera il valore del materiale trasportato».
Di seguito la ricostruzione dell’Ufficio di giornalismo investigativo di Londra
Casualty estimates
Reported deaths and injuries
Pakistan
US Drone Strikes
Total strikes: 424
Obama strikes: 373
Total killed: 2,499-4,001
Civilians killed: 424-966
Children killed: 172-207
Injured: 1,161-1,744
Yemen
Confirmed drone strikes: 133-153
Total killed: 573-833
Civilians killed: 65-101
Children killed: 8-9
Injured: 98-232
Possible extra drone strikes:89-106
Total killed: 351-503
Civilians killed: 26-61
Children killed: 6-9
Injured: 82-109
Other covert operations: 15-78
Total killed: 203-436
Civilians killed: 68-102
Children killed: 26-28
Injured: 43-132
Somalia
Drone strikes: 30-34
Total killed: 228-392
Civilians killed: 3-10
Children killed: 0-2
Injured: 2-8
Other covert operations: 9-13
Total killed: 59-160
Civilians killed: 7-47
Children killed: 0-2
Injured: 11-21
Afghanistan
Total strikes: 458-463
Total killed: 2,036-2,688
Civilians killed: 75-130
Children killed: 4-21
Injured: 217-225
USAF data
Missions with at least one
weapon release: 733
Total weapons released: 1,622
Un milione di lacrime. Il prezzo del drone che uccise Giovanni
Gli Stati Uniti “donano” ai Lo Porto un milione di euro per chiudere il caso del cooperante ucciso in Pakistan. E avvertono:“Non è un risarcimento” . Una pratica sempre più diffusa sugli omicidi segreti dal cielo. Ma la famiglia non ci sta
 |
| Giovanni Lo Porto. Alla famiglia il denaro ma non la verità sulla morte |
Con una “donazione” di 1 milione e 185mila euro alla famiglia Lo Porto per compensare la morte del figlio Giovanni, gli Stati Uniti considerano chiuso il caso del cooperante ucciso da un drone americano in Pakistan nel gennaio del 2015. Una donazione “in memoria”, formula ribadita ieri dall’ambasciata americana dopo che il quotidiano La Repubblica aveva rivelato l’accordo siglato l’8 luglio da un diplomatico incaricato di mettere una pietra tombale sulla vicenda. Che resta invece aperta in tutta la sua drammaticità anche se Washington si è tutelata con una formuletta che esclude che la donazione – non dunque un risarcimento ma al massimo un asettico riconoscimento del fatto – possa collegarsi a qualsivoglia futura azione legale: «Ciò non implica il consenso degli Stati Uniti d’America all’esercizio della giurisdizione italiana in eventuali controversie direttamente o indirettamente connesse al presente atto…». Punto e basta.
Ma per i familiari la ferita sanguina perché il denaro non spiega l’errore fatale che si portò via Giovanni e il suo compagno di prigionia Warren Weinstein (detenuti pare da un gruppo qaedista) alla memoria del quale per ora non si sa se l’Amministrazione abbia riconosciuto altrettanto: « Non potrò più rivedere mio figlio e il suo sorriso. Hanno preso il mio prezioso figliolo e hanno ucciso anche me – ha detto la madre di Giovanni – e ora tutto ciò che mi rimane è attendere l’ultimo giorno della mia vita per aver giustizia divina, non certo terrena». Le fa eco Margherita Romanelli della Ong Gvc con cui Lo Porto aveva a lungo collaborato: «Bene i soldi ai genitori di Giovanni, ma non ci arrendiamo. Vogliamo tutta la verità sulla vicenda. Possono mascherare come vogliono ma non ci sarebbe stata donazione senza una responsabilità reale e i soldi sono una chiara dimostrazione di risarcimento. Chiediamo che venga fatta chiarezza per vie legali, con un’inchiesta per far luce sulla vicenda e scoprire cosa sia esattamente successo e quali siano stati gli errori che hanno determinato la morte». E’ quanto ha sempre chiesto anche il senatore Luigi Manconi (lo stesso che segue da vicino il caso Regeni) che proprio alcuni mesi fa, dopo l’ammissione pubblica di Obama sulla morte di Lo Porto e Wallestein, aveva chiesto, con la famiglia, sia il risarcimento sia la verità. Ma quella, rischiando di compromettere la “sicurezza nazionale”, difficilmente verrà fuori.
Quella per Giovanni non è né la prima né sarà forse l’ultima donazione-risarcimento fatta dagli americani per chiudere i casi in cui i droni hanno ucciso civili innocenti. Il caso forse più famoso è quello che vede protagonista Faisal bin Ali Jaber cui un funzionario yemenita aveva messo in mano 100mila dollari in contanti che Faisal aveva rifiutato preferendo rivolgersi al tribunale. Nell’aprile scorso ha impugnato la decisione di un tribunale distrettuale federale di Washington che ha rigettato la sua causa del 2015 con cui voleva determinare se fossero o meno legali gli attacchi dei droni che, nell’agosto 2012, avevano ucciso suo cognato Salem, un imam (tra l’altro anti jihadista), e il nipote Waleed, agente di polizia. Un caso che non smette di far discutere e che vede coinvolti anche tre veterani che hanno lavorato nei programmi speciali militari che utilizzano droni. Gli ex soldati hanno detto alla corte di essere “testimoni di un segreto”, di un sistema che non ha riguardo per i confini e che molto spesso non ti fa sapere chi stai uccidendo. In molti casi infatti si tratta di “signature strike” (quel che di potrebbe definire un “attacco all’impronta”) e che si verifica quando i militari o gli agenti della Cia decidono di colpire non in base all’identità dell’obiettivo ma perché il bersaglio ricalca un’impronta: rientra cioè in un certo schema che automaticamente lo infila in una determinata casella che funziona secondo certi criteri. Naturalmente non sempre è così ma nell’aprile del 2015 (proprio l’anno della morte di Lo Porto) il Wall Street Journal rivelò che il presidente Obama aveva autorizzato a violare le regole piuttosto rigide sui droni approvate nel 2013 per far si che la Cia potesse spingersi a colpire i jihadisti pachistani con maggior “flessibilità”. Quanto alla giustizia americana, segue lo stesso copione che per Faisal: un giudice federale, come nel suo caso, ha rigettato l’azione legale contro l’Amministrazione promossa dopo uno “strike”sempre in Yemen nel 2011 che aveva ucciso tre cittadini americani. In un altro caso yemenita, per evitare azioni legali, gli americani (secondo Reprieve, un’associazione di tutela dei diritti umani) han pagato un milione di dollari ai parenti delle 12 vittime di un attacco di droni durante un matrimonio nel 2013.
 E se per la morte di un solo italiano gli Stati Uniti hanno versato un milione – la cifra più alta pagata per la vittima di un drone – c’è anche uno spiacevole aspetto razzista, di convenienza politica, di equilibri diplomatici e pelosi con gli alleati. Sì perché, come ha scritto un vecchio giornalista di vaglia – Valerio Pellizzari nel suo “In battaglia, quando l’uva è matura” – la vita degli “altri” costa davvero poco: «Un morto afgano vale tremila dollari. Ma è una cifra teorica… non viene pagata in valuta ma in kit, in pacchi di vario genere che possono contenere dai pannelli solari…. ai ferri da stiro elettrici… in villaggi dove la corrente non arriva… Per ricevere queste donazioni c’è da seguire una procedura rigorosa e contorta… umiliante… e il costo del viaggio (per trasportare i kit ndr) spesso supera il valore del materiale trasportato».
E se per la morte di un solo italiano gli Stati Uniti hanno versato un milione – la cifra più alta pagata per la vittima di un drone – c’è anche uno spiacevole aspetto razzista, di convenienza politica, di equilibri diplomatici e pelosi con gli alleati. Sì perché, come ha scritto un vecchio giornalista di vaglia – Valerio Pellizzari nel suo “In battaglia, quando l’uva è matura” – la vita degli “altri” costa davvero poco: «Un morto afgano vale tremila dollari. Ma è una cifra teorica… non viene pagata in valuta ma in kit, in pacchi di vario genere che possono contenere dai pannelli solari…. ai ferri da stiro elettrici… in villaggi dove la corrente non arriva… Per ricevere queste donazioni c’è da seguire una procedura rigorosa e contorta… umiliante… e il costo del viaggio (per trasportare i kit ndr) spesso supera il valore del materiale trasportato».
Di seguito la ricostruzione dell’Ufficio di giornalismo investigativo di Londra
Casualty estimates
Reported deaths and injuries
Pakistan
US Drone Strikes
Total strikes: 424
Obama strikes: 373
Total killed: 2,499-4,001
Civilians killed: 424-966
Children killed: 172-207
Injured: 1,161-1,744
Yemen
Confirmed drone strikes: 133-153
Total killed: 573-833
Civilians killed: 65-101
Children killed: 8-9
Injured: 98-232
Possible extra drone strikes:89-106
Total killed: 351-503
Civilians killed: 26-61
Children killed: 6-9
Injured: 82-109
Other covert operations: 15-78
Total killed: 203-436
Civilians killed: 68-102
Children killed: 26-28
Injured: 43-132
Somalia
Drone strikes: 30-34
Total killed: 228-392
Civilians killed: 3-10
Children killed: 0-2
Injured: 2-8
Other covert operations: 9-13
Total killed: 59-160
Civilians killed: 7-47
Children killed: 0-2
Injured: 11-21
Afghanistan
Total strikes: 458-463
Total killed: 2,036-2,688
Civilians killed: 75-130
Children killed: 4-21
Injured: 217-225
USAF data
Missions with at least one
weapon release: 733
Total weapons released: 1,622
Sabato notte di pace tra Perugia e Assisi
“Non sarà facile ma lo faremo. Questa notte* marceremo da Perugia ad Assisi sfidando il buio e il
sonno. A mezzanotte, ciascuno accenderà una torcia e ci metteremo in cammino. La meta è certa e la strada è già stata tracciata nel 1961 da Aldo Capitini, ma l’oscurità della notte rende tutto più incerto. E’ la prima volta che un gruppo di persone decide di fare la PerugiAssisi di notte. Lo facciamo perché sentiamo il dovere di reagire al buio che sta ricoprendo la coscienza e l’umanità di tante persone…”
* La marcia “tradizionale” si tiene il 9 ottobre sempre da Parugia ad Assisi
Pakistan/Afghanistan: guerra diplomatica sulla pelle della gente
Che Pakistan e Afghanistan siano ai ferri corti da mesi è noto. Per Islamabad è cruciale controllare il negoziato coi talebani e assicurarsi un governo amico a Kabul dove invece si amoreggia con Nuova Delhi. Il Pakistan ha ospitato e nutrito dentro le sue frontiere schiere di jihadisti di ogni sorta finché il problema non si è fatto grosso in casa sua e i figliocci pachistani dei talebani afgani han cominciato a far stragi nel Paese dei puri. A quel punto Kabul ha reso pan per focaccia a Islamabad chiudendo un occhio sui paktalebani che si rifugiano oltre confine: l’esempio eclatante e mullah Fazluallh, detto mullah Radio e leader dei paktalebani (Ttp). Si nasconderebbe oltre frontiera in Afghanistan e la cosa rende rabbiosi i pachistani. Kabul dal canto suo sa bene che la Rete Haqqani, la più radicale tra gli afgtalebani, gode da sempre dei buoni uffici di Islamabad: e quando c’era un problema o da chiedere una mano ai Saud in ambasciata, nessuno interferiva nei viaggi dei capi della famiglia nella capitale. Nemmeno un vigile. Gli americani ci mettono del loro: qualche mese fa han fatto secco il capo dei talebani afgani, possibile negoziatore. In più, continuano a bombardare e non solo coi droni. Con un solo risultato: seppellire definitivamente il processo di pace. Morale: pace addio e tensioni alle stelle.
Tutto è iniziato nell’agosto scorso con una camion bomba mai rivendicato che, scoppiando in piena notte ha creato un cratere, profondo dieci metri a Kabul. I circoli più antipachistani han dato fiato alle trombe e il processo negoziale, appena iniziato, si è fermato. Anche il presidente Ghani, più morbido con Islamabad, ha cambiato idea. Poi le cose si sono ulteriormente complicate anche perché l’offensiva talebana, che per gli afgani è roba dei pachistani, si è fatta più violenta e sanguinaria. . Morale della favola, Islamabad tratta con l’Acnur il rimpatrio degli afgani che vivono in Pakistan: son 2,5 milioni, un milione dei quali senza documenti. L’espulsione – cominciata per decreto dopo l’assalto alla scuola militare di Peshawar nel dicembre 2014 – a oggi registrerebbe quota 245mila. Entro dicembre tutti gli indocumentati correvano il rischio di essere espulsi, ossia un milione di sfollati in più per un Paese che ne deve sistemare già più di un milione. Ieri però, forse dopo le pressioni dell’Onu, Nawaz Sharif ha fatto sapere che il suo governo ha spostato la deadline a marzo 2017. Tre mesi in più di respiro (è il terzo rinvio: anziché dicembre 2015 la deadline era già stata spostata a giugno 2016 e poi a fine 2016). Vuol dire che invece che 5mila al giorno le espulsioni saranno solo di 2500 persone al dì. Tanti quanti i siriani che affollano la frontiera turca.
 |
| A destra Ashraf Ghani, a sinistra il capo dell’esecutivo Abdullah. Sopra Nawaz Sharif |
Kabul comunque non sta con le mani in mano: ieri Ashraf Ghani ha detto che intende bloccare le merci pachistane che transitano dal suo Paese dirette in Asia centrale. Ci mandate a casa i profughi? E allora noi vi blocchiamo le merci. Del resto Islamabad ha bloccato il commercio della frutta dall’Afghanistan. E gli indiani, sempre pronti a mettere il dito nella piaga, hanno offerto di far transitare prugne e melograni… in areo. Qualsiasi prezzo non è troppo alto per dar fastidio a Islamabad.
Come se ne esce? Non se ne esce per ora. Si può solo sperare che la moratoria venga prolungata e che la comunità internazionale risponda all’appello di Ocha per versare un po’ di denaro e far fronte all’emergenza…. Su tutto ciò aleggia la prossima conferenza di Bruxelles voluta dalla Ue. Di che parleranno? Forse di diritti delle donne, il mantra che non conosce confine (non che non sia giusto ma pare che ormai l’Afghanistan sia solo una questione di burqa). Forse anche di immigrazione. Preoccupati come siamo dalle nuove invasioni di barbari forse possiamo immaginare che un milione di sfollati in più in Afghanistan significherà qualche centomila in più alle porte di case.
Bambini sotto tiro nel mondo e in Afghanistan. E i talebani smentiscono l’attacco a Care International
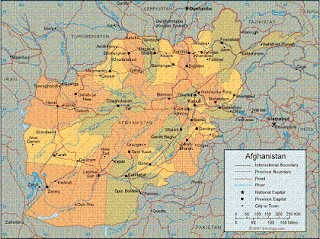 Un altro milione di sfollati afgani nel 2016. L’Onu lancia l’allarme per un’emergenza annunciata. A rischio la vita di 120mila bambini. Quelli in fuga nel mondo, dice Unicef, sono 50 milioni, la metà da Irak e Afghanistan. I talebani smentiscono di aver attaccato la Ong “Care”
Un altro milione di sfollati afgani nel 2016. L’Onu lancia l’allarme per un’emergenza annunciata. A rischio la vita di 120mila bambini. Quelli in fuga nel mondo, dice Unicef, sono 50 milioni, la metà da Irak e Afghanistan. I talebani smentiscono di aver attaccato la Ong “Care”
C’è un’emergenza profughi anche nella guerra ormai semi nascosta che si combatte in Asia centrale. Una guerra che miete vittime ogni giorno ma ormai uscita dalla lettura mainstream e senza quasi più copertura mediatica. Eppure, dice l’Onu, c’è di che preoccuparsi: entro la fine dell’anno in Afghanistan ci saranno un milione di nuovi profughi e ogni giorno 5mila attraversano la frontiera pachistana preparando una delle più pericolose e sofferte emergenze umanitarie del 2016. Tra loro molti bambini, parte rilevante di un esercito, spiega l’Unicef, che conta nel mondo 50 milioni di piccoli profughi che in gran parte sono afgani. E sul fronte umanitario di notizia ce n’è anche un’altra: i talebani hanno scritto sul loro sito che non volevano colpire Care International, la cui sede a Kabul è stata sventrata da un’esplosione lunedi notte, ma che l’obiettivo era un centro militare. L’Ong fu quindi un “danno collaterale”.
 Nel suo ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” il Fondo dell’Onu per l’infanzia spiega che quasi 50 milioni di ragazzi e bambini hanno attraversato frontiere o han dovuto sfollare a causa di conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra o e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Possono essere rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, sono bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte dei bambini in fuga proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da soli due Paesi: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci. Dell’Afghanistan assai meno. E mentre scatta l’ennesima idea di muro per far fronte a 9mila migranti a Calais, ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano 5mila persone che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
Nel suo ultimo rapporto su bambini e adolescenti “sradicati” il Fondo dell’Onu per l’infanzia spiega che quasi 50 milioni di ragazzi e bambini hanno attraversato frontiere o han dovuto sfollare a causa di conflitti. E’ un calcolo “prudente” dice un rapporto che segnala come 28 milioni di ragazze e ragazzi di età compresa tra o e 18 anni abbiano dovuto scappare da violenza e insicurezza, mentre altri 20 milioni – accompagnati o soli – hanno comunque dovuto abbandonare le loro case: «Possono essere rifugiati, sfollati interni o migranti – scrive Unicef – però, prima di tutto, sono bambini: senza eccezione e senza che sia importante chi siano e da dove vengano». Nel 2015 la maggior parte dei bambini in fuga proveniva da dieci Paesi ma il 45% di tutti quelli sotto mandato dell’Acnur hanno origine da soli due Paesi: Siria e Afghanistan. Della Siria siamo abbastanza consci. Dell’Afghanistan assai meno. E mentre scatta l’ennesima idea di muro per far fronte a 9mila migranti a Calais, ogni giorno alle frontiere afgane si affacciano 5mila persone che la nuova politica pachistana sta cacciando dal Paese dove, dall’invasione sovietica, si sono installati 2,5 milioni di afgani, un milione dei quali senza documenti.
L’allarme l’ha lanciato mercoledi a Kabul il sottosegretario generale per gli Affari umanitari (Ocha) Stephen O’Brien che ha chiesto alla comunità internazionale un intervento urgente in Afghanistan per far fronte a quello che si pensa sarà presumibilmente il numero degli sfollati interni e di quelli che attraversano la frontiera col Pakistan entro la fine dell’anno: un milione di persone. L’inverno ha detto O’Brian rischia di vedere centinaia di famiglie esposte con un flusso dalla frontiera pachistana che è di 5mila persone al giorno (già 245mila dall’inizio del 2016). La richiesta è di uno stanziamento di almeno 150 milioni di dollari per far fronte all’emergenza di «gente che ha perso casa e armenti, vive nelle tende e non è in grado di sfamare i suoi figli». I nuovi arrivati si aggiungono alla fila che conta già oltre un milione di sfollati interni in una situazione in cui 2,7 milioni di persone sono malnutrite: fra questi ci sono un milione di bambini sotto i 5 anni. Il rischio è che quest’anno si chiuda con un bilancio di oltre 120mila tra loro morti per fame.
Intanto è arrivata la smentita dei talebani sull’azione di commando che lunedi notte ha semidistrutto un ufficio di Care a Kabul: alcuni militanti armati, con l’aiuto di un autobomba, avevano preso d’assalto Sharenaw, area della città dove hanno sede ambasciate e Ong, sventrando diverse strutture. Care aveva messo le mani avanti sostenendo che a loro avviso l’obiettivo era altro e i talebani hanno chiarito che il target era «un centro di intelligence militare gestito dall’ex capo dell’intelligence dell’amministrazione di Kabul nella quale ha sede anche una branca dello spionaggio straniero… la Ong ha sede in una strada della zona militarizzata e dunque non aveva nulla a che vedere col piano. L’obiettivo – scrivono – non era Care International cosa che peraltro Care aveva già detto indicando che il target era un compound accanto al loro ufficio». Vero o falso che sia, la guerra afgana è anche una guerra di bugie visto che per il ministero degli Interni l’obiettivo era senza dubbio Care anche se la Ong aveva smentito. I talebani hanno polemizzato anche con Amnesty, accusata per il il suo comunicato contro l’azione di lunedi definita un “crimine di guerra” seguendo, dicono i talebani, «le fantasie dell’ambasciata americana». Amnesty però ha chiesto anche un’indagine indipendente che chiarisca le responsabilità anche se purtroppo questo genere di inchieste, sempre invocate (come nel caso del bombardamento dell’ospedale di Kunduz), non vengono mai messe in opera. La guerra (ieri i talebani han preso la capitale della provincia di Uruzgan, Tarinkot) con le sue ombre, i pelosi distinguo, la violazione costante di ogni regola finisce per appiattire un paesaggio dove le prime a pagare sono le vittime civili e i loro diritti.
Afghanistan, un milione di sfollati entro l’anno
 |
| In questa vecchia stampa il passo di Bolan, l’ingresso meridionale dal Pakistan |
Il dovere di un giornalista dovrebbe essere quello di dare se possibile l’idea di quel che in futuro potrebbe accadere e non solo di limitarsi ad osservare quanto accade nell’ultima ora. Così che vale credo la pena di riferire quanto ha detto il sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi d’emergenza dell’Onu, Stephen O’Brien, in visita a Kabul mercoledi scorso. Ha invitato la comunità internazionale a considerare con urgenza il sostegno per oltre un milione di sfollati che presumibilmente, tra gente all’interno del Paese e altri che ne arrivano dal Pakistan (5mila al giorno!), si potranno contare in Afghanistan entro la fine dell’anno.
O’Brien ha chiesto 150 milioni di dollari per aiuti di emergenza. Mentre a Calé si pensa all’ennesimo muro per 9mila disperati in cerca di fortuna, laggiù tra le pietre asiatiche ce ne saranno un milione entro dicembre.
* Scarica da qui il rapporto dell’Unicef sui 50 milioni di bambini in fuga
Bombe a Kabul e la difficoltà dello spazio umanitario
 Come se i morti non bastassero – almeno una trentina lunedi più almeno uno nella notte tra lunedi e martedi oltre ai guerriglieri suicidi o uccisi e a un centinaio di feriti – c’è anche un giallo nell’ennesimo attacco suicida che costella ormai la quotidianità della capitale afgana. Un giallo sull’obiettivo e, ancora una volta, un problema che riguarda l’azione militare e lo spazio umanitario*.
Come se i morti non bastassero – almeno una trentina lunedi più almeno uno nella notte tra lunedi e martedi oltre ai guerriglieri suicidi o uccisi e a un centinaio di feriti – c’è anche un giallo nell’ennesimo attacco suicida che costella ormai la quotidianità della capitale afgana. Un giallo sull’obiettivo e, ancora una volta, un problema che riguarda l’azione militare e lo spazio umanitario*.
Il primo attacco dei talebani a Kabul è di lunedi quando per l’ennesima volta la guerriglia cerca di colpire il ministero della Difesa. In quella che per il sito degli islamisti è una vittoria che avrebbe un bilancio di 58 agenti delle forze di sicurezza uccisi (poi la notizia è scomparsa ieri misteriosamente dal website dell’emirato), la carneficina soprattutto di civili si conclude con almeno una trentina di vittime. Ma non era l’unica azione prevista, benché per la seconda non vi sia ancora una rivendicazione scritta. Alcuni militanti armati, con l’aiuto di un autobomba, prendono d’assalto Sharenaw, la zona della città dove hanno sede le ambasciate e molte Ong che lavorano nel Paese (in quella zona c’è anche l’ospedale di Emergency). L’esplosione sventra un edificio. Poi comincia un vero e proprio assedio che si conclude solo il giorno seguente. Il giorno seguente perché l’attacco avviene di notte (il che segna una novità poiché gli attentato notturni sono rari) e quando la città pensa che forse per questa giornata di lunedi la guerra nella capitale sia finita. Il ministero degli Interni non ha dubbi: il colpo da assestare, che fortunatamente produce una sola vittima, è la Ong Care, che nella zona colpita ha una sede della sua rete internazionale in Afghanistan. Ma dopo un po’ l’organizzazione smentisce, sostenendo che il probabile target poteva invece essere un ufficio governativo situato a ridosso della sede umanitaria. La cosa fa una bella differenza e per ora la rivendicazione che viene citata da alcuni siti Internet non chiarisce quale fosse l’obiettivo. Se fossero gli attivisti di un’organizzazione umanitaria la cosa avrebbe un peso diverso che non se si fosse trattato di un obiettivo governativo. Non sarebbe la prima volta che gli umanitari entrano nel mirino, ma solitamente i talebani colpiscono solo gli afgani “collaborazionisti” (e di solito nelle aree periferiche) oppure attaccano obiettivi militari contigui facendo danno ad altre strutture (e potrebbe essere questo il caso) o ancora colpiscono umanitari per errore (famoso il caso di alcune cooperanti uccise mentre viaggiavano a bordo di auto bianche di solito in uso agli umanitari che però la Nato continua a usare benché proprio un comandante italiano di Isaf, anni fa, ne avesse vietato l’utilizzo proprio per evitare spiacevoli errori).
Care, in un comunicato successivo, punta l’indice sulla guerra e sulla difficoltà di operare in uno spazio umanitario sempre più ristretto e rischioso. “Secondo le Nazioni Unite – scrive l’organizzazione umanitaria nel suo cominciato – più di 5.100 civili sono stati uccisi o mutilati a causa del conflitto in atto nella sola prima metà del 2016… Oltre otto milioni di persone in Afghanistan hanno bisogno di assistenza umanitaria: soffrono di malnutrizione, hanno un sistema sanitario a pezzi mentre la maggior parte degli sfollati sono donne e bambini… Lo spazio umanitario è diventato molto più rischioso in questi ultimi anni, soprattutto nelle zone in cui vi è un conflitto intenso. Nonostante questo – continua Care che opera nel Paese da cinquant’anni – siamo desiderosi di riprendere il lavoro importante che stiamo facendo in Afghanistan il più presto possibile. Detto questo, siamo fortunati perché nessuno fra noi è stato ferito in modo grave o peggio, e come organizzazione continuiamo a sottolineare che una linea rigorosa deve essere osservata tra le operazioni umanitarie e quelle militari”. Un vecchio problema, uno fra i tanti della guerra che non finisce mai e mentre a Kabul i vertici del governo continuano a litigare. Se ne sono accorti anche gli americani, gli artefici del papocchio istituzionale benedetto dal ministro Kerry che “governa” a Kabul (due presidenti invece di uno): qualche giorno fa il Washington Post ha scritto questo titolo: “L’Afghanistan ha molti problemi. Il suo presidente potrebbe essere uno di questi”… I talebani sembrano approfittarsene e anche Daesh è riuscita a fare la sua apparizione nella capitale (con l’attentato che ha ucciso un’ottantina di hazara sciiti che manifestavano in centro). E per i talebani è ancora l’Operazione “Omari”, dedicata a mullah Omar e al capo talebano che lo ha sostituito – mullah Mansur – ucciso da un drone americano in Pakistan la primavera scorsa. Un gesto che ha dato nuovo vigore alla guerra e assestato un ennesimo deciso colpo al processo di pace. Per ora morto e sepolto.
*Mentre scrivo, dall’Italia, la giornalista Laura Cesaretti (da Kabul) avverte di un nuovo attentato una volta aclato il buio. Il terzo dunque in due giorni
La bella platea di Rovereto al Festival Oriente Occidente
 |
| Rovereto |
Quando vado in giro per l’Italia a parlare di conflitti, morte e dolore non mi aspetto mai platee piene. L’argomento non è molto sexy e la televisione, la cultura dominante di questo Paese, ci ha abituati che l’intrattenimento è meglio. Così che ieri a Rovereto, a un incontro promosso da Oriente Occidente (festival arrivato alla 36ma edizione!) ho trovato una piacevole sorpresa. All’incontro, organizzato per il Festival da Raffaele Crocco (il direttore dell‘Atlante delle guerre) c’erano circa 180 persone! Venute ad ascoltare un tema già ostico in sé e presentato come ancora più ostico: “Cos’è cambiato nella guerra? Non si combatte più tra eserciti ma “in mezzo alla gente”, tra coalizioni di Stati con mostrine unificate e combattenti senza divisa ma forti in termini ideologici. Alla radici – dicevamo sull’invito – ci sono antichi problemi irrisolti: il retaggio neo coloniale, le ingiustizie sociali, una vaga idea di riscatto nazionale che producono lo scoppio di tensioni latenti in cui si inserisce la criminalità organizzata, la devianza ideologica estremista, le manovre di gruppi di potere politico d economico. Le guerre moderne, al contrario di quelle convenzionali, tendono a trascinarsi. A iniziare ma a non terminare. A fingere successi che non sono reali. E a farci abituare alla guerra come a una delle tante forme della quotidianità moderna. La guerra richiede forse dunque un ripensamento: quanto è utile? quanto hanno senso le alleanze regionali? perché abbiamo deciso che l’Onu non serve? perché rinunciamo a priori a studiare strumenti di pacificazione e dialogo?”. Direi che ce n’era abbastanza per rifuggire tema e relatori. E invece…
 |
| Sun Tsu |
L’abbiamo presa alla larga cominciando da definizioni possibili: non più ormai quella famosa e contenuta in “Della Guerra” di Carl Von Clausevitz (“E’ la continuazione della politica con altri mezzi”) ma passando in rassegna i conflitti del supposto periodo di pace che si chiama “Guerra fredda”: gli eserciti di liberazione nazionale, la nascita delle guerre asimmetriche o delle “guerre tra la gente”, definizione che si deve al militare britannico Rupert Smith nel suo “L’arte della guerra nel mondo contemporaneo”, dove sostiene che la guerra degli eserciti in divisa è stata sostituita da quella che egli chiama “guerra fra la gente”, in cui il campo di battaglia è costituito dalle strade, dalle case e, soprattutto, dalla popolazione civile, come è avvenuto in Cecenia, Jugoslavia, Medio Oriente, Ruanda… Ovunque. I civili diventano ostaggi da sfruttare, scudi umani da utilizzare senza scrupoli, bersagli da colpire, obiettivi da conquistare, in un nuovo paradigma bellico che ha minato la possibilità di un uso efficace della forza da parte degli Stati e dunque degli eserciti, non più in grado di ottenere risultati. Abbiamo ricordato anche la “Guerra senza limiti”, saggio scritto dai colonnelli Qiao Liang e Wang Xiangsui, eredi della tradizione che discende dal famoso “L’arte della guerra” di Sun Tzu. Quella che descrivono è una guerra condotta attraverso le manipolazioni dei media, le azioni di piraterie su Internet, le turbative dei mercati azionari o la diffusione di virus informatici. Guerre senza confini appunto, altro tema toccato (i confini post coloniali).
E poi ancora, le guerre nascoste, quelle dei droni e delle truppe speciali, presenti anche in missioni “non combat”. Il tutto rigorosamente segreto. E poi il business della guerra col famoso esempio, a me caro, dell’acqua minerale. L’esempio è afgano: quando sul terreno c’erano circa 140mila soldati, ognuno di loro beveva forse una una media di tre litri di acqua al giorno. Acqua in bottiglia, si intende. E che per tutela dei soldati deve provenire da un luogo sicuro, di solito da oltre confine. E se 420mila litri sono il fabbisogno quotidiano di acqua potabile dei militari, ciò significa che in Afghanistan, ogni anno, dovevano entrare qualcosa come 15 milioni di litri di acqua minerale (oggi si è ridotto a un decimo). Quante bottiglie ci vogliono per contenerla? E quanti camion per trasportarla? Il conto non è finito. Dietro ogni soldato c’è un folto personale a contratto che non è in divisa ma che lavora per lui. Ci sono cuochi, addetti alle pulizie, operatori della sicurezza, i cosiddetti contractor: americani, britannici, sudafricani, israeliani, filippini, tailandesi e, per quasi l’80%, anche personale locale. Soldati anche loro pur se non in divisa.
E se dietro ogni soldato c’è un uomo o due, dietro tutti loro ci sono pasti caldi, divise, stringhe per le
| Carl Von Clausewitz |
scarpe, spazzolini. Tutto materiale che arriva da fuori: dal dentifricio alle zucchine. Quanti camion fa marciare la guerra considerato che l’acqua la bevono anche loro? In altre parole, se foste un produttore di acqua minerale, vorreste la fine della guerra? Ma oltre a questo aspetto, ce n’è un altro. Questo lato oscuro e poco noto del conflitto, paradossalmente, oltre che alimentare una macchina economica milionaria, nutre la guerra stessa. E nutre gli stessi nemici che l’esercito straniero è venuto a combattere. La guerra in Afghanistan finanzia i talebani con l’acqua minerale perché per ogni camion che passa la frontiera pachistana nel Sud, terra talebana, si paga una mazzetta di 800-1000 dollari alla guerriglia perché non attacchi i convogli e il nemico possa bere…
La guerra costa cara. In termini di vite umane soprattutto. E soprattutto di vittime civili. In Iraq, dove tra il 2003 e il 2012 sono morti poco più di 4mila militari (soprattutto americani), il conteggio delle vittime civili oltrepassava allora le 100mila unità. Oggi, contando i combattenti, siamo a oltre 250mila. In Afghanistan (oltre 50 morti tra i militari italiani), ogni anno moriva invece una media di oltre 2mila civili innocenti anche se, secondo i rapporti dell’United Nation Assistance Mission in Afghanistan (Unama), le vittime civili sono salite nel 2011 a 3021 (erano 2790 nel 2010 e 2412 nel 2009). Nel 2015 il costo è ancora più elevato: 11.002 civili colpiti (3545 morti e 7457 feriti. Sempre di più. Ma la guerra non era finita?
Abbiamo toccato molti temi e, dal pubblico, c’è chi aggiunto altre riflessioni davvero interessanti manifestate dal desiderio di “poter fare qualcosa”. Non so se anche la serata di ieri sia “fare qualcosa” ma penso di si. Per me è stata un’iniezione di fiducia nel mio lavoro: per farlo meglio, per continuare a raccontare cosa accade quando i riflettori delle telecamere si allontanano. Grazie!
Guerre moderne al Festival Oriente Occidente di Rovereto
 Guerre moderne. Visibili, invisibili, calcolate. Dai talebani a Daesh, dalla guerra al terrore all’abitudine alla guerra
Guerre moderne. Visibili, invisibili, calcolate. Dai talebani a Daesh, dalla guerra al terrore all’abitudine alla guerra
Cos’è cambiato nella guerra? Non si combatte più tra eserciti ma “in mezzo alla gente”, tra coalizioni di Stati con mostrine unificate e combattenti senza divisa ma forti in termini ideologici. Alla radici di sono antichi problemi irrisolti: il retaggio neo coloniale, le ingiustizie sociali, una vaga idea di riscatto nazionale che producono lo scoppio di tensioni latenti in cui si inserisce la criminalità organizzata, la devianza ideologica estremista, le manovre di gruppi di potere politico d economico. Le guerre moderne, al contrario di quelle convenzionali, tendono a trascinarsi. A iniziare ma a non terminare. A fingere successi che non sono reali. E a farci abituare alla guerra come a una delle tante forme della quotidianità moderna. La guerra richiede forse dunque un ripensamento: quanto è utile? quanto hanno senso le alleanze regionali? perché abbiamo deciso che l’Onu non serve? perché rinunciamo a priori a studiare strumenti di pacificazione e dialogo?
E ancora dunque. Come prevenirle? quali nuove forme di diplomazia, di coinvolgimento della società civile, di alleanze tra comunità diverse mettere in campo?
E infine: le migrazioni – che tanto ci affannano: non sono, oltre al prodotto della guerra, anche l’esplosione di quelle tensioni irrisolte che alla guerra hanno portato?
Lunedi alle 18 incontro con Raffaele Crocco per parlare di conflitti al Mart di Rovereto
Duplice attentato in Pakistan: con Al Qaeda o Daesh?
 Un duplice attacco suicida in Pakistan nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, ha segnato ieri l’ennesima giornata di violenza nel Paese dei puri. Entrambi gli attacchi, il cui bilancio è sinora di 13 morti tra poliziotti e civili oltre a diverse decine di feriti, ha preso di mira una corte di giustizia a Mardan, distretto a una cinquantina di chilometri da Peshawar. E nei sobborghi della capitale provinciale, poco prima, era stata presa di mira una Christian Colony, una comunità di cristiani. Tutti e due gli attentati – condotti da kamikaze armati – portano la stessa firma: Jamaat ul-Ahrar, un gruppo jihadista a geometria variabile che si è staccato nel 2014 dal cartello madre dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan o Ttp) per poi farvi ritorno nel 2015. Aveva espresso il suo sostegno a Daesh e al progetto del Grande Khorasan che dovrebbe segnare l’espansione a Est del califfato di Raqqa.
Un duplice attacco suicida in Pakistan nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, ha segnato ieri l’ennesima giornata di violenza nel Paese dei puri. Entrambi gli attacchi, il cui bilancio è sinora di 13 morti tra poliziotti e civili oltre a diverse decine di feriti, ha preso di mira una corte di giustizia a Mardan, distretto a una cinquantina di chilometri da Peshawar. E nei sobborghi della capitale provinciale, poco prima, era stata presa di mira una Christian Colony, una comunità di cristiani. Tutti e due gli attentati – condotti da kamikaze armati – portano la stessa firma: Jamaat ul-Ahrar, un gruppo jihadista a geometria variabile che si è staccato nel 2014 dal cartello madre dei talebani pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan o Ttp) per poi farvi ritorno nel 2015. Aveva espresso il suo sostegno a Daesh e al progetto del Grande Khorasan che dovrebbe segnare l’espansione a Est del califfato di Raqqa.
La strage di Mardan si deve a un uomo solo che prima ha lanciato una granata e poi si è fatto esplodere davanti alla corte di giustizia quando, fatto segno dei colpi della polizia, ha capito che non sarebbe riuscito a entrare nel tribunale. Tra i 13 morti ci sono tre poliziotti e quattro avvocati. I feriti sono oltre una quarantina. Il quotidiano pachistano “The Dawn” fa notare che il mese scorso 73 persone sono state uccise da un kamikaze all’Ospedale civile di Quetta (capitale della provincia occidentale Belucistan) e che la maggior parte tra loro erano avvocati che si erano ritrovati al nosocomio per rendere omaggio a Bilal Anwar Kasi, presidente dell’associazione provinciale degli avvocati (Balochistan Bar Association), vittima a sua volta di un omicidio. Anche l’attacco di Quetta, come i due odierni, era stato rivendicato da Jamaat ul-Ahrar e nel contempo da Desh.
 La tentata strage alla Christian Colony di Peshawar si è invece conclusa con la morte del laico cattolico Samuel Masih, il ferimento di alcuni agenti e la morte dei quattro kamikaze (che si sono fatti esplodere), entrati all’alba nella zona dove vivono i cristiani, una sorta di ghetto abbastanza comune nelle città pachistane e spesso di recente costruzione: quartieri nati per paura di persecuzioni, delle leggi sulla blasfemia e per gli attacchi a chiese o luoghi di ritrovo messi in atto da gruppi settari. Ma, secondo la stampa locale, questa volta non erano i cristiani l’obiettivo del commando: la Christian Colony si trova alla periferia di Peshawar dove sono situati anche un centro di formazione, un istituto per cadetti e una scuola dell’esercito. Scoperti dall’intelligence e con la polizia alle calcagna, i militanti avrebbero optato per un obiettivo vicino e più semplice da colpire. La dinamica dell’attacco (sventato) ricorderebbe quella avvenuto il 16 dicembre 2014 in una scuola militare di Peshawar come ritorsione contro l’operativo Zarb-e-Azb* e nel quale un commando del Ttp fece una massacro tra gli studenti che si concluse con un bilancio di 141 vittime (Umar Naray, l’ideatore della strage di Peshawar del 2014 e di quello alla Bacha Khan University nel gennaio 2016 è stato poi ucciso da un drone).
La tentata strage alla Christian Colony di Peshawar si è invece conclusa con la morte del laico cattolico Samuel Masih, il ferimento di alcuni agenti e la morte dei quattro kamikaze (che si sono fatti esplodere), entrati all’alba nella zona dove vivono i cristiani, una sorta di ghetto abbastanza comune nelle città pachistane e spesso di recente costruzione: quartieri nati per paura di persecuzioni, delle leggi sulla blasfemia e per gli attacchi a chiese o luoghi di ritrovo messi in atto da gruppi settari. Ma, secondo la stampa locale, questa volta non erano i cristiani l’obiettivo del commando: la Christian Colony si trova alla periferia di Peshawar dove sono situati anche un centro di formazione, un istituto per cadetti e una scuola dell’esercito. Scoperti dall’intelligence e con la polizia alle calcagna, i militanti avrebbero optato per un obiettivo vicino e più semplice da colpire. La dinamica dell’attacco (sventato) ricorderebbe quella avvenuto il 16 dicembre 2014 in una scuola militare di Peshawar come ritorsione contro l’operativo Zarb-e-Azb* e nel quale un commando del Ttp fece una massacro tra gli studenti che si concluse con un bilancio di 141 vittime (Umar Naray, l’ideatore della strage di Peshawar del 2014 e di quello alla Bacha Khan University nel gennaio 2016 è stato poi ucciso da un drone).
Quanto alla Jamaat ul-Ahrar, il gruppo che ha rivendicato gli attentati, la sua posizione è controversa. Inizialmente si è scisso nel 2014 dal Ttp accusato di aver sposato una fallimentare linea negoziale col governo. I suoi leader, tra cui l’ex portavoce del Ttp, hanno in seguito dato il loro sostegno a Daesh (anche se non gli hanno giurato bay’a, fedeltà) ma nel 2015 il gruppo ha poi reso noto di essere rientrato nei ranghi del Ttp, conservando però l’etichetta. Riconoscendo dunque nuovamente come leader mullah Fazlullah, che non ha mai aderito a Daesh ed è semmai vicino ad Al Qaeda (nemico giurato dello Stato islamico) e che si troverebbe in Afghanistan uccel di bosco.
*Zarb-e-Azb è un’operzione lanciata nel 2014 allo scopo di colpire le basi jihadiste nelle aree tribali. Secondo l’esercito avrebbe eliminato 3500 militanti mentre sarebbero morti 537 soldati. Ha prodotto un milione di sfollati.
Trentasei anni fa a Beirut: una (brutta) storia italiana
 |
| Italo Toni in una foto di Fausto Giaccone |
Il 2 settembre 1980, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella de Palo, scomparvero nella Beirut della guerra civile. Una storia italiana ancora coperta dal segreto di Stato. Un racconto per Wikiradio
Beirut, primo settembre 1980. Due giornalisti italiani si recano alla nostra ambasciata nella capitale libanese e confidano a un diplomatico di avere l’indomani, 2 settembre, un appuntamento con uomini del Fronte democratico per la Liberazione della Palestina. Sono preoccupati: «Se tra tre giorni non siamo rientrati in albergo, date l’allarme». Il giorno dopo, un’auto li preleva all’hotel Triumph, a Beirut Ovest. Non è chiaro di chi sia quell’auto; non lo sanno nemmeno Italo Toni e Graziella De Palo, i due reporter che da quel viaggio non faranno mai più ritorno. A 36 anni dalla loro scomparsa, i loro corpi non sono mai stati trovati e non si sa chi li andò a prendere né perché. Sono il simbolo di una delle storie più controverse del nostro Paese dove il segreto di Stato, omissioni, connivenze, servizi segreti e interessi si mescolano in un gioco delle ombre che né le inchieste giudiziarie né le indagini di colleghi e parenti hanno mai saputo completamente spiegare e dalle quali emergono solo spezzoni di verità.
Agenda rossa
I due giornalisti sono partiti per il Libano per continuare a lavorare sulle loro inchieste: Graziella è una specialista di traffico d’armi. Italo è un giornalista cui le redazioni vanno strette: ci rimane qualche mese al massimo, poi deve andare. E’ già diventato famoso per un’inchiesta sui campi d’addestramento palestinesi che, con le foto di Fausto Giaccone, è apparsa su Paris Match facendo il giro del mondo. E’ un filopalestinese militante che mescola il lavoro alla passione politica. Il Libano sembra il luogo ideale per entrambi. Nicola De Palo, cugino di Graziella e che ha ricostruito l’intera vicenda in un libro, ci restituisce parte della progettazione del viaggio attraverso il diario della giornalista che a un certo punto riappare. Scrive in “Omicidio di Stato” (Armando Curcio editore): «La sua agenda rossa è preziosa testimonianza dei preparativi: sulla pagina del 16 maggio appare l’abbozzo di una cartina geografica con una misteriosa freccia che parte dal Medio oriente e va verso la penisola greca e italiana… ».
Cosa voleva dire per Graziella quella freccia? Era un’esperta di traffico d’armi e Beirut è una delle grandi piazze di quel traffico. Armi che vanno e vengono. Anche da e per l’Italia. Era questo il motivo che l’aveva spinta a seguire Toni in Libano? Alvaro Rossi, un parente di Italo cui ha dedicato il libro “Il caso Toni De Palo” e un sito traccia questo profilo del giornalista: «Era nato a Sassoferrato nel 1930 da una famiglia apprezzata di artigiani del ferro. Ma lui ha deciso di seguire un’altra strada. E’ maestro elementare, ma dopo pochi anni si trasferisce a Roma, dove lavora al periodico della Federazione giovanile socialista “La Conquista”, e poi all’”Avanti!”, al settimanale “L’Astrolabio”, al “Quotidiano dei lavoratori”, al “Diario” di Venezia ed alla sua agenzia “Notizie”…. Professionalmente si è sempre interessato delle vicende del vicino oriente e suo è il “colpo giornalistico” che rivela al mondo l’esistenza dei primi campi di addestramento della guerriglia palestinese… è un socialista sempre disposto a muoversi in modo istintivamente partecipe e solidale verso i deboli e le vittime delle violenze e dei soprusi».
Inchieste pericolose

Forse Toni vuole ripetere lo scoop di Paris Match o trovare altre strade. Chi lo ha conosciuto lo dipinge come un uomo appassionato, colto, pieno di contatti ma che a volte, pur di arrivare allo scopo, non esita a correre rischi. In lui, dicono le testimonianze, si mescola il desiderio di conoscere a fondo la realtà con la voglia di viverla in prima persona. Probabilmente è cosciente dei rischi e il viaggio lo ha preparato con cura. Quanto a Graziella, è molto più giovane: è nata a Roma nel ‘56. E’ meticolosa e non ha paura di addentrarsi in inchieste che scottano: la Fiat degli anni caldi, il lavoro sporco delle multinazionali, il traffico d’armi… Il 21 marzo, due mesi prima del viaggio, Paese Sera pubblica un suo articolo dal titolo “False vendite, spie, società fantasma: così diciamo armi”. Graziella, che ha indagato anche sulle coperture fornite dai servizi italiani, si espone. Forse è proprio nell’ostinata passione per le inchieste che va cercata una delle chiavi della sua scomparsa.
Quando è certo che sono stati rapiti inizia l’odissea delle famiglie. Sono soprattutto i De Palo, la madre Renata Capotorti e i fratelli Giancarlo e Fabio, a darsi da fare. Ma l’invito è il silenzio: nulla deve trapelare affinché ricerche e trattative vadano in porto. E in effetti solo il 2 ottobre, sulla base di un lancio Ansa, i giornali danno la notizia della scomparsa. Forse è stato l’ambasciatore a Beirut Stefano D’Andrea a far uscire la notizia. Fin da subito si nota infatti un contrasto tra come agisce l’ambasciatore a Beirut e come si muove la Farnesina a Roma. D’Andrea, poi sollevato dall’incarico e spedito in un’altra ambasciata nei Paesi scandinavi, non la vede allo stesso modo del segretario generale Malfatti di Montetretto. E non la vede allo stesso modo di Stefano Giovannone, colonnello del Simsi alle dipendenze del generale Giuseppe Santovito a capo dell’allora servizio segreto militare. Giovannone – accusato di favoreggiamento e rivelazione di segreti di Stato nell’istruttoria del magistrato Renato Squillante sulla scomparsa di Toni e Graziella e poi inquisito nell’inchiesta sui rapporti fra palestinesi e Brigate rosse, è “il nostro uomo” a Beirut. Parla l’arabo. Lo chiamano “Stefano d’Arabia” o “il maestro”. Tra lui e l’ambasciatore non corre buon sangue. Il primo è convinto che Giovannone stia coprendo delle responsabilità. Il secondo detesta i modi troppo ufficiali del diplomatico. La vera arte di Giovannone infatti è il depistaggio. Sarà una costante dell’intera vicenda con piste che si intersecano e si confondono. C’è quella siro palestinese cara a D’Andrea e che viene rapidamente abbandonata. C’è quella falangista – la più improbabile – che è invece suggerita da Giovannone.
Sappiamo che a organizzare il viaggio in Libano ci ha pensato l’Olp di Arafat, attraverso la sua “ambasciata” a Roma. Ma una volta a Beirut, i due reporter hanno preso accordi anche col Fronte Democratico – una delle sigle più radicali dell’Olp – per un viaggio nel Sud che deve appunto iniziare il 2 settembre. E lì che accade qualcosa. Lo sappiamo grazie a Lya Rosa, una fonte scovata dalla caparbietà del parlamentare ecologista Marco Boato. Sono entrambi trentini e il senatore riesce a rintracciare a Beirut la “pasionaria” che presta il suo aiuto ai palestinesi come infermiera. Rosa conferma che fu un’auto di Fatah a prelevare i due e non quella del Fronte democratico. Ma cosa sia esattamente successo, se effettivamente l’auto era di Fatah e cosa accadde dopo non lo sappiamo. Non sappiamo se vi fu una prigionia e quanto durò e se, come si disse, i palestinesi consideravano i due delle spie. Quel che sappiamo è che allora i vertici della sicurezza e della diplomazia del nostro Paese propendono per mesi per la pista falangista, a destra insomma, tra gli estremisti cristiani. Ma è un depistaggio che si concluderà solo con il rinvio a giudizio di Santovito e Giovannone. Quanto alla Farnesina, il segretario generale di allora, Malfatti di Montetretto, risulterà iscritto alla loggia eversiva P2 di Licio Gelli. In quell’elenco c’è anche il nome di Santovito.
Il “Lodo Moro”
La verità sul caso dei due giornalisti è ancora in parte contenuta in documenti su cui vige ancora il segreto di Stato benché siano ormai passati oltre trent’anni. Cosa scotta ancora in quelle carte? La famiglia alcuni mesi fa ha reso nota l’ultima lettera inviata al presidente Mattarella in cui Renata Capotorti, Aldo Toni, Alvaro Rossi e Nicola De Palo hanno scritto: «Lo scorso 28 agosto 2014 sono scaduti i termini per il disvelamento completo del segreto di Stato. Rimangono però classificati gli ultimi documenti dove viene dimostrata l’esistenza della trattativa con il terrorismo arabo-palestinese. Questi documenti dimostrerebbero, almeno storicamente, che Graziella ed Italo sono stati sacrificati sull’altare della ragion di Stato. Non chiediamo la riapertura di indagini giudiziarie o di commissioni d’inchiesta, ma almeno di poter riavere i loro poveri resti». La tesi della famiglia è sempre stata quella che Italo e Graziella finirono tra le maglie di quello che è stato chiamato il Lodo-Moro, un accordo segreto tra l’Olp e Roma in cui i palestinesi si impegnavano a non creare problemi in Italia in cambio di protezione per le loro azioni.
 |
| Mappa di Beirut. Divisa dalla linea verde |
Non c’è una prova del Lodo-Moro e non è detto che la loro morte sia legata, come è stato supposto, all’arresto in Italia di un palestinese implicato in un traffico d’armi che nel 1979 porta all’arresto di tre militanti dell’Autonomia Operaia e in seguito di Abu Anzeh Saleh, un tramite che si occupa del traffico di armi e che verrà scarcerato dopo venti mesi di galera. I tre di AO invece la pena la scontano per intero. E se non è neppure detto, come sostiene la famiglia, che ci sia un filo rosso che lega i palestinesi e la sparizione dei giornalisti addirittura alla strage di Bologna attraverso la figura di Saleh, è un fatto che Bassam Abu Sharif – uomo per anni a fianco di George Habbash nell’ufficio politico del Fronte popolare – ha confermato nel 2008 al Corriere della sera che quell’accordo esisteva: «Ho seguito personalmente le trattative… Aldo Moro non l’ho mai incontrato. Abbiamo discusso i dettagli con un ammiraglio, gente dei servizi segreti, e con Giovannone… a Roma e in Libano». E’ anche un fatto – ricorda il giornalista Amedeo Ricucci – che l’Olp stava preparando il viaggio a Roma di Arafat dove il capo dei capi, in ottimi rapporti col governo italiano, avrebbe incontrato il papa. Nulla doveva turbare quell’operazione. E’ un fatto anche che si fece di tutto per allontanare la pista palestinese. Che si nascose la verità. Su cui ancora pesa il segreto di Stato.
Nel turbine della guerra. Il contesto
Nel 1980 Beirut è in guerra, una guerra civile che viene combattuta tra il 1975 e il 1990, in un turbinio di voltafaccia, capovolgimenti di alleanze, distruzione, morte. Una guerra che si combatte soprattutto in città e che trasforma la “Svizzera del medio oriente” in un buco nero nel quale intervengono interessi, finanziamenti e pressioni di altri Paesi. Nel 1980 siamo tra due periodi che vedono l’intervento diretto degli israeliani che invadono il Paese una prima volta nel 1978 e una seconda nel 1982 con la famosa operazione “Pace in Galilea”. Nel 1980, la Beirut che Italo Toni e Graziella De Palo si trovano davanti è una città divisa in due dalla cosiddetta linea verde che si snoda lungo una grande arteria, la via di Damasco. La linea verde, definitivamente smantellata solo nel 1990, divide la capitale in due aree: la zona cristiana a Est, la musulmana a Ovest.
E’ qui che hanno sede le organizzazioni palestinesi cui Toni e Graziella si sono affidati. C’è l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, il cartello unitario che è ufficialmente rappresentato da Yasser Arafat, leader di Al Fatah, la fazione che potremmo definire “moderata” o comunque quella che si muove soprattutto sul fronte diplomatico. Ma in quel cartello ci sono una miriade di gruppi e gruppuscoli che spesso si muovono con una propria personale agenda. Tra loro ci sono il Fronte Popolare di George Habbash, appoggiato da Siria e Iraq, e il Fronte Democratico di Nayef Hawatmeh, un gruppo rigidamente marxista leninista e ultra radicale. Italo e Graziella sono arrivati in Libano grazie a un accordo con il rappresentante dell’Olp a Roma Nemer Hammad che ha messo loro a disposizione un biglietto scontato, una prenotazione all’hotel Triumph e i buoni uffici con la Siria che proietta la sua ombra su tutto il Libano. Una volta a Beirut Italo e Graziella prendono accordi anche col Fronte Democratico per un viaggio nel Sud che deve iniziare il 2 settembre. E’ da lì che si perdono le loro tracce.
Per dipanare la matassa bisognerebbe che tutto fosse chiaro e limpido: senza omissis e senza prolungamenti del segreto di Stato, tutte cose che alimentano la sensazione che, anche a distanza di decenni, vi sia ancora qualcosa di imbarazzante da nascondere. Una trattativa segreta, una trama oscura, delle responsabilità insospettabili. E’ in quella rete che, forse inconsapevolmente o forse per aver fatto troppe domande, finirono Italo Toni e Graziella de Palo quel 2 settembre del 1980.
Mistero italiano. Oggi su Wikiradio
 |
| Italo Toni in uno scatto di Fausto Giaccone |
Il 2 settembre 1980 due giornalisti feelance scompaiono nella Beirut della guerra civile. Trentasei anni dopo cosa sappiamo della morte di Italo Toni e Graziella de Palo. Oggi alle 14 in onda su wikiradio (regia di Loredana Rotundo)
Il primo settembre del 1980 a Beirut, due giornalisti italiani vanno alla nostra ambasciata nella capitale libanese. L’ambasciatore è in ferie e vengono ricevuti da un consigliere di legazione a cui confidano di avere l’indomani, il 2 settembre, un appuntamento con uomini del Fronte democratico per la Liberazione della Palestina. Non sappiamo se spiegano al consigliere Guido Tonini il motivo dell’incontro ma gli confidano di essere preoccupati: “Consigliere, se tra tre giorni non siamo rientrati in albergo, date l’allarme. Venite a cercarci”…
Mistero italiano. Domani a Wikiradio
 |
| Italo Toni in uno scatto di Fausto Giaccone |
Il 2 settembre 1980 due giornalisti feelance scompaiono nella Beirut della guerra civile. Trentasei anni dopo cosa sappiamo della morte di Italo Toni e Graziella de Palo. Domani su il manifesto e alle 14 in onda su wikiradio (regia di Loredana Rotundo)
Il primo settembre del 1980 a Beirut, due giornalisti italiani vanno alla nostra ambasciata nella capitale libanese. L’ambasciatore è in ferie e vengono ricevuti da un consigliere di legazione a cui confidano di avere l’indomani, il 2 settembre, un appuntamento con uomini del Fronte democratico per la Liberazione della Palestina. Non sappiamo se spiegano al consigliere Guido Tonini il motivo dell’incontro ma gli confidano di essere preoccupati: “Consigliere, se tra tre giorni non siamo rientrati in albergo, date l’allarme. Venite a cercarci”…
La posta in gioco a Naypyidaw
 Centinaia di delegati delle minoranze etniche e dei gruppi armati in lotta da sempre col governo centrale birmano hanno partecipato ieri all’apertura della 21ma Conferenza di Panglong, dal nome della città dove nel 1947 si celebrò il primo incontro. Che dal ‘47 se ne siano tenuti solo una ventina la dice lunga sulla distanza tra il centro e la periferia ma il fatto che la Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, ora al governo del Paese, sia riuscita in pochi mesi dalla sua vittoria elettorale in novembre a convocarla – pur suscitando qualche polemica tra chi l’ha vissuta ancora come un’imposizione dal centro – la dice lunga sulla volontà di sistemare le cose in un Paese con 135 gruppi etnici riconosciuti per legge e oltre una ventina di gruppi armati secessionisti di cui 17 partecipano agli incontri nella capitale.
Centinaia di delegati delle minoranze etniche e dei gruppi armati in lotta da sempre col governo centrale birmano hanno partecipato ieri all’apertura della 21ma Conferenza di Panglong, dal nome della città dove nel 1947 si celebrò il primo incontro. Che dal ‘47 se ne siano tenuti solo una ventina la dice lunga sulla distanza tra il centro e la periferia ma il fatto che la Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, ora al governo del Paese, sia riuscita in pochi mesi dalla sua vittoria elettorale in novembre a convocarla – pur suscitando qualche polemica tra chi l’ha vissuta ancora come un’imposizione dal centro – la dice lunga sulla volontà di sistemare le cose in un Paese con 135 gruppi etnici riconosciuti per legge e oltre una ventina di gruppi armati secessionisti di cui 17 partecipano agli incontri nella capitale.
Nel febbraio del 1947 a Panglong – nello Stato Shan, 700 chilometri a Nord di Ranggon – ci provò per la prima volta il padre di Aung San Suu Kyi, il generale Aung San: sul piatto c’era l’indipendenza dagli inglesi. E il patto siglato a Panglong era che, in cambio di un’alleanza anti britannica, il nuovo corso post coloniale avrebbe riconosciuto agli alleati sia una base legale sia la possibilità di secedere. Ma dopo l’indipendenza dal Regno unito nel 1948, e con Aung San già assassinato dai sicari dei suoi avversari politici nel luglio del ‘47, il patto fu tradito. Il pugno divenne anzi assai duro con un potere militare diventato la cornice istituzionale del Paese.
Secondo gli osservatori locali non ci si può aspettare troppo dai cinque giorni della Conferenza ma è anche abbastanza chiaro che non sono le conferenze a sistemare le cose. Sono un segno però di apertura al dialogo che sembra far dunque rispettare al governo un’agenda politica in cui il processo negoziale coi gruppi armati, in stallo da anni, resta una priorità. E così quello con le minoranze che rappresentano circa il 40% della popolazione del Paese (oltre 50 milioni di abitanti).
Alla Conferenza Aung San Suu Kyi è affiancata dal generale Min Aung Hlaing, a capo delle forze armate ma uomo con cui la Nobel ha saputo costruire un’intesa. A Naypyidaw, la nuova capitale del Myanmar, è arrivato però anche Ban Ki-moon che questa volta non si è limitato al cerimoniale. Il segretario generale dell’Onu ha affrontato con Suu Kyi una questione spinosa: i Rohingya, quel milione di musulmani che vive sul confine occidentale e che non solo non è presente alla Conferenza ma non rientra neppure tra le minoranze riconosciute. Indocumentati vissuti come “immigrati clandestini” venuti dal Bangladesh da una popolazione in maggioranza buddista che non ha esitato a paventare un’ipotetica jihad per dare addosso alla piccola e vessata comunità fedele al Profeta. 120Mila tra loro sono alloggiati In «squallidi campi per sfollati interni», scrive il giornale Irrawaddy, mentre in tanti han preso la via del mare cercando fortuna a Sud, in Thailandia o Malaysia.
Campi profughi per gli sfollati della lunga guerra interna si trovano invece a ridosso del confine occidentale con la Thailandia ed è l’altra immagine che accompagna la conferenza. Questa volta si spera. Sembra che Pechino, sponsor di molti gruppi armati, specie lungo i suoi confini, questa volta abbia indirettamente sostenuto la partecipazione agli incontri. Tra gli ottimisti c’è ad esempio Khua Uk Lian, membro del Chin National Front, uno dei tanti gruppi guerriglieri. Ma per far finire il conflitto – ha detto all’agenzia France Press – i problemi da risolvere sono tanti: oppio, risorse, tensioni locali. La partita è aperta.
Uccisa la mente dell’attacco al bar di Dacca. Ma i dubbi sopravvivono
La polizia del Bangladesh ne è certa. Anzi, certissima: quel corpo riversato a terra accanto ad altri due distesi in un lago di sangue nella palazzina a due piani della cittadina di Narayanganj, 25 chilometri a Sud della capitale Dacca, è quello di Tamim Chowdhury. Con la sua morte, e quella di due suoi sodali, il Bangladesh chiude almeno in parte lo spinoso capitolo della strage che agli inizi di luglio ha visto uccidere un gruppo di 22 ostaggi – tra cui nove italiani – in un bar esclusivo della capitale frequentato da “expat”. L’azione era stata rivendicata da Daesh e Tamin ne sarebbe stato l’ideatore. Tamin è però anche leader di una fazione del gruppo Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb), gruppo jihadista del Paese asiatico, che il governo aveva indicato subito come l’autore dell’attentato negando fosse opera di Daesh. La morte di Tamin non potrà smentirlo o confermarlo.
 |
| Daesh o no? Non possiamo saperlo per ora |
Stando alle fonti di polizia, l’azione è iniziata al mattino presto, all’alba, quando la palazzina coi tre sospetti è stata circondata. Per un quarto d’ora (!), dice sempre la polizia, si intima la resa ma non arrivano risposte: i militanti invece avrebbero dato fuoco a una stanza con l’intento forse di distruggere prove, documenti, laptop. Alle 8 e 45 scatta l’operativo e benché ora la polizia dica che avrebbe voluto Tamin vivo, i tre vengono falciati. Del resto sono armati di mitra e machete e forse non si vogliono arrendere ma la resistenza comunque dev’essere durata poco. Passa qualche ora e giornali e rete vengono inondati di fotografie dei tre cadaveri il cui capo sarebbe stato l’uomo che progettò la strage del 1 luglio al Holey Artisan Bakery a Gulshan, quartiere residenziale di alto bordo a Dacca. Su Tamin, un bangla canadese tornato a Dacca nel 2013 e presto indicato tra i sospetti, vien messa una taglia di 22mila euro e per gli inquirenti il colpevole è lui. Non sono chiari i rapporti tra Daesh e Jmb ma Tamin sarebbe stato a capo di una fazione pro califfato.
Il quadro resta confuso, almeno nelle attribuzioni delle sigle. Daesh o no? Certo, ai famigliari delle vittime non deve comprensibilmente importare un granché, ma c’è un aspetto rilevante che non ha solo a che vedere con i diritti che vanno riconosciuti anche agli assassini e che è difficile riconoscere loro una volta morti. Il governo reagisce sempre come se Daesh non esistesse anche se ha rivendicato l’attentato a diversi stranieri, come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo. Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è sempre di gruppi locali e non di una branca in Bangladesh del progetto dell’Uomo nero in turbante. Del resto coi gruppi islamisti (alcuni dei quali – come Jmb – fuorilegge) il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo e molto spesso i militanti finiscono giustiziati senza che possano poi essere interrogati. Diversi attivisti di Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine e sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 ordigni (da allora è stata messa fuori legge). In questo Paese violento, violento anche sul piano del riconoscimento dei diritti, si alterna il pugno di ferro alla tolleranza necessaria a far convivere oltre 150 milioni di persone che sopravvivono su un Paese grande la metà dell’Italia e che sono in larghissima maggioranza di fede musulmana (e poveri). E’ una storia difficile, complicata dal retaggio coloniale (e dalla guerra che divise l’allora Pakistan orientale – oggi Bangladesh – dal Pakistan) e di cui si fa fatica a venire a capo. A cominciare dall’attentato al bar: messo in atto da ragazzi che, in molti casi venivano da buone famiglie o, come Tamin, dalla diaspora ricca in Occidente. E’ che a volte, studiare apre il cervello e gli occhi anche sulle ingiustizie del proprio Paese e questo può portare a scelte radicali, specie se il retroterra culturale è un patrimonio di violenze. Ma Tamin non potrà raccontarcelo. Né dirci di Daesh o se davvero era stato lui a progettare l’attentato.
Il governo e la polizia registrano una vittoria. Noi forse ne sappiamo meno di prima.
Dimenticare Kabul. La guerra delle SIM
 A tre giorni dall’attacco mercoledi scorso all’Università americana di Kabul (almeno 16 morti e oltre 50 feriti) una guerra delle “SIM card” si insinua nella guerra guerreggiata che tutti i giorni miete le sue vittime nel Paese dell’Hindukush. Come un un copione ritrito, Afghanistan e Pakistan si scontrano di nuovo perché, dicono a Kabul, ci sono tracce di telefonate che avrebbero raggiunto gli attentatori nella capitale dal Pakistan. Ergo, il colpevole sta nel Paese dei puri. Islamabad risponde per le rime: anche loro hanno tracciato le telefonate ma queste sarebbero partite da… sim afgane, che riescono a collegarsi dal poroso e indefinito confine tra i due Paesi. Ergo, cercate in casa vostra. Guerra delle parole per ora, e anche cauta perché a Islamabad è arrivata una delegazione statunitense di altissimo profilo e dunque, visto che di mezzo c’è l’università americana, la prudenza è di rigore: c’è l’inviato speciale per Afghanistan e Pakistan Richard Olson, l’assistente speciale del presidente Obama Peter Lavoy e il comandante di Resolute Support, la nuova missione Nato in Afghanistan (cui l’Italia partecipa con 800 soldati), generale John Nicholson. Non son queste visite che si programmano certo da un giorno con l’altro, ma il caso, o forse no, fa coincidere la visita con l’ennesima strage. Strage senza rivendicazione, il che getta una luce ancor più sinistra sull’attentato.
A tre giorni dall’attacco mercoledi scorso all’Università americana di Kabul (almeno 16 morti e oltre 50 feriti) una guerra delle “SIM card” si insinua nella guerra guerreggiata che tutti i giorni miete le sue vittime nel Paese dell’Hindukush. Come un un copione ritrito, Afghanistan e Pakistan si scontrano di nuovo perché, dicono a Kabul, ci sono tracce di telefonate che avrebbero raggiunto gli attentatori nella capitale dal Pakistan. Ergo, il colpevole sta nel Paese dei puri. Islamabad risponde per le rime: anche loro hanno tracciato le telefonate ma queste sarebbero partite da… sim afgane, che riescono a collegarsi dal poroso e indefinito confine tra i due Paesi. Ergo, cercate in casa vostra. Guerra delle parole per ora, e anche cauta perché a Islamabad è arrivata una delegazione statunitense di altissimo profilo e dunque, visto che di mezzo c’è l’università americana, la prudenza è di rigore: c’è l’inviato speciale per Afghanistan e Pakistan Richard Olson, l’assistente speciale del presidente Obama Peter Lavoy e il comandante di Resolute Support, la nuova missione Nato in Afghanistan (cui l’Italia partecipa con 800 soldati), generale John Nicholson. Non son queste visite che si programmano certo da un giorno con l’altro, ma il caso, o forse no, fa coincidere la visita con l’ennesima strage. Strage senza rivendicazione, il che getta una luce ancor più sinistra sull’attentato.
I rapporti tra i due Paesi sono ormai più che tesi da oltre un anno e la tensione ha subito nei mesi recenti un’accelerazione cui l’attentato all’Università porta acqua come a un mulino che lavora a pieno ritmo. Indispettito per gli incidenti di frontiera, la montante pachistanofobia afgana e la tolleranza che gli afgani dimostrano per mullah Fazlullah e i suoi accoliti – è il capo dei talebani pachistani che Islamabad è convinta abbia eletto residenza in territorio afgano – il Pakistan ha deciso di reagire con l’espulsione degli afgani che risiedono nel Paese: sono circa due milioni e mezzo e un milione fra loro non ha le carte a posto. Da gennaio Islamabad ha cominciato a far pulizia e adesso sono già 100mila gli afgani cacciati oltre frontiera (67mila solo da giugno). Molti di loro han così perso quel poco che avevano ricostruito della loro vita da profughi infiniti: c’è chi la prende con filosofia ma anche chi subisce l’espulsione come una catastrofe che l’Unhcr, l’Alto commissariato dell’Onu, ha già denunciato chiedendo finanziamenti e attenzione a donatori già troppo impegnati coi profughi siriani e di vedute ristrette visto che quella gente finirà per ingrossare le fila di chi tenta fortuna a Occidente. Il governo afgano infatti è in difficoltà: non li può certo respingere ma non ha soldi per accoglierli. La notizia però è di quelle non troppo seducenti nemmeno per i cronisti visto che di immigrati clandestini e non se ne parla già fin troppo. Non è l’unico aspetto dell’Afghanistan a trovar distratti media e politici.
L’altro aspetto, che par quasi irrilevante, è la guerra. La “mission accomplished” infatti non è compiuta per niente. In Afghanistan si combatte, se non più di prima, come sempre. I morti civili aumentano. I bombardamenti sono frequenti e chissà di che entità visto che gli americani hanno introdotto in teatro i B-52, i bombardieri volanti con una fama sinistra acquisita durante la guerra in Vietnam. La differenza è che adesso combattono solo gli afgani e solo raramente le truppe speciali americane appoggiate dall’aviazione. La Nato sta a guardare (la sua non è una missione “combat” come si dice in gergo) e per ora gli afgani sembrano esser affiancati soprattutto dagli americani. Ma sono in difficoltà: militari e politiche. Quelle militari sono di routine (fatto salvo il fatto che ormai si combatte sempre più spesso nel Nord del Paese e non più solo nel Sudovest): i talebani riescono a prendere alcuni distretti per qualche giorno o qualche ora, poi arrivano gli afgani e riconquistano la postazione perduta. Ma, come commenta un militare, questo «non dovrebbe accadere». Il problema è che la catena di comando, dal centro alla periferia, è labile quando non è inceppata. Ciò dipende, dicono gli analisti afgani, dal grado di perenne litigiosità del governo di Unità nazionale, un “papocchio” istituzionale nato dalle elezioni malate di due anni fa che, per far contenti i due galli in batteria, ha inventato un capo dell’esecutivo (Abdullah Abdullah) che affianca il presidente (Ashraf Ghani) col risultato che quel che uno fa la sera l’altro disfa la mattina: si tratti della nomina di un viceministro o di quella di un governatore. Succede così che quando qualche colonnello chiede rinforzi a Kabul si temporeggia perché gli ordini da palazzo son vaghi in questa guerra infinita che pare sia finita soltanto perché non ne parliamo più.
Dimenticare
 |
| Herat, la Grande Moschea |
Mentre lascio ancora una volta questo amato Paese, mi vien da pensare che purtroppo Afghanistan significa ormai #guerra dimenticata#, una locuzione che ho sempre odiato ma temo proprio che adesso sia cosi. Nessuno ne vuol sapere di questa guerra che, anziché esser terminata, cresce di intensità. Qualche esempio. Dopo il famoso attacco alla scuola militare nel 2014 a Peshawar, Islamabad – forse per ritorsione con Kabul che chiude gli occhi sui paktalebani che hanno santuari in Afghanistan – ha deciso un piano di espulsione che, dal gennaio scorso, ha gia riversati 100mila afgani residenti in Pakistan fuori dal Paese. 67mila solo da giugno (in Pakistan vivono 2 mln e mezzo di afgani di cui 1 milione non registrati). In Helmand le cose vanno male come al solito ma ora assai peggio e i talebani sono a un passo di Lashkargah. Ma quel che par peggio riguarda tutta la zona di Baghlan Kunduz, dove i talebani hanno prima preso un distretto poi diversi check point governativi (poi ripresi), bloccato la autostrada e fatto saltare il ponte che va in città. Si combatte furiosamente mentre a Kabul il governo litiga. Gli americani fanno largo uso delle loro forze speciali e hanno ricominciato i bombardamenti ma con i famigerati B-52. Che questa non sia guerra…. Lascio il Paese con questa amarezza mentre ammiro le tonalità del terreno che circonda Herat, dal marrone scuro al giallo tipicamente desertico di un territorio struggente. E dimenticato
Asia: il continente più nucleare
Un paio di anni fa l’artista giapponese Isao Hashimoto ha fatto una mappatura visuale delle 2053 esplosioni nucleari avvenute tra il 1945 e il 1998, di quella che comunemente chiamiamo “corsa agli armamenti”, in questo caso “tecnologicamente avanzati”. Fino al 1949 sono solo gli americani poi cominciano i sovietici. Nel 1952 arriva il Regno Unito. Nel 1960 entra in campo Parigi mentre Londra ha già testato 21 esplosioni, l’Urss 83 e gli Stati Uniti 196. Solo 4 anni dopo, nel gennaio del 1964, il punteggio è: Francia 9, GB 23, Urss 221, Usa 349. Ma nel 1964 si registra anche il primo test cinese. Nel 1974 il primo indiano. Nel 1998 arriva anche il Pakistan. L’esperimento visuale di Hashimoto si conclude con questo bilancio: Stati Uniti 1032; Russia (rimasta al palo dopo la caduta del muro) 715; Francia 210; GB e Cina 45; India 4; Pakistan 2 (in realtà nel 1998 furono ben di più i test dei due Paesi asiatici). L’artista si ferma qui. I bombaroli no (il grafico visuale su può vedere su Youtube: lo riproduco qui sotto).
Continente atomico
Non solo gran parte delle esplosioni avvengono in Asia ma l’Asia è anche il continente che ospita il maggior numero di Paesi con l’arma nucleare. Se si escludono Usa, Gran Bretagna e Francia, nel Consiglio di sicurezza siedono gli altri due Paesi con la bomba “ufficiale”: Cina, che è Asia a tutti gli effetti, e Russia, la cui gran parte del territorio sta nel continente asiatico. Tutti gli altri Paesi con la bomba, più o meno nascosta, sono asiatici. Da Ovest a Est: Israele, Pakistan, India, Corea del Nord (pur se sul suo arsenale c’è un punto interrogativo). Anche molte velleità nucleari stanno in Asia, sebbene non si siano mai trasformate in una bomba: dall’Iran all’Arabia saudita. Se si escludono il Sudafrica, l’Egitto, la Libia o il Brasile in cui è serpeggiato il desiderio di aver l’arma nucleare – e se si escludono le velleità non dichiarate che devono aver attraversato un po’ tutti i Paesi – si può affermare a buon diritto che l’Asia è il continente più nucleare. Con che rischi?
Giochi pericolosi sulla Radcliffe Line
 |
| Il visconte di Radcliffe. Uno degli architetti della Partition |
Lasciando da parte l’interrogativo nordcoreano, la zona forse più a rischio è quella tra India e Pakistan che corre lungo la frontiera artificiale tracciata dal righello di sir Cyril Radcliffe, uno dei legulei che il Raj aveva messo a capo delle Border Commissions col compito di tracciare le linee di demarcazione della “Partition” che, nell’agosto del 1947, doveva dar luogo alla nascita di India e Pakistan. In effetti Radcliffe rese pubblico il suo lavoro proprio nel giorno dell’indipendenza – il 17 – dando luogo al più grande esodo della storia e a un massacro dal bilancio spaventoso. La Radcliffe Line è di fatto ancora oggi la frontiera tra India e Pakistan a Ovest e tra India e Bangladesh a Est ed è anche un po’ il simbolo (come la Durand Line nell’annoso contenzioso tra Pakistan e Afghanistan) di una discordia mai sanata tra i due Paesi gemelli. L’India fu la prima, come abbiamo visto, a dotarsi della bomba. E ovviamente Islamabad non voleva essere da meno. Fin che la Guerra Fredda dominava la scena, le cose erano tutto sommato sotto controllo, ma nel 2006 il presidente Bush firma il via libera all’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India che doveva soffiare su un fuoco mai spento. L’accordo consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento atomico in un continente dove il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). A differenza di Israele, che le sue bombe le nasconde, e della Corea del Nord, che vanta forse più di quel che ha, per India e Pakistan la bomba è una realtà ammessa e dichiarata. Anzi, rivendicata: in un equilibrio precario che, dopo l’accordo tra Delhi e Washington, è diventato ancora più fragile.
Tensioni mai sopite
Le tensioni tra i due Paesi, al di là delle guerre (1947-1965-1971) o degli “incidenti” (Kargil 1999) sono pane quotidiano. Nel 1998, sui due fronti, si assiste a una dimostrazione di forza: il 6 aprile parte il primo test pachistano e in maggio l’India risponde con cinque esplosioni nucleari, seguite da altrettante nel Paese dei puri. Il confronto fortunatamente rientrerà, scongiurando una guerra tra i due colossi nucleari. Ma i rapporti tornano tesissimi nel 2001, con l’attacco al parlamento indiano, e nel 2008, dopo gli attentati nel cuore di Mumbay: torna ad agitarsi, per fortuna senza conseguenze, lo spettro dell’uso di testate atomiche (circa un centinaio a testa). Nel 2001 la possibilità di un conflitto e dunque l’uso di missili nucleari diventerà una possibilità reale per mesi e sarà la diplomazia internazionale a raffreddare la tensione. Una tensione che non si è mai allentata mentre il processo di riconciliazione tra i due Paesi continua a restare solo all’orizzonte. Fermo.
Progetto Kahuta
 Se gli indiani hanno iniziato presto, il programma nucleare pachistano comincia nel 1972 con Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir. E’ un civile modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare del cugino indiano che è grande quattro volte più e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. L’incarico viene affidato a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991. Bhutto vorrebbe la bomba entro quattro anni, ma in realtà si dovrà aspettare Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana. Corrono gli anni Ottanta anche se, ufficialmente, il Pakistan diventa un Paese con la bomba nel 1998 quando fa il suo primo test. Per il possesso dell’atomica è molto corteggiato, soprattutto da Riad, anche perché è l’unico Paese islamico a possedere la bomba. E quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra Islamabad e Riad: la presenza del Pakistan a fianco dei Saud significa infatti poter contare anche sul deterrente nucleare.
Se gli indiani hanno iniziato presto, il programma nucleare pachistano comincia nel 1972 con Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir. E’ un civile modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare del cugino indiano che è grande quattro volte più e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. L’incarico viene affidato a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991. Bhutto vorrebbe la bomba entro quattro anni, ma in realtà si dovrà aspettare Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana. Corrono gli anni Ottanta anche se, ufficialmente, il Pakistan diventa un Paese con la bomba nel 1998 quando fa il suo primo test. Per il possesso dell’atomica è molto corteggiato, soprattutto da Riad, anche perché è l’unico Paese islamico a possedere la bomba. E quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra Islamabad e Riad: la presenza del Pakistan a fianco dei Saud significa infatti poter contare anche sul deterrente nucleare.
L’Asia e lo sport. Una palla di cervo a 140 all’ora tra gioco e politica
 |
| Pazzi per la palla di cervo. Dopo il calcio il gioco del cricket è lo sport più giocato al mondo |
Da Sarajevo a Kabul. Da Lahore a Calcutta, la parabola del gioco e della politica visti da un osservatore che odia guardare qualsiasi partita. Persino le Olimpiadi. Un raccontone scritto per il manifesto. Con qualche eccezione
Conclusi nel 1995 gli accordi di Dayton, che avevano decretato la fine della guerra in Bosnia, eravamo partiti per Sarajevo ancora un volta. L’occasione ghiotta era la partita di calcio allo stadio Koshevo che doveva sancire la ripresa della normalità nella capitale del Paese più devastato da quel conflitto alle porte di casa. Ricordo che la radiocronaca Rai era affidata nientemeno che a Bruno Pizzul – voce inconfondibile, piglio deciso, conoscenza dettagliatissima di squadre e giocatori – e i giornalisti erano tantissimi, assiepati con me alle spalle di Pizzul per far la cronaca di quell’incontro che si giocava sul prato da poco ricostruito dello stadio. Io non avevo alcun interesse per la partita in sé: odio lo sport e il calcio in particolare da che quattordicenne, convinto da un manipolo di amici tifosi, ero andato controvoglia a San Siro per una partita Milan Verona conclusasi 2 a 0 ma soprattutto col furto del mio motorino nuovo di zecca. Se odiavo lo sport, in quell’occasione gliela avevo proprio giurata. Mi siedo dunque col fedele taccuino e comincio a chiedere ai colleghi più esperti la provenienza etnica dei calciatori: «… quello è un serbo che ha giocato là e quello forse un croato che faceva l’ala destra… ». Forse? Bene non sapevano: conoscevano la provenienza dalle varie squadre ma i miei colleghi, Pizzul in testa, sembravano ignorare che la forza di quella partita stava nel metter assieme serbi, croati e musulmani o, come li chiaman adesso, bosgnacchi. A loro importava poco l’etichetta politica: guardavano al dribbling, al contropiede, alle azioni in area di rigore. Ne venni a casa sconcertato e mentre scrivevo in albergo il mio pezzo, mi domandavo che razza di giornalisti fossero quelli sportivi. Ma forse avevano ragione. Quella partita era la normalità e forse era giusto passar sopra alle connotazioni etniche che avevano costituito il terreno prediletto dei nazionalisti e fatto da corollario alle stragi. E l’incontro era solo il segno che era finita una stagione e ne iniziava un’altra. Io rivangavo, loro ignoravano. Forse il torto era mio.
Lo sport però, come tutto nella vita, va oltre l’azione in sé. E’ divertimento, certo, e, per chi lo ama, grande passione. Ma è pur sempre parte di un contesto. In Asia, come nel resto del mondo. Sarajevo è in un certo senso la porta dell’Asia: ti accoglie con una sfilza di casermoni realsocialisti – ma di una certa raffinatezza architettonica – che ti conducono, lungo il fiume Miljacka, nella città asburgica e alla fine ti proiettano nella cittadella turca, Bascarsija, ornata di cupole e minareti, fontane e piccole botteghe. Respiri un’aria che troverai a Istanbul, la Sublime Porta, il vero ingresso del Continente al di là dei Dardanelli. Un viaggio in Asia è dunque anche un viaggio nei suoi sport. E il calcio non la fa sempre da padrone. Ci sono sport antichissimi e diffusi in un solo Paese, come il buzkashi afgano, e altri, come il cricket, che nonostante siano d’importazione, hanno in Asia il loro cuore pulsante: dall’Arabia Saudita al Pakistan, dall’India allo Sri Lanka per finire in Australia, il cricket è in termini numerici, il secondo sport più popolare del mondo. Si gioca in grandi spiazzi (ground) dove la partita può durare giorni o settimane; si vede in India su decine di canali televisivi e si gioca nei vicoli di Islamabad con tre birilli di legno, una palla gualcita e la classica mazza piatta. Con l’arrivo dei migranti è ritornato in Europa, sua terra d’origine, per sbarcare a Piazza Vittorio, dietro la Stazione Termini di Roma, o nei giardinetti di altre città: squadre che si allenano in club ben organizzati o semplicemente con team messi assieme la domenica nelle ore più fresche della giornata.
Da Sarajevo a Kabul
Dallo stadio Koshevo passo allo stadio Ghazi di Kabul. Qui di giochi se ne fanno tanti anche se una volta era l’arena prediletta dei talebani per punire gli apostati. Ora ci corrono per allenarsi i giocatori di khosti, un’afgana versione della lotta libera, chissà se imparentata con la yağlı güreş, la “lotta turca” sport nazionale della Turchia, o ancora colcoreano taekwondo, uno sport che ha fatto portare a casa agli afgani anche un bronzo olimpico nel 2012. Ci sono persino donne che si allenano: ci correva ad esempio Mahboba Ahadyar, velocista e unica femmina tra i quattro atleti afgani che nel 2008 erano in lista per le Olimpiadi di Pechino, sostituita all’ultimo momento (aveva chiesto asilo politico in Europa perché minacciata) da un’altra atleta di nome Robina Jalali, che aveva già rappresentato l’Afghanistan ad Atene nel 2004. Eccola la politica, o il contesto, rientrare di diritto nello sport. Il gioco nazionale comunque e il buzkashi, che si gioca nel vasto piazzale antistante lo stadio. E’ un gioco vecchio come il mondo, forse di origine mongolica: secondo la leggenda, quando i prigionieri catturati venivano gettati sul terreno davanti ai vincitori, se li portava a casa chi, a cavallo, se li caricava. Da gioco di guerra a gioco di squadre il buzkashi, nelle sue diverse versioni, funziona grosso modo così: in mezzo all’arena di terra battuta, c’è la carcassa di un animale con la testa mozzata e le zampe tagliate all’altezza del garretto. Un centinaio di cavalieri – i chapandaz – si lanciano verso la preda al centro del campo e il giocatore che per primo afferra il trofeo cerca di trascinarlo verso l’esterno dell’arena, in un punto che segna la vittoria finale. Inseguito dagli altri senza esclusione di colpi (bassi).
Gli occidentalisti impenitenti lo hanno definito un violento “polo senza regole” ma il buzkashi le sue regole le ha. Di più: Whitney Azoy, autore di Buzkashi: Game and Power in Afghanistan, sostiene che è il manifesto di questo Paese: «Il buzkashi – mi ha detto una volta – è il simbolo di una violenta competizione per il potere politico che è sempre pronta a esplodere». Una chiave che a suo dire permette di capire il potere dei signori della guerra, dei capi di clan e tribù. «Chiamarlo “sport nazionale” non ha senso – dice Azoy – perché l’Afghanistan non è mai stata, e non è, una nazione, nel senso di un rapporto di coerenza e responsabilità delle sue anime con l’autorità centrale. E infatti nel buzkashi si gioca in squadra ma ognuno corre per sé». Non so se Azoy abbia ragione ma ecco che di nuovo questo gioco non è solo uno sport anche perché, argomentava il saggista, dietro ogni cavaliere c’è sempre un padrone, un capo clan. Come dietro l’Inter o la Juve.
Dallo stadio di Ghazi potremmo passare al Margalla Ground di Islamabad o al Gymkhana Ground di Mumbai. Qui si gioca la versione moderna di un’invenzione sportiva nata nel Sud dell’Inghilterra tra il XIV e il XV secolo e diventata molto popolare in epoca vittoriana per poi trasferirsi, con grande fortuna, nelle colonie dell’Impero. Per Pakistan e India, fratelli coltelli dal giorno in cui il Raj Britannico li mise al mondo con un parto gemellare quanto sanguinoso, il cricket è diventato sia il simbolo di un orgoglio identitario durante i campionati internazionali, sia il modo più o meno ufficioso col quale tornare a parlarsi quando la diplomazia ha bisogno di altri canali per raffreddare gli animi.
Cricket diplomacy
Questi due colossi asiatici si guardano sempre in cagnesco per un motivo o per l’altro: dagli incidenti di frontiera agli attentati, al recente contenzioso sull’ingresso nel Nuclear Suppliers Group, un consesso di una cinquantina di Stati che trattano materia e tecnologia nucleare. Entrambi ci vorrebbero entrare e la diatriba è su chi sarà ammesso per primo. Lo sport che si gioca con una palla di pelle di cervo, che va bene a musulmani e indù, è diventato per questi due Paesi anche la metafora di una diplomazia indiretta: la “cricket diplomacy”. C’è tensione? Una partita potrebbe stemperarla. Dunque la politica c’entra eccome nello sport più diffuso nel mondo (2,5 miliardi di fan) dopo il calcio (3,5 miliardi) e del resto è un rapporto ineludibile se è vero quanto sostiene Cyril L. James, un intellettuale socialista e anticolonialista nato nelle Indie occidentali, che nel 1938 ha scritto The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. Dice che il cricket può essere interpretato con le categorie della politica e viceversa e che, per gli abitanti delle colonie, fu la metafora dell’indipendenza: vincere nello sport della “madrepatria” imperiale, diventava per gli oppressi la possibile liberazione dalle proprie catene.
Se per qualcuno è il gioco più noioso del mondo e per altri una passione che non ha eguali, nei rapporti difficili tra India e Pakistan è invece il termometro di un dialogo non sempre lineare. Ed è diventato, da Londra a Sidney passando per Lahore e Calcutta, anche un modo di dire se qualcosa non è corretto o non va per il verso giusto: it’s not cricket”. Non so se i diplomatici dei due Paesi usino questa espressione quando la “cricket diplomacy” si arena, ma so che questa lettura può riconciliare con lo sport anche chi cordialmente lo detesta. E mi son sorpreso, in qualche alberghetto del Maharashtra o in qualche stanzetta di Sri Lanka, a guardare la partita. Senza capire gli applausi per l’azione ma affascinato da quella palla che può viaggiare a 140 km l’ora. Più veloce dei lenti e maldestri tentativi della politica o dei nostri tentativi di spiegarla.
L’Asia e lo sport. Una palla di cervo a 140 all’ora tra gioco e politica
 |
| Pazzi per la palla di cervo. Dopo il calcio il gioco del cricket è lo sport più giocato al mondo |
Da Sarajevo a Kabul. Da Lahore a Calcutta, la parabola del gioco e della politica visti da un osservatore che odia guardare qualsiasi partita. Persino le Olimpiadi. Un raccontone scritto per il manifesto. Con qualche eccezione
Conclusi nel 1995 gli accordi di Dayton, che avevano decretato la fine della guerra in Bosnia, eravamo partiti per Sarajevo ancora un volta. L’occasione ghiotta era la partita di calcio allo stadio Koshevo che doveva sancire la ripresa della normalità nella capitale del Paese più devastato da quel conflitto alle porte di casa. Ricordo che la radiocronaca Rai era affidata nientemeno che a Bruno Pizzul – voce inconfondibile, piglio deciso, conoscenza dettagliatissima di squadre e giocatori – e i giornalisti erano tantissimi, assiepati con me alle spalle di Pizzul per far la cronaca di quell’incontro che si giocava sul prato da poco ricostruito dello stadio. Io non avevo alcun interesse per la partita in sé: odio lo sport e il calcio in particolare da che quattordicenne, convinto da un manipolo di amici tifosi, ero andato controvoglia a San Siro per una partita Milan Verona conclusasi 2 a 0 ma soprattutto col furto del mio motorino nuovo di zecca. Se odiavo lo sport, in quell’occasione gliela avevo proprio giurata. Mi siedo dunque col fedele taccuino e comincio a chiedere ai colleghi più esperti la provenienza etnica dei calciatori: «… quello è un serbo che ha giocato là e quello forse un croato che faceva l’ala destra… ». Forse? Bene non sapevano: conoscevano la provenienza dalle varie squadre ma i miei colleghi, Pizzul in testa, sembravano ignorare che la forza di quella partita stava nel metter assieme serbi, croati e musulmani o, come li chiaman adesso, bosgnacchi. A loro importava poco l’etichetta politica: guardavano al dribbling, al contropiede, alle azioni in area di rigore. Ne venni a casa sconcertato e mentre scrivevo in albergo il mio pezzo, mi domandavo che razza di giornalisti fossero quelli sportivi. Ma forse avevano ragione. Quella partita era la normalità e forse era giusto passar sopra alle connotazioni etniche che avevano costituito il terreno prediletto dei nazionalisti e fatto da corollario alle stragi. E l’incontro era solo il segno che era finita una stagione e ne iniziava un’altra. Io rivangavo, loro ignoravano. Forse il torto era mio.
Lo sport però, come tutto nella vita, va oltre l’azione in sé. E’ divertimento, certo, e, per chi lo ama, grande passione. Ma è pur sempre parte di un contesto. In Asia, come nel resto del mondo. Sarajevo è in un certo senso la porta dell’Asia: ti accoglie con una sfilza di casermoni realsocialisti – ma di una certa raffinatezza architettonica – che ti conducono, lungo il fiume Miljacka, nella città asburgica e alla fine ti proiettano nella cittadella turca, Bascarsija, ornata di cupole e minareti, fontane e piccole botteghe. Respiri un’aria che troverai a Istanbul, la Sublime Porta, il vero ingresso del Continente al di là dei Dardanelli. Un viaggio in Asia è dunque anche un viaggio nei suoi sport. E il calcio non la fa sempre da padrone. Ci sono sport antichissimi e diffusi in un solo Paese, come il buzkashi afgano, e altri, come il cricket, che nonostante siano d’importazione, hanno in Asia il loro cuore pulsante: dall’Arabia Saudita al Pakistan, dall’India allo Sri Lanka per finire in Australia, il cricket è in termini numerici, il secondo sport più popolare del mondo. Si gioca in grandi spiazzi (ground) dove la partita può durare giorni o settimane; si vede in India su decine di canali televisivi e si gioca nei vicoli di Islamabad con tre birilli di legno, una palla gualcita e la classica mazza piatta. Con l’arrivo dei migranti è ritornato in Europa, sua terra d’origine, per sbarcare a Piazza Vittorio, dietro la Stazione Termini di Roma, o nei giardinetti di altre città: squadre che si allenano in club ben organizzati o semplicemente con team messi assieme la domenica nelle ore più fresche della giornata.
Da Sarajevo a Kabul
Dallo stadio Koshevo passo allo stadio Ghazi di Kabul. Qui di giochi se ne fanno tanti anche se una volta era l’arena prediletta dei talebani per punire gli apostati. Ora ci corrono per allenarsi i giocatori di khosti, un’afgana versione della lotta libera, chissà se imparentata con la yağlı güreş, la “lotta turca” sport nazionale della Turchia, o ancora colcoreano taekwondo, uno sport che ha fatto portare a casa agli afgani anche un bronzo olimpico nel 2012. Ci sono persino donne che si allenano: ci correva ad esempio Mahboba Ahadyar, velocista e unica femmina tra i quattro atleti afgani che nel 2008 erano in lista per le Olimpiadi di Pechino, sostituita all’ultimo momento (aveva chiesto asilo politico in Europa perché minacciata) da un’altra atleta di nome Robina Jalali, che aveva già rappresentato l’Afghanistan ad Atene nel 2004. Eccola la politica, o il contesto, rientrare di diritto nello sport. Il gioco nazionale comunque e il buzkashi, che si gioca nel vasto piazzale antistante lo stadio. E’ un gioco vecchio come il mondo, forse di origine mongolica: secondo la leggenda, quando i prigionieri catturati venivano gettati sul terreno davanti ai vincitori, se li portava a casa chi, a cavallo, se li caricava. Da gioco di guerra a gioco di squadre il buzkashi, nelle sue diverse versioni, funziona grosso modo così: in mezzo all’arena di terra battuta, c’è la carcassa di un animale con la testa mozzata e le zampe tagliate all’altezza del garretto. Un centinaio di cavalieri – i chapandaz – si lanciano verso la preda al centro del campo e il giocatore che per primo afferra il trofeo cerca di trascinarlo verso l’esterno dell’arena, in un punto che segna la vittoria finale. Inseguito dagli altri senza esclusione di colpi (bassi).
Gli occidentalisti impenitenti lo hanno definito un violento “polo senza regole” ma il buzkashi le sue regole le ha. Di più: Whitney Azoy, autore di Buzkashi: Game and Power in Afghanistan, sostiene che è il manifesto di questo Paese: «Il buzkashi – mi ha detto una volta – è il simbolo di una violenta competizione per il potere politico che è sempre pronta a esplodere». Una chiave che a suo dire permette di capire il potere dei signori della guerra, dei capi di clan e tribù. «Chiamarlo “sport nazionale” non ha senso – dice Azoy – perché l’Afghanistan non è mai stata, e non è, una nazione, nel senso di un rapporto di coerenza e responsabilità delle sue anime con l’autorità centrale. E infatti nel buzkashi si gioca in squadra ma ognuno corre per sé». Non so se Azoy abbia ragione ma ecco che di nuovo questo gioco non è solo uno sport anche perché, argomentava il saggista, dietro ogni cavaliere c’è sempre un padrone, un capo clan. Come dietro l’Inter o la Juve.
Dallo stadio di Ghazi potremmo passare al Margalla Ground di Islamabad o al Gymkhana Ground di Mumbai. Qui si gioca la versione moderna di un’invenzione sportiva nata nel Sud dell’Inghilterra tra il XIV e il XV secolo e diventata molto popolare in epoca vittoriana per poi trasferirsi, con grande fortuna, nelle colonie dell’Impero. Per Pakistan e India, fratelli coltelli dal giorno in cui il Raj Britannico li mise al mondo con un parto gemellare quanto sanguinoso, il cricket è diventato sia il simbolo di un orgoglio identitario durante i campionati internazionali, sia il modo più o meno ufficioso col quale tornare a parlarsi quando la diplomazia ha bisogno di altri canali per raffreddare gli animi.
Cricket diplomacy
Questi due colossi asiatici si guardano sempre in cagnesco per un motivo o per l’altro: dagli incidenti di frontiera agli attentati, al recente contenzioso sull’ingresso nel Nuclear Suppliers Group, un consesso di una cinquantina di Stati che trattano materia e tecnologia nucleare. Entrambi ci vorrebbero entrare e la diatriba è su chi sarà ammesso per primo. Lo sport che si gioca con una palla di pelle di cervo, che va bene a musulmani e indù, è diventato per questi due Paesi anche la metafora di una diplomazia indiretta: la “cricket diplomacy”. C’è tensione? Una partita potrebbe stemperarla. Dunque la politica c’entra eccome nello sport più diffuso nel mondo (2,5 miliardi di fan) dopo il calcio (3,5 miliardi) e del resto è un rapporto ineludibile se è vero quanto sostiene Cyril L. James, un intellettuale socialista e anticolonialista nato nelle Indie occidentali, che nel 1938 ha scritto The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. Dice che il cricket può essere interpretato con le categorie della politica e viceversa e che, per gli abitanti delle colonie, fu la metafora dell’indipendenza: vincere nello sport della “madrepatria” imperiale, diventava per gli oppressi la possibile liberazione dalle proprie catene.
Se per qualcuno è il gioco più noioso del mondo e per altri una passione che non ha eguali, nei rapporti difficili tra India e Pakistan è invece il termometro di un dialogo non sempre lineare. Ed è diventato, da Londra a Sidney passando per Lahore e Calcutta, anche un modo di dire se qualcosa non è corretto o non va per il verso giusto: it’s not cricket”. Non so se i diplomatici dei due Paesi usino questa espressione quando la “cricket diplomacy” si arena, ma so che questa lettura può riconciliare con lo sport anche chi cordialmente lo detesta. E mi son sorpreso, in qualche alberghetto del Maharashtra o in qualche stanzetta di Sri Lanka, a guardare la partita. Senza capire gli applausi per l’azione ma affascinato da quella palla che può viaggiare a 140 km l’ora. Più veloce dei lenti e maldestri tentativi della politica o dei nostri tentativi di spiegarla.
L’Asia e lo sport. Una palla di cervo a 140 all’ora tra gioco e politica
 |
| Pazzi per la palla di cervo. Dopo il calcio il gioco del cricket è lo sport più giocato al mondo |
Da Sarajevo a Kabul. Da Lahore a Calcutta, la parabola del gioco e della politica visti da un osservatore che odia guardare qualsiasi partita. Persino le Olimpiadi. Un raccontone scritto per il manifesto. Con qualche eccezione
Conclusi nel 1995 gli accordi di Dayton, che avevano decretato la fine della guerra in Bosnia, eravamo partiti per Sarajevo ancora un volta. L’occasione ghiotta era la partita di calcio allo stadio Koshevo che doveva sancire la ripresa della normalità nella capitale del Paese più devastato da quel conflitto alle porte di casa. Ricordo che la radiocronaca Rai era affidata nientemeno che a Bruno Pizzul – voce inconfondibile, piglio deciso, conoscenza dettagliatissima di squadre e giocatori – e i giornalisti erano tantissimi, assiepati con me alle spalle di Pizzul per far la cronaca di quell’incontro che si giocava sul prato da poco ricostruito dello stadio. Io non avevo alcun interesse per la partita in sé: odio lo sport e il calcio in particolare da che quattordicenne, convinto da un manipolo di amici tifosi, ero andato controvoglia a San Siro per una partita Milan Verona conclusasi 2 a 0 ma soprattutto col furto del mio motorino nuovo di zecca. Se odiavo lo sport, in quell’occasione gliela avevo proprio giurata. Mi siedo dunque col fedele taccuino e comincio a chiedere ai colleghi più esperti la provenienza etnica dei calciatori: «… quello è un serbo che ha giocato là e quello forse un croato che faceva l’ala destra… ». Forse? Bene non sapevano: conoscevano la provenienza dalle varie squadre ma i miei colleghi, Pizzul in testa, sembravano ignorare che la forza di quella partita stava nel metter assieme serbi, croati e musulmani o, come li chiaman adesso, bosgnacchi. A loro importava poco l’etichetta politica: guardavano al dribbling, al contropiede, alle azioni in area di rigore. Ne venni a casa sconcertato e mentre scrivevo in albergo il mio pezzo, mi domandavo che razza di giornalisti fossero quelli sportivi. Ma forse avevano ragione. Quella partita era la normalità e forse era giusto passar sopra alle connotazioni etniche che avevano costituito il terreno prediletto dei nazionalisti e fatto da corollario alle stragi. E l’incontro era solo il segno che era finita una stagione e ne iniziava un’altra. Io rivangavo, loro ignoravano. Forse il torto era mio.
Lo sport però, come tutto nella vita, va oltre l’azione in sé. E’ divertimento, certo, e, per chi lo ama, grande passione. Ma è pur sempre parte di un contesto. In Asia, come nel resto del mondo. Sarajevo è in un certo senso la porta dell’Asia: ti accoglie con una sfilza di casermoni realsocialisti – ma di una certa raffinatezza architettonica – che ti conducono, lungo il fiume Miljacka, nella città asburgica e alla fine ti proiettano nella cittadella turca, Bascarsija, ornata di cupole e minareti, fontane e piccole botteghe. Respiri un’aria che troverai a Istanbul, la Sublime Porta, il vero ingresso del Continente al di là dei Dardanelli. Un viaggio in Asia è dunque anche un viaggio nei suoi sport. E il calcio non la fa sempre da padrone. Ci sono sport antichissimi e diffusi in un solo Paese, come il buzkashi afgano, e altri, come il cricket, che nonostante siano d’importazione, hanno in Asia il loro cuore pulsante: dall’Arabia Saudita al Pakistan, dall’India allo Sri Lanka per finire in Australia, il cricket è in termini numerici, il secondo sport più popolare del mondo. Si gioca in grandi spiazzi (ground) dove la partita può durare giorni o settimane; si vede in India su decine di canali televisivi e si gioca nei vicoli di Islamabad con tre birilli di legno, una palla gualcita e la classica mazza piatta. Con l’arrivo dei migranti è ritornato in Europa, sua terra d’origine, per sbarcare a Piazza Vittorio, dietro la Stazione Termini di Roma, o nei giardinetti di altre città: squadre che si allenano in club ben organizzati o semplicemente con team messi assieme la domenica nelle ore più fresche della giornata.
Da Sarajevo a Kabul
Dallo stadio Koshevo passo allo stadio Ghazi di Kabul. Qui di giochi se ne fanno tanti anche se una volta era l’arena prediletta dei talebani per punire gli apostati. Ora ci corrono per allenarsi i giocatori di khosti, un’afgana versione della lotta libera, chissà se imparentata con la yağlı güreş, la “lotta turca” sport nazionale della Turchia, o ancora colcoreano taekwondo, uno sport che ha fatto portare a casa agli afgani anche un bronzo olimpico nel 2012. Ci sono persino donne che si allenano: ci correva ad esempio Mahboba Ahadyar, velocista e unica femmina tra i quattro atleti afgani che nel 2008 erano in lista per le Olimpiadi di Pechino, sostituita all’ultimo momento (aveva chiesto asilo politico in Europa perché minacciata) da un’altra atleta di nome Robina Jalali, che aveva già rappresentato l’Afghanistan ad Atene nel 2004. Eccola la politica, o il contesto, rientrare di diritto nello sport. Il gioco nazionale comunque e il buzkashi, che si gioca nel vasto piazzale antistante lo stadio. E’ un gioco vecchio come il mondo, forse di origine mongolica: secondo la leggenda, quando i prigionieri catturati venivano gettati sul terreno davanti ai vincitori, se li portava a casa chi, a cavallo, se li caricava. Da gioco di guerra a gioco di squadre il buzkashi, nelle sue diverse versioni, funziona grosso modo così: in mezzo all’arena di terra battuta, c’è la carcassa di un animale con la testa mozzata e le zampe tagliate all’altezza del garretto. Un centinaio di cavalieri – i chapandaz – si lanciano verso la preda al centro del campo e il giocatore che per primo afferra il trofeo cerca di trascinarlo verso l’esterno dell’arena, in un punto che segna la vittoria finale. Inseguito dagli altri senza esclusione di colpi (bassi).
Gli occidentalisti impenitenti lo hanno definito un violento “polo senza regole” ma il buzkashi le sue regole le ha. Di più: Whitney Azoy, autore di Buzkashi: Game and Power in Afghanistan, sostiene che è il manifesto di questo Paese: «Il buzkashi – mi ha detto una volta – è il simbolo di una violenta competizione per il potere politico che è sempre pronta a esplodere». Una chiave che a suo dire permette di capire il potere dei signori della guerra, dei capi di clan e tribù. «Chiamarlo “sport nazionale” non ha senso – dice Azoy – perché l’Afghanistan non è mai stata, e non è, una nazione, nel senso di un rapporto di coerenza e responsabilità delle sue anime con l’autorità centrale. E infatti nel buzkashi si gioca in squadra ma ognuno corre per sé». Non so se Azoy abbia ragione ma ecco che di nuovo questo gioco non è solo uno sport anche perché, argomentava il saggista, dietro ogni cavaliere c’è sempre un padrone, un capo clan. Come dietro l’Inter o la Juve.
Dallo stadio di Ghazi potremmo passare al Margalla Ground di Islamabad o al Gymkhana Ground di Mumbai. Qui si gioca la versione moderna di un’invenzione sportiva nata nel Sud dell’Inghilterra tra il XIV e il XV secolo e diventata molto popolare in epoca vittoriana per poi trasferirsi, con grande fortuna, nelle colonie dell’Impero. Per Pakistan e India, fratelli coltelli dal giorno in cui il Raj Britannico li mise al mondo con un parto gemellare quanto sanguinoso, il cricket è diventato sia il simbolo di un orgoglio identitario durante i campionati internazionali, sia il modo più o meno ufficioso col quale tornare a parlarsi quando la diplomazia ha bisogno di altri canali per raffreddare gli animi.
Cricket diplomacy
Questi due colossi asiatici si guardano sempre in cagnesco per un motivo o per l’altro: dagli incidenti di frontiera agli attentati, al recente contenzioso sull’ingresso nel Nuclear Suppliers Group, un consesso di una cinquantina di Stati che trattano materia e tecnologia nucleare. Entrambi ci vorrebbero entrare e la diatriba è su chi sarà ammesso per primo. Lo sport che si gioca con una palla di pelle di cervo, che va bene a musulmani e indù, è diventato per questi due Paesi anche la metafora di una diplomazia indiretta: la “cricket diplomacy”. C’è tensione? Una partita potrebbe stemperarla. Dunque la politica c’entra eccome nello sport più diffuso nel mondo (2,5 miliardi di fan) dopo il calcio (3,5 miliardi) e del resto è un rapporto ineludibile se è vero quanto sostiene Cyril L. James, un intellettuale socialista e anticolonialista nato nelle Indie occidentali, che nel 1938 ha scritto The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. Dice che il cricket può essere interpretato con le categorie della politica e viceversa e che, per gli abitanti delle colonie, fu la metafora dell’indipendenza: vincere nello sport della “madrepatria” imperiale, diventava per gli oppressi la possibile liberazione dalle proprie catene.
Se per qualcuno è il gioco più noioso del mondo e per altri una passione che non ha eguali, nei rapporti difficili tra India e Pakistan è invece il termometro di un dialogo non sempre lineare. Ed è diventato, da Londra a Sidney passando per Lahore e Calcutta, anche un modo di dire se qualcosa non è corretto o non va per il verso giusto: it’s not cricket”. Non so se i diplomatici dei due Paesi usino questa espressione quando la “cricket diplomacy” si arena, ma so che questa lettura può riconciliare con lo sport anche chi cordialmente lo detesta. E mi son sorpreso, in qualche alberghetto del Maharashtra o in qualche stanzetta di Sri Lanka, a guardare la partita. Senza capire gli applausi per l’azione ma affascinato da quella palla che può viaggiare a 140 km l’ora. Più veloce dei lenti e maldestri tentativi della politica o dei nostri tentativi di spiegarla.
Libia, Siria, Afghanistan: la saggezza dell’esperienza
 Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Libia, Siria, Afghanistan: la saggezza dell’esperienza
 Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Libia, Siria, Afghanistan: la saggezza dell’esperienza
 Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Mentre i caccia americani volano sui cieli libici e quelli russi sui cieli siriani, qualcuno che di bombardamenti se ne intende commenta i raid che sull’Afghanistan non sono mai smessi. «Sbagliati – dice in un’intervista al britannico Guardian l’ex presidente Karzai – molto sbagliati. Chi chiede agli stranieri di bombardare l’Afghanistan non rappresenta il popolo e i suoi interessi». Furberia post presidenziale? No, il discorso è più articolato perché – dice – la presenza straniera è la negazione dell’autodeterminazione e «provoca frustrazione e rabbia che alimentano il conflitto… Se non possiamo combattere da soli, non possiamo chiedere agli stranieri di farlo per noi», dice l’ex presidente che, come ora Faraj, avallò la presenza straniera. Da sempre contrario ai raid, rincara la dose: «Ho detto al governo di non chiedere agli Usa nuovi raid. Usano prodotti chimici ogni giorno: uccidono i nostri campi e diffondono malattie senza por fine alla guerra». La Nato è stata qui per 14 anni, dice ancora, ma le forze straniere stanno combattendo per gli stessi distretti come quando c’erano 150mila soldati… «Stiamo meglio? C’è più sicurezza? No. Vuol dire che qualcosa non va». Per Karzai le forze straniere devono ritirarsi e semmai concentrarsi sui sostenitori stranieri dei talebani.
Tutto il mondo è palese/2
Minareti d’ItaliaPalazzo Nicolosio Lomellino, Genova(da APGI)
Tutto il mondo è palese/2
Minareti d’ItaliaPalazzo Nicolosio Lomellino, Genova(da APGI)
Tutto il mondo è palese/2
Minareti d’ItaliaPalazzo Nicolosio Lomellino, Genova(da APGI)
Tutto il mondo è palese
Minareti d’Italia. Lombardia, sull’Adda.(Spino d’Adda, villa Zineroni-Casati-Dell’Orto)
Tutto il mondo è palese
Minareti d’Italia. Lombardia, sull’Adda.(Spino d’Adda, villa Zineroni-Casati-Dell’Orto)
Tutto il mondo è palese
Minareti d’Italia. Lombardia, sull’Adda.(Spino d’Adda, villa Zineroni-Casati-Dell’Orto)
Qualche pensiero dopo la strage di Kabul. Se i talebani diventano alleati
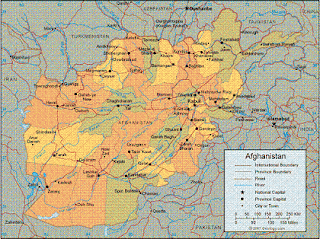 La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
Nate nell’humus della guerra, le cellule di Daesh sono più esposte sul fronte islamista che non su quello della pura repressione governativa: com’è noto, in certe zone del Paese la polizia o l’esercito non ci vanno proprio. E se un villaggio da solo non ce la fa a estromettere queste cellule del cancro califfale, i talebani possono farlo. L’hanno già fatto. Sono i loro peggior nemici. Il movimento talebano non è mai stato jihadsita nel senso che comunemente attribuiamo alla parola “jihad”, meccanicamente tradotta (e ridotta) alla locuzione “guerra santa”. I talebani sono un movimento di liberazione nazionale che anche da Al Qaeda, e dal suo progetto di jihad globale, si sono sempre dissociati fin da tempi non sospetti. Ospitare bin Laden non significava aderire al suo progetto. Così vero, che i talebani furono disposti a negoziare direttamente con gli americani, nemico numero uno di Al Qaeda. Può non piacere ma la guerra talebana è una lotta per la liberazione dell’Afghanistan dall’invasore straniero. E’, a tutti gli effetti, una lotta partigiana, benché possa non piacerci né la radice ideologica (la lettura religiosa della scuola Deobandi) né tantomeno i mezzi con cui viene condotta che, va detto, non sono troppo dissimili da quelli che anche noi e l’esercito afgano utilizziamo o abbiamo utilizzato (voglio dire che, se per colpire un obiettivo militare, si fa poi una strage di civili, non c’è molta differenza tra una bomba sporca sulla strada messa dai talebani e un drone che spara un missile su un matrimonio perché le informazioni erano sbagliate). Ora, per i talebani Daesh non è solo un “concorrente” sulla piazza dell’islam politico: è un invasore i cui obiettivi sono del tutto diversi da quelli del movimento.
Questa è ovviamente una lettura provocatoria e certamente lacunosa. Ci sono pezzi del movimento talebano sicuramente stragisti e ci sono state azioni commesse da talebani o supposti tali da cui i talebani stessi han preso le distanze (come hanno fatto col massacro di sabato a Kabul). Ma ciò che vorrei argomentare è che, nel caso afgano, né noi come forza occupante, né il governo di Kabul stiamo, credo, andando nella direzione giusta. Finché continueremo a negare la strada del negoziato (ammazzando per esempio il capo dei possibili negoziatori), non andremo da nessuna parte. E fin che le truppe d’occupazione non saranno tornate a casa, difficilmente i talebani sceglieranno di negoziare. Si può sperare in una guerra di logoramento ma in Afghanistan si combatte da quasi quarant’anni. Quanti ce ne vorranno ancora? Quanta morte, quanto dolore?
Infine ecco apparire la variabile Daesh che ancora non sappiamo a quale agenda corrisponda. A quella di Raqqa, può darsi, ma forse anche a quella di qualche cellula talebana impazzita: molti talebani rimasti senza lavoro (chi rubava ad esempio ed è stato espulso dal movimento) possono aderire a un progetto che forse gode anche dell’appoggio di qualche potenza straniera che ha a cuore l’instabilità del crocevia tra Asia centrale, Medio oriente e subcontinente indiano. E noi, da che parte stiamo?
Se qualcuno libererà l’Afghanistan da Daesh saranno i talebani. E se invece di organizzare tavole rotonde e summit, mettendo cerotti alla devastazione della guerra e tentando di arginare il fiume in piena dei migranti verso Ovest, ragionassimo sull’unico passo da fare? Ossia, lasciare il Paese (continuando a pagare gli stipendi ai soldati)? Allo stesso tavolo e riconosciutisi reciprocamente come forza politica, talebani e governo potrebbero trovare la quadra. La gente è stanca della guerra e al passo decisivo mancherebbe davvero poco. E’ che bisogna però rinunciare alla basi militari, a mettere il nostro cappello sulla testa degli altri e bisogna accettare che altri Paesi entrino nel gioco delle alleanze che Kabul deciderà di fare. Altrimenti la guerra continuerà e alimenterà anche idee come quella del califfato, oggi poca cosa ma domani chissà. Abbiamo delle responsabilità anche come italiani. Le abbiamo verso gli afgani e anche verso i nostri alleati europei e americani che dovremmo consigliare meglio e non seguire pedissequamente. Andiamocene ma senza per questo stare alla finestra. Lontani però e fuori dal Paese con la truppa. Smettiamola di nasconderci dietro il burqa e i diritti delle donne.
Credo che alle donne afgane – e così ai loro figli, mariti, genitori e parenti – prema soprattutto vivere in pace. Vivere. Il burqa se lo leveranno – inshallah – anche senza di noi.
Qualche pensiero dopo la strage di Kabul. Se i talebani diventano alleati
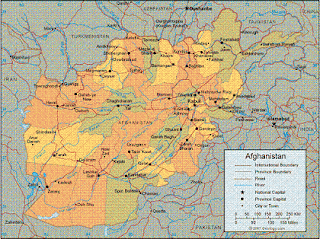 La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
Nate nell’humus della guerra, le cellule di Daesh sono più esposte sul fronte islamista che non su quello della pura repressione governativa: com’è noto, in certe zone del Paese la polizia o l’esercito non ci vanno proprio. E se un villaggio da solo non ce la fa a estromettere queste cellule del cancro califfale, i talebani possono farlo. L’hanno già fatto. Sono i loro peggior nemici. Il movimento talebano non è mai stato jihadsita nel senso che comunemente attribuiamo alla parola “jihad”, meccanicamente tradotta (e ridotta) alla locuzione “guerra santa”. I talebani sono un movimento di liberazione nazionale che anche da Al Qaeda, e dal suo progetto di jihad globale, si sono sempre dissociati fin da tempi non sospetti. Ospitare bin Laden non significava aderire al suo progetto. Così vero, che i talebani furono disposti a negoziare direttamente con gli americani, nemico numero uno di Al Qaeda. Può non piacere ma la guerra talebana è una lotta per la liberazione dell’Afghanistan dall’invasore straniero. E’, a tutti gli effetti, una lotta partigiana, benché possa non piacerci né la radice ideologica (la lettura religiosa della scuola Deobandi) né tantomeno i mezzi con cui viene condotta che, va detto, non sono troppo dissimili da quelli che anche noi e l’esercito afgano utilizziamo o abbiamo utilizzato (voglio dire che, se per colpire un obiettivo militare, si fa poi una strage di civili, non c’è molta differenza tra una bomba sporca sulla strada messa dai talebani e un drone che spara un missile su un matrimonio perché le informazioni erano sbagliate). Ora, per i talebani Daesh non è solo un “concorrente” sulla piazza dell’islam politico: è un invasore i cui obiettivi sono del tutto diversi da quelli del movimento.
Questa è ovviamente una lettura provocatoria e certamente lacunosa. Ci sono pezzi del movimento talebano sicuramente stragisti e ci sono state azioni commesse da talebani o supposti tali da cui i talebani stessi han preso le distanze (come hanno fatto col massacro di sabato a Kabul). Ma ciò che vorrei argomentare è che, nel caso afgano, né noi come forza occupante, né il governo di Kabul stiamo, credo, andando nella direzione giusta. Finché continueremo a negare la strada del negoziato (ammazzando per esempio il capo dei possibili negoziatori), non andremo da nessuna parte. E fin che le truppe d’occupazione non saranno tornate a casa, difficilmente i talebani sceglieranno di negoziare. Si può sperare in una guerra di logoramento ma in Afghanistan si combatte da quasi quarant’anni. Quanti ce ne vorranno ancora? Quanta morte, quanto dolore?
Infine ecco apparire la variabile Daesh che ancora non sappiamo a quale agenda corrisponda. A quella di Raqqa, può darsi, ma forse anche a quella di qualche cellula talebana impazzita: molti talebani rimasti senza lavoro (chi rubava ad esempio ed è stato espulso dal movimento) possono aderire a un progetto che forse gode anche dell’appoggio di qualche potenza straniera che ha a cuore l’instabilità del crocevia tra Asia centrale, Medio oriente e subcontinente indiano. E noi, da che parte stiamo?
Se qualcuno libererà l’Afghanistan da Daesh saranno i talebani. E se invece di organizzare tavole rotonde e summit, mettendo cerotti alla devastazione della guerra e tentando di arginare il fiume in piena dei migranti verso Ovest, ragionassimo sull’unico passo da fare? Ossia, lasciare il Paese (continuando a pagare gli stipendi ai soldati)? Allo stesso tavolo e riconosciutisi reciprocamente come forza politica, talebani e governo potrebbero trovare la quadra. La gente è stanca della guerra e al passo decisivo mancherebbe davvero poco. E’ che bisogna però rinunciare alla basi militari, a mettere il nostro cappello sulla testa degli altri e bisogna accettare che altri Paesi entrino nel gioco delle alleanze che Kabul deciderà di fare. Altrimenti la guerra continuerà e alimenterà anche idee come quella del califfato, oggi poca cosa ma domani chissà. Abbiamo delle responsabilità anche come italiani. Le abbiamo verso gli afgani e anche verso i nostri alleati europei e americani che dovremmo consigliare meglio e non seguire pedissequamente. Andiamocene ma senza per questo stare alla finestra. Lontani però e fuori dal Paese con la truppa. Smettiamola di nasconderci dietro il burqa e i diritti delle donne.
Credo che alle donne afgane – e così ai loro figli, mariti, genitori e parenti – prema soprattutto vivere in pace. Vivere. Il burqa se lo leveranno – inshallah – anche senza di noi.
Qualche pensiero dopo la strage di Kabul. Se i talebani diventano alleati
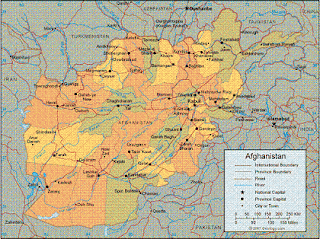 La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
Nate nell’humus della guerra, le cellule di Daesh sono più esposte sul fronte islamista che non su quello della pura repressione governativa: com’è noto, in certe zone del Paese la polizia o l’esercito non ci vanno proprio. E se un villaggio da solo non ce la fa a estromettere queste cellule del cancro califfale, i talebani possono farlo. L’hanno già fatto. Sono i loro peggior nemici. Il movimento talebano non è mai stato jihadsita nel senso che comunemente attribuiamo alla parola “jihad”, meccanicamente tradotta (e ridotta) alla locuzione “guerra santa”. I talebani sono un movimento di liberazione nazionale che anche da Al Qaeda, e dal suo progetto di jihad globale, si sono sempre dissociati fin da tempi non sospetti. Ospitare bin Laden non significava aderire al suo progetto. Così vero, che i talebani furono disposti a negoziare direttamente con gli americani, nemico numero uno di Al Qaeda. Può non piacere ma la guerra talebana è una lotta per la liberazione dell’Afghanistan dall’invasore straniero. E’, a tutti gli effetti, una lotta partigiana, benché possa non piacerci né la radice ideologica (la lettura religiosa della scuola Deobandi) né tantomeno i mezzi con cui viene condotta che, va detto, non sono troppo dissimili da quelli che anche noi e l’esercito afgano utilizziamo o abbiamo utilizzato (voglio dire che, se per colpire un obiettivo militare, si fa poi una strage di civili, non c’è molta differenza tra una bomba sporca sulla strada messa dai talebani e un drone che spara un missile su un matrimonio perché le informazioni erano sbagliate). Ora, per i talebani Daesh non è solo un “concorrente” sulla piazza dell’islam politico: è un invasore i cui obiettivi sono del tutto diversi da quelli del movimento.
Questa è ovviamente una lettura provocatoria e certamente lacunosa. Ci sono pezzi del movimento talebano sicuramente stragisti e ci sono state azioni commesse da talebani o supposti tali da cui i talebani stessi han preso le distanze (come hanno fatto col massacro di sabato a Kabul). Ma ciò che vorrei argomentare è che, nel caso afgano, né noi come forza occupante, né il governo di Kabul stiamo, credo, andando nella direzione giusta. Finché continueremo a negare la strada del negoziato (ammazzando per esempio il capo dei possibili negoziatori), non andremo da nessuna parte. E fin che le truppe d’occupazione non saranno tornate a casa, difficilmente i talebani sceglieranno di negoziare. Si può sperare in una guerra di logoramento ma in Afghanistan si combatte da quasi quarant’anni. Quanti ce ne vorranno ancora? Quanta morte, quanto dolore?
Infine ecco apparire la variabile Daesh che ancora non sappiamo a quale agenda corrisponda. A quella di Raqqa, può darsi, ma forse anche a quella di qualche cellula talebana impazzita: molti talebani rimasti senza lavoro (chi rubava ad esempio ed è stato espulso dal movimento) possono aderire a un progetto che forse gode anche dell’appoggio di qualche potenza straniera che ha a cuore l’instabilità del crocevia tra Asia centrale, Medio oriente e subcontinente indiano. E noi, da che parte stiamo?
Se qualcuno libererà l’Afghanistan da Daesh saranno i talebani. E se invece di organizzare tavole rotonde e summit, mettendo cerotti alla devastazione della guerra e tentando di arginare il fiume in piena dei migranti verso Ovest, ragionassimo sull’unico passo da fare? Ossia, lasciare il Paese (continuando a pagare gli stipendi ai soldati)? Allo stesso tavolo e riconosciutisi reciprocamente come forza politica, talebani e governo potrebbero trovare la quadra. La gente è stanca della guerra e al passo decisivo mancherebbe davvero poco. E’ che bisogna però rinunciare alla basi militari, a mettere il nostro cappello sulla testa degli altri e bisogna accettare che altri Paesi entrino nel gioco delle alleanze che Kabul deciderà di fare. Altrimenti la guerra continuerà e alimenterà anche idee come quella del califfato, oggi poca cosa ma domani chissà. Abbiamo delle responsabilità anche come italiani. Le abbiamo verso gli afgani e anche verso i nostri alleati europei e americani che dovremmo consigliare meglio e non seguire pedissequamente. Andiamocene ma senza per questo stare alla finestra. Lontani però e fuori dal Paese con la truppa. Smettiamola di nasconderci dietro il burqa e i diritti delle donne.
Credo che alle donne afgane – e così ai loro figli, mariti, genitori e parenti – prema soprattutto vivere in pace. Vivere. Il burqa se lo leveranno – inshallah – anche senza di noi.
Qualche pensiero dopo la strage di Kabul. Se i talebani diventano alleati
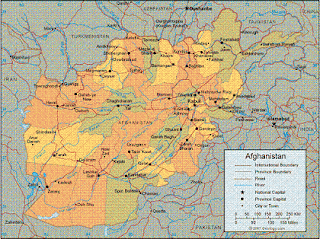 La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
La strage dell’altro ieri a Kabul con un’ottantina di morti tra gli hazara (ma non c’erano solo loro) che protestavano per essere stati tagliati fuori da un progetto energetico che bypassa la loro provincia, racconta molte cose. La prima è che Daesh ci sta provando sempre più seriamente con l’unica strategia che ormai gli resta. L’altra è che non colpisce solo nel mucchio: seleziona e, per la prima volta, si intromette in una manifestazione politica. L’altra cosa ancora è che – come a Parigi o a Dacca – bisogna difendersi in tanti modi e la sola repressione non basterà. Bisogna saldare alleanze e in Afghanistan l’unica alleanza possibile per sgominare Daesh… sono i talebani.
Nate nell’humus della guerra, le cellule di Daesh sono più esposte sul fronte islamista che non su quello della pura repressione governativa: com’è noto, in certe zone del Paese la polizia o l’esercito non ci vanno proprio. E se un villaggio da solo non ce la fa a estromettere queste cellule del cancro califfale, i talebani possono farlo. L’hanno già fatto. Sono i loro peggior nemici. Il movimento talebano non è mai stato jihadsita nel senso che comunemente attribuiamo alla parola “jihad”, meccanicamente tradotta (e ridotta) alla locuzione “guerra santa”. I talebani sono un movimento di liberazione nazionale che anche da Al Qaeda, e dal suo progetto di jihad globale, si sono sempre dissociati fin da tempi non sospetti. Ospitare bin Laden non significava aderire al suo progetto. Così vero, che i talebani furono disposti a negoziare direttamente con gli americani, nemico numero uno di Al Qaeda. Può non piacere ma la guerra talebana è una lotta per la liberazione dell’Afghanistan dall’invasore straniero. E’, a tutti gli effetti, una lotta partigiana, benché possa non piacerci né la radice ideologica (la lettura religiosa della scuola Deobandi) né tantomeno i mezzi con cui viene condotta che, va detto, non sono troppo dissimili da quelli che anche noi e l’esercito afgano utilizziamo o abbiamo utilizzato (voglio dire che, se per colpire un obiettivo militare, si fa poi una strage di civili, non c’è molta differenza tra una bomba sporca sulla strada messa dai talebani e un drone che spara un missile su un matrimonio perché le informazioni erano sbagliate). Ora, per i talebani Daesh non è solo un “concorrente” sulla piazza dell’islam politico: è un invasore i cui obiettivi sono del tutto diversi da quelli del movimento.
Questa è ovviamente una lettura provocatoria e certamente lacunosa. Ci sono pezzi del movimento talebano sicuramente stragisti e ci sono state azioni commesse da talebani o supposti tali da cui i talebani stessi han preso le distanze (come hanno fatto col massacro di sabato a Kabul). Ma ciò che vorrei argomentare è che, nel caso afgano, né noi come forza occupante, né il governo di Kabul stiamo, credo, andando nella direzione giusta. Finché continueremo a negare la strada del negoziato (ammazzando per esempio il capo dei possibili negoziatori), non andremo da nessuna parte. E fin che le truppe d’occupazione non saranno tornate a casa, difficilmente i talebani sceglieranno di negoziare. Si può sperare in una guerra di logoramento ma in Afghanistan si combatte da quasi quarant’anni. Quanti ce ne vorranno ancora? Quanta morte, quanto dolore?
Infine ecco apparire la variabile Daesh che ancora non sappiamo a quale agenda corrisponda. A quella di Raqqa, può darsi, ma forse anche a quella di qualche cellula talebana impazzita: molti talebani rimasti senza lavoro (chi rubava ad esempio ed è stato espulso dal movimento) possono aderire a un progetto che forse gode anche dell’appoggio di qualche potenza straniera che ha a cuore l’instabilità del crocevia tra Asia centrale, Medio oriente e subcontinente indiano. E noi, da che parte stiamo?
Se qualcuno libererà l’Afghanistan da Daesh saranno i talebani. E se invece di organizzare tavole rotonde e summit, mettendo cerotti alla devastazione della guerra e tentando di arginare il fiume in piena dei migranti verso Ovest, ragionassimo sull’unico passo da fare? Ossia, lasciare il Paese (continuando a pagare gli stipendi ai soldati)? Allo stesso tavolo e riconosciutisi reciprocamente come forza politica, talebani e governo potrebbero trovare la quadra. La gente è stanca della guerra e al passo decisivo mancherebbe davvero poco. E’ che bisogna però rinunciare alla basi militari, a mettere il nostro cappello sulla testa degli altri e bisogna accettare che altri Paesi entrino nel gioco delle alleanze che Kabul deciderà di fare. Altrimenti la guerra continuerà e alimenterà anche idee come quella del califfato, oggi poca cosa ma domani chissà. Abbiamo delle responsabilità anche come italiani. Le abbiamo verso gli afgani e anche verso i nostri alleati europei e americani che dovremmo consigliare meglio e non seguire pedissequamente. Andiamocene ma senza per questo stare alla finestra. Lontani però e fuori dal Paese con la truppa. Smettiamola di nasconderci dietro il burqa e i diritti delle donne.
Credo che alle donne afgane – e così ai loro figli, mariti, genitori e parenti – prema soprattutto vivere in pace. Vivere. Il burqa se lo leveranno – inshallah – anche senza di noi.
Ankara, Mosca, Teheran. La nuova politica estera del sultano in cerca di alleanze. A Est
 |
| L’immagine è ripresa dal sito Il caffè geopolitico |
Se il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” è sempre valido, potrebbe essere questa la chiave di lettura della recente svolta turca in politica estera. Non che il golpe c’entri qualcosa con un processo già avviato (col “licenziamento” in maggio del premier già capo degli Esteri Ahmet Davutoğlu), ma certo la presa di distanze dal comportamento di Erdogan di molti Paesi, a cominciare dalla Germania di Angela Merkel, ha probabilmente accelerato un processo di cui si sono visti recentemente i primi passi formali. Il più evidente è quello verso la Russia, dove una delegazione del governo turco, guidata dal vice primo ministro Nurettin Canikli, si recherà in visita il 26-27 luglio per colloqui – dicono fonti di stampa – che dovrebbero includere l’energia. Dopo le scuse turche per l’abbattimento del bombardiere russo, la marcia innestata è quella alta: Mosca dal canto suo ha ripreso i voli per la Turchia e presto riprenderanno anche i charter, carichi di turisti russi in cerca di spiagge europee. Avviata una nuova luna di miele con Israele, si è visto un seppur timido riavvicinamento anche con Teheran (che avrebbe avvisato Ankara dell’imminente golpe), amica nemica di sempre. «Sono mosse che si spiegano con alleanze di mutuo interesse perché – spiega Michele Brunelli, storico dell’Università di Bergamo – alla Russia fa comodo un alleato come la Turchia che non ha aderito all’embargo imposto a Mosca. Per la Turchia invece un asse con Mosca significa poter uscire dal pasticcio mediorientale dove Ankara non è riuscita a fare quel che voleva. Quanto a Teheran, in cerca di ogni possibile amico, la Turchia va benissimo e lo stesso vale per Ankara, al momento senza più grandi alleati. L’Iran è sempre stato tra l’altro un buon mercato per i turchi se si pensa al sistema di telecomunicazioni o all’aeroporto internazionale Khomeini. Poi però gli iraniani avevano frenato. Ora le cose sono cambiate e le strade si ricongiungono». Motivi economici e politici.
 |
| Il libro di Buttino su Samarcanda. Come cambia una città post sovietica |
Anche Marco Buttino, storico dell’Università di Torino e studioso dell’Asia centrale ritiene che la nuova alleanza con Mosca sia più che possibile: «E se il passato ci insegna qualcosa – aggiunge – Turchia e Russia, quando c’era L’Urss, furono già alleati ai tempi di Atatürk. Allora Mosca temeva il panturchismo nelle aree di sua influenza e dunque ci fu un patto tra i due Paesi. La Russia per altro ha sempre avuto bisogno della Turchia per arrivare al Mediterraneo. E ci sono sempre stati due modi: la guerra o la pace. Adesso si sceglie la seconda per due governi che si assomigliano, perché l’islamismo di Erdogan ha un elemento nazionalistico e c’è una sorta di retorica comune. Infine la Turchia è mezza Europa e mezza no e inoltre è dentro la Nato, elemento che adesso crea scompiglio. Mosca non credo voglia far guerra all’Occidente o agli Stati Uniti; credo però che sia interessata al mantenimento ai suoi confini di aree di forte instabilità, di guerre – diciamo – che non finiscono mai, dalla Georgia all’Ucraina al Nagorno-Karabakh. Elementi che le consentono di esercitare la sua influenza». Se la Russia non si preoccupa troppo dell’islamismo di Erdogan, non teme però che Ankara riprenda il suo vecchio progetto panturco nei Paesi di lingua turca dell’ex Urss? «Quel progetto fallì alla metà degli anni Novanta – ricorda Buttino, autore di “Samarcanda” un saggio uscito per Viella in cui analizzi i cambiamenti dal 1945 di questa città dal nome evocativo – quando quei Paesi si spaventarono degli investimenti turchi, dalle moschee ai programmi televisivi. Ora non credo ci sia questo pericolo né questo disegno il che rende ancora più possibile un patto che rende più forti sia Ankara sia Mosca».
 Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Ankara, Mosca, Teheran. La nuova politica estera del sultano in cerca di alleanze. A Est
 |
| L’immagine è ripresa dal sito Il caffè geopolitico |
Se il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” è sempre valido, potrebbe essere questa la chiave di lettura della recente svolta turca in politica estera. Non che il golpe c’entri qualcosa con un processo già avviato (col “licenziamento” in maggio del premier già capo degli Esteri Ahmet Davutoğlu), ma certo la presa di distanze dal comportamento di Erdogan di molti Paesi, a cominciare dalla Germania di Angela Merkel, ha probabilmente accelerato un processo di cui si sono visti recentemente i primi passi formali. Il più evidente è quello verso la Russia, dove una delegazione del governo turco, guidata dal vice primo ministro Nurettin Canikli, si recherà in visita il 26-27 luglio per colloqui – dicono fonti di stampa – che dovrebbero includere l’energia. Dopo le scuse turche per l’abbattimento del bombardiere russo, la marcia innestata è quella alta: Mosca dal canto suo ha ripreso i voli per la Turchia e presto riprenderanno anche i charter, carichi di turisti russi in cerca di spiagge europee. Avviata una nuova luna di miele con Israele, si è visto un seppur timido riavvicinamento anche con Teheran (che avrebbe avvisato Ankara dell’imminente golpe), amica nemica di sempre. «Sono mosse che si spiegano con alleanze di mutuo interesse perché – spiega Michele Brunelli, storico dell’Università di Bergamo – alla Russia fa comodo un alleato come la Turchia che non ha aderito all’embargo imposto a Mosca. Per la Turchia invece un asse con Mosca significa poter uscire dal pasticcio mediorientale dove Ankara non è riuscita a fare quel che voleva. Quanto a Teheran, in cerca di ogni possibile amico, la Turchia va benissimo e lo stesso vale per Ankara, al momento senza più grandi alleati. L’Iran è sempre stato tra l’altro un buon mercato per i turchi se si pensa al sistema di telecomunicazioni o all’aeroporto internazionale Khomeini. Poi però gli iraniani avevano frenato. Ora le cose sono cambiate e le strade si ricongiungono». Motivi economici e politici.
 |
| Il libro di Buttino su Samarcanda. Come cambia una città post sovietica |
Anche Marco Buttino, storico dell’Università di Torino e studioso dell’Asia centrale ritiene che la nuova alleanza con Mosca sia più che possibile: «E se il passato ci insegna qualcosa – aggiunge – Turchia e Russia, quando c’era L’Urss, furono già alleati ai tempi di Atatürk. Allora Mosca temeva il panturchismo nelle aree di sua influenza e dunque ci fu un patto tra i due Paesi. La Russia per altro ha sempre avuto bisogno della Turchia per arrivare al Mediterraneo. E ci sono sempre stati due modi: la guerra o la pace. Adesso si sceglie la seconda per due governi che si assomigliano, perché l’islamismo di Erdogan ha un elemento nazionalistico e c’è una sorta di retorica comune. Infine la Turchia è mezza Europa e mezza no e inoltre è dentro la Nato, elemento che adesso crea scompiglio. Mosca non credo voglia far guerra all’Occidente o agli Stati Uniti; credo però che sia interessata al mantenimento ai suoi confini di aree di forte instabilità, di guerre – diciamo – che non finiscono mai, dalla Georgia all’Ucraina al Nagorno-Karabakh. Elementi che le consentono di esercitare la sua influenza». Se la Russia non si preoccupa troppo dell’islamismo di Erdogan, non teme però che Ankara riprenda il suo vecchio progetto panturco nei Paesi di lingua turca dell’ex Urss? «Quel progetto fallì alla metà degli anni Novanta – ricorda Buttino, autore di “Samarcanda” un saggio uscito per Viella in cui analizzi i cambiamenti dal 1945 di questa città dal nome evocativo – quando quei Paesi si spaventarono degli investimenti turchi, dalle moschee ai programmi televisivi. Ora non credo ci sia questo pericolo né questo disegno il che rende ancora più possibile un patto che rende più forti sia Ankara sia Mosca».
 Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Ankara, Mosca, Teheran. La nuova politica estera del sultano in cerca di alleanze. A Est
 |
| L’immagine è ripresa dal sito Il caffè geopolitico |
Se il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” è sempre valido, potrebbe essere questa la chiave di lettura della recente svolta turca in politica estera. Non che il golpe c’entri qualcosa con un processo già avviato (col “licenziamento” in maggio del premier già capo degli Esteri Ahmet Davutoğlu), ma certo la presa di distanze dal comportamento di Erdogan di molti Paesi, a cominciare dalla Germania di Angela Merkel, ha probabilmente accelerato un processo di cui si sono visti recentemente i primi passi formali. Il più evidente è quello verso la Russia, dove una delegazione del governo turco, guidata dal vice primo ministro Nurettin Canikli, si recherà in visita il 26-27 luglio per colloqui – dicono fonti di stampa – che dovrebbero includere l’energia. Dopo le scuse turche per l’abbattimento del bombardiere russo, la marcia innestata è quella alta: Mosca dal canto suo ha ripreso i voli per la Turchia e presto riprenderanno anche i charter, carichi di turisti russi in cerca di spiagge europee. Avviata una nuova luna di miele con Israele, si è visto un seppur timido riavvicinamento anche con Teheran (che avrebbe avvisato Ankara dell’imminente golpe), amica nemica di sempre. «Sono mosse che si spiegano con alleanze di mutuo interesse perché – spiega Michele Brunelli, storico dell’Università di Bergamo – alla Russia fa comodo un alleato come la Turchia che non ha aderito all’embargo imposto a Mosca. Per la Turchia invece un asse con Mosca significa poter uscire dal pasticcio mediorientale dove Ankara non è riuscita a fare quel che voleva. Quanto a Teheran, in cerca di ogni possibile amico, la Turchia va benissimo e lo stesso vale per Ankara, al momento senza più grandi alleati. L’Iran è sempre stato tra l’altro un buon mercato per i turchi se si pensa al sistema di telecomunicazioni o all’aeroporto internazionale Khomeini. Poi però gli iraniani avevano frenato. Ora le cose sono cambiate e le strade si ricongiungono». Motivi economici e politici.
 |
| Il libro di Buttino su Samarcanda. Come cambia una città post sovietica |
Anche Marco Buttino, storico dell’Università di Torino e studioso dell’Asia centrale ritiene che la nuova alleanza con Mosca sia più che possibile: «E se il passato ci insegna qualcosa – aggiunge – Turchia e Russia, quando c’era L’Urss, furono già alleati ai tempi di Atatürk. Allora Mosca temeva il panturchismo nelle aree di sua influenza e dunque ci fu un patto tra i due Paesi. La Russia per altro ha sempre avuto bisogno della Turchia per arrivare al Mediterraneo. E ci sono sempre stati due modi: la guerra o la pace. Adesso si sceglie la seconda per due governi che si assomigliano, perché l’islamismo di Erdogan ha un elemento nazionalistico e c’è una sorta di retorica comune. Infine la Turchia è mezza Europa e mezza no e inoltre è dentro la Nato, elemento che adesso crea scompiglio. Mosca non credo voglia far guerra all’Occidente o agli Stati Uniti; credo però che sia interessata al mantenimento ai suoi confini di aree di forte instabilità, di guerre – diciamo – che non finiscono mai, dalla Georgia all’Ucraina al Nagorno-Karabakh. Elementi che le consentono di esercitare la sua influenza». Se la Russia non si preoccupa troppo dell’islamismo di Erdogan, non teme però che Ankara riprenda il suo vecchio progetto panturco nei Paesi di lingua turca dell’ex Urss? «Quel progetto fallì alla metà degli anni Novanta – ricorda Buttino, autore di “Samarcanda” un saggio uscito per Viella in cui analizzi i cambiamenti dal 1945 di questa città dal nome evocativo – quando quei Paesi si spaventarono degli investimenti turchi, dalle moschee ai programmi televisivi. Ora non credo ci sia questo pericolo né questo disegno il che rende ancora più possibile un patto che rende più forti sia Ankara sia Mosca».
 Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Ankara, Mosca, Teheran. La nuova politica estera del sultano in cerca di alleanze. A Est
 |
| L’immagine è ripresa dal sito Il caffè geopolitico |
Se il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” è sempre valido, potrebbe essere questa la chiave di lettura della recente svolta turca in politica estera. Non che il golpe c’entri qualcosa con un processo già avviato (col “licenziamento” in maggio del premier già capo degli Esteri Ahmet Davutoğlu), ma certo la presa di distanze dal comportamento di Erdogan di molti Paesi, a cominciare dalla Germania di Angela Merkel, ha probabilmente accelerato un processo di cui si sono visti recentemente i primi passi formali. Il più evidente è quello verso la Russia, dove una delegazione del governo turco, guidata dal vice primo ministro Nurettin Canikli, si recherà in visita il 26-27 luglio per colloqui – dicono fonti di stampa – che dovrebbero includere l’energia. Dopo le scuse turche per l’abbattimento del bombardiere russo, la marcia innestata è quella alta: Mosca dal canto suo ha ripreso i voli per la Turchia e presto riprenderanno anche i charter, carichi di turisti russi in cerca di spiagge europee. Avviata una nuova luna di miele con Israele, si è visto un seppur timido riavvicinamento anche con Teheran (che avrebbe avvisato Ankara dell’imminente golpe), amica nemica di sempre. «Sono mosse che si spiegano con alleanze di mutuo interesse perché – spiega Michele Brunelli, storico dell’Università di Bergamo – alla Russia fa comodo un alleato come la Turchia che non ha aderito all’embargo imposto a Mosca. Per la Turchia invece un asse con Mosca significa poter uscire dal pasticcio mediorientale dove Ankara non è riuscita a fare quel che voleva. Quanto a Teheran, in cerca di ogni possibile amico, la Turchia va benissimo e lo stesso vale per Ankara, al momento senza più grandi alleati. L’Iran è sempre stato tra l’altro un buon mercato per i turchi se si pensa al sistema di telecomunicazioni o all’aeroporto internazionale Khomeini. Poi però gli iraniani avevano frenato. Ora le cose sono cambiate e le strade si ricongiungono». Motivi economici e politici.
 |
| Il libro di Buttino su Samarcanda. Come cambia una città post sovietica |
Anche Marco Buttino, storico dell’Università di Torino e studioso dell’Asia centrale ritiene che la nuova alleanza con Mosca sia più che possibile: «E se il passato ci insegna qualcosa – aggiunge – Turchia e Russia, quando c’era L’Urss, furono già alleati ai tempi di Atatürk. Allora Mosca temeva il panturchismo nelle aree di sua influenza e dunque ci fu un patto tra i due Paesi. La Russia per altro ha sempre avuto bisogno della Turchia per arrivare al Mediterraneo. E ci sono sempre stati due modi: la guerra o la pace. Adesso si sceglie la seconda per due governi che si assomigliano, perché l’islamismo di Erdogan ha un elemento nazionalistico e c’è una sorta di retorica comune. Infine la Turchia è mezza Europa e mezza no e inoltre è dentro la Nato, elemento che adesso crea scompiglio. Mosca non credo voglia far guerra all’Occidente o agli Stati Uniti; credo però che sia interessata al mantenimento ai suoi confini di aree di forte instabilità, di guerre – diciamo – che non finiscono mai, dalla Georgia all’Ucraina al Nagorno-Karabakh. Elementi che le consentono di esercitare la sua influenza». Se la Russia non si preoccupa troppo dell’islamismo di Erdogan, non teme però che Ankara riprenda il suo vecchio progetto panturco nei Paesi di lingua turca dell’ex Urss? «Quel progetto fallì alla metà degli anni Novanta – ricorda Buttino, autore di “Samarcanda” un saggio uscito per Viella in cui analizzi i cambiamenti dal 1945 di questa città dal nome evocativo – quando quei Paesi si spaventarono degli investimenti turchi, dalle moschee ai programmi televisivi. Ora non credo ci sia questo pericolo né questo disegno il che rende ancora più possibile un patto che rende più forti sia Ankara sia Mosca».
 Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Un altro elemento lo aggiunge Fernando Orlandi della Biblioteca-Archivio del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale (Csseo): «Dopo l’abbattimento del Sukhoi russo nel novembre del 2015, collassarono i colloqui per un progetto chiave sia per Mosca sia per Ankara: il cosiddetto Turkish Stream, una gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Turchia via Mar Nero. Dopo il fallimento di Nabucco e di South Stream, questa era una carta fondamentale della politica energetica della regione e credo che adesso il progetto tornerà in auge» Ne parlerà martedì a Mosca la delegazione turca? «Dopo le scuse turche, Gazprom si era già detta disponibile al dialogo con Ankara e comunque Erdogan e Putin si incontreranno al Cremlino ai primi di agosto. Stiamo parlando di un affare da 60 miliardi di metri cubi di gas all’anno».
Turchia, la lezione di Giacarta
Durante il colpo di stato in Cile contro Allende sui muri di Santiago appariva la scritta “Jakarta”: un modello! Anche la vicenda turca sembra ricordare – assai più che in Cile – quanto avvenne in Indonesia nel 1965. Un “controgolpe” minuziosamente preparato su cui oggi un tribunale internazionale popolare chiede agli indonesiani di riaprire il caso e perseguire i colpevoli. Invano per ora
Nei tanti misteri che circondano il colpo di stato fallito in Turchia, l’ipotesi complottista (Erdogan ha architettato il golpe) non sembra per ora aver gambe sufficienti. Certo l’impreparazione dei golpisti, l’esiguità del loro numero, la mancanza di veri leader tra gli stessi militari lasciano perplessi. Così come la campagna scatenata contro Fethullah Gülen, un tempo mentore di Erdogan e ora ritenuto addirittura, ma senza prove, la mente del pronunciamento militare. Le modalità della reazione e la rapidità nell’esecuzione delle epurazioni fa semmai pensare a qualcosa che accadde in Indonesia oltre cinquant’anni fa: il colpo di stato con cui il generale Suharto mise fine all’esperimento nazionalpopulista e venato di socialismo di Sukarno, uno dei leader dell’indipendenza del Paese dall’Olanda. Viene da pensarlo nel giorno in cui il governo indonesiano, per bocca del ministro per la sicurezza Luhut Panjaitan, ha bocciato il risultato di un tribunale popolare internazionale – formato da giuristi che hanno consultato documenti e ascoltato testimonianze – che all’Aja due giorni fa ha rilasciato la sua sentenza. Con cui chiede al governo di procedere a identificare chi si macchiò di crimini contro l’umanità nel periodo 1965-66 quando almeno 400mila persone furono massacrate dopo il golpe di Suharto. Panjaitan ha detto chiaramente che l’Indonesia ha il suo sistema di giustizia e che non è affare di altri indagare sui fatti di casa. Il portavoce del ministero degli Esteri ha infine chiarito che l’Indonesia non si sente obbligata a seguire le indicazioni di un tribunale che non ha basi legali. L’argomento è infatti tabù anche se recentemente il neo presidente Joko Widodo aveva mostrato segni di apertura salvo poi fare marcia indietro quando lo Stato avrebbe dovuto fare pubblica ammenda. Cosa accadde allora e cosa se ne può trarre oggi a proposito della vicenda turca?
 Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Turchia, la lezione di Giacarta
Durante il colpo di stato in Cile contro Allende sui muri di Santiago appariva la scritta “Jakarta”: un modello! Anche la vicenda turca sembra ricordare – assai più che in Cile – quanto avvenne in Indonesia nel 1965. Un “controgolpe” minuziosamente preparato su cui oggi un tribunale internazionale popolare chiede agli indonesiani di riaprire il caso e perseguire i colpevoli. Invano per ora
Nei tanti misteri che circondano il colpo di stato fallito in Turchia, l’ipotesi complottista (Erdogan ha architettato il golpe) non sembra per ora aver gambe sufficienti. Certo l’impreparazione dei golpisti, l’esiguità del loro numero, la mancanza di veri leader tra gli stessi militari lasciano perplessi. Così come la campagna scatenata contro Fethullah Gülen, un tempo mentore di Erdogan e ora ritenuto addirittura, ma senza prove, la mente del pronunciamento militare. Le modalità della reazione e la rapidità nell’esecuzione delle epurazioni fa semmai pensare a qualcosa che accadde in Indonesia oltre cinquant’anni fa: il colpo di stato con cui il generale Suharto mise fine all’esperimento nazionalpopulista e venato di socialismo di Sukarno, uno dei leader dell’indipendenza del Paese dall’Olanda. Viene da pensarlo nel giorno in cui il governo indonesiano, per bocca del ministro per la sicurezza Luhut Panjaitan, ha bocciato il risultato di un tribunale popolare internazionale – formato da giuristi che hanno consultato documenti e ascoltato testimonianze – che all’Aja due giorni fa ha rilasciato la sua sentenza. Con cui chiede al governo di procedere a identificare chi si macchiò di crimini contro l’umanità nel periodo 1965-66 quando almeno 400mila persone furono massacrate dopo il golpe di Suharto. Panjaitan ha detto chiaramente che l’Indonesia ha il suo sistema di giustizia e che non è affare di altri indagare sui fatti di casa. Il portavoce del ministero degli Esteri ha infine chiarito che l’Indonesia non si sente obbligata a seguire le indicazioni di un tribunale che non ha basi legali. L’argomento è infatti tabù anche se recentemente il neo presidente Joko Widodo aveva mostrato segni di apertura salvo poi fare marcia indietro quando lo Stato avrebbe dovuto fare pubblica ammenda. Cosa accadde allora e cosa se ne può trarre oggi a proposito della vicenda turca?
 Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Turchia, la lezione di Giacarta
Durante il colpo di stato in Cile contro Allende sui muri di Santiago appariva la scritta “Jakarta”: un modello! Anche la vicenda turca sembra ricordare – assai più che in Cile – quanto avvenne in Indonesia nel 1965. Un “controgolpe” minuziosamente preparato su cui oggi un tribunale internazionale popolare chiede agli indonesiani di riaprire il caso e perseguire i colpevoli. Invano per ora
Nei tanti misteri che circondano il colpo di stato fallito in Turchia, l’ipotesi complottista (Erdogan ha architettato il golpe) non sembra per ora aver gambe sufficienti. Certo l’impreparazione dei golpisti, l’esiguità del loro numero, la mancanza di veri leader tra gli stessi militari lasciano perplessi. Così come la campagna scatenata contro Fethullah Gülen, un tempo mentore di Erdogan e ora ritenuto addirittura, ma senza prove, la mente del pronunciamento militare. Le modalità della reazione e la rapidità nell’esecuzione delle epurazioni fa semmai pensare a qualcosa che accadde in Indonesia oltre cinquant’anni fa: il colpo di stato con cui il generale Suharto mise fine all’esperimento nazionalpopulista e venato di socialismo di Sukarno, uno dei leader dell’indipendenza del Paese dall’Olanda. Viene da pensarlo nel giorno in cui il governo indonesiano, per bocca del ministro per la sicurezza Luhut Panjaitan, ha bocciato il risultato di un tribunale popolare internazionale – formato da giuristi che hanno consultato documenti e ascoltato testimonianze – che all’Aja due giorni fa ha rilasciato la sua sentenza. Con cui chiede al governo di procedere a identificare chi si macchiò di crimini contro l’umanità nel periodo 1965-66 quando almeno 400mila persone furono massacrate dopo il golpe di Suharto. Panjaitan ha detto chiaramente che l’Indonesia ha il suo sistema di giustizia e che non è affare di altri indagare sui fatti di casa. Il portavoce del ministero degli Esteri ha infine chiarito che l’Indonesia non si sente obbligata a seguire le indicazioni di un tribunale che non ha basi legali. L’argomento è infatti tabù anche se recentemente il neo presidente Joko Widodo aveva mostrato segni di apertura salvo poi fare marcia indietro quando lo Stato avrebbe dovuto fare pubblica ammenda. Cosa accadde allora e cosa se ne può trarre oggi a proposito della vicenda turca?
 Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Turchia, la lezione di Giacarta
Durante il colpo di stato in Cile contro Allende sui muri di Santiago appariva la scritta “Jakarta”: un modello! Anche la vicenda turca sembra ricordare – assai più che in Cile – quanto avvenne in Indonesia nel 1965. Un “controgolpe” minuziosamente preparato su cui oggi un tribunale internazionale popolare chiede agli indonesiani di riaprire il caso e perseguire i colpevoli. Invano per ora
Nei tanti misteri che circondano il colpo di stato fallito in Turchia, l’ipotesi complottista (Erdogan ha architettato il golpe) non sembra per ora aver gambe sufficienti. Certo l’impreparazione dei golpisti, l’esiguità del loro numero, la mancanza di veri leader tra gli stessi militari lasciano perplessi. Così come la campagna scatenata contro Fethullah Gülen, un tempo mentore di Erdogan e ora ritenuto addirittura, ma senza prove, la mente del pronunciamento militare. Le modalità della reazione e la rapidità nell’esecuzione delle epurazioni fa semmai pensare a qualcosa che accadde in Indonesia oltre cinquant’anni fa: il colpo di stato con cui il generale Suharto mise fine all’esperimento nazionalpopulista e venato di socialismo di Sukarno, uno dei leader dell’indipendenza del Paese dall’Olanda. Viene da pensarlo nel giorno in cui il governo indonesiano, per bocca del ministro per la sicurezza Luhut Panjaitan, ha bocciato il risultato di un tribunale popolare internazionale – formato da giuristi che hanno consultato documenti e ascoltato testimonianze – che all’Aja due giorni fa ha rilasciato la sua sentenza. Con cui chiede al governo di procedere a identificare chi si macchiò di crimini contro l’umanità nel periodo 1965-66 quando almeno 400mila persone furono massacrate dopo il golpe di Suharto. Panjaitan ha detto chiaramente che l’Indonesia ha il suo sistema di giustizia e che non è affare di altri indagare sui fatti di casa. Il portavoce del ministero degli Esteri ha infine chiarito che l’Indonesia non si sente obbligata a seguire le indicazioni di un tribunale che non ha basi legali. L’argomento è infatti tabù anche se recentemente il neo presidente Joko Widodo aveva mostrato segni di apertura salvo poi fare marcia indietro quando lo Stato avrebbe dovuto fare pubblica ammenda. Cosa accadde allora e cosa se ne può trarre oggi a proposito della vicenda turca?
 Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
Alle prime ore del 1 ottobre del 1965, il Gerakan 30 September, un movimento di militari progressisti che aveva contatti col Partito comunista locale, tentò un golpe che fallì nell’arco stesso della giornata. La vicenda era cominciata con il sequestro di alcuni generali, poi trovati morti, e col dispiegamento di alcuni soldati al comando del colonnello Untung Syamsuri, la mente del golpe. La reazione della parte dell’esercito che faceva capo a un gruppo di generali riuniti nel Dewan Jendral e che aveva in odio Sukarno, fu rapida e feroce. A comandarla c’era il giovane generale Suharto che “prese in custodia” Sukarno e fece abortire il golpe. Si disse che Untung, temendo una mossa della destra militare, avesse anticipato i tempi ma forse la dinamica fu diversa. Suharto probabilmente sapeva cosa Untung stava preparando e gli lasciò sequestrare i generali, occupare la Radio e tentare un’occupazione della capitale che durò poche ore. Qualche sacca di resistenza resistette in periferia ma in breve venne repressa. Il dispositivo di reazione era pronto al punto tale che di Untung non si ricorda più nessuno. Fu solo la scintilla che doveva dare il pretesto a Suharto per deporre, come fece, lo scomodo Sukarno. Il Pki, il Partito comunista indonesiano, fu accusato di essere dietro al golpe (cosa di cui non c’era prova) e si scatenò una repressione feroce: 400mila morti è probabilmente un numero per difetto. Case e villaggi vennero bruciati, la gente uccisa senza processo, centinaia furono trasferiti in campi di prigionia. E l’Occidente chiuse un occhio, anzi entrambi, su un “controgolpe” che fu seguito e aiutato dai servizi segreti amici del nuovo corso – Orde Baru, Ordine nuovo – che durò poi fino a che nel 1998 il dittatore non fu costretto – sempre dai militari – a ritirarsi.
La lunga notte dei pronunciamenti militari turchi. Che una volta piacevano
 |
| Dal fez alla visiera |
In politica la memoria è sempre un buon esercizio. Tutti in effetti hanno riportato i colpi di Stato che hanno costellato la Turchia contemporanea ma non molti hanno ricordato chi allora, anziché stracciarsi le vesti, chiuse un occhio quando addirittura non aiutò più o meno direttamente la manina militare. Per venire a tempi più recenti si può ricordare l’apprezzatissimo golpe algerino (1992) dopo la vittoria islamista alle elezioni e, in tempi ancor più prossimi, il putsch di Al Sisi (2013), anche quello tutto sommato salutato con favore, come sa bene il nostro premier che, prima che il caso Regeni ci mettesse con l’Egitto ai ferri corti, salutò il generalissimo come «grande statista». Era in buona compagnia perché la condanna del golpe fu piuttosto freddina a livello internazionale. Appena più calorosa delle rimostranze per l’invasione saudita del Bahrein o della guerra dei Saud nello Yemen. Nel caso turco, la presa di distanza americana è invece arrivata subito, prima ancora che il golpe fosse concluso. Erdogan è tutto sommato una sorta di garanzia anche se la sua virata filorussa rischia di far aumentare l’allarme su un personaggio che, seppur eletto, sta ora facendo il golpe istituzionale che gli permette di far le pulizie di fino. Ci son sempre pesi e misure insomma. A seconda di cointesto e convenienze. E in passato?
Se adesso le cose sono un po’ confuse, quando nel maggio del 1960 la prima sollevazione militare scelse il generale Cemal Gürsel come presidente di un nuovo corso che doveva riportare ordine e stabilità, correvano gli anni della Guerra Fredda e non piaceva il primo ministro Adnan Menderes, fondatore di un Partito democratico di destra moderata che però aveva scelto di strizzare l’occhio a Mosca dove Menderes, con cui la Turchia era entrata nella Nato, aveva pianificato un viaggio in cerca di aiuti economici. I golpisti lo impiccarono e purgarono tribunali (centinaia di giudici) e università mettendo sotto arresto l’intera classe dirigente. Allora si pensò che era uno dei tanti golpe del Terzo mondo (secondo il Journal of Cold War Studies 357 tentativi con 183 successi tra il 1945 e il 1985) anche se quello turco avveniva in un Paese Nato.
Il cosiddetto “Golpe del memorandum” del 1971 avviene in un momento di grande turbolenza politica che ha ridato fiato alla sinistra turca. A differenza del golpe del 1960, animato da militari radicali diventati famosi per un pogrom anti greco a Istanbul, l’élite delle Forze armate che aveva organizzato il colpo del 1971 era violentemente anti comunista e si distinse per la repressione di ogni cosa che avesse a che fare con la sinistra. Inutile dire che quel colpo di Stato andava bene così. Il 12 settembre del 1980 arriva il terzo golpe. Anche lì c’è un’anima di destra che si esplicita in una repressione brutale e in una riduzione dell’intervento dello Stato in economia. Le carceri si riempiono di oppositori, 230 mila dei quali vengono processati. A cinquanta viene comminata la pena di morte, a 14mila viene ritirata la cittadinanza. Secondo la stampa curda c’era una sorta di lista di proscrizione con 1.683.000 nomi. A chi era piaciuta la mano pesante?
All’epoca reggeva la base operativa della Cia in Turchia Paul Henze, uno specialista della guerra psicologica, diventato famoso per un libro in cui sosteneva che dietro l’attentato a Papa Woytila ci fosse Mosca. Henze, già a capo della Cia in Etiopia e che se n’era andato da Ankara alla vigilia del golpe, ha negato, ma la Cia probabilmente sapeva: tanto che Carter ne sarebbe stato addirittura informato con un cablo che recava la frase «our boys did it» (lo han fatto i nostri ragazzi). Vero non vero, un portavoce del Dipartimento di Stato confermò che Washington era stata informata in anticipo e il bilancio di quel golpe fu l’annichilimento di partiti politici e organizzazioni sindacali. E’ di quel periodo del resto un commento di Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale durante la presidenza Carter dal 1977 al 1981: «Per la Turchia come per il Brasile – racconta lo storico svizzero Daniele Ganser in Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe – un governo militare sarebbe la soluzione migliore».
La lunga notte dei pronunciamenti militari turchi. Che una volta piacevano
 |
| Dal fez alla visiera |
In politica la memoria è sempre un buon esercizio. Tutti in effetti hanno riportato i colpi di Stato che hanno costellato la Turchia contemporanea ma non molti hanno ricordato chi allora, anziché stracciarsi le vesti, chiuse un occhio quando addirittura non aiutò più o meno direttamente la manina militare. Per venire a tempi più recenti si può ricordare l’apprezzatissimo golpe algerino (1992) dopo la vittoria islamista alle elezioni e, in tempi ancor più prossimi, il putsch di Al Sisi (2013), anche quello tutto sommato salutato con favore, come sa bene il nostro premier che, prima che il caso Regeni ci mettesse con l’Egitto ai ferri corti, salutò il generalissimo come «grande statista». Era in buona compagnia perché la condanna del golpe fu piuttosto freddina a livello internazionale. Appena più calorosa delle rimostranze per l’invasione saudita del Bahrein o della guerra dei Saud nello Yemen. Nel caso turco, la presa di distanza americana è invece arrivata subito, prima ancora che il golpe fosse concluso. Erdogan è tutto sommato una sorta di garanzia anche se la sua virata filorussa rischia di far aumentare l’allarme su un personaggio che, seppur eletto, sta ora facendo il golpe istituzionale che gli permette di far le pulizie di fino. Ci son sempre pesi e misure insomma. A seconda di cointesto e convenienze. E in passato?
Se adesso le cose sono un po’ confuse, quando nel maggio del 1960 la prima sollevazione militare scelse il generale Cemal Gürsel come presidente di un nuovo corso che doveva riportare ordine e stabilità, correvano gli anni della Guerra Fredda e non piaceva il primo ministro Adnan Menderes, fondatore di un Partito democratico di destra moderata che però aveva scelto di strizzare l’occhio a Mosca dove Menderes, con cui la Turchia era entrata nella Nato, aveva pianificato un viaggio in cerca di aiuti economici. I golpisti lo impiccarono e purgarono tribunali (centinaia di giudici) e università mettendo sotto arresto l’intera classe dirigente. Allora si pensò che era uno dei tanti golpe del Terzo mondo (secondo il Journal of Cold War Studies 357 tentativi con 183 successi tra il 1945 e il 1985) anche se quello turco avveniva in un Paese Nato.
Il cosiddetto “Golpe del memorandum” del 1971 avviene in un momento di grande turbolenza politica che ha ridato fiato alla sinistra turca. A differenza del golpe del 1960, animato da militari radicali diventati famosi per un pogrom anti greco a Istanbul, l’élite delle Forze armate che aveva organizzato il colpo del 1971 era violentemente anti comunista e si distinse per la repressione di ogni cosa che avesse a che fare con la sinistra. Inutile dire che quel colpo di Stato andava bene così. Il 12 settembre del 1980 arriva il terzo golpe. Anche lì c’è un’anima di destra che si esplicita in una repressione brutale e in una riduzione dell’intervento dello Stato in economia. Le carceri si riempiono di oppositori, 230 mila dei quali vengono processati. A cinquanta viene comminata la pena di morte, a 14mila viene ritirata la cittadinanza. Secondo la stampa curda c’era una sorta di lista di proscrizione con 1.683.000 nomi. A chi era piaciuta la mano pesante?
All’epoca reggeva la base operativa della Cia in Turchia Paul Henze, uno specialista della guerra psicologica, diventato famoso per un libro in cui sosteneva che dietro l’attentato a Papa Woytila ci fosse Mosca. Henze, già a capo della Cia in Etiopia e che se n’era andato da Ankara alla vigilia del golpe, ha negato, ma la Cia probabilmente sapeva: tanto che Carter ne sarebbe stato addirittura informato con un cablo che recava la frase «our boys did it» (lo han fatto i nostri ragazzi). Vero non vero, un portavoce del Dipartimento di Stato confermò che Washington era stata informata in anticipo e il bilancio di quel golpe fu l’annichilimento di partiti politici e organizzazioni sindacali. E’ di quel periodo del resto un commento di Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale durante la presidenza Carter dal 1977 al 1981: «Per la Turchia come per il Brasile – racconta lo storico svizzero Daniele Ganser in Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe – un governo militare sarebbe la soluzione migliore».
La lunga notte dei pronunciamenti militari turchi. Che una volta piacevano
 |
| Dal fez alla visiera |
In politica la memoria è sempre un buon esercizio. Tutti in effetti hanno riportato i colpi di Stato che hanno costellato la Turchia contemporanea ma non molti hanno ricordato chi allora, anziché stracciarsi le vesti, chiuse un occhio quando addirittura non aiutò più o meno direttamente la manina militare. Per venire a tempi più recenti si può ricordare l’apprezzatissimo golpe algerino (1992) dopo la vittoria islamista alle elezioni e, in tempi ancor più prossimi, il putsch di Al Sisi (2013), anche quello tutto sommato salutato con favore, come sa bene il nostro premier che, prima che il caso Regeni ci mettesse con l’Egitto ai ferri corti, salutò il generalissimo come «grande statista». Era in buona compagnia perché la condanna del golpe fu piuttosto freddina a livello internazionale. Appena più calorosa delle rimostranze per l’invasione saudita del Bahrein o della guerra dei Saud nello Yemen. Nel caso turco, la presa di distanza americana è invece arrivata subito, prima ancora che il golpe fosse concluso. Erdogan è tutto sommato una sorta di garanzia anche se la sua virata filorussa rischia di far aumentare l’allarme su un personaggio che, seppur eletto, sta ora facendo il golpe istituzionale che gli permette di far le pulizie di fino. Ci son sempre pesi e misure insomma. A seconda di cointesto e convenienze. E in passato?
Se adesso le cose sono un po’ confuse, quando nel maggio del 1960 la prima sollevazione militare scelse il generale Cemal Gürsel come presidente di un nuovo corso che doveva riportare ordine e stabilità, correvano gli anni della Guerra Fredda e non piaceva il primo ministro Adnan Menderes, fondatore di un Partito democratico di destra moderata che però aveva scelto di strizzare l’occhio a Mosca dove Menderes, con cui la Turchia era entrata nella Nato, aveva pianificato un viaggio in cerca di aiuti economici. I golpisti lo impiccarono e purgarono tribunali (centinaia di giudici) e università mettendo sotto arresto l’intera classe dirigente. Allora si pensò che era uno dei tanti golpe del Terzo mondo (secondo il Journal of Cold War Studies 357 tentativi con 183 successi tra il 1945 e il 1985) anche se quello turco avveniva in un Paese Nato.
Il cosiddetto “Golpe del memorandum” del 1971 avviene in un momento di grande turbolenza politica che ha ridato fiato alla sinistra turca. A differenza del golpe del 1960, animato da militari radicali diventati famosi per un pogrom anti greco a Istanbul, l’élite delle Forze armate che aveva organizzato il colpo del 1971 era violentemente anti comunista e si distinse per la repressione di ogni cosa che avesse a che fare con la sinistra. Inutile dire che quel colpo di Stato andava bene così. Il 12 settembre del 1980 arriva il terzo golpe. Anche lì c’è un’anima di destra che si esplicita in una repressione brutale e in una riduzione dell’intervento dello Stato in economia. Le carceri si riempiono di oppositori, 230 mila dei quali vengono processati. A cinquanta viene comminata la pena di morte, a 14mila viene ritirata la cittadinanza. Secondo la stampa curda c’era una sorta di lista di proscrizione con 1.683.000 nomi. A chi era piaciuta la mano pesante?
All’epoca reggeva la base operativa della Cia in Turchia Paul Henze, uno specialista della guerra psicologica, diventato famoso per un libro in cui sosteneva che dietro l’attentato a Papa Woytila ci fosse Mosca. Henze, già a capo della Cia in Etiopia e che se n’era andato da Ankara alla vigilia del golpe, ha negato, ma la Cia probabilmente sapeva: tanto che Carter ne sarebbe stato addirittura informato con un cablo che recava la frase «our boys did it» (lo han fatto i nostri ragazzi). Vero non vero, un portavoce del Dipartimento di Stato confermò che Washington era stata informata in anticipo e il bilancio di quel golpe fu l’annichilimento di partiti politici e organizzazioni sindacali. E’ di quel periodo del resto un commento di Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale durante la presidenza Carter dal 1977 al 1981: «Per la Turchia come per il Brasile – racconta lo storico svizzero Daniele Ganser in Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe – un governo militare sarebbe la soluzione migliore».
La lunga notte dei pronunciamenti militari turchi. Che una volta piacevano
 |
| Dal fez alla visiera |
In politica la memoria è sempre un buon esercizio. Tutti in effetti hanno riportato i colpi di Stato che hanno costellato la Turchia contemporanea ma non molti hanno ricordato chi allora, anziché stracciarsi le vesti, chiuse un occhio quando addirittura non aiutò più o meno direttamente la manina militare. Per venire a tempi più recenti si può ricordare l’apprezzatissimo golpe algerino (1992) dopo la vittoria islamista alle elezioni e, in tempi ancor più prossimi, il putsch di Al Sisi (2013), anche quello tutto sommato salutato con favore, come sa bene il nostro premier che, prima che il caso Regeni ci mettesse con l’Egitto ai ferri corti, salutò il generalissimo come «grande statista». Era in buona compagnia perché la condanna del golpe fu piuttosto freddina a livello internazionale. Appena più calorosa delle rimostranze per l’invasione saudita del Bahrein o della guerra dei Saud nello Yemen. Nel caso turco, la presa di distanza americana è invece arrivata subito, prima ancora che il golpe fosse concluso. Erdogan è tutto sommato una sorta di garanzia anche se la sua virata filorussa rischia di far aumentare l’allarme su un personaggio che, seppur eletto, sta ora facendo il golpe istituzionale che gli permette di far le pulizie di fino. Ci son sempre pesi e misure insomma. A seconda di cointesto e convenienze. E in passato?
Se adesso le cose sono un po’ confuse, quando nel maggio del 1960 la prima sollevazione militare scelse il generale Cemal Gürsel come presidente di un nuovo corso che doveva riportare ordine e stabilità, correvano gli anni della Guerra Fredda e non piaceva il primo ministro Adnan Menderes, fondatore di un Partito democratico di destra moderata che però aveva scelto di strizzare l’occhio a Mosca dove Menderes, con cui la Turchia era entrata nella Nato, aveva pianificato un viaggio in cerca di aiuti economici. I golpisti lo impiccarono e purgarono tribunali (centinaia di giudici) e università mettendo sotto arresto l’intera classe dirigente. Allora si pensò che era uno dei tanti golpe del Terzo mondo (secondo il Journal of Cold War Studies 357 tentativi con 183 successi tra il 1945 e il 1985) anche se quello turco avveniva in un Paese Nato.
Il cosiddetto “Golpe del memorandum” del 1971 avviene in un momento di grande turbolenza politica che ha ridato fiato alla sinistra turca. A differenza del golpe del 1960, animato da militari radicali diventati famosi per un pogrom anti greco a Istanbul, l’élite delle Forze armate che aveva organizzato il colpo del 1971 era violentemente anti comunista e si distinse per la repressione di ogni cosa che avesse a che fare con la sinistra. Inutile dire che quel colpo di Stato andava bene così. Il 12 settembre del 1980 arriva il terzo golpe. Anche lì c’è un’anima di destra che si esplicita in una repressione brutale e in una riduzione dell’intervento dello Stato in economia. Le carceri si riempiono di oppositori, 230 mila dei quali vengono processati. A cinquanta viene comminata la pena di morte, a 14mila viene ritirata la cittadinanza. Secondo la stampa curda c’era una sorta di lista di proscrizione con 1.683.000 nomi. A chi era piaciuta la mano pesante?
All’epoca reggeva la base operativa della Cia in Turchia Paul Henze, uno specialista della guerra psicologica, diventato famoso per un libro in cui sosteneva che dietro l’attentato a Papa Woytila ci fosse Mosca. Henze, già a capo della Cia in Etiopia e che se n’era andato da Ankara alla vigilia del golpe, ha negato, ma la Cia probabilmente sapeva: tanto che Carter ne sarebbe stato addirittura informato con un cablo che recava la frase «our boys did it» (lo han fatto i nostri ragazzi). Vero non vero, un portavoce del Dipartimento di Stato confermò che Washington era stata informata in anticipo e il bilancio di quel golpe fu l’annichilimento di partiti politici e organizzazioni sindacali. E’ di quel periodo del resto un commento di Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale durante la presidenza Carter dal 1977 al 1981: «Per la Turchia come per il Brasile – racconta lo storico svizzero Daniele Ganser in Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe – un governo militare sarebbe la soluzione migliore».
Un intrigo tra Australia e Palestina
 C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
 Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
 Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
L‘intrigo non è dunque solo nel disvelamento di una personalità occulta e in un progetto ossessivo che si nutre di ricerche d’archivio, ritagli di giornali, rare conversazioni con un gruppo di amici, ma l’intreccio in cui si muovono i protagonisti. Tra agenti del Mossad e dei servizi britannici e australiani, assassini sotto falso nome, cacciatori e cacciati, si snoda una storia che ci porta dall’immensa Australia alla piccolissima comunità templare immersa nel pasticcio mediorientale in un reticolo di connivenze, falsità, speculazioni politiche che restituisce, nella finzione, un pezzo di verità. La cifra stilistica è quella del buon giornalista che, senza troppi aggettivi e manierismi, vi trasferisce nel cuore della Storia con la S maiuscola fatta di tante storie minori come quella dell’orologiaio di Melbourne e dei suoi incubi: «Non bisogna criminalizzare un’intera comunità, ripeteva sempre Felix, ma così come molti in Italia scelsero il fascismo arrivando fino all’ultimo rigurgito di Salò, centinaia di templari in Palestina furono i primi tedeschi residenti fuori dalla Germania a mettersi in fila per prendere la tessera del partito di Hitler. E tra gli ultimi a buttarla via».
Un intrigo tra Australia e Palestina
 C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
 Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
 Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
L‘intrigo non è dunque solo nel disvelamento di una personalità occulta e in un progetto ossessivo che si nutre di ricerche d’archivio, ritagli di giornali, rare conversazioni con un gruppo di amici, ma l’intreccio in cui si muovono i protagonisti. Tra agenti del Mossad e dei servizi britannici e australiani, assassini sotto falso nome, cacciatori e cacciati, si snoda una storia che ci porta dall’immensa Australia alla piccolissima comunità templare immersa nel pasticcio mediorientale in un reticolo di connivenze, falsità, speculazioni politiche che restituisce, nella finzione, un pezzo di verità. La cifra stilistica è quella del buon giornalista che, senza troppi aggettivi e manierismi, vi trasferisce nel cuore della Storia con la S maiuscola fatta di tante storie minori come quella dell’orologiaio di Melbourne e dei suoi incubi: «Non bisogna criminalizzare un’intera comunità, ripeteva sempre Felix, ma così come molti in Italia scelsero il fascismo arrivando fino all’ultimo rigurgito di Salò, centinaia di templari in Palestina furono i primi tedeschi residenti fuori dalla Germania a mettersi in fila per prendere la tessera del partito di Hitler. E tra gli ultimi a buttarla via».
Un intrigo tra Australia e Palestina
 C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
 Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
 Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
L‘intrigo non è dunque solo nel disvelamento di una personalità occulta e in un progetto ossessivo che si nutre di ricerche d’archivio, ritagli di giornali, rare conversazioni con un gruppo di amici, ma l’intreccio in cui si muovono i protagonisti. Tra agenti del Mossad e dei servizi britannici e australiani, assassini sotto falso nome, cacciatori e cacciati, si snoda una storia che ci porta dall’immensa Australia alla piccolissima comunità templare immersa nel pasticcio mediorientale in un reticolo di connivenze, falsità, speculazioni politiche che restituisce, nella finzione, un pezzo di verità. La cifra stilistica è quella del buon giornalista che, senza troppi aggettivi e manierismi, vi trasferisce nel cuore della Storia con la S maiuscola fatta di tante storie minori come quella dell’orologiaio di Melbourne e dei suoi incubi: «Non bisogna criminalizzare un’intera comunità, ripeteva sempre Felix, ma così come molti in Italia scelsero il fascismo arrivando fino all’ultimo rigurgito di Salò, centinaia di templari in Palestina furono i primi tedeschi residenti fuori dalla Germania a mettersi in fila per prendere la tessera del partito di Hitler. E tra gli ultimi a buttarla via».
Un intrigo tra Australia e Palestina
 C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
C’è una località di Tel Aviv che si chiama Colonia Tedesca e che è una meta turistica abbastanza nota: case in pietra con tetti spioventi e il richiamo a uno stile immediatamente identificabile. Non è l’unico luogo di Israele con un’architettura simile. La colonia dei Templari tedeschi era stata fondata in diverse città della Palestina nel 1869 da una gruppo di cristiani convinti che Cristo sarebbe tornato nelle terre d’origine e che il terreno andava preparato. In realtà i nuovi templari prepararono il terreno a qualcos’altro. Negli anni Trenta, con l’ascesa del nazionalsocialismo, le idee di Hitler cominciarono a diffondersi anche fuori dalla Germania e già nel 1931 era stata creata la Nsdap/Ao, un organismo del partito che coordinava gli iscritti al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap) che risiedevano fuori dai confini patrii (Auslands Organisation). I templari di Palestina, fino a quel momento una pacifica comunità millenarista, strizzarono l’occhio alle promesse del Führer e alle sue teorie. La storia è poco conosciuta quanto efferata. Cominciarono ad appendere bandiere nazi alle loro finestre e a sventolarle dalle automobili e promulgarono una serie di editti che comprendevano il saluto nazista e una sorta di divieto a fare affari con gli ebrei. Ci fu chi si limitò al braccio teso e un’adesione ideologica, chi invece prese sul serio l’idea che gli ebrei dovessero sparire dalla faccia della terra. In un romanzo che ha il sapore del giallo, il giornalista e scrittore Eric Salerno, molti anni in Israele come corrispondente del Messaggero, ricostruisce questo pezzo di Storia minore utilizzando uno scenario ancora più lontano: l’Australia.
 Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
Intrigo, da poco uscito per Il Saggiatore, è ambientato a Melbourne dove un orologiaio di nome Felix, che aveva combattuto come partigiano i nazisti in Europa orientale e aveva poi scelto l’ospitalità offerta dall’Australia, vive un’esistenza monotona osservando le impercettibili movenze degli orologi che ripara nella sua piccola bottega. Sembra un uomo tranquillo e in pace con se stesso, ma in realtà Felix è ossessionato da un desiderio di vendetta. L’Australia poi, apparentemente ospitale con gli ebrei dopo la caduta del nazismo, si è rivelata un Paese dove a loro è toccato finire in un nuovo ghetto: non di mura e recinti ma costruito dall’isolamento psicologico verso un gruppo di persone da cui diffidar. Ritenute “pericolose” per via della provenienza di molti fra loro dalle truppe partigiane. La civile Australia, che guarda con sospetto i nuovi arrivati, è invece decisamente più aperta ad altri immigrati dall’Europa: tedeschi, magari con qualche neo sulla coscienza. Magari con un passato da sterminatori. Ma certamente anticomunisti.
 Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
Salerno a destra nell’immagine) , utilizzando la sua conoscenza di Israele, ma andando in realtà a ripescare anche qualche elemento tra le vicende di famiglia (di cui molto ha già scritto ell’autobiografico Rossi a Manhattan), racconta i particolari di una vicenda che non si esaurisce nell’Olocausto e nella vittoria sul nazismo ma che si addentra in quelle vicende infinite che, dopo la seconda Guerra mondiale, videro la caccia ai nazisti che si erano nascosti, grazie ad amicizie importanti e ai buoni uffici dei servizi segreti, in diverse parti del mondo, dal Sudamerica all’Australia. E’ un pezzo di storia ancora poco raccontato e che si presta perfettamente alla trama del giallo che svela solo nelle ultime battute del libro la seconda personalità di Felix. Un uomo tranquillo che lavorava ai suoi orologi mettendo assieme un meccanismo altrettanto raffinato e complesso per rimettere al loro posto le pedine sulla scacchiera della giustizia.
L‘intrigo non è dunque solo nel disvelamento di una personalità occulta e in un progetto ossessivo che si nutre di ricerche d’archivio, ritagli di giornali, rare conversazioni con un gruppo di amici, ma l’intreccio in cui si muovono i protagonisti. Tra agenti del Mossad e dei servizi britannici e australiani, assassini sotto falso nome, cacciatori e cacciati, si snoda una storia che ci porta dall’immensa Australia alla piccolissima comunità templare immersa nel pasticcio mediorientale in un reticolo di connivenze, falsità, speculazioni politiche che restituisce, nella finzione, un pezzo di verità. La cifra stilistica è quella del buon giornalista che, senza troppi aggettivi e manierismi, vi trasferisce nel cuore della Storia con la S maiuscola fatta di tante storie minori come quella dell’orologiaio di Melbourne e dei suoi incubi: «Non bisogna criminalizzare un’intera comunità, ripeteva sempre Felix, ma così come molti in Italia scelsero il fascismo arrivando fino all’ultimo rigurgito di Salò, centinaia di templari in Palestina furono i primi tedeschi residenti fuori dalla Germania a mettersi in fila per prendere la tessera del partito di Hitler. E tra gli ultimi a buttarla via».
Addio a Qandeel Baloch, l’eroina dei social che sta aiutando a cancellare il delitto d’onore
 |
| Qandeel Baloch in una foto tratta dal quotidiano Dawn |
Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, era una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il suo corpo, le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confresso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei genitori a Multan. Delitto d’onore si è subito detto. E Baloch ha conosciuto una fine non molto diversa da quella che subiscono tante coetanee che, per motivi d’onore, sono state uccise dalla famiglia o dai fidanzati. Sono 500 ogni anno in Pakistan le persone uccise, per la maggior parte donne. L’Italia, è bene ricordarlo, abolì la legge che giustificava il delitto d’onore solo nel 1981 e le donne comunque continuano a morire anche se non allo stesso ritmo del Pakistan (che è però assai più popoloso del Belpaese). Ma la sua morte ha lasciato un segno profondo a differenza di tante anonime coetanee meno famose di lei. La notorietà del personaggio infatti, per la quale persino qualche mullah aveva espresso simpatia, ha sollevato un putiferio e rilanciato dibattiti e polemiche sulla questione. E c’è anche stato un passo ufficiale: oggi, a un paio di giorni dalla morte della giovane star dei social, il governo del Punjab (che già ha una legge provinciale più avanzata che nel resto del Paese) ha vietato alla famiglia di “perdonare” il figliolo omicida, una mossa che apre la strada in tribunale a pene minori. Qandeel Baloch però non c’è più. Le sia lieve il viaggio nell’ignoto.
Addio a Qandeel Baloch, l’eroina dei social che sta aiutando a cancellare il delitto d’onore
 |
| Qandeel Baloch in una foto tratta dal quotidiano Dawn |
Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, era una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il suo corpo, le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confresso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei genitori a Multan. Delitto d’onore si è subito detto. E Baloch ha conosciuto una fine non molto diversa da quella che subiscono tante coetanee che, per motivi d’onore, sono state uccise dalla famiglia o dai fidanzati. Sono 500 ogni anno in Pakistan le persone uccise, per la maggior parte donne. L’Italia, è bene ricordarlo, abolì la legge che giustificava il delitto d’onore solo nel 1981 e le donne comunque continuano a morire anche se non allo stesso ritmo del Pakistan (che è però assai più popoloso del Belpaese). Ma la sua morte ha lasciato un segno profondo a differenza di tante anonime coetanee meno famose di lei. La notorietà del personaggio infatti, per la quale persino qualche mullah aveva espresso simpatia, ha sollevato un putiferio e rilanciato dibattiti e polemiche sulla questione. E c’è anche stato un passo ufficiale: oggi, a un paio di giorni dalla morte della giovane star dei social, il governo del Punjab (che già ha una legge provinciale più avanzata che nel resto del Paese) ha vietato alla famiglia di “perdonare” il figliolo omicida, una mossa che apre la strada in tribunale a pene minori. Qandeel Baloch però non c’è più. Le sia lieve il viaggio nell’ignoto.
Addio a Qandeel Baloch, l’eroina dei social che sta aiutando a cancellare il delitto d’onore
 |
| Qandeel Baloch in una foto tratta dal quotidiano Dawn |
Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, era una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il suo corpo, le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confresso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei genitori a Multan. Delitto d’onore si è subito detto. E Baloch ha conosciuto una fine non molto diversa da quella che subiscono tante coetanee che, per motivi d’onore, sono state uccise dalla famiglia o dai fidanzati. Sono 500 ogni anno in Pakistan le persone uccise, per la maggior parte donne. L’Italia, è bene ricordarlo, abolì la legge che giustificava il delitto d’onore solo nel 1981 e le donne comunque continuano a morire anche se non allo stesso ritmo del Pakistan (che è però assai più popoloso del Belpaese). Ma la sua morte ha lasciato un segno profondo a differenza di tante anonime coetanee meno famose di lei. La notorietà del personaggio infatti, per la quale persino qualche mullah aveva espresso simpatia, ha sollevato un putiferio e rilanciato dibattiti e polemiche sulla questione. E c’è anche stato un passo ufficiale: oggi, a un paio di giorni dalla morte della giovane star dei social, il governo del Punjab (che già ha una legge provinciale più avanzata che nel resto del Paese) ha vietato alla famiglia di “perdonare” il figliolo omicida, una mossa che apre la strada in tribunale a pene minori. Qandeel Baloch però non c’è più. Le sia lieve il viaggio nell’ignoto.
Addio a Qandeel Baloch, l’eroina dei social che sta aiutando a cancellare il delitto d’onore
 |
| Qandeel Baloch in una foto tratta dal quotidiano Dawn |
Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, era una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il suo corpo, le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confresso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei genitori a Multan. Delitto d’onore si è subito detto. E Baloch ha conosciuto una fine non molto diversa da quella che subiscono tante coetanee che, per motivi d’onore, sono state uccise dalla famiglia o dai fidanzati. Sono 500 ogni anno in Pakistan le persone uccise, per la maggior parte donne. L’Italia, è bene ricordarlo, abolì la legge che giustificava il delitto d’onore solo nel 1981 e le donne comunque continuano a morire anche se non allo stesso ritmo del Pakistan (che è però assai più popoloso del Belpaese). Ma la sua morte ha lasciato un segno profondo a differenza di tante anonime coetanee meno famose di lei. La notorietà del personaggio infatti, per la quale persino qualche mullah aveva espresso simpatia, ha sollevato un putiferio e rilanciato dibattiti e polemiche sulla questione. E c’è anche stato un passo ufficiale: oggi, a un paio di giorni dalla morte della giovane star dei social, il governo del Punjab (che già ha una legge provinciale più avanzata che nel resto del Paese) ha vietato alla famiglia di “perdonare” il figliolo omicida, una mossa che apre la strada in tribunale a pene minori. Qandeel Baloch però non c’è più. Le sia lieve il viaggio nell’ignoto.
I golpe turchi con due pesi diversi sulla bilancia
La mia prima volta in Turchia – correvano i favolosi Settanta – fu durante un colpo di Stato militare. Nonostante ciò i turisti, anche con coda di cavallo o capelli alla presbitero, erano ben accetti. Ci si arrivava peraltro da un Paese, la Grecia, sotto la dittatura dei colonnelli del 21 aprile. Era il mondo spensierato dei golpe militari che venivano condotti col beneplacito internazionale che non solo lasciava fare ma semmai dava una mano. A veder oggi la reazione di Obama durante il golpe e prima che si concludesse, viene da pensare che siamo un passo avanti. E che oggi i golpe non si usano più per rovesciare governi democraticamente eletti. Ma non è esattamente così. Mi viene in mente quel generale egiziano che un paio di anni fa ha desautorato un presidente democraticamente eletto. Un signore nel cui Paese la tortura è un’attività sistematica dell’intelligence, cosa che era conosciuta ben prima del suo autoinsediamento poi benedette dalle urne. Allora però le reazioni furono assai più tiepide, per usare un eufemismo, quando non velatamente soddisfatte. Solo anni dopo – e dopo il caso di Giulio Regeni, dei giornalisti di Al Jazeera, delle condanne a morte, dei rapporti di Amnesty etc – il mondo si è accorto che una dittatura militare è sempre e comunque una cattiva scelta. Se vado ancora più indietro, ma nemmen di tanto, mi viene in mente l’Algeria e le elezioni vinte dal Fis e i carriarmati subito dopo nelle strade. Ero allora un giovane reporter ma fu la prima volta che ragionai davvero sulle parole democrazia e dittatura senza troppa ideologia ma con sano pragmatismo. Mi convinsi che i militari avevano sbagliato. Allora come oggi.
Detto questo è un bene dunque che sia andata com’è andata anche se ora dovremmo fare pressione sulla Turchia perché non applichi la pena di morte e dia garanzie agli arrestati. Tocca a noi cittadini e tocca ai nostri ministeri degli Esteri. Il golpe è una cattiva notizia ma Erdogan lo è già da un pezzo.
Quanto al golpe degli anni Settanta, ricordo un particolare. Uscimmo nella notte dall’ostello di Balikesir dove dormivamo in camerata. Uscimmo, io e il fido Enrico detto Henry, badando che il guardiano non ci vedesse per via del coprifuoco. Nella città semideserta fumammo per la prima volta il narghilè in un posticino ancora aperto. Poi ci rendemmo conto che non potevamo più rientrare nel nostro alberghetto pena frustate e reprimende e dunque vagammo nella notte fino all’alba stupefatti come bambini dalla bellezza incantata della città tutta in legno che stava sopra Sultan Ahmet e che ora non esiste quasi più. Che poteva farci il golpe a noi bianchi turisti italiani? In realtà fu pura incoscienza e per grazia divina il sogno non divenne un incubo. Come sa bene chi -vedi Cile – turista o meno, bianco o nero, incappava – anche solo per puro caso – nel maglio repressivo dei militari.
I golpe turchi con due pesi diversi sulla bilancia
La mia prima volta in Turchia – correvano i favolosi Settanta – fu durante un colpo di Stato militare. Nonostante ciò i turisti, anche con coda di cavallo o capelli alla presbitero, erano ben accetti. Ci si arrivava peraltro da un Paese, la Grecia, sotto la dittatura dei colonnelli del 21 aprile. Era il mondo spensierato dei golpe militari che venivano condotti col beneplacito internazionale che non solo lasciava fare ma semmai dava una mano. A veder oggi la reazione di Obama durante il golpe e prima che si concludesse, viene da pensare che siamo un passo avanti. E che oggi i golpe non si usano più per rovesciare governi democraticamente eletti. Ma non è esattamente così. Mi viene in mente quel generale egiziano che un paio di anni fa ha desautorato un presidente democraticamente eletto. Un signore nel cui Paese la tortura è un’attività sistematica dell’intelligence, cosa che era conosciuta ben prima del suo autoinsediamento poi benedette dalle urne. Allora però le reazioni furono assai più tiepide, per usare un eufemismo, quando non velatamente soddisfatte. Solo anni dopo – e dopo il caso di Giulio Regeni, dei giornalisti di Al Jazeera, delle condanne a morte, dei rapporti di Amnesty etc – il mondo si è accorto che una dittatura militare è sempre e comunque una cattiva scelta. Se vado ancora più indietro, ma nemmen di tanto, mi viene in mente l’Algeria e le elezioni vinte dal Fis e i carriarmati subito dopo nelle strade. Ero allora un giovane reporter ma fu la prima volta che ragionai davvero sulle parole democrazia e dittatura senza troppa ideologia ma con sano pragmatismo. Mi convinsi che i militari avevano sbagliato. Allora come oggi.
Detto questo è un bene dunque che sia andata com’è andata anche se ora dovremmo fare pressione sulla Turchia perché non applichi la pena di morte e dia garanzie agli arrestati. Tocca a noi cittadini e tocca ai nostri ministeri degli Esteri. Il golpe è una cattiva notizia ma Erdogan lo è già da un pezzo.
Quanto al golpe degli anni Settanta, ricordo un particolare. Uscimmo nella notte dall’ostello di Balikesir dove dormivamo in camerata. Uscimmo, io e il fido Enrico detto Henry, badando che il guardiano non ci vedesse per via del coprifuoco. Nella città semideserta fumammo per la prima volta il narghilè in un posticino ancora aperto. Poi ci rendemmo conto che non potevamo più rientrare nel nostro alberghetto pena frustate e reprimende e dunque vagammo nella notte fino all’alba stupefatti come bambini dalla bellezza incantata della città tutta in legno che stava sopra Sultan Ahmet e che ora non esiste quasi più. Che poteva farci il golpe a noi bianchi turisti italiani? In realtà fu pura incoscienza e per grazia divina il sogno non divenne un incubo. Come sa bene chi -vedi Cile – turista o meno, bianco o nero, incappava – anche solo per puro caso – nel maglio repressivo dei militari.
I golpe turchi con due pesi diversi sulla bilancia
La mia prima volta in Turchia – correvano i favolosi Settanta – fu durante un colpo di Stato militare. Nonostante ciò i turisti, anche con coda di cavallo o capelli alla presbitero, erano ben accetti. Ci si arrivava peraltro da un Paese, la Grecia, sotto la dittatura dei colonnelli del 21 aprile. Era il mondo spensierato dei golpe militari che venivano condotti col beneplacito internazionale che non solo lasciava fare ma semmai dava una mano. A veder oggi la reazione di Obama durante il golpe e prima che si concludesse, viene da pensare che siamo un passo avanti. E che oggi i golpe non si usano più per rovesciare governi democraticamente eletti. Ma non è esattamente così. Mi viene in mente quel generale egiziano che un paio di anni fa ha desautorato un presidente democraticamente eletto. Un signore nel cui Paese la tortura è un’attività sistematica dell’intelligence, cosa che era conosciuta ben prima del suo autoinsediamento poi benedette dalle urne. Allora però le reazioni furono assai più tiepide, per usare un eufemismo, quando non velatamente soddisfatte. Solo anni dopo – e dopo il caso di Giulio Regeni, dei giornalisti di Al Jazeera, delle condanne a morte, dei rapporti di Amnesty etc – il mondo si è accorto che una dittatura militare è sempre e comunque una cattiva scelta. Se vado ancora più indietro, ma nemmen di tanto, mi viene in mente l’Algeria e le elezioni vinte dal Fis e i carriarmati subito dopo nelle strade. Ero allora un giovane reporter ma fu la prima volta che ragionai davvero sulle parole democrazia e dittatura senza troppa ideologia ma con sano pragmatismo. Mi convinsi che i militari avevano sbagliato. Allora come oggi.
Detto questo è un bene dunque che sia andata com’è andata anche se ora dovremmo fare pressione sulla Turchia perché non applichi la pena di morte e dia garanzie agli arrestati. Tocca a noi cittadini e tocca ai nostri ministeri degli Esteri. Il golpe è una cattiva notizia ma Erdogan lo è già da un pezzo.
Quanto al golpe degli anni Settanta, ricordo un particolare. Uscimmo nella notte dall’ostello di Balikesir dove dormivamo in camerata. Uscimmo, io e il fido Enrico detto Henry, badando che il guardiano non ci vedesse per via del coprifuoco. Nella città semideserta fumammo per la prima volta il narghilè in un posticino ancora aperto. Poi ci rendemmo conto che non potevamo più rientrare nel nostro alberghetto pena frustate e reprimende e dunque vagammo nella notte fino all’alba stupefatti come bambini dalla bellezza incantata della città tutta in legno che stava sopra Sultan Ahmet e che ora non esiste quasi più. Che poteva farci il golpe a noi bianchi turisti italiani? In realtà fu pura incoscienza e per grazia divina il sogno non divenne un incubo. Come sa bene chi -vedi Cile – turista o meno, bianco o nero, incappava – anche solo per puro caso – nel maglio repressivo dei militari.
I golpe turchi con due pesi diversi sulla bilancia
La mia prima volta in Turchia – correvano i favolosi Settanta – fu durante un colpo di Stato militare. Nonostante ciò i turisti, anche con coda di cavallo o capelli alla presbitero, erano ben accetti. Ci si arrivava peraltro da un Paese, la Grecia, sotto la dittatura dei colonnelli del 21 aprile. Era il mondo spensierato dei golpe militari che venivano condotti col beneplacito internazionale che non solo lasciava fare ma semmai dava una mano. A veder oggi la reazione di Obama durante il golpe e prima che si concludesse, viene da pensare che siamo un passo avanti. E che oggi i golpe non si usano più per rovesciare governi democraticamente eletti. Ma non è esattamente così. Mi viene in mente quel generale egiziano che un paio di anni fa ha desautorato un presidente democraticamente eletto. Un signore nel cui Paese la tortura è un’attività sistematica dell’intelligence, cosa che era conosciuta ben prima del suo autoinsediamento poi benedette dalle urne. Allora però le reazioni furono assai più tiepide, per usare un eufemismo, quando non velatamente soddisfatte. Solo anni dopo – e dopo il caso di Giulio Regeni, dei giornalisti di Al Jazeera, delle condanne a morte, dei rapporti di Amnesty etc – il mondo si è accorto che una dittatura militare è sempre e comunque una cattiva scelta. Se vado ancora più indietro, ma nemmen di tanto, mi viene in mente l’Algeria e le elezioni vinte dal Fis e i carriarmati subito dopo nelle strade. Ero allora un giovane reporter ma fu la prima volta che ragionai davvero sulle parole democrazia e dittatura senza troppa ideologia ma con sano pragmatismo. Mi convinsi che i militari avevano sbagliato. Allora come oggi.
Detto questo è un bene dunque che sia andata com’è andata anche se ora dovremmo fare pressione sulla Turchia perché non applichi la pena di morte e dia garanzie agli arrestati. Tocca a noi cittadini e tocca ai nostri ministeri degli Esteri. Il golpe è una cattiva notizia ma Erdogan lo è già da un pezzo.
Quanto al golpe degli anni Settanta, ricordo un particolare. Uscimmo nella notte dall’ostello di Balikesir dove dormivamo in camerata. Uscimmo, io e il fido Enrico detto Henry, badando che il guardiano non ci vedesse per via del coprifuoco. Nella città semideserta fumammo per la prima volta il narghilè in un posticino ancora aperto. Poi ci rendemmo conto che non potevamo più rientrare nel nostro alberghetto pena frustate e reprimende e dunque vagammo nella notte fino all’alba stupefatti come bambini dalla bellezza incantata della città tutta in legno che stava sopra Sultan Ahmet e che ora non esiste quasi più. Che poteva farci il golpe a noi bianchi turisti italiani? In realtà fu pura incoscienza e per grazia divina il sogno non divenne un incubo. Come sa bene chi -vedi Cile – turista o meno, bianco o nero, incappava – anche solo per puro caso – nel maglio repressivo dei militari.
Afghanistan: esequie di Stato per il processo di pace
 |
| Arthur Conolly: finì ucciso dall’emiro di Bukhara |
Dopo che Obama ha deciso di rallentare l’uscita delle truppe americane dall’Afghanistan, la Nato ha reiterato il prolungamento della sua missione oltre il 2016 e il governo di Kabul ha spiegato che non ha alcuna intenzione di rivitalizzare il processo di pace, lo stallo è più che evidente. Qui di seguito un’analisi* che cerca di fare il punto della situazione
——————-
Com’è noto la locuzione “Grande Gioco” – Great Game – si deve al britannico Arthur Conolly. Era uno dei tanti esploratori, diplomatici, spie al servizio di Sua Maestà britannica e aveva dato questo nome all’intrigo che dal 1800 aveva opposto soprattutto britannici e russi, ma anche francesi, persiani, afgani, circassi o turcmeni, che durante due secoli si erano combattuti, spiati, alleati e traditi in vista della grande posta in gioco: la conquista, o la conservazione della conquista, dell’India e, in molti casi, della propria indipendenza dalle mire russe o britanniche in Asia. Quello che in tempi recenti è stato chiamato Nuovo Grande Gioco sembra assomigliare alla primigenia edizione, benché la posta in gioco sia ovviamente mutata e così le tecniche per raggiungerla, ma mai come oggi sembra più appropriato il termine che aveva scelto un ministro dello Zar per descrivere quella guerra prolungata e non sempre guerreggiata senza esclusione di colpi: torneo delle ombre. Oggi come allora si agitano infatti, sullo sfondo del conflitto afgano, delle violenze in Pakistan, dei sommovimenti nel Caucaso, in Tagikistan, in Uzbekistan o nel Turkestan cinese, protagonisti e comprimari spesso in ombra assai più che tra l’800 e il 900. Sicuramente il campo di battaglia primario resta l’Afghanistan, ed è su questo campo di battaglia che porremo la nostra attenzione ma senza dimenticare le ombre che lo circondano. Metteremo assieme qualche idea e molte domande senza aver la pretesa di indicare risposte ma cercando di mettere in fila alcuni interrogativi che, oggi come allora, coinvolgono le grandi potenze regionali, gli Stati confinanti dal Caspio alla Cina, e le superpotenze che, adesso come un tempo, sono interessate al controllo di questo pietroso Paese senza sbocco al mare, quasi privo di gas e petrolio e con ricchezze minerarie ancora poco esplorate e comunque di difficile estrazione. Porremo la nostra attenzione soprattutto sull’Afghanistan per un semplicissimo motivo: la guerra – o la stagione di conflitto perenne iniziata con l’invasione sovietica del 1979 (quasi quarant’anni fa) – è ben lungi dall’esser terminata e assiste anzi a una ripresa che, solo in termini di vite umane, è diventata più esigente da quando la missione Isaf Nato si è ritirata – sostituita dalla più mite missione dell’Alleanza “Resolute Support” – nel dicembre 2014. Il fatto che la guerra afgana sia uscita dai riflettori della cronaca è solo – se mai ce ne fosse bisogno – l’indicazione che – per citare un vecchio adagio pacifista – la prima vittima della guerra è la verità. La guerra infatti non è affatto finita e gode anzi – ci si perdoni l’iperbole – di ottima salute.
 |
| La Nato ha appena deciso che la sua missione andrà oltre il 2016 con circa 1200 uomini |
Il Paese è un crocevia naturale sia delle assi commerciali Est Ovest Nord Sud sia per la posizione strategica per il passaggio di gasdotti e oleodotti. Cina e India sembrano i Paesi più interessati alla fine della turbolenza afgana di cui beneficerebbero però anche la Russia e i Paesi centroasiatici molti dei quali hanno già firmato con Kabul accordi per il passaggio dei tubi, affare cui sono interessate anche aziende occidentali (e italiane). Il Pakistan rappresenta un caso a parte ma si potrebbe ritenere che non sia più interessato a un’Afghanistan destabilizzato, a patto che un governo stabile a Kabul non sia anti pachistano. Infine il Paese è ricco di terre rare e minerali anche se di difficile estrazione. I cinesi hanno già firmato contratti importanti e stanno sviluppando una direttrice viaria che dal corridoio di Wakan, che confina con la Cina, raggiungerebbe Kabul via Panjshir.
 |
| Il classico di Peter Hopkirk |
Kabul è ossessionata dalla convinzione che ogni male si debba al Pakistan reo di ospitare, finanziare, allevare talebani. Ha scelto di fare la stessa cosa sul suo territorio coi talebani pachistani, i guerriglieri anti Islamabad al di là della frontiera (“cugini” dei fratelli afgani ma più violenti e brutali), ripagando il Pakistan con la sua stessa moneta. E’ interessante notare che appena i due Paesi si riavvicinano (sia il presidente Ghani, sia il premier pachistano Nawaz Sharif sono “aperturisti”) succede qualcosa che li allontana (di solito una strage non sempre rivendicata o incidenti alla frontiera). I rapporti sono sempre tesi sia per le controversie di confine o sui dazi commerciali, sia per la gestione dei rispettivi profughi (il Pakistan ospita circa un milione e mezzo di afgani, Kabul deve gestire una fuga massiccia di profughi dal Waziristan pachistano messo a ferro e fuoco da due anni dall’esercito del Paese dei puri). Kabul per ora non sembra il fautore di una politica di aperture e riconciliazioni. L’ultima invenzione, abortita dopo gli ultimi attacchi stragisti talebani soprattutto nella capitale, è stata la nascita di un comitato quadrilaterale con Afghanistan, Pakistan, Stati Uniti e Cina. Una buona idea coinvolgere la Cina e forse una buona idea cominciare da 4 e non da 8 o 10 (anche se in effetti non ha molto senso lasciar fuori Teheran, Riad, Delhi e persino Mosca), ma comunque una scelta di sola cornice per accompagnare un processo negoziale per ora abortito. E’ probabile che la Quadrilaterale, decisa a Kabul, sia stata pensata a Washington ma un tavolo negoziale senza il nemico non è un tavolo negoziale. Se poi il probabile principale negoziatore è stato ucciso…
Afghanistan: esequie di Stato per il processo di pace
 |
| Arthur Conolly: finì ucciso dall’emiro di Bukhara |
Dopo che Obama ha deciso di rallentare l’uscita delle truppe americane dall’Afghanistan, la Nato ha reiterato il prolungamento della sua missione oltre il 2016 e il governo di Kabul ha spiegato che non ha alcuna intenzione di rivitalizzare il processo di pace, lo stallo è più che evidente. Qui di seguito un’analisi* che cerca di fare il punto della situazione
——————-
Com’è noto la locuzione “Grande Gioco” – Great Game – si deve al britannico Arthur Conolly. Era uno dei tanti esploratori, diplomatici, spie al servizio di Sua Maestà britannica e aveva dato questo nome all’intrigo che dal 1800 aveva opposto soprattutto britannici e russi, ma anche francesi, persiani, afgani, circassi o turcmeni, che durante due secoli si erano combattuti, spiati, alleati e traditi in vista della grande posta in gioco: la conquista, o la conservazione della conquista, dell’India e, in molti casi, della propria indipendenza dalle mire russe o britanniche in Asia. Quello che in tempi recenti è stato chiamato Nuovo Grande Gioco sembra assomigliare alla primigenia edizione, benché la posta in gioco sia ovviamente mutata e così le tecniche per raggiungerla, ma mai come oggi sembra più appropriato il termine che aveva scelto un ministro dello Zar per descrivere quella guerra prolungata e non sempre guerreggiata senza esclusione di colpi: torneo delle ombre. Oggi come allora si agitano infatti, sullo sfondo del conflitto afgano, delle violenze in Pakistan, dei sommovimenti nel Caucaso, in Tagikistan, in Uzbekistan o nel Turkestan cinese, protagonisti e comprimari spesso in ombra assai più che tra l’800 e il 900. Sicuramente il campo di battaglia primario resta l’Afghanistan, ed è su questo campo di battaglia che porremo la nostra attenzione ma senza dimenticare le ombre che lo circondano. Metteremo assieme qualche idea e molte domande senza aver la pretesa di indicare risposte ma cercando di mettere in fila alcuni interrogativi che, oggi come allora, coinvolgono le grandi potenze regionali, gli Stati confinanti dal Caspio alla Cina, e le superpotenze che, adesso come un tempo, sono interessate al controllo di questo pietroso Paese senza sbocco al mare, quasi privo di gas e petrolio e con ricchezze minerarie ancora poco esplorate e comunque di difficile estrazione. Porremo la nostra attenzione soprattutto sull’Afghanistan per un semplicissimo motivo: la guerra – o la stagione di conflitto perenne iniziata con l’invasione sovietica del 1979 (quasi quarant’anni fa) – è ben lungi dall’esser terminata e assiste anzi a una ripresa che, solo in termini di vite umane, è diventata più esigente da quando la missione Isaf Nato si è ritirata – sostituita dalla più mite missione dell’Alleanza “Resolute Support” – nel dicembre 2014. Il fatto che la guerra afgana sia uscita dai riflettori della cronaca è solo – se mai ce ne fosse bisogno – l’indicazione che – per citare un vecchio adagio pacifista – la prima vittima della guerra è la verità. La guerra infatti non è affatto finita e gode anzi – ci si perdoni l’iperbole – di ottima salute.
 |
| La Nato ha appena deciso che la sua missione andrà oltre il 2016 con circa 1200 uomini |
Il Paese è un crocevia naturale sia delle assi commerciali Est Ovest Nord Sud sia per la posizione strategica per il passaggio di gasdotti e oleodotti. Cina e India sembrano i Paesi più interessati alla fine della turbolenza afgana di cui beneficerebbero però anche la Russia e i Paesi centroasiatici molti dei quali hanno già firmato con Kabul accordi per il passaggio dei tubi, affare cui sono interessate anche aziende occidentali (e italiane). Il Pakistan rappresenta un caso a parte ma si potrebbe ritenere che non sia più interessato a un’Afghanistan destabilizzato, a patto che un governo stabile a Kabul non sia anti pachistano. Infine il Paese è ricco di terre rare e minerali anche se di difficile estrazione. I cinesi hanno già firmato contratti importanti e stanno sviluppando una direttrice viaria che dal corridoio di Wakan, che confina con la Cina, raggiungerebbe Kabul via Panjshir.
 |
| Il classico di Peter Hopkirk |
Kabul è ossessionata dalla convinzione che ogni male si debba al Pakistan reo di ospitare, finanziare, allevare talebani. Ha scelto di fare la stessa cosa sul suo territorio coi talebani pachistani, i guerriglieri anti Islamabad al di là della frontiera (“cugini” dei fratelli afgani ma più violenti e brutali), ripagando il Pakistan con la sua stessa moneta. E’ interessante notare che appena i due Paesi si riavvicinano (sia il presidente Ghani, sia il premier pachistano Nawaz Sharif sono “aperturisti”) succede qualcosa che li allontana (di solito una strage non sempre rivendicata o incidenti alla frontiera). I rapporti sono sempre tesi sia per le controversie di confine o sui dazi commerciali, sia per la gestione dei rispettivi profughi (il Pakistan ospita circa un milione e mezzo di afgani, Kabul deve gestire una fuga massiccia di profughi dal Waziristan pachistano messo a ferro e fuoco da due anni dall’esercito del Paese dei puri). Kabul per ora non sembra il fautore di una politica di aperture e riconciliazioni. L’ultima invenzione, abortita dopo gli ultimi attacchi stragisti talebani soprattutto nella capitale, è stata la nascita di un comitato quadrilaterale con Afghanistan, Pakistan, Stati Uniti e Cina. Una buona idea coinvolgere la Cina e forse una buona idea cominciare da 4 e non da 8 o 10 (anche se in effetti non ha molto senso lasciar fuori Teheran, Riad, Delhi e persino Mosca), ma comunque una scelta di sola cornice per accompagnare un processo negoziale per ora abortito. E’ probabile che la Quadrilaterale, decisa a Kabul, sia stata pensata a Washington ma un tavolo negoziale senza il nemico non è un tavolo negoziale. Se poi il probabile principale negoziatore è stato ucciso…
Afghanistan: esequie di Stato per il processo di pace
 |
| Arthur Conolly: finì ucciso dall’emiro di Bukhara |
Dopo che Obama ha deciso di rallentare l’uscita delle truppe americane dall’Afghanistan, la Nato ha reiterato il prolungamento della sua missione oltre il 2016 e il governo di Kabul ha spiegato che non ha alcuna intenzione di rivitalizzare il processo di pace, lo stallo è più che evidente. Qui di seguito un’analisi* che cerca di fare il punto della situazione
——————-
Com’è noto la locuzione “Grande Gioco” – Great Game – si deve al britannico Arthur Conolly. Era uno dei tanti esploratori, diplomatici, spie al servizio di Sua Maestà britannica e aveva dato questo nome all’intrigo che dal 1800 aveva opposto soprattutto britannici e russi, ma anche francesi, persiani, afgani, circassi o turcmeni, che durante due secoli si erano combattuti, spiati, alleati e traditi in vista della grande posta in gioco: la conquista, o la conservazione della conquista, dell’India e, in molti casi, della propria indipendenza dalle mire russe o britanniche in Asia. Quello che in tempi recenti è stato chiamato Nuovo Grande Gioco sembra assomigliare alla primigenia edizione, benché la posta in gioco sia ovviamente mutata e così le tecniche per raggiungerla, ma mai come oggi sembra più appropriato il termine che aveva scelto un ministro dello Zar per descrivere quella guerra prolungata e non sempre guerreggiata senza esclusione di colpi: torneo delle ombre. Oggi come allora si agitano infatti, sullo sfondo del conflitto afgano, delle violenze in Pakistan, dei sommovimenti nel Caucaso, in Tagikistan, in Uzbekistan o nel Turkestan cinese, protagonisti e comprimari spesso in ombra assai più che tra l’800 e il 900. Sicuramente il campo di battaglia primario resta l’Afghanistan, ed è su questo campo di battaglia che porremo la nostra attenzione ma senza dimenticare le ombre che lo circondano. Metteremo assieme qualche idea e molte domande senza aver la pretesa di indicare risposte ma cercando di mettere in fila alcuni interrogativi che, oggi come allora, coinvolgono le grandi potenze regionali, gli Stati confinanti dal Caspio alla Cina, e le superpotenze che, adesso come un tempo, sono interessate al controllo di questo pietroso Paese senza sbocco al mare, quasi privo di gas e petrolio e con ricchezze minerarie ancora poco esplorate e comunque di difficile estrazione. Porremo la nostra attenzione soprattutto sull’Afghanistan per un semplicissimo motivo: la guerra – o la stagione di conflitto perenne iniziata con l’invasione sovietica del 1979 (quasi quarant’anni fa) – è ben lungi dall’esser terminata e assiste anzi a una ripresa che, solo in termini di vite umane, è diventata più esigente da quando la missione Isaf Nato si è ritirata – sostituita dalla più mite missione dell’Alleanza “Resolute Support” – nel dicembre 2014. Il fatto che la guerra afgana sia uscita dai riflettori della cronaca è solo – se mai ce ne fosse bisogno – l’indicazione che – per citare un vecchio adagio pacifista – la prima vittima della guerra è la verità. La guerra infatti non è affatto finita e gode anzi – ci si perdoni l’iperbole – di ottima salute.
 |
| La Nato ha appena deciso che la sua missione andrà oltre il 2016 con circa 1200 uomini |
Il Paese è un crocevia naturale sia delle assi commerciali Est Ovest Nord Sud sia per la posizione strategica per il passaggio di gasdotti e oleodotti. Cina e India sembrano i Paesi più interessati alla fine della turbolenza afgana di cui beneficerebbero però anche la Russia e i Paesi centroasiatici molti dei quali hanno già firmato con Kabul accordi per il passaggio dei tubi, affare cui sono interessate anche aziende occidentali (e italiane). Il Pakistan rappresenta un caso a parte ma si potrebbe ritenere che non sia più interessato a un’Afghanistan destabilizzato, a patto che un governo stabile a Kabul non sia anti pachistano. Infine il Paese è ricco di terre rare e minerali anche se di difficile estrazione. I cinesi hanno già firmato contratti importanti e stanno sviluppando una direttrice viaria che dal corridoio di Wakan, che confina con la Cina, raggiungerebbe Kabul via Panjshir.
 |
| Il classico di Peter Hopkirk |
Kabul è ossessionata dalla convinzione che ogni male si debba al Pakistan reo di ospitare, finanziare, allevare talebani. Ha scelto di fare la stessa cosa sul suo territorio coi talebani pachistani, i guerriglieri anti Islamabad al di là della frontiera (“cugini” dei fratelli afgani ma più violenti e brutali), ripagando il Pakistan con la sua stessa moneta. E’ interessante notare che appena i due Paesi si riavvicinano (sia il presidente Ghani, sia il premier pachistano Nawaz Sharif sono “aperturisti”) succede qualcosa che li allontana (di solito una strage non sempre rivendicata o incidenti alla frontiera). I rapporti sono sempre tesi sia per le controversie di confine o sui dazi commerciali, sia per la gestione dei rispettivi profughi (il Pakistan ospita circa un milione e mezzo di afgani, Kabul deve gestire una fuga massiccia di profughi dal Waziristan pachistano messo a ferro e fuoco da due anni dall’esercito del Paese dei puri). Kabul per ora non sembra il fautore di una politica di aperture e riconciliazioni. L’ultima invenzione, abortita dopo gli ultimi attacchi stragisti talebani soprattutto nella capitale, è stata la nascita di un comitato quadrilaterale con Afghanistan, Pakistan, Stati Uniti e Cina. Una buona idea coinvolgere la Cina e forse una buona idea cominciare da 4 e non da 8 o 10 (anche se in effetti non ha molto senso lasciar fuori Teheran, Riad, Delhi e persino Mosca), ma comunque una scelta di sola cornice per accompagnare un processo negoziale per ora abortito. E’ probabile che la Quadrilaterale, decisa a Kabul, sia stata pensata a Washington ma un tavolo negoziale senza il nemico non è un tavolo negoziale. Se poi il probabile principale negoziatore è stato ucciso…
Afghanistan: esequie di Stato per il processo di pace
 |
| Arthur Conolly: finì ucciso dall’emiro di Bukhara |
Dopo che Obama ha deciso di rallentare l’uscita delle truppe americane dall’Afghanistan, la Nato ha reiterato il prolungamento della sua missione oltre il 2016 e il governo di Kabul ha spiegato che non ha alcuna intenzione di rivitalizzare il processo di pace, lo stallo è più che evidente. Qui di seguito un’analisi* che cerca di fare il punto della situazione
——————-
Com’è noto la locuzione “Grande Gioco” – Great Game – si deve al britannico Arthur Conolly. Era uno dei tanti esploratori, diplomatici, spie al servizio di Sua Maestà britannica e aveva dato questo nome all’intrigo che dal 1800 aveva opposto soprattutto britannici e russi, ma anche francesi, persiani, afgani, circassi o turcmeni, che durante due secoli si erano combattuti, spiati, alleati e traditi in vista della grande posta in gioco: la conquista, o la conservazione della conquista, dell’India e, in molti casi, della propria indipendenza dalle mire russe o britanniche in Asia. Quello che in tempi recenti è stato chiamato Nuovo Grande Gioco sembra assomigliare alla primigenia edizione, benché la posta in gioco sia ovviamente mutata e così le tecniche per raggiungerla, ma mai come oggi sembra più appropriato il termine che aveva scelto un ministro dello Zar per descrivere quella guerra prolungata e non sempre guerreggiata senza esclusione di colpi: torneo delle ombre. Oggi come allora si agitano infatti, sullo sfondo del conflitto afgano, delle violenze in Pakistan, dei sommovimenti nel Caucaso, in Tagikistan, in Uzbekistan o nel Turkestan cinese, protagonisti e comprimari spesso in ombra assai più che tra l’800 e il 900. Sicuramente il campo di battaglia primario resta l’Afghanistan, ed è su questo campo di battaglia che porremo la nostra attenzione ma senza dimenticare le ombre che lo circondano. Metteremo assieme qualche idea e molte domande senza aver la pretesa di indicare risposte ma cercando di mettere in fila alcuni interrogativi che, oggi come allora, coinvolgono le grandi potenze regionali, gli Stati confinanti dal Caspio alla Cina, e le superpotenze che, adesso come un tempo, sono interessate al controllo di questo pietroso Paese senza sbocco al mare, quasi privo di gas e petrolio e con ricchezze minerarie ancora poco esplorate e comunque di difficile estrazione. Porremo la nostra attenzione soprattutto sull’Afghanistan per un semplicissimo motivo: la guerra – o la stagione di conflitto perenne iniziata con l’invasione sovietica del 1979 (quasi quarant’anni fa) – è ben lungi dall’esser terminata e assiste anzi a una ripresa che, solo in termini di vite umane, è diventata più esigente da quando la missione Isaf Nato si è ritirata – sostituita dalla più mite missione dell’Alleanza “Resolute Support” – nel dicembre 2014. Il fatto che la guerra afgana sia uscita dai riflettori della cronaca è solo – se mai ce ne fosse bisogno – l’indicazione che – per citare un vecchio adagio pacifista – la prima vittima della guerra è la verità. La guerra infatti non è affatto finita e gode anzi – ci si perdoni l’iperbole – di ottima salute.
 |
| La Nato ha appena deciso che la sua missione andrà oltre il 2016 con circa 1200 uomini |
Il Paese è un crocevia naturale sia delle assi commerciali Est Ovest Nord Sud sia per la posizione strategica per il passaggio di gasdotti e oleodotti. Cina e India sembrano i Paesi più interessati alla fine della turbolenza afgana di cui beneficerebbero però anche la Russia e i Paesi centroasiatici molti dei quali hanno già firmato con Kabul accordi per il passaggio dei tubi, affare cui sono interessate anche aziende occidentali (e italiane). Il Pakistan rappresenta un caso a parte ma si potrebbe ritenere che non sia più interessato a un’Afghanistan destabilizzato, a patto che un governo stabile a Kabul non sia anti pachistano. Infine il Paese è ricco di terre rare e minerali anche se di difficile estrazione. I cinesi hanno già firmato contratti importanti e stanno sviluppando una direttrice viaria che dal corridoio di Wakan, che confina con la Cina, raggiungerebbe Kabul via Panjshir.
 |
| Il classico di Peter Hopkirk |
Kabul è ossessionata dalla convinzione che ogni male si debba al Pakistan reo di ospitare, finanziare, allevare talebani. Ha scelto di fare la stessa cosa sul suo territorio coi talebani pachistani, i guerriglieri anti Islamabad al di là della frontiera (“cugini” dei fratelli afgani ma più violenti e brutali), ripagando il Pakistan con la sua stessa moneta. E’ interessante notare che appena i due Paesi si riavvicinano (sia il presidente Ghani, sia il premier pachistano Nawaz Sharif sono “aperturisti”) succede qualcosa che li allontana (di solito una strage non sempre rivendicata o incidenti alla frontiera). I rapporti sono sempre tesi sia per le controversie di confine o sui dazi commerciali, sia per la gestione dei rispettivi profughi (il Pakistan ospita circa un milione e mezzo di afgani, Kabul deve gestire una fuga massiccia di profughi dal Waziristan pachistano messo a ferro e fuoco da due anni dall’esercito del Paese dei puri). Kabul per ora non sembra il fautore di una politica di aperture e riconciliazioni. L’ultima invenzione, abortita dopo gli ultimi attacchi stragisti talebani soprattutto nella capitale, è stata la nascita di un comitato quadrilaterale con Afghanistan, Pakistan, Stati Uniti e Cina. Una buona idea coinvolgere la Cina e forse una buona idea cominciare da 4 e non da 8 o 10 (anche se in effetti non ha molto senso lasciar fuori Teheran, Riad, Delhi e persino Mosca), ma comunque una scelta di sola cornice per accompagnare un processo negoziale per ora abortito. E’ probabile che la Quadrilaterale, decisa a Kabul, sia stata pensata a Washington ma un tavolo negoziale senza il nemico non è un tavolo negoziale. Se poi il probabile principale negoziatore è stato ucciso…
Un drone ha ucciso l’ideatore delle ultime stragi in Pakistan (aggiornato)
 Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Per ora non ci sono conferme ufficiali e il Ttp smentisce. Ma fonti militari hanno detto al quotidiano Dawn, uno dei più autorevoli del Paese, che la notizia è credibile. Umar era stato catalogato in maggio dal Dipartimento di stato americano “terrorista globale”. L’obiettivo sarebbero ora Abdul Wali, alias Omar Khalid Khurasani, and Maulvi Fazlullah, leader del Ttp.
Aggiornamento: la notizia è stata confermata dal capo delle forze armate pachistane
Un drone ha ucciso l’ideatore delle ultime stragi in Pakistan (aggiornato)
 Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Per ora non ci sono conferme ufficiali e il Ttp smentisce. Ma fonti militari hanno detto al quotidiano Dawn, uno dei più autorevoli del Paese, che la notizia è credibile. Umar era stato catalogato in maggio dal Dipartimento di stato americano “terrorista globale”. L’obiettivo sarebbero ora Abdul Wali, alias Omar Khalid Khurasani, and Maulvi Fazlullah, leader del Ttp.
Aggiornamento: la notizia è stata confermata dal capo delle forze armate pachistane
Un drone ha ucciso l’ideatore delle ultime stragi in Pakistan (aggiornato)
 Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Per ora non ci sono conferme ufficiali e il Ttp smentisce. Ma fonti militari hanno detto al quotidiano Dawn, uno dei più autorevoli del Paese, che la notizia è credibile. Umar era stato catalogato in maggio dal Dipartimento di stato americano “terrorista globale”. L’obiettivo sarebbero ora Abdul Wali, alias Omar Khalid Khurasani, and Maulvi Fazlullah, leader del Ttp.
Aggiornamento: la notizia è stata confermata dal capo delle forze armate pachistane
Un drone ha ucciso l’ideatore delle ultime stragi in Pakistan (aggiornato)
 Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Secondo la stampa pachistana un drone americano avrebbe freddato in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar, Umar Mansur e Qari Saifullah, due militanti chiave dei talebani pachistani (Tehreek-i-Taliban Pakistan/Ttp). In particolare Umar Mansur, alias Khalifa Mansur, alias Umar Naray – a capo della fazione Tariq Geedar del Ttp – sarebbe l’ideatore di almeno tre recenti stragi avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan: la prima è il massacro di oltre 140 persone (in maggioranza studenti) alla Army Public School di Peshawar avvenuto nel 2014. La seconda si deve a un attacco contro una base militare dell’aviazione nel 2015 sempre nella zona di Peshawar (29 vittime). L’ultima, nel 2016, riguarda sempre un’università, la Bacha Khan di Charsadda, dove i morti sono stati 18.
Per ora non ci sono conferme ufficiali e il Ttp smentisce. Ma fonti militari hanno detto al quotidiano Dawn, uno dei più autorevoli del Paese, che la notizia è credibile. Umar era stato catalogato in maggio dal Dipartimento di stato americano “terrorista globale”. L’obiettivo sarebbero ora Abdul Wali, alias Omar Khalid Khurasani, and Maulvi Fazlullah, leader del Ttp.
Aggiornamento: la notizia è stata confermata dal capo delle forze armate pachistane
Gli occhi di Abdul Sattar Edhi
Due persone di Karachi vedono adesso con gli occhi di Abdul Sattar Edhi, l’ottuagenario filantropo pachistano i cui funerali si sono svolti sabato dopo una preghiera allo Stadio nazionale per l’uomo che viene celebrato in Pakistan come un eroe e che fu candidato al Nobel dal padre di Malala Yusufzai, la giovane studentessa pachistana che i talebani tentarono di uccidere. Morto venerdi scorso a 88 anni, avrebbe voluto donare tutti i suoi organi ma solo le cornee sono state trapiantate con successo al Sindh Institute of Urology and Transplant. Il suo corpo era provato e da anni i suoi reni non funzionavano più costringendolo alla dialisi. Nel 2014 poi, una gang di malavitosi aveva fatto irruzione a casa sua e il vecchio era rimasto sotto choc: più per il fatto che qualcuno potesse rubare proprio a lui che non per lo spavento. Quando andammo a trovarlo nel 2000 in uno dei suoi centri a Karachi, era già malato e non riceveva volentieri gli ospiti. Non solo per la malattia. Edhi era schivo e se si era fatto in quattro per far finanziare la sua Fondazione, non aveva il culto della sua personalità. Eppure, funerali come quelli di sabato non si riservano a un uomo qualunque. Qualcuno dice che una celebrazione così si è vista solo alla morte di Jinnah – il fondatore del Pakistan – o per il dittatore generale Zia ul-Haq che invece della sua persona menava gran vanto. Chi era Abdul Sattar Edhi?
Era un sognatore. In Pakistan al sistema sanitario pubblico – con visite e e medicine gratuite – viene obtorto collo preferito il settore privato che può contare sull’80% dei pazienti. Gli ospedali pubblici infatti non ce la fanno a reggere la domanda. Ma i costi non possono pagarli tutti, figurarsi chi vive in strada o in abitazioni di fortuna nei grandi slum urbani. Edhi pensa che forse di può provare a creare uno spazio privato ma per tutti. E’ un filantropo ma con le idee chiare e ovviamente preferirebbe che fosse lo Stato a seguire le gente di cui si deve far carico lui. Ne era così convinto che, nel giugno scorso, aveva rifiutato l’offerta dell’ex presidente Asif Ali Zardari di farsi curare fuori dal Paese. Manco per sogno. Edhi gli spiegò che voleva essere curato in Pakistan. E in una struttura pubblica.
 Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
commercianti, che, come tanti musulmani indiani, decide di partire nel 1947 verso la promessa di un Paese per i fedeli di Maometto, il sogno di Jinnah di creare il “Paese dei puri”. Ma il Paese dei puri è una promessa che non diventa realtà. Nel nuovo Paese, formato da cinque province che hanno ereditato la parte occidentale del Raj (e un’area del Bengala oggi Bangladesh), lo Stato non ha mezzi per prendersi cura dei suoi puri. Ne fa le spese la madre di Edhi, che è paralizzata e con disturbi mentali. Comincia lì il suo desiderio di fare qualcosa. E nel 1951 apre la sua prima “clinica”. Poi comincia a lavorare per creare orfanotrofi, camere mortuarie, luoghi di riposo per anziani e un servizio di ambulanze che corrono per tutto il Paese. E’ animato da un forte idealismo e da un senso di giustizia. E’ musulmano ma non ne fa una bandiera.
Premio Balzan 2000 per l’umanità, la pace e la fratellanza fra i popoli, Edhi viene in Italia, a Milano, dove Tehmina Durrani, scrittrice pachistana diventata famosa per i suoi libri tradotti in molte lingue sulla schiavitù delle donne nel suo Paese, racconta come ha scritto la sua biografia “A Mirror to the Blind” (Uno specchio per il cieco”). E dice: «Schiava di mio marito è stato tradotto in 35 lingue e Empietà sta seguendo lo stesso corso, mentre A Mirror to the Blind è stato pubblicato solamente in Pakistan dalla Edhi Foundation… Mentre la letteratura che parla dei “buoni” è sotterrata sotto un velo di fremiti ed eccitazione perversa, i personaggi simili a quelli di Schiava di mio marito e Empietà attraggono un pubblico entusiasta di lettori… Questa ignoranza a livello planetario – una pericolosa strada che l’intera umanità sta imboccando – necessita di un esame più approfondito… Non si arriverà mai a enfatizzare abbastanza l’importanza del messaggio e della vita di Edhi, un uomo del nostro tempo, il cui esempio renderà possibile distinguere tra il vero Islam e i preconcetti legati a esso».
Gli occhi di Abdul Sattar Edhi
Due persone di Karachi vedono adesso con gli occhi di Abdul Sattar Edhi, l’ottuagenario filantropo pachistano i cui funerali si sono svolti sabato dopo una preghiera allo Stadio nazionale per l’uomo che viene celebrato in Pakistan come un eroe e che fu candidato al Nobel dal padre di Malala Yusufzai, la giovane studentessa pachistana che i talebani tentarono di uccidere. Morto venerdi scorso a 88 anni, avrebbe voluto donare tutti i suoi organi ma solo le cornee sono state trapiantate con successo al Sindh Institute of Urology and Transplant. Il suo corpo era provato e da anni i suoi reni non funzionavano più costringendolo alla dialisi. Nel 2014 poi, una gang di malavitosi aveva fatto irruzione a casa sua e il vecchio era rimasto sotto choc: più per il fatto che qualcuno potesse rubare proprio a lui che non per lo spavento. Quando andammo a trovarlo nel 2000 in uno dei suoi centri a Karachi, era già malato e non riceveva volentieri gli ospiti. Non solo per la malattia. Edhi era schivo e se si era fatto in quattro per far finanziare la sua Fondazione, non aveva il culto della sua personalità. Eppure, funerali come quelli di sabato non si riservano a un uomo qualunque. Qualcuno dice che una celebrazione così si è vista solo alla morte di Jinnah – il fondatore del Pakistan – o per il dittatore generale Zia ul-Haq che invece della sua persona menava gran vanto. Chi era Abdul Sattar Edhi?
Era un sognatore. In Pakistan al sistema sanitario pubblico – con visite e e medicine gratuite – viene obtorto collo preferito il settore privato che può contare sull’80% dei pazienti. Gli ospedali pubblici infatti non ce la fanno a reggere la domanda. Ma i costi non possono pagarli tutti, figurarsi chi vive in strada o in abitazioni di fortuna nei grandi slum urbani. Edhi pensa che forse di può provare a creare uno spazio privato ma per tutti. E’ un filantropo ma con le idee chiare e ovviamente preferirebbe che fosse lo Stato a seguire le gente di cui si deve far carico lui. Ne era così convinto che, nel giugno scorso, aveva rifiutato l’offerta dell’ex presidente Asif Ali Zardari di farsi curare fuori dal Paese. Manco per sogno. Edhi gli spiegò che voleva essere curato in Pakistan. E in una struttura pubblica.
 Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
commercianti, che, come tanti musulmani indiani, decide di partire nel 1947 verso la promessa di un Paese per i fedeli di Maometto, il sogno di Jinnah di creare il “Paese dei puri”. Ma il Paese dei puri è una promessa che non diventa realtà. Nel nuovo Paese, formato da cinque province che hanno ereditato la parte occidentale del Raj (e un’area del Bengala oggi Bangladesh), lo Stato non ha mezzi per prendersi cura dei suoi puri. Ne fa le spese la madre di Edhi, che è paralizzata e con disturbi mentali. Comincia lì il suo desiderio di fare qualcosa. E nel 1951 apre la sua prima “clinica”. Poi comincia a lavorare per creare orfanotrofi, camere mortuarie, luoghi di riposo per anziani e un servizio di ambulanze che corrono per tutto il Paese. E’ animato da un forte idealismo e da un senso di giustizia. E’ musulmano ma non ne fa una bandiera.
Premio Balzan 2000 per l’umanità, la pace e la fratellanza fra i popoli, Edhi viene in Italia, a Milano, dove Tehmina Durrani, scrittrice pachistana diventata famosa per i suoi libri tradotti in molte lingue sulla schiavitù delle donne nel suo Paese, racconta come ha scritto la sua biografia “A Mirror to the Blind” (Uno specchio per il cieco”). E dice: «Schiava di mio marito è stato tradotto in 35 lingue e Empietà sta seguendo lo stesso corso, mentre A Mirror to the Blind è stato pubblicato solamente in Pakistan dalla Edhi Foundation… Mentre la letteratura che parla dei “buoni” è sotterrata sotto un velo di fremiti ed eccitazione perversa, i personaggi simili a quelli di Schiava di mio marito e Empietà attraggono un pubblico entusiasta di lettori… Questa ignoranza a livello planetario – una pericolosa strada che l’intera umanità sta imboccando – necessita di un esame più approfondito… Non si arriverà mai a enfatizzare abbastanza l’importanza del messaggio e della vita di Edhi, un uomo del nostro tempo, il cui esempio renderà possibile distinguere tra il vero Islam e i preconcetti legati a esso».
Gli occhi di Abdul Sattar Edhi
Due persone di Karachi vedono adesso con gli occhi di Abdul Sattar Edhi, l’ottuagenario filantropo pachistano i cui funerali si sono svolti sabato dopo una preghiera allo Stadio nazionale per l’uomo che viene celebrato in Pakistan come un eroe e che fu candidato al Nobel dal padre di Malala Yusufzai, la giovane studentessa pachistana che i talebani tentarono di uccidere. Morto venerdi scorso a 88 anni, avrebbe voluto donare tutti i suoi organi ma solo le cornee sono state trapiantate con successo al Sindh Institute of Urology and Transplant. Il suo corpo era provato e da anni i suoi reni non funzionavano più costringendolo alla dialisi. Nel 2014 poi, una gang di malavitosi aveva fatto irruzione a casa sua e il vecchio era rimasto sotto choc: più per il fatto che qualcuno potesse rubare proprio a lui che non per lo spavento. Quando andammo a trovarlo nel 2000 in uno dei suoi centri a Karachi, era già malato e non riceveva volentieri gli ospiti. Non solo per la malattia. Edhi era schivo e se si era fatto in quattro per far finanziare la sua Fondazione, non aveva il culto della sua personalità. Eppure, funerali come quelli di sabato non si riservano a un uomo qualunque. Qualcuno dice che una celebrazione così si è vista solo alla morte di Jinnah – il fondatore del Pakistan – o per il dittatore generale Zia ul-Haq che invece della sua persona menava gran vanto. Chi era Abdul Sattar Edhi?
Era un sognatore. In Pakistan al sistema sanitario pubblico – con visite e e medicine gratuite – viene obtorto collo preferito il settore privato che può contare sull’80% dei pazienti. Gli ospedali pubblici infatti non ce la fanno a reggere la domanda. Ma i costi non possono pagarli tutti, figurarsi chi vive in strada o in abitazioni di fortuna nei grandi slum urbani. Edhi pensa che forse di può provare a creare uno spazio privato ma per tutti. E’ un filantropo ma con le idee chiare e ovviamente preferirebbe che fosse lo Stato a seguire le gente di cui si deve far carico lui. Ne era così convinto che, nel giugno scorso, aveva rifiutato l’offerta dell’ex presidente Asif Ali Zardari di farsi curare fuori dal Paese. Manco per sogno. Edhi gli spiegò che voleva essere curato in Pakistan. E in una struttura pubblica.
 Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
commercianti, che, come tanti musulmani indiani, decide di partire nel 1947 verso la promessa di un Paese per i fedeli di Maometto, il sogno di Jinnah di creare il “Paese dei puri”. Ma il Paese dei puri è una promessa che non diventa realtà. Nel nuovo Paese, formato da cinque province che hanno ereditato la parte occidentale del Raj (e un’area del Bengala oggi Bangladesh), lo Stato non ha mezzi per prendersi cura dei suoi puri. Ne fa le spese la madre di Edhi, che è paralizzata e con disturbi mentali. Comincia lì il suo desiderio di fare qualcosa. E nel 1951 apre la sua prima “clinica”. Poi comincia a lavorare per creare orfanotrofi, camere mortuarie, luoghi di riposo per anziani e un servizio di ambulanze che corrono per tutto il Paese. E’ animato da un forte idealismo e da un senso di giustizia. E’ musulmano ma non ne fa una bandiera.
Premio Balzan 2000 per l’umanità, la pace e la fratellanza fra i popoli, Edhi viene in Italia, a Milano, dove Tehmina Durrani, scrittrice pachistana diventata famosa per i suoi libri tradotti in molte lingue sulla schiavitù delle donne nel suo Paese, racconta come ha scritto la sua biografia “A Mirror to the Blind” (Uno specchio per il cieco”). E dice: «Schiava di mio marito è stato tradotto in 35 lingue e Empietà sta seguendo lo stesso corso, mentre A Mirror to the Blind è stato pubblicato solamente in Pakistan dalla Edhi Foundation… Mentre la letteratura che parla dei “buoni” è sotterrata sotto un velo di fremiti ed eccitazione perversa, i personaggi simili a quelli di Schiava di mio marito e Empietà attraggono un pubblico entusiasta di lettori… Questa ignoranza a livello planetario – una pericolosa strada che l’intera umanità sta imboccando – necessita di un esame più approfondito… Non si arriverà mai a enfatizzare abbastanza l’importanza del messaggio e della vita di Edhi, un uomo del nostro tempo, il cui esempio renderà possibile distinguere tra il vero Islam e i preconcetti legati a esso».
Gli occhi di Abdul Sattar Edhi
Due persone di Karachi vedono adesso con gli occhi di Abdul Sattar Edhi, l’ottuagenario filantropo pachistano i cui funerali si sono svolti sabato dopo una preghiera allo Stadio nazionale per l’uomo che viene celebrato in Pakistan come un eroe e che fu candidato al Nobel dal padre di Malala Yusufzai, la giovane studentessa pachistana che i talebani tentarono di uccidere. Morto venerdi scorso a 88 anni, avrebbe voluto donare tutti i suoi organi ma solo le cornee sono state trapiantate con successo al Sindh Institute of Urology and Transplant. Il suo corpo era provato e da anni i suoi reni non funzionavano più costringendolo alla dialisi. Nel 2014 poi, una gang di malavitosi aveva fatto irruzione a casa sua e il vecchio era rimasto sotto choc: più per il fatto che qualcuno potesse rubare proprio a lui che non per lo spavento. Quando andammo a trovarlo nel 2000 in uno dei suoi centri a Karachi, era già malato e non riceveva volentieri gli ospiti. Non solo per la malattia. Edhi era schivo e se si era fatto in quattro per far finanziare la sua Fondazione, non aveva il culto della sua personalità. Eppure, funerali come quelli di sabato non si riservano a un uomo qualunque. Qualcuno dice che una celebrazione così si è vista solo alla morte di Jinnah – il fondatore del Pakistan – o per il dittatore generale Zia ul-Haq che invece della sua persona menava gran vanto. Chi era Abdul Sattar Edhi?
Era un sognatore. In Pakistan al sistema sanitario pubblico – con visite e e medicine gratuite – viene obtorto collo preferito il settore privato che può contare sull’80% dei pazienti. Gli ospedali pubblici infatti non ce la fanno a reggere la domanda. Ma i costi non possono pagarli tutti, figurarsi chi vive in strada o in abitazioni di fortuna nei grandi slum urbani. Edhi pensa che forse di può provare a creare uno spazio privato ma per tutti. E’ un filantropo ma con le idee chiare e ovviamente preferirebbe che fosse lo Stato a seguire le gente di cui si deve far carico lui. Ne era così convinto che, nel giugno scorso, aveva rifiutato l’offerta dell’ex presidente Asif Ali Zardari di farsi curare fuori dal Paese. Manco per sogno. Edhi gli spiegò che voleva essere curato in Pakistan. E in una struttura pubblica.
 Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
Era nato nel Gujarat, Stato ora indiano e allora parte del Raj britannico. La sua è una famiglia di
commercianti, che, come tanti musulmani indiani, decide di partire nel 1947 verso la promessa di un Paese per i fedeli di Maometto, il sogno di Jinnah di creare il “Paese dei puri”. Ma il Paese dei puri è una promessa che non diventa realtà. Nel nuovo Paese, formato da cinque province che hanno ereditato la parte occidentale del Raj (e un’area del Bengala oggi Bangladesh), lo Stato non ha mezzi per prendersi cura dei suoi puri. Ne fa le spese la madre di Edhi, che è paralizzata e con disturbi mentali. Comincia lì il suo desiderio di fare qualcosa. E nel 1951 apre la sua prima “clinica”. Poi comincia a lavorare per creare orfanotrofi, camere mortuarie, luoghi di riposo per anziani e un servizio di ambulanze che corrono per tutto il Paese. E’ animato da un forte idealismo e da un senso di giustizia. E’ musulmano ma non ne fa una bandiera.
Premio Balzan 2000 per l’umanità, la pace e la fratellanza fra i popoli, Edhi viene in Italia, a Milano, dove Tehmina Durrani, scrittrice pachistana diventata famosa per i suoi libri tradotti in molte lingue sulla schiavitù delle donne nel suo Paese, racconta come ha scritto la sua biografia “A Mirror to the Blind” (Uno specchio per il cieco”). E dice: «Schiava di mio marito è stato tradotto in 35 lingue e Empietà sta seguendo lo stesso corso, mentre A Mirror to the Blind è stato pubblicato solamente in Pakistan dalla Edhi Foundation… Mentre la letteratura che parla dei “buoni” è sotterrata sotto un velo di fremiti ed eccitazione perversa, i personaggi simili a quelli di Schiava di mio marito e Empietà attraggono un pubblico entusiasta di lettori… Questa ignoranza a livello planetario – una pericolosa strada che l’intera umanità sta imboccando – necessita di un esame più approfondito… Non si arriverà mai a enfatizzare abbastanza l’importanza del messaggio e della vita di Edhi, un uomo del nostro tempo, il cui esempio renderà possibile distinguere tra il vero Islam e i preconcetti legati a esso».
Afghanistan: la strategia che non va
A chiusura del vertice Nato di Varsavia, oltre alle novità sul fronte ucraino, anche la conferma che la missione Resolute Support andrà oltre il 2016 con 12mila soldati Nato e gli 8500 uomini che Obama ha fatto sapere – il 6 luglio scorso – che gli Usa lasceranno nel Paese. La forza d’occupazione rimane. La pace si allontana. Nessuna nuova idea ma la ripetizione di un modello che non ha funzionato.
Il mio commento a Radiopopolare (minuto 8’25”)
Barack Obama sull’Afghansitan il 6 luglio alla Casa Bianca
Afghanistan: la strategia che non va
A chiusura del vertice Nato di Varsavia, oltre alle novità sul fronte ucraino, anche la conferma che la missione Resolute Support andrà oltre il 2016 con 12mila soldati Nato e gli 8500 uomini che Obama ha fatto sapere – il 6 luglio scorso – che gli Usa lasceranno nel Paese. La forza d’occupazione rimane. La pace si allontana. Nessuna nuova idea ma la ripetizione di un modello che non ha funzionato.
Il mio commento a Radiopopolare (minuto 8’25”)
Barack Obama sull’Afghansitan il 6 luglio alla Casa Bianca
Afghanistan: la strategia che non va
A chiusura del vertice Nato di Varsavia, oltre alle novità sul fronte ucraino, anche la conferma che la missione Resolute Support andrà oltre il 2016 con 12mila soldati Nato e gli 8500 uomini che Obama ha fatto sapere – il 6 luglio scorso – che gli Usa lasceranno nel Paese. La forza d’occupazione rimane. La pace si allontana. Nessuna nuova idea ma la ripetizione di un modello che non ha funzionato.
Il mio commento a Radiopopolare (minuto 8’25”)
Barack Obama sull’Afghansitan il 6 luglio alla Casa Bianca
Afghanistan: la strategia che non va
A chiusura del vertice Nato di Varsavia, oltre alle novità sul fronte ucraino, anche la conferma che la missione Resolute Support andrà oltre il 2016 con 12mila soldati Nato e gli 8500 uomini che Obama ha fatto sapere – il 6 luglio scorso – che gli Usa lasceranno nel Paese. La forza d’occupazione rimane. La pace si allontana. Nessuna nuova idea ma la ripetizione di un modello che non ha funzionato.
Il mio commento a Radiopopolare (minuto 8’25”)
Barack Obama sull’Afghansitan il 6 luglio alla Casa Bianca
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Se il terrorista è di buona famiglia
Se qualcuno è rimasto spiazzato dall’appartenenza “castale” del giovane commando di Dacca, e sostiene dunque che l’equazione povertà, ingiustizia, terrorismo non funziona, si potrebbe rispondere che la cosa non fa differenza. I motivi per cui si aderisce a Daesh sono diversi e vanno dall’ideologia più radicale alla necessità di avere uno stipendio a fors’anche un malriposto desiderio di avventura eroica che ha qualcosa di perversamente romantico. Ma in un caso, nell’altro o nell’altro ancora, l’equazione povertà, ingiustizia continua a esistere anche se si è studiato a Oxford. Se l’equazione è chiara per chi è in stato di necessità (gli stipendiati di Daesh o Al Qaeda, i martiri a pagamento della cui morte beneficia la famiglia), nel caso del giovane rampollo benestante c’è comunque un’adesione ideologica che affonda le sue radici nella constatazione della povertà o dell’ingiustizia. Non la sua certo. Ma quella appresa anche solo osservando i servi di casa che per due rupie servono il pasto nei quartiri residenziali. Di Dacca o della Mecca. Il terrorismo e, soprattutto la sua brutalità, sono fenomeni complessi, difficili da analizzare ma, benché ingiustificabili, con radici che affondano prepotentemente in un mondo ineguale e dove la violenza è un modello quotidiano: un modello che, nel caso dei terroristi, viene declinato nel modo più brutale. Povertà e ineguaglianza c‘entrano sempre. Cominciare a eradicarle, come si fa con la malaria, sarebbe un passo avanti.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Dietro la strage al bar di Dacca
 Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
Scrivi Bangladesh e dici povertà, ingiustizia, sovrappopolazione (150 milioni su un territorio grande
la metà dell’Italia), alluvioni e inondazioni marine devastanti. Dici Bangladesh e racconti una storia di risentimento sedimentato che diventa spesso violenza politica. Dici Bangladesh e pensi che la politica di quel Paese è iperpolarizzata da quasi trent’anni e modellata su due partiti e, soprattutto, da due leader ormai ottuagenarie ma saldamente al potere. A turno: Sheikh Hasina dell’Awami League, un partito laico e nazionalista, e Khaleda Zia del Bangladesh Nationalist Party, organizzazzione nazionalista e conservatrice. Dici Bangladesh e vedi nella forza delle organizzazioni islamiste, a cominciare dalla Jamaat-e-Islami – formazione con status parlamentare – la capacità di raccogliere un consenso che nasce dalla frustrazione legata a un cambiamento che non si avvera e dove l’islam rappresenta una promessa di purezza e riscatto in una nazione che ha a lungo detenuto la palma del Paese più corrotto al mondo. C’è tutto quel che ci vuole per preparare il terreno e il brodo di coltura dove far crescere la trasformazione del risentimento in odio e violenza. Dove è facile insomma reclutare e, per un pugno di rupie, armare mani assassine. La strage del bar è un salto di qualità ma purtroppo non stupisce. La violenza politica è stata una costante in questo Paese e negli ultimi anni, benché il governo di Hasina si ostini a negarlo, il brand di Daesh ha fatto parlare di sé molte volte con assassini mirati individuali e addirittura una lista di proscrizione di blogger, attivisti, intellettuali e insegnanti laici da far fuori.
 |
| Balle di iuta: ricchezza nazionale |
Raccontata così però sarebbe una storia a metà, di quelle che si liquidano in fretta perché il Paese è povero, sovrappopolato e per di più ingiusto e musulmano: abbastanza per derubricare il caso a vicenda di ordinaria povertà. Ma il Bangladesh è anche il luogo delle responsabilità nascoste che ancora una volta rimandano le radici dell’ingiustizia sociale a scelte prima coloniali e poi industriali. Quel Paese inizia la sua Storia “indipendente” nel 1947 quando la follia britannica, sostenuta da quella della Muslim League del subcontinente indiano, divide il nascente Pakistan in due Stati che distano tra loro… 10 ore di volo. Il Pakistan orientale, abitato da bengalesi musulmani, con l’aiuto dell’India, si stacca dal Pakistan nel 1971 con una guerra sanguinosa le cui ferite non si sono ancora cicatrizzate (sono stati giustiziati di recente molti capi della resistenza pro pachistana accusati di crimini contro l’umanità). Il Paese ha una solo vera ricchezza, la iuta, il cotone e una rinomata tradizione manufatturiera, che fanno di questo Paese un enorme cantiere tessile. Ed è in Bangladesh che in tempi recenti sbarcano le multinazionali del tessile che hanno scelto la delocalizzazione in Paesi che lavorano in conto terzi: salari minimi, materia prima di buona qualità a prezzi bassi, scarsa capacità sindacale, governi col pugno duro quando si rivendica un diritto.
Ci sono un nome, un luogo e una data che raccontano bene questa storia: Rana Plaza a Dacca, il 24 aprile del 2013. Un edificio commerciale di otto piani, figlio di abusi speculativi locali, crolla a Savar, un sub-distretto della capitale. Il bilancio è gravissimo e le operazioni di soccorso richiedono quasi un mese e si concludono il 13 maggio con un bilancio di oltre mille vittime e oltre duemila feriti, molti dei quali ormai menomati e inabili al lavoro. Quello che è considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile e anche il più letale cedimento strutturale accidentale della Storia contemporanea, scoperchia anche le responsabilità di marchi europei, americani, italiani. Scoperchia il tema della sicurezza, dei diritti, dei risarcimenti che non arrivano. Farà aumentare il salario base ma lascerà anche intere famiglie sul lastrico. Eccolo un altro humus pieno di risentimento. Nel Rana Plaza avevano i loro laboratori fabbrichette locali che lavoravano per grandi marchi internazionali. Loro a fare il lavoro sporco, gli altri a esibire t-shirt a basso prezzo con la griffe. Se non ci fossero state campagne internazionali di attenzione (in Italia la Ong “Abiti puliti”), se non si fosse mosso l’Ufficio internazionale del lavoro dell’Onu, la storia si sarebbe dimenticata in fretta. E, in queste ore, pochi la mettono in relazione alla strage di due giorni fa nella capitale. Eppure…
 Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Eppure il Bangladesh è anche questo: la tragedia del Rana Plaza fa firmare a circa 160 compagnie il Fire and Building Safety, un primo passo per mettere in sicurezza strutture e forza lavoro che, nel tessile, conta circa 4 milioni di operai e operaie. Ma, dalle colonne del britannico Guardian, Tansy Hoskins, autrice del saggio Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, avverte che nonostante vi sia un elevato numero di sindacati del settore, sono pochi i lavoratori che vi aderiscono, il che li lascia vulnerabili agli abusi in fabbriche poco sicure. Anche un sindacato importante come la National Garment Workers’ Federation deve affrontare grandi ostacoli perché per registrare un’organizzazione al Dipartimento del lavoro si deve nel contempo avere come soci un terzo della forza lavoro: insomma se vuoi registrati come attivo in una fabrica con 10mila lavoratori ne devi avere come soci almeno 3mila… ma in Bangladesh se ti iscrivi rischi – dopo le minacce – il licenziamento. E una volta per strada, da vittima del mercato, è facile diventare il soldatino di qualche Califfo in cerca di nuovi sodali.
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
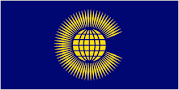 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
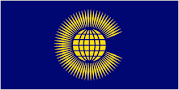 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
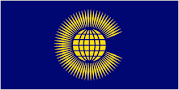 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
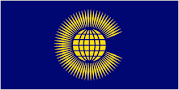 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Brexit: cosa ne pensano nel Commonwealth
 Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
Certo, c’è anche il parlamentare del Partito liberale conservatore che, dalle colonne di un quotidiano dell’Australia – ancora virtualmente governata dalla Regina Elisabetta – plaude alla Brexit, orgoglio che par d’altri tempi e ispirato a un passato coloniale cui forse nemmeno nel Regno Unito si sognano di pensare. E forse c’è anche qualche indiano ottuagenario dell’11mo Sikh Regiment della British Indian Army – nato negli anni Venti – che prende la pensione da Londra e pensa che la vecchia Inghilterra abbia fatto bene. Ma son voci fuori dal coro in un panorama che abbraccia il vecchio mondo coloniale britannico che si riconosce nel Commonwealth – che raccoglie 53 nazioni e 2,2 miliardi persone – il cui cuore pulsa soprattutto in Asia, fino a lambire il Quinto continente. Sarà perché sei abitanti su dieci del Commonwealth hanno meno di trent’anni, sarà perché il mondo è davvero cambiato – l’ultima bandiera adottata a Ottawa nel 1976 non ha più l’Union Jack – a plaudire alla Brexit son davvero pochini. Il resto son toni allarmati e solo in parte per l’economia. A volo d’uccello par di capire che la preoccupazione maggiore sia la piega nazional populista e isolazionista che non piace soprattutto nei Paesi di tradizionale immigrazione, come India o Pakistan, ma che fa storcer bocca e naso anche a intellettuali australiani o canadesi.
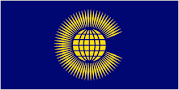 |
| La bandiera del Commonwealth senza l’Unione Jack. Sopra, una foto d’epoca del reggimento sikh nella Vritish India Army |
Scrive Michael Pascoe, editorialista economico di Business Day, inserto economico del Sidney Mornig Herald: «In realtà non me la prendo con la Gran Bretagna. Non è un gran danno per l’Australia e vale solo un paio di punti percentuali delle nostre esportazioni. Se i Poms (nickname per britannici ndr) si vogliono sparare sui piedi ritirandosi da un potente blocco commerciale, non mi interessa. Mi preoccupa invece la meschinità isolazionista che sembra aver guidato Brexit; la contrazione di cuori e menti di quella che fu una grande nazione rivolta verso l’esterno. Il pericolo, come molti hanno commentato, è che dà forza a tipi xenofobi e anti-globalizzazione. Le stesse forze populiste che demonizzano i migranti e, in particolare, i rifugiati, e che spingono verso il mito di un futuro protezionista. Forze che sono al lavoro ovunque nel mondo. Questa è la preoccupazione». Sempre sul Smh, Brexit fa paragonare il Regno Unito alla Svizzera che, nel 1992, rifiutò l’ingresso in Europa con un referendum. Ma, scrive il quotidiano «Qual è l’unico problema? E difficile che la Gran Bretagna (o qualsiasi altro Paese europeo) sia in grado di replicare, abbandonando l’Unione Europea, ciò che è noto come il “miracolo svizzero”», ossia un altissimo reddito procapite e una bassa disoccupazione. Illusioni. E paura di una virata xenofoba. Mohammad Zia Adnan, un giovane che scrive per il pachistano The Dawn e che in Gran Bretagna ha diritto di voto ma non è andato alle urne nel giorno del Brexit perché aveva dimenticato di registrarsi, scrive ora, «Me ne sono pentito». Gli fa eco un titolo di The Times of India, uno dei più autorevoli giornali indiani: «Brexit wins, everybody loses». Più chiaro di così. Naturalmente c’è anche ci si sfrega le mani. Ancora lo stesso giornale pachistano rivela che c’è chi si muove per comprare immobili approfittando della caduta della sterlina e di una possibile discesa del prezzo degli appartamenti. Che però potrebbero anche scendere troppo e dunque rivelarsi un cattivo affare. Incertezze che rimbalzano sui giornali africani: un articolo del keniano The Star riferisce che una delle più grandi aziende di trasferimento di denaro in Africa, la Dahabshiil, ha spiegato che Brexit potrebbe deprimere il ricco giro d’affari legato alle rimesse degli emigrati e influenzare negativamente gli investimenti nella regione. Preoccupazioni.
 |
| Brexit: una delle tante immagini grafiche |
C’è infine un altro aspetto interessante che viene suggerito dal giornale di un area asiatica dove il British Rule è durata più a lungo che altrove, fino al 1957: la Federazione della Malaysia che inizialmente comprendeva anche Singapore. Ed è appunto lo Straits Times di Singapore a scrivere di un clima dove prevalgono «istinti tribali, nazionalismo, xenofobia, isolazionismo» e persino violenza. Così, si chiede il Times, potrebbe essere adesso la Gran Bretagna «una delle prime nazioni che ha sperimentato e tratto profitto, della globalizzazione? Quelli della British East India Company, fondata nel 1600, sono stati i primi commercianti globali e aziende globali sono state costruite dalla rete dell’Impero». Colpisce nell’articolo il riferimento al processo di integrazione europea «cui abbiamo guardato in Asia come a un modello», tradottosi poi nelle varie associazioni regionali. «Come ha fatto la Gran Bretagna ad arrivare a questo punto?», si chiede il giornale che ricorda una frase di Winston Churchill, «adulato primo ministro in tempo di guerra, che una volta aveva prefigurato gli “Stati Uniti d’Europa”…».
Onu/Italia: accordo salva la faccia all’Aja e a Roma
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Onu/Italia: accordo salva la faccia all’Aja e a Roma
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Onu/Italia: accordo salva la faccia all’Aja e a Roma
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Onu/Italia: accordo salva la faccia all’Aja e a Roma
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Onu/Italia: accordo salva la faccia all’Aja e a Roma
 Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Accordo sul filo del rasoio tra l’Italia e l’Olanda per il seggio come membro non permanente al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I due Paesi si divideranno il seggio un anno per ciascuno. Renzi, riferiscono le agenzie, avrebbe proposto per l’Italia il 2017, quando Roma avrà la presidenza del G7, mentre all’Olanda andrebbe bene avere il seggio l’anno successivo, nel 2018. Una maratona dolorosa conclusasi dopo una giornata di votazioni (cinque) senza risultato e senza che nessuno dei due raggiungesse il quorum di 128 previsto. L’Assemblea dovrebbe oggi ratificare il bizzarro accordo.
Proviamo a ricapitolare.
Messa ormai da parte la battaglia per una riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Italia si è fatta avanti per ottenere il suo settimo mandato come membro non permanente del CdS. All’inizio va male: l’Assemblea plenaria dell’Onu ha eletto nel CdS al primo turno di votazioni la Svezia, l’Etiopia e la Bolivia. La Svezia ha ottenuto 134 voti, Amsterdam 125, Roma 113. C’erano dunque in ballo due seggi: uno per l’Europa occidentale – per cui restavano in ballottaggio Italia e Olanda – e uno per l’area asiatica – per cui correvano Thailandia e Kazakistan. Ma al ballottaggio con l’Olanda, Roma ha ottenuto solo 94 voti contro i 96 dei Paesi Bassi. L’Assemblea ha aggiornato la seduta. Nel secondo turno ha invece vinto il Kazakistan sulla Thailandia. Al voto seguente il nostro paese ha ottenuto 95 voti, e l’Olanda 96. Dopo 5 votazioni i due governi si sono salomonicamente accordati salvando il salvabile.
 Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Il Consiglio di sicurezza, organo supremo dell’Onu, ha 5 membri permanenti con diritto di veto e altri dieci a rotazione di cui 5 si eleggevano appunto ieri. Com’è noto i permanenti – Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – hanno tre atout in borsa: sono i vincitori della II Guerra mondiale, son potenze nucleari, han diritto di veto. E son permanenti: lezione di evidente ingiustizia che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, esercitare il veto, imporre risoluzioni. Non di meno, essere nella banda dei 15 ha il suo peso. E’ li che si decidono (in parte) i destini del mondo, a cominciare dalle missioni dei caschi blu, carta che l’Italia poteva giocare grazie al fatto di essere un contribuente importante, per finire col al dossier rifugiati. Renzi ci teneva e ha messo in piedi la sua macchina del consenso sfruttando una vecchia scuola che si deve a Francesco Paolo Fulci, il diplomatico italiano che, negli anni Novanta, tentò il colpaccio: riformare, allargandolo, il CdS. Andò male ma il consenso sul progetto in parte era rimasto. Roma si è dunque messa in lizza e doveva vedersela con Svezia e Olanda, due Paesi non così minori come sembra. Il primo in particolare è un grande donatore, motivo per il quale l’Italia ha rilanciato sui fondi per la cooperazione aumentandoli e creando l’Agenzia che, seppur “indirizzata” da un viceministro ad hoc (Mario Giro), agisce ora in autonomia e, si spera, con meccanismi più rapidi e meno farraginosi. Ma la cooperazione è solo uno dei tanti aspetti. Roma ha puntato sul suo ruolo di Paese cerniera nel Mediterraneo e sul suo attivismo in Libia, se non altro rivendicando di aver messo il cappello sull’opera di mediazione a sostegno del nuovo governo faticosamente insediato nel pasticcio libico dove, dopo un primo momento di imbaldanzimento interventista, l’Italia ha frenato mettendo da parte per ora velleità belliciste. Non era bastato.
Difficile dire se nel colloquio di due giorni fa con Angela Merkel Renzi abbia toccato il tema con un partner molto sensibile al nodo CdS e le cui mire per un posto al sole nel Gran Consiglio dell’Onu sono da sempre evidenti. Ma certo Renzi ci ha lavorato in questi mesi, convinto forse che un successo all’estero di Gentiloni potesse servire a smorzare polemiche e scontento verso il suo governo e dentro il suo partito. Non c’è, a quanto si sa, una riedizione del progetto Fulci ma la conquista del seggio per un biennio è un passo importante nella stanza dei bottoni anche se le decisioni, come ben dimostra il caso siriano, si prendono a Mosca e a Washington bypassando il Palazzo di vetro, ormai sempre più relegato a ruolo di notaio.
Raccontava un diplomatico, all’epoca un giovane allievo di Paolo Fulci, come il capo delegazione imponesse ai suoi sottoposti levatacce propedeutiche a prendere il caffè con questo o quel rappresentante di Paesi “minori”. Fu Fulci a puntare sulle piccole isole per aumentare il consenso al Coffee Club, un gruppo di pressione fondato con Paesi come Egitto, Pakistan e Messico che si proponevano una riforma del Consiglio di sicurezza per strappare ai 5 “nucleari” lo strapotere che consente loro di dettar legge o di bloccarla. Nel contempo si sbarrava il passo alla Germania che mirava a diventare il sesto “grande”. Fulci perse la partita ma creò una squadra di Paesi. Per ora non è servito per vincere al primo colpo. Ma l’accordo ha salvato la faccia sia a Roma sia all’Aja.
Ancora per Kabul il Guinness dell’oppio
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
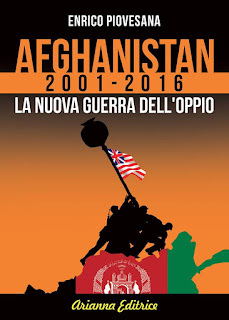 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Ancora per Kabul il Guinness dell’oppio
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
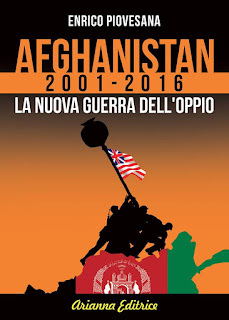 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Ancora per Kabul il Guinness dell’oppio
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
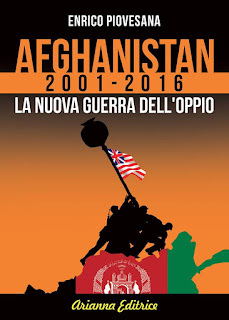 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Ancora per Kabul il Guinness dell’oppio
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
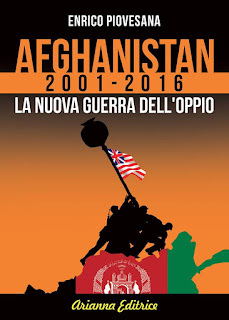 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Ancora per Kabul il Guinness dell’oppio
 L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
L’Afghanistan resta anche quest’anno in cima alla classifica dei produttori di oppiacei seguito dal Triangolo d’oro nel Sudest asiatico. Ma Kabul detiene anche la palma del maggior trasformatore di oppio in eroina. E’ in cima alla classifica per la maggior parte della produzione delle 327 tonnellate di polvere bianca che prende in gran parte la via dell’estero ma di cui una larga fetta rimane nel Paese facendo aumentare il numero di tossicodipendenti.
Sono i dati del rapporto sulle droghe del 2016 reso noto dall’Ufficio delle Nazioni Unite (Unodc) che monitora lo stato del pianeta e l’attività criminale relativa al commercio degli stupefacenti. Il rapporto si concentra su un uso generico che riguarderebbe un adulto su venti, ossia un quarto di miliardo di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno fatto uso di droghe almeno una volta nel corso del 2014. Il dato dice che in termini relativi si assiste a uno stallo per cui il numero dei tossicodipendenti non è aumentato con l’aumentare della popolazione globale. Tuttavia, dice l’Unodc, si stima che 29 milioni di persone che fanno uso di droghe soffrano di disturbi connessi all’uso di stupefacenti e, di questi, 12 milioni sono persone che le droghe le iniettano: tra loro il 14% risulta sieropositivo. E dunque, conclude il rapporto «l’impatto del consumo di droga in termini di conseguenze sulla salute continua ad essere devastante». Con una stima di 207.400 decessi per droga nel 2014, corrispondenti a 43,5 morti per milione di persone di età compresa tra i 15 e i 64, il numero delle vittime sembra comunque stabile in tutto il mondo: i decessi per overdose contribuiscono a oltre un terzo di tutti le vittime di un eccesso e sono attribuibili nella maggior parte dei casi all’uso di oppiacei.
 Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
Anche la produzione di papavero ha visto comunque un calo: le stime globali indicano che la produzione di oppio illecito ha registrato un forte calo nel 2015 (del 38 per cento) con un totale di 4.770 tonnellate, lo stesso livello della fine degli anni Novanta. Di questa quantità, si stima che siano stati trasformati in eroina circa 327 tonnellate, in gran parte da eroina prodotta in Afghanistan. Nel 2015, l’area totale della coltivazione del papavero da oppio in tutto il mondo è diminuita dell’11 per cento rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 281.000 ettari coltivati: questo declino sarebbe principalmente il riflesso di un calo nella coltivazione in Afghanistan (-19 per cento), anche se, con 183.000 ettari, l’Afghanistan ha rappresentato quasi due terzi della superficie totale coltivata illecitamente a oppio. Il Myanmar rappresenta il 20 per cento (55.500 ha) del totale, seguito da Messico (9%) e Laos (2%) Il calo in Afghanistan è soprattutto il risultato di una minor produzione (-48 per cento rispetto all’anno precedente), principalmente attribuibile alla scarsa resa stagionale nelle province meridionali del Paese.
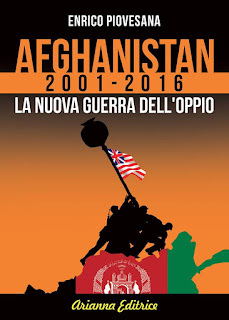 La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
La stampa in Afghanistan ha dato risalto alla notizia che il Paese resta di gran lunga ancora il più grande produttore di oppio al mondo, con una produzione che rappresenta circa il 70 per cento del totale globale. Secondo il World Drug Report del 2016 il valore totale dell’economia oppiacea illecita in Afghanistan è stato di $ 2.8 miliardi di dollari nel 2014 – pari al 13 per cento del prodotto interno lordo del paese (Pil) – ma il ministero afgano che si occupa della lotta al narcotraffico stima che il giro d’affari prodotto dal commercio di droghe sia pari a 70 miliardi di dollari di dollari all’anno, in calo però di quasi $ 9 miliardi.
Sulle cause della diffusione dell’oppio afgano si è interrogato il giornalista Enrico Piovesana che nel suo recente “Afghanistan, la nuova guerra dell’oppio” (Arianna Ed.) traccia un forte parallelo tra conflitto e produzione di oppiacei ed eroina: non solo talebani, conclude Piovesana, ma anche l’accordo coi signori della guerra e della terra per renderseli stabili alleati. Piovesana punta l’indice sugli americani, colpevoli di una politica del doppio binario: lotta alla droga ma di fatto sostegno a chi la produce (i padroni della terra, non certo i contadini). La sua inchiesta viaggia nelle zone del Sud del Paese dove l’oppio diventa un meccanismo folle tanto quanto il conflitto. Che anche di oppiacei si alimenta.
Un fotografo… per strada
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Un fotografo… per strada
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Un fotografo… per strada
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Un fotografo… per strada
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Un fotografo… per strada
 |
| Una delle immagini di Mario scelte per la mostra |
Il Veregra Street Festival (18-25 giugno) e il Comune di Montegranaro presentano la Mostra ”Dondero, fotografo di strada” per ricordare l’arte del grande fotoreporter Mario Dondero, fermano di adozione, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Molti sono stati negli anni i legami di Mario Dondero con la città di Montegranaro, frequentazioni, amicizie e collaborazioni. La mostra – inaugura oggi, il 19 giugno, alle sette di sera – è stata allestita in collaborazione con la fototeca provinciale di Altidona e l’associazione Philosofarte.
Ho scritto per il catalogo, con altri, un piccolo ritratto di Mario che posto qui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se c’è un tratto che contraddistingue Mario Dondero e il suo modo di fotografare il teatro di strada, è che la strada resta l’elemento centrale. Mario Dondero è stato un “fotografo di strada”, il luogo prediletto delle sue scorribande e il teatro naturale dove si svolge la commedia umana: tutti i santi giorni, a tutte le ore, con un evento speciale che ne segna il percorso o con la normalità quotidiana di chi attraversa il mondo per andare al lavoro, bere un piccolo caffè, fare la spesa. I fotografi amano la strada ma molti di loro si concentrano su un particolare o le preferiscono i luoghi chiusi. Mario aveva sempre, oseremmo dire, la necessità di far sì che la strada non fosse mai semplicemente uno scenario ma semmai un contesto. Persino nei ritratti, dove Mario il contesto lo restituisce perché nessuno dei sui soggetti possa restarne avulso. Non che Mario abbia disdegnato i luoghi chiusi e, del resto, le case non son forse un prolungamento della strada? Luoghi ridotti dello spazio dove comunque si gioca la partita individuale e collettiva dell’umanità? Ma l’oggetto privilegiato dal suo obiettivo era la strada. In uno dei nostri primi incontri mi portò appunto su una stradella di campagna che da Fermo conduce in cima a un colle da cui lo sguardo spazia sul mare, il porto laggiù e quel formicolare di attività umana che si muove, da lontano, come uno sciame dai movimenti piccoli e impercettibili. Sì, perché l’altro elemento che Mario amava della strada erano i suoi attori umani o animali. Difficile trovare nel repertorio di Dondero qualche immagine naturalistica, qualche “bel paesaggio”, qualche tramonto suggestivo. C’è sempre un uomo, un toro, un cane, una famigliola, un mare di persone che manifestano e, come nel caso di queste belle immagini, gli attori che raccontano il mondo nelle strade. Chi meglio di Mario per restituire i loro movimenti?
La strada è stata nella vita di Mario la cartucciera per i suoi scatti. Ho compiuto con lui così tanti
viaggi in automobile da pensare che forse è più il tempo passato on the road (c’è del resto un libro su Mario che si intitola Donderoad) che non quello passato in qualche casa – la sua, la mia, quelle di amici – a conversare. La strada offriva sempre qualche spunto. Disdegnando le autostrade percorrevamo gli interni ancora intatti di un Paese attraversato da strisce di asfalto anonime dove gli autogrill rappresentano la premonizione di una vita da trascorrere nei centri commerciali e in cui, se viaggi da Milano a Palermo, il paesaggio resta quasi anonimo, accompagnato da un grigio guardrail e viadotti tutti uguali o da quei fessi che ti si piazzan dietro a flasshare gli abbaglianti chiedendo strada. Sulle provinciali, le comunali, le vicinali è tutta un’altra storia. Quando lavorammo sul porto di Genova, gli facevo da aiutante e autista e sceglievamo sempre di fare quella strada che da Piacenza, lungo la Val Trebbia, passa per Bobbio e, dopo il passo della Scoffera, scende sulla capitale ligure. Scoprimmo che lungo la discesa al mare c’era un paesino di quattro case che si chiama Donderi e così ci andammo, inerpicando la macchina lungo una specie di tratturo, perché Mario voleva scoprire qualche elemento che riconducesse il luogo alle radici del suo cognome. Sbarcammo in un villaggetto che aveva ancora un antichissimo fienile di legno, alcune case molte delle quali abbandonate e un vecchio pensionato che prendeva il primo sole. Mario parlò col vecchio e scattò qualche foto ma non venne a capo della liaison col suo cognome. Tornammo in strada, verso Genova, chiudendo quel minuscolo capitolo della sua storia fotografica e personale. Son quelle immagini, chissà dove riposte, il luogo dove la grande protagonista resta la strada e il suo teatro. Con i misteri – non sempre risolti – legati ai nomi e ai cognomi dei suoi attori e delle sue comparse e forse non meno vivaci del teatro di strada rappresentato dagli scatti di questo catalogo.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Dopo Orlando: oltre la pista islamo qaedo daeshista. Le armi in pugno
 La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
La piaga della diffusione di pistole e fucili tra i privati. Negli Usa sono 89 ogni cento abitanti. La percentuale più alta del pianeta
Negli Stati Uniti ogni giorno in media 36 persone vengono uccise da armi da fuoco. La metà di loro sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; un terzo sono giovanissimi con meno di 20 anni. Per aggiungere un altro dato, tra queste trentasei vittime quotidiane (il bilancio esclude i suicidi), nel 2015 circa il 50% sono stati afroamericani che rappresentano solo il 6% della popolazione. E son stati proprio i controversi omicidi di afroamericani ad aver rialimentato, negli ultimi 12 mesi, il dibattito e la polemica sulla diffusione delle armi in America.
Anche la strage di Orlando ha finito, per forza di cose, per riportare il problema del possesso diffuso di armi nel dibattito pre elettorale. Ma l’insieme dei commenti, in America e altrove, sembra prestare poca attenzione al fatto che gli Stati Uniti sono il Paese dove circola liberamente il maggior numero di piccole (e grandi) armi del pianeta. La ricerca del “lupo solitario”, della pista islamo qaedo daeshista o dei motivi, materiali o psicologici, che spingono qualcuno ad ammazzare uomini come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti e con la quale anche Obama ha perso un’altra battaglia. Se però si dà un’occhiata alle tabelle, i dati parlano chiaro. I Paesi dove si muore di più per colpa di un’arma da fuoco sono quelli in guerra: Afghanistan o Irak ma, appena dopo le nazioni in conflitto, appaiono gli Usa. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey– circa 875 milioni di armi leggere (pistole, fucili, carabine e mitragliatrici), prodotte da oltre un migliaio di aziende in circa cento Paesi per un giro d’affari di circa sei miliardi di dollari all’anno. Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte
 «La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
«La maggior parte delle armi da fuoco in circolazione sul pianeta – scrive il ricercatore Maged Srour in un saggio preparato per Archivio Disarmo (Gli Stati Uniti e le armi da fuoco) – è in possesso di privati». Non tutti “legalmente a posto” ovviamente. Il rapporto è più o meno di 26mila armi in mano alla polizia, 200mila tra le braccia dei soldati e… 650mila nelle tasche dei civili. Gli Usa detengono la palma. Scrive Srour: «Gli Stati Uniti sono allo stesso tempo il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco ad uso civile. Secondo una delle più recenti analisi, gli Stati Uniti hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi ogni 100 abitanti su un totale di 270 milioni di armi in circolazione nel Paese. Di fatto, è oltre il 40% in più rispetto a quello che si ha in Yemen, secondo solo agli Stati Uniti con 54,8 armi da fuoco ogni 100 abitanti». Ovviamente l’equazione “molte armi molti omicidi” non è per forza diretta: abbiamo visto il caso afgano o iracheno che sono Paesi in guerra, e il rapporto cita ad esempio il caso dell’Honduras dove, nel 2012, il tasso di omicidi con armi da fuoco è stato di 68,43 ogni 100mila abitanti mentre negli Stati Uniti era di 2,97. Non di meno «…il tasso di omicidi con armi da fuoco negli Usa è 20 volte maggiore rispetto a quello medio registrato tra tutti i Paesi dell’area Ocse (Messico escluso). Ciò vuol dire – conclude Srour – che in America del Nord si verificano omicidi con armi da fuoco più che in ogni altro Paese sviluppato».
Uno studio della Boston University per altro, rileva che in realtà esiste una “correlazione positiva” tra diffusione di armi e numero di omicidi perpetrati con armi. Lo studio conclude che ogni 1% di incremento nella proporzione di possesso domestico di armi da fuoco, si è tradotto in un incremento dello 0,9% del tasso di omicidi.
L’indagine di Srour affronta anche il tema “sparatorie di massa” (mass shootings), situazioni nelle quali quattro o più persone sono colpite e/o uccise da armi da fuoco in un singolo evento, alla stessa ora e nello stesso luogo. Negli Usa se ne sono verificate nel 2015 in circa 100 aree metropolitane. Sociologi e psicologi si possono sbizzarrire ma riportiamo qui quello che il Procuratore Generale della California ha sottolineato alcuni anni fa in un suo rapporto: il rischio elevato che la presenza di un’arma da fuoco in una casa “problematica” porti a un incidente “fatale”.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Nucleare: guerra diplomatica tra India e Pakistan per un posto nel Nsg
 |
| Il Gruppo raccoglie 51 Paesi (in rosso) tra cui l’Italia clicca per ingrandire |
C’è un nuovo conflitto, per fortuna solo diplomatico e a colpi di lettere e non di missili, che oppone per l’ennesima volta India e Pakistan. C’entra il nucleare, la bomba, i sistemi di difesa a tecnologia nucleare e, ovviamente, le grandi potenze che, a colpi di veto – chi per una parte chi per l’altra – attizzano una brace mai spenta tra le due cugine uscite dal sanguinoso parto gemellare del 1947 quando venne diviso il Raj britannico.
L’oggetto del contendere si chiama Nuclear Suppliers Group (Nsg), che è un gruppo di Paesi che hanno a che vedere con materiali e tecnologie legate al nucleare (ne fa parte anche l’Italia) che cercano di impedirne la proliferazione controllando l’esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie che possano essere utilizzate per fabbricare armi letali. Il Nsg è stato fondato in risposta al test nucleare indiano del maggio 1974 e il primo incontro del gruppo è avvenuto nel mese di novembre del 1975. Ora, a distanza di quarant’anni, gli Stati Uniti, che con l’India hanno da dieci anni un accordo sul nucleare civile che fece all’epoca imbestialire i pachistani, appoggiano la candidatura di Delhi che vuole entrare a far parte del consesso formato da 51 Paesi. Islamabad si è inalberata chiedendo a Washington, con cui è alleata nella guerra al terrore, di appoggiare anche la sua di candidatura: la guerra in conto terzi ha visto gli Usa fare melina e i cinesi, sponsor del Pakistan, porre il veto sulla candidatura indiana.
Bocce ferme? Si, ma tensione alta e non si vede perché entrambi i Paesi non possano entrare nel gruppo, un modo per favorire la distensione. Il Pakistan, che di solito fa la parte del paria o dello Stato semi fallito, questa volta sembra aver tutte le ragioni. E, a ben vedere, il Paese dei puri – reo di aver sviluppato, come l’India, l’atomica a scopi bellici e fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) – avance distensive ne ha già fatte: in passato Islamabad ha mandato a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato. Sarebbe interessante sapere quel è la poszione dell’Italia se la vicenda marò (siamo buoni amici di entrambi i Paesi) non ostacola. L’ingresso di entrambi nel Nsg sarebbe infatti una buona notizia per tutti.
Great Game 2016-06-13 15:54:00
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
Bangladesh, caccia agli islamisti
 |
| Il Califfo di Daesh e il progetto Bangladesh, In concoirrenza con Aqis |
L’ondata di omicidi mirati di miscredenti, atei, blogger, attivisti lgbt non accenna diminuire in Bangladesh dove venerdi è stato ucciso Nitya Ranjan Pandey, di 60 anni, un volontario che lavorava in un monastero hindu nel distretto di Pabna, cinque ore di macchina a Ovest della capitale. Daesh ha rivendicato attraverso l’agenzia Amaq, monitorata dal Site Intelligence Group.
Nel giro di un mese, tre appartenenti a minoranze sono stati uccisi: un sacerdote hindu, Ananda Gopal Ganguly, di 70 anni, il proprietario cristiano di un negozio – Sunil Gomes di 60 – e, a metà maggio, un monaco buddista di 75, Mongsowe U Chak, ucciso nel tempio dove viveva solo nel Sud del Paese. Il nuovo omicidio avviene mentre già la polizia del Bangladesh ha messo in piedi una caccia agli islamisti che avrebbe già visto fermi e arresti di almeno 1800 persone. La caccia all’uomo è mirata soprattutto a due gruppi fuori legge – Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb) e Ansarullah Bangla Team (Abt) – ma anche agli attivisti di un partito legale, la Jamaat-e-Islami, la più vasta e importante organizzazione islamista del Bangladesh. La caccia è in realtà cominciata in grande stile dopo assassinio, alcuni giorni fa, di Mahmuda Aktar, la giovane moglie di un investigatore di polizia impegnato nelle indagini sui movimenti jihadisti che colpiscono attivisti e minoranze. Mahmuda è stata uccisa a Chittagong, la seconda città del Bangladesh, davanti al figlioletto di sei anni. Sarebbe stata giustiziata proprio per il lavoro del marito, legato alle indagini che cercano di capire chi è dietro all’uccisione di laici e sacerdoti, minoranze e omosessuali, blogger e attivisti. In particolare il marito indagava sul Jmb, gruppo islamista messo al bando nel 2005 e che vorrebbe fare del Bangladesh un Paese governato dalla sharia. Si ispirerebbero ai talebani afgani e avrebbero simpatie per Al Qaeda anche se il 10 giugno Ansar al-Islam (Aai) – la “divisione” bangladese di Al Qaeda nel Subcontinente indiano (Aqis), costola di Al Qaeda in Asia sudorientale – ha emesso un comunicato di condanna dell’azione ai danni della donna. Un elemento che complica il quadro tra gli islamisti stessi, divisi tra simpatie qaediste e ammirazione per Daesh, in un reticolo di sigle e secessioni interne.
 Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Il governo reagisce come sempre, col pugno duro da un lato e con la negazione che Daesh esista dall’altro anche se, ricordava ieri Al Jazeera, su una trentina di attentati quest’anno (nel mirino anche le minoranze sciite o altre ritenute apostate dagli islamisti) Daesh ne avrebbe rivendicate 21 e Al Qaeda la maggior parte delle restanti. Daesh ha anche rivendicato l’assassinio di stranieri come nel caso degli italiani Cesare Tavella e Piero Parolari, quest’ultimo salvatosi per miracolo.
Per il governo laico della premier Sheikh Hasina, la responsabilità è comunque di gruppi locali e non di emanazioni del Califfato. Sui gruppi fuorilegge il governo ha scelto il pugno di ferro da tempo: sui militanti di Abt c’è una taglia di 23mila dollari e recentemente cinque sospettati di appartenere a Jmb sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze dell’ordine mentre sei dei suoi leader sono stati impiccati nel 2007 dopo che l’organizzazione aveva messo a punto, nel 2005, l’esplosione in un solo giorno di 500 bombe, il che rende bene l’idea della loro capacità logistico organizzativa. Ma il pugno duro non sembra sufficiente né è detto che l’ondata di quasi duemila arresti possa fermare quella che sembra una deriva che consente comunque a questi gruppi di colpire indiscriminatamente i loro bersagli.
Quanto ciò significhi una forza reale di Aqis o di Daesh resta da vedere. I due gruppi si guardano in cagnesco – come in altre aree del pianeta – anche se hanno progetti vagamente simili in cui vorrebbero avere la supremazia nel movimento islamista. Il problema vero resta forse la galassia attorno alla Jamaat, nata nel 1941 quando esisteva ancora l’India britannica e che era contraria sia alla Partition sia alla Muslim League, allora la più importante organizzazione musulmana. Oggi è un partito legale anche se nel 2013 la Suprema Corte ha cancellato la sua registrazione come partito in quanto contraria all’indipendenza del Paese del 1971.
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
A Sudest del Califfo. Il progetto Daesh in Asia orientale*
 |
| Il primo numero di “Asia” inserto mensile de il manifesto uscito l’8 giugno |
Proprio mentre l’esercito iracheno, martedi scorso, iniziava la sua offensiva su Falluja nel tentativo di dare un’altra spallata a Daesh in Medio Oriente, dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, l’esercito di Manila si dava da fare nella medesima direzione. E assestava un duro colpo al gruppo islamista “Maute”, dal nome della famiglia che lo ha creato a partire da una secessione dal Fronte islamico Moro di liberazione (Milf), una delle più antiche guerriglie secessioniste dell’arcipelago. I Maute, che avevano assaltato in febbraio un centro dell’esercito nel Lanao del Sur, la loro roccaforte nell’isola di Mindanao, avrebbero lasciato sul terreno una cinquantina di militanti provenienti da campi d’addestramento dove i prigionieri, scambiati per denaro quando non vengono decapitati, vivrebbero vestiti d’arancio come nelle galere di Daesh e il gruppo sventolerebbe volentieri la bandiera nera del Califfo. Ma è difficile capire quanto le notizie sian figlie della propaganda e quanto forti siano questi emuli dello Stato islamico. In genere, a Oriente del subcontinente indiano, si tende a negare o a esagerare la presenza di Daesh, un “partito” che – in leasing, per adesione ideologica o per comodità di sigla – appare e sparisce seguendo in parte le sorti della Casa madre in Siria o in Iraq. Un progetto sudorientale di Daesh comunque esiste e parrebbe voler ricalcare la diffusione dell’islam in questa parte di mondo asiatico. Vediamolo Paese per Paese, dal Bangladesh all’Australia.
Bangladesh
L’ex Bengala pachistano e, prima ancora, una parte rilevante del Bengala indobritannico, è un luogo tormentato dove ingiustizia sociale e povertà sono un ottimo humus per i gruppi radicali. Daesh ha rivendicato l’assassinio dell’italiano Cesare Tavella e del giapponese Kunio Hoshi oltre all’attentato al sacerdote italiano Piero Parolari ma il governo nega che il Califfato abbia basi nel Paese. Le simpatie però sono abbastanza accertate per lo meno per il gruppo Jamaat ul Mujahidden Bangladesh, autore di attentati anche contro gli sciiti locali, e lo stendardo nero potrebbe aver contagiato alcuni rami giovanili ultraradicali vicini alla Jamaat-e-Islami, il partito islamista per eccellenza. Poi c’è il gruppo Ansarullah Bangla Team che è però molto più vicino all’Aquis o Al Qaeda nel subcontinete indiano, il progetto “orientale” di Al Zawahiri. Il quadro è confuso ma quel che è certo è che esiste una politica di omicidi mirati: blogger, attivisti per i diritti lgbt, laici o atei, monaci o preti non musulmani. Dabiq, la rivista ideologica di Daesh, ha dedicato spazio al Bangladesh ma non fa menzione dei gruppi che si sarebbero associati allo Stato islamico.
Nell’ex Birmania non esiste certo un pericolo Daesh e nemmeno un’emergenza qaedista. La bandiera islamista è semmai agitata come spauracchio dai gruppi oltranzisti buddisti che se la sono presa soprattutto coi Rohingya, una minoranza musulmana diffusa ai confini occidentali del Paese: perseguitata e senza diritti, spesso vittima di pogrom. Se Daesh avesse un progetto anche in questa roccaforte dell’Illuminato potrebbe far leva sulla disperazione dei Rohingya, troppo deboli però per lottare e che preferiscono lasciare il Paese emigrando sulle carrette del mare locali.
Thailandia
Si era pensato anche a Daesh quando, nell’agosto scorso, un attentato nel centro di Bangkok ha ucciso una ventina di persone. Poi le indagini han puntato altrove e anche altre segnalazioni son rimaste lettera morta. Per ora non c’è traccia di Daesh in Thailandia anche se per Bangkok il movimento islamico autonomista del Sud rimane un pericolo e si teme che un possibile bacino di reclutamenti siano le aree di Satun, Songkhla Yala, Pattani e Narathiwat, le cinque province dove vive una minoranza musulmana per lo più di origine malese: circa il 5 % dei 68 milioni di tailandesi per l’80% thai e per il 95% buddisti. La storia è vecchia, anzi antica. Yala, Pattani e Narathiwat – aree, che con altre oggi sotto la Malaysia, formavano il sultanato semi indipendente di Pattani dal 1909 definitivamente tailandese – sono le province più turbolente: è lì che, nella seconda metà del Novecento, son cresciuti i primi movimenti indipendentisti anche se si deve arrivare al 2001 per vedere un risveglio recente del separatismo. A quel risveglio il governo, nel 2005 (e dopo una durissima repressione), ha risposto con la legge marziale e, un anno dopo, con i pieni poteri all’esercito. Alternando bastone a carota, Bangkok ha ricompensato nel 2012 i familiari delle vittime di un’ondata di violenze che, benché non abbia più visto azioni eclatanti, non è affatto diminuita. Il Bangkok Post, nel 2012, ha reso note le stime delle vittime di quasi dieci anni di guerra: otre 5.200 morti e quasi 9mila feriti. Tra i decessi: 4.215 civili, 351 soldati, 280 poliziotti, sette monaci e 242 “sospetti insorgenti”. Una conflitto infinito che potrebbe attirare il sedicente Califfato.
Malaysia e Singapore
Da un paio d’anni Daesh avrebbe istituito in Siria un’unità malese-indonesiana chiamata Khatibah Nusantara e una scuola di formazione per ragazzi che parlano malese/indonesiano (sostanzialmente lo stesso idioma). I materiali in questa lingua girano sul web e i governi han preso contromisure pesanti. In Malaysia ci sono state decine di arresti anche preventivi e recenti grazie a una nuova legge anti terrorismo che consente manette facili. La Prevention of Terrorism Act (Pota) è stata duramente contesta perché è la fotocopia di una vecchia legge abolita nel 2012 e si aggiunge ad altre misure preventive che consentono, ad esempio, la revoca del passaporto. In gennaio del resto, il premier della Malaysia Najib Razak ha messo in guardia sul pericolo “reale” rappresentato da Daesh nella federazione. Nella piccola città Stato di Singapore, i numeri restano invece minimi: una paio di famiglie soltanto sarebbero state “coinvolte” da Daesh.
Filippine
Nelle Filippine le cose son forse più complicate: nelle isole meridionali, dove è forte il sentimento
indipendentista, lo stallo nel negoziato tra governo e separatisti islamici ha finito per lasciar spazio ai gruppi islamisti più marginali e agguerriti che spesso sconfinano nel banditismo. E’ il caso della famosa Abu Sayyaf (Brando divino) o dei Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, che in un video hanno dichiarato l’adesione a Daesh. Poi c’è il gruppo dei fratelli Maute in un groviglio di sigle e siglette che spesso coprono taglieggiamenti e sequestri a scopo estorsivo. Quanto i legami con gli uomini di Raqqa siano forti e reali resta dunque da dimostrare, ma certo l’area dove sono attivi da anni gruppi e gruppetti guerriglieri si presta a nascondigli e campi di addestramento. I numeri però restano piccoli e sarebbero un centinaio i filippini che han scelto la via siriana. Il nuovo presidente appena eletto – Rody Duterte – potrebbe scegliere il pugno ancora più duro rispetto a quanto fatto sinora.
Indonesia
A metà gennaio esplosioni e morti sbattono Daesh in prima pagina a Giacarta, la capitale indonesiana, ma l’episodio, che sembrava la miccia di una nuova stagione del terrore, non ha avuto seguito. Prima di Natale la polizia indonesiana aveva arrestato un gruppo di probabili affiliati a Daesh responsabili di un piano per colpire la capitale e altre città. Piano che sarebbe stato, e il condizionale resta d’obbligo, finanziato direttamente con risorse siriane. Poi gli attentati a Giacarta hanno riacceso l’attenzione mentre già si era diffusa la notizia che Abu Bakar Bashir – l’uomo che si pensò fosse dietro la strage di Bali del 2002, emulazione asiatica della Torri gemelle – avesse giurato fedeltà a Daesh, cosa che il suo gruppo – Jamaah Ansharaut Tauhid – avrebbe confermato. Ma è anche vero che proprio quel supposto giuramento, che Bashir avrebbe fatto in prigione durante una preghiera collettiva, ha creato scompiglio nelle file sella sua organizzazione e, pare, abbia dato adito a una scissione. Si segnala qualche manifestazioni pubblica di sostegno a Daesh – come quella organizzata a Giacarta dal gruppo Islamic Sharia Activists Forum (Faksi) – e alcune centinaia di indonesiani sono andati in Siria ma i numeri restano relativamente piccoli e la repressione è dura: chi è andato in Medio Oriente col fucile non può più tornare a casa e il controllo è affidato a un reparto d’élite – Densus 88 – che non risparmia il pugno di ferro e che usa, per le sue indagini, metodi molto opinabili.
Australia
L’Australia non è musulmana ma è terra d’immigrazione. Oltre un centinaio i reclutati da Daesh, alcune decine dei quali hanno perso la vita in Medio Oriente. Oggi, se si è legati a gruppi terroristici, si perde la doppia nazionalità e l’eccesso di zelo non manca. Quando il governo ha messo nel mirino il gruppo islamista non violento Hizb ut Tahir, c’è chi l’ha tacciato di paranoia. Ma tutto sommato il Califfato non sembra aver grande futuro nel quinto continente.
* Questo articolo è uscito l’8 giugno sull’inserto Asia de il manifesto, una preziosa iniziativa iniziata con questa pubblicazione che è la prima di un appuntamento mensile
Il lavoro nero dei siriani in Turchia: adulti e bambini
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
Il lavoro nero dei siriani in Turchia: adulti e bambini
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
Il lavoro nero dei siriani in Turchia: adulti e bambini
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
Il lavoro nero dei siriani in Turchia: adulti e bambini
 Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
Per gli studenti italiani oggi è l’ultimo giorno di scuola. Via libri e quaderni e grandi sorrisi verso le vacanze. Ma non è così per tutti. Non è così per chi da anni non va a scuola o non ci è mai andato. E non è così per chi ci andava e adesso non ci può andarci più anche se almeno è riuscito a mettere in salvo la propria vita. Il caso dei bambini siriani in Turchia, alle porte di casa nostra, racconta una realtà con numeri impressionanti: prima della guerra il 99% delle bambine e dei bambini siriani andava alle elementari e 8 su dieci fra loro proseguivano alle secondarie. Oggi, secondo l’Unicef, tre milioni di bambini siriani – fuori e dentro il Paese – a scuola non ci vanno più. Quella che era una grande conquista della Siria è oggi un cumulo di macerie come buona parte del Paese.
I più “fortunati” sono in Turchia, nei campi profughi allestiti da Ankara grazie al buon cuore peloso degli europei che i siriani li vogliono vivi ma lontani dagli occhi e dal cuore. Almeno in teoria, tutti i profughi della guerra siriana avrebbero diritto all’accesso al sistema scolare nazionale (che comunque presenta problemi di inserimento, dalla lingua alla logistica, al costo del materiale didattico). Ma non è proprio così. Se è vero – dice Human Rights Watch – che nei campi profughi il 90% dei bimbi siriani va a scuola, il numero non è di per sé rassicurante. La maggior parte dei bambini siriani vive infatti fuori dai campi in una situazione dove anche le più elementari regole dell’asilo vengono violate con più facilità: secondo Hrw, tra il 2014 e il 2015 la stima poteva essere del 25%, ossia un bambino su quattro. Grosso modo, a fine 2015, andava a scuola meno di un terzo dei 700mila bambini in età scolare entrati in Turchia negli ultimi quattro anni: 215mila bambini. E gli altri?
 E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
E’ ancora Hrw a illuminarci con una serie di interviste a famiglie di rifugiati in Turchia: che fanno i ragazzi? Lavorano. Dove? Fabbriche di abbigliamento o di frutta liofilizzata, laboratori per produzione di calzature, officine di meccanici, lavori stagionali in agricoltura come braccianti o raccoglitori di frutta. Ce n’è anche per le strade, a vendere stoffe, frutta, acqua. La polizia chiude un occhio. E lo facciamo anche noi pur se non volontariamente. Non è simpatico, ma i bambini siriani – e, quando riescono, i loro genitori – lavorano in produzioni che arrivano sui nostri mercati. Una storia che ormai si ripete quasi per tutto ma che questa volta è davvero dolorosa. Il meccanismo è semplice e lo spiega un padre di 38 anni con sei figli che abita a Smirne: suo figlio di 12 anni a scuola non ci va. Cuce borse in un negozio turco. «Lavora cinque giorni e mezzo alla settimana e guadagna 500 lire turche al mese (circa 170 euro) – spiega il padre di Ahmed, 12 anni, agli intervistatori di Hrw – Io voglio mandare i miei figli più giovani a scuola l’anno prossimo ma ho bisogno dell’aiuto di Ahmed. Se lui non lavora noi non mangiamo». Niente scuola per Ahmed. Se lui non lavora la famiglia salta il pasto.
Il regime di Protezione Temporanea garantito dalle autorità turche ai rifugiati siriani è l’accordo che, sulla carta, li dovrebbe proteggere e garantire. Lo fa in un certo senso ma fino a un certo punto. I diritti cioè sono garantiti ma fino a dove? E quello sul lavoro non lo è per niente. Secondo l’Ong Business & Human Rights Resource Centre, circa 2,2 milioni di siriani vivono in Siria ma solo 4mila fra loro hanno un regolare permesso di lavoro. A complicare le cose ci si mette la concorrenza dei turchi poveri che convive con una percentuale di disoccupazione del 10%. Si stima dunque che tra 250 e 400mila siriani lavorino illegalmente, senza cioè uno status regolare, il che li rende ricattabili ed estremamente vulnerabili. In una parola pronti ad accettare qualsiasi cosa. Adulti o bambini che siano.
Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da nascondere. Una stima precisa di quanti siano non esiste. Secondo un rapporto dell’Unicef del 2014, l’impatto della guerra siriana aveva gettato sul mercato del lavoro in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia almeno un bambino siriano su dieci. Le statistiche turche dicono che sono poco meno di un milione i bambini – turchi e non turchi – che lavorano sotto l’età minima consentita che è per legge 15 anni. 300mila fra loro avrebbero tra i 6 e i 14 anni. Il problema – rileva Hrw – è che queste statistiche non sono attendibili. I bambini al lavoro e non a scuola sono molti di più. Come nota giustamente l’Unicef, il problema del lavoro minorile o dei “bambini di strada” non si può risolvere solo studiando la cosa in sé ma «osservando i problemi a casa o nella scuola che spesso forzano i bambini ad andare per strada…il lavoro minorile è l’effetto chiaro di una vulnerabilità causata da povertà e privazioni». Non si elimina l’uno senza l’altro. Il problema è che in Turchia, come abbiamo detto, è difficile lavorare per un adulto: le Temporary Protection Regulation in realtà non regolano affatto ciò che un siriano può fare nel mercato del lavoro. E se non si può lavorare legalmente, se è difficile o impossibile ottenere un permesso di lavoro, si lavora nel mercato illegalmente. Grandi e piccoli.
Business & Human Rights Resource Centre ha cercato di vederci chiaro specie in relazione ai prodotti che vengono creati da questo mercato di manodopera illegale, adulta o infantile. La sua indagine Syrian refugees in Turkish garment supply chains su 28 marchi di abbigliamento che lavorano con la Turchia, rivela che molto pochi tra loro stanno prendendo misure adeguate per garantire che i rifugiati siriani non lavorino in condizioni di sfruttamento. Quattordici aziende non hanno nemmeno risposto al questionario inviato dalla Ong. Per loro il problema non esiste.
Il dossier spiega in dettaglio che solo tre “firme” si sono impegnate con le fabbriche in outsourcing per quel che riguarda il trattamento dei rifugiati e che in realtà – “lontano dagli occhi e dal cuore” – le aziende tendono a limitarsi a qualche raccomandazione senza in realtà controllare. I più virtuosi però si sono anche messi in contatto con organizzazioni della società civile (le campagne alla fine funzionano!), che conoscono bene i problemi locali di discriminazione dei gruppi più vulnerabili. Ma quel che manca è una vera azione di pressione sul governo che pure ha firmato tutti gli accordi internazionali dell’Ufficio del Lavoro delle Nazioni Unite. Forse una pressione che spetterebbe ai governi.
Bambini siriani, un’iniziativa a Milano l’8 giugno alla Camera del Lavoro
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
Bambini siriani, un’iniziativa a Milano l’8 giugno alla Camera del Lavoro
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
Bambini siriani, un’iniziativa a Milano l’8 giugno alla Camera del Lavoro
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
Bambini siriani, un’iniziativa a Milano l’8 giugno alla Camera del Lavoro
 Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Si deve all’iniziativa personale di un’insegnante milanese che da anni si occupa di dialogo e integrazione tra i bimbi della scuola, l’invito a fare dell’8 giugno (domani) un giorno simbolico. Non solo l’ultimo giorno di scuola per gli scolari italiani ma “il primo giorno di liberazione per questi bambini e bambine che hanno già perso tutto nella guerra”. Sono i bambini siriani “prigionieri” della solidarietà pelosa dell’Europa e dell’aiuto interessato della Turchia nei campi profughi al confine col conflitto. Scrive Arcangela Mastromarco nell’invito (vedi sotto le adesioni*) che si rifà a quanto già rivelato dall’organizzazione no profit Business and Human Rights Resource (BHRRC) nel report Syrian refugees in Turkish garment supply chains: “Non possiamo accettare che ai piccoli profughi siriani, schiavi bambini che lavorano fino a 12 ore al giorno, venga rubata l’infanzia, il diritto di andare a scuola, di giocare, disegnare, correre, stare insieme agli amici”. Il rapporto rivela che tra 250 e 400mila siriani lavorano illegalmente e senza diritti in Turchia (tra cui anche bambini) in una condizione che viene sfruttata anche da firme europee più o meno direttamente.
Le iniziativa sono in realtà due: un incontro alla Camera del Lavoro di Milano (Corso di Porta Vittoria 43) mercoledì 8 giugno, dalle ore 18.00. E un’azione di mailbombing nei confronti dell’ambasciata turca e dei profili sui social con il seguente testo “Fermate immediatamente lo sfruttamento dei bambini profughi siriani nel vostro Paese”
– Ambasciatore a Roma Aydin Adnan Sezgin [email protected]
– Console generale a Milano Hami Aksoy [email protected]
– https://www.facebook.com/ambasciataturchia
*Albatros, Amici del Parco Trotter, Amnesty International, ANPI Crescenzago, Asnada, Associazione Fiorella Ghilardotti, Crinali, Codici, Comitato Genitori della Casa del Sole, Emergency Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc CGIL Milano, IBVA-Centro Italiano per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per Emergenza profughi, La Grande Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mamme a scuola onlus, Mondo Aperto Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, Terrenuove, Villapallavicini
Cina: Diritti come scarpe vecchie
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
Cina: Diritti come scarpe vecchie
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
Cina: Diritti come scarpe vecchie
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
Cina: Diritti come scarpe vecchie
 Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
Con oltre 15,7 miliardi di paia di scarpe confezionate nel solo 2014, la Cina è il maggior produttore
mondiale di calzature e l’Unione Europea è, a sua volta, il più grande mercato di sbocco dei prodotti in cuoio e calzaturieri del Celeste impero. Scarpe che vengono e che vanno: cuoio, suole, tomaie, cuciture, prodotti finiti e semilavorati. Loro là noi qua, ma le scarpe su cui camminiamo, le borsette o i giacconi di cuoio che indossiamo, hanno spesso una componente cinese anche se sono «Made in Italy». Chiedersi come e in che condizioni lavora il più grande mercato mondiale delle scarpe non è dunque peregrino. Lo abbiamo fatto con le magliette, i palloni, i tappeti, le tennis. Adesso un’alleanza internazionale di 18 organizzazioni, che ha lanciato la campagna Change Your Shoes, cerca di vedere oltre confine. Perché i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto a un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure. E perché i consumatori sappiano su cosa camminano.
Non è la prima indagine della Campagna che ha già condotto ricerche in India, Indonesia, Europa dell’Est, Italia e Turchia. Questa volta un dossier – Tricky Footwork. The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry – punta i riflettori sulla Cina, sulla base di un’inchiesta realizzata a fine 2015 tra i lavoratori di tre fabbriche della provincia di Guangdong curata dall’organizzazione tedesca Südwind. Il rapporto denuncia una situazione allarmante dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani per chi lavora nella grande fabbrica asiatica di scarpe.
L’indagine non è stata facile e si basa in gran parte su interviste che confermano come nell’industria cinese del cuoio e delle calzature le violazioni delle leggi sul lavoro siano diffuse. E così le punizioni: un verniciatore è stato licenziato dopo 5 anni di lavoro nei giorni seguenti a uno sciopero. «Mentre scioperavamo – racconta un altro – la polizia ci ha aizzato i cani contro, istigandoli a mordere». Gli intervistati, che lavorano in stabilimenti che producono per conto di noti marchi europei (come Adidas, Clarks, Ecco), segnalano retribuzioni basse (400 euro al mese circa) e orari faticosi (una media di oltre 10 ore al giorno) con straordinari obbligatori, sicurezza inadeguata, tutele insufficienti per i più giovani, maltrattamenti e divieto di riunirsi in assemblea, repressione degli scioperi, contributi previdenziali non versati, liquidazioni insufficienti.
Le donne poi sono un capitolo a parte: solo la metà degli intervistati ha riferito che alle donne è concessa l’aspettativa per maternità e per alcune di loro, nel periodo di assenza dal lavoro, lo stipendio è stato calcolato sul minimo anziché sulla media salariale come stabilisce per legge. Donne e uomini non sarebbero poi trattati allo stesso modo senza contare le denunce di abusi verbali.
Ma ciò che colpisce della situazione cinese – che raccontata così non differisce molto da quella di altri Paesi dell’area – è che le condizioni di lavoro degli operai del settore sono in contrasto con le leggi sul lavoro, in Cina molto avanzate. Soprattutto, nota il rapporto, se il confronto lo si fa a con quelle di altri Paesi produttori. Per legge infatti i lavoratori godono di molte tutele – anche se non della libertà di riunione e associazione – e inoltre quasi tutti i grandi marchi delle calzature hanno adottato codici di condotta per un maggior controllo dei fornitori.
 |
| La provincia del Guandong in Cina: centro manufatturiero |
Una spiegazione la dà Deborah Lucchetti, coordinatrice di Abiti Puliti che aderisce alla Campagna: «Il settore delle calzature è molto dinamico e la Cina gioca un ruolo fondamentale nella rete di fornitura globale che assegna ai veri Paesi funzioni produttive diverse. Questo porta a una competizione senza regole che sacrifica i diritti dei lavoratori e ostacola processi di emancipazione nelle fabbriche». Anche a discapito delle regole che evidentemente subiscono pochi controlli in nome del motto «arricchitevi» che in realtà non è ancora stato sostituito dal nuovo trend cinese la cui parola d’ordine sarebbe «armonia». Nelle fabbriche del Guangdong sembra ce ne sia pochina.
Per mettere assieme il dossier sono stati intervistati 47 lavoratori di tre calzaturifici del Guangdong, una delle aree più densamente industrializzate del Paese e centro della produzione di scarpe. Lo studio termina con una serie di raccomandazioni per favorire miglioramenti di natura sociale e ambientale nell’industria cinese di cuoio e calzature, settore che ha conosciuto una crescita record ma che ha anche ignorato alcuni standard internazionali di tutela come quelli indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Documenta però un dato positivo: una maggiore capacità di organizzazione dei lavoratori e di conseguenza conquiste ottenute attraverso diverse forme di lotta.
India e Pakistan. Paura della bomba.
 La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
Le tensioni tra i due Paesi, al di là delle guerre (1947-1965-1971) o degli “incidenti” (Kargil 1999), non sono mai mancate neppure in tempo di pace. Una pace armata. Nel 1986 ad esempio, l’Operation Brasstacks, condotta dall’India in Rajastan al confine occidentale col Pakistan, mette immediatamente Islamabad in allarme: Delhi del resto, in quelle che ha annunciato come normali “esercitazioni”, ha schierato 600mila uomini e tutto il dispositivo della marina e dell’aeronautica. Una sorta di prova generale in caso di attacco al Pakistan. A Islamabad fanno i conti. Delhi può colpire le centrali pachistane in 3 minuti, i pachistani in 8. La tensione è alle stelle. Non è la prima volta. Non sarà l’ultima. Nel 1988, sui due fronti, si assiste a una dimostrazione di forza: cinque esplosioni nucleari in India l’11 maggio seguite da altrettante in Pakistan il 28 e da una sesta il 30. Il confronto fortunatamente rientrerà, scongiurando uno scontro tra i due colossi nucleari, ma l’episodio segna indelebilmente i rapporti tra i due Paesi che, nel 2001 con l’attacco al parlamento indiano, e nel 2008, dopo gli attentati nel cuore di Bombay, tornano a farsi bollenti: la guerra, fortunatamente solo diplomatica, agita più o meno apertamente lo spauracchio del first strike nucleare. Soprattutto nel 2001 lo spettro di un conflitto con la possibilità dell’uso di testate nucleari (circa un centinaio a testa), diventerà una possibilità reale per mesi e sarà la diplomazia internazionale a raffreddare gli animi di due Paesi retti allora da governi forti (il dittatore militare Musharraf in Pakistan) e molto nazionalisti (il Bjp al governo di Delhi). Da allora la tensione si è allentata ma il processo di riconciliazione tra i due Paesi continua ad essere in alto mare mentre non rallenta la corsa agli armamenti, un pericolo che, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche la Russia, vorrebbero scongiurare.
 Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Se quella della simmetria nucleare tra India e Pakistan è la prima preoccupazione (è difficile stabilire quale delle due potenze abbia la maggior capacità di offesa) è emersa negli ultimi anni una nuova questione: ossia la possibilità che in un Paese dove la minaccia terroristica è elevata, un’eventuale vittoria dei jihadisti doti l’islam radicale della bomba nell’unica nazione a maggioranza musulmana che la possieda. Ovviamente si tratta di un pericolo teorico anche se molto temuto (recentemente ribadito da un rapporto dell’Harvard Kennedy School): attualmente la catena di comando in caso di conflitto nucleare è condivisa e porta alla National Command Authority cui è a capo il primo ministro e che è formata da cinque ministri coadiuvati dal capo di Stato maggiore dell’esercito e dai quattro comandanti delle forze armate (terra, mare, cielo, corpi speciali). Durante l’epoca di Zia – un dittatore di ispirazione islamista – la preoccupazione poteva forse essere legittima anche se il generale si limitò a usare lo spauracchio nucleare contro l’India. E’ anche vero però che Al Qaeda ha studiato un possibile piano di sviluppo dell’arma nucleare e Daesh potrebbe fare altrettanto, utilizzando infiltrati nel programma nucleare o sfruttando i legami con settori deviati dei servizi. Fittizia o reale che sia l’ipotesi, gli Stati Uniti si sono mossi per cercare un accordo simile a quello siglato con l’India proprio per attenuare le tensioni tra i due Paesi asiatici e per garantire un maggior controllo internazionale sul nucleare pachistano e sulla possibilità che sia copiato da terzi. C’è dell’altro.
.
Il Pakistan è in effetti molto corteggiato, in primis dall’Arabia saudita, proprio per la sua capacità offensiva nucleare. Quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra i due Paesi: la presenza del Pakistan a fianco di Riad significa di fatto per i sauditi poter contare sulla capacità nucleare del Pakistan, anche solo per utilizzarla come deterrente.
 Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
India e Pakistan. Paura della bomba.
 La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
Le tensioni tra i due Paesi, al di là delle guerre (1947-1965-1971) o degli “incidenti” (Kargil 1999), non sono mai mancate neppure in tempo di pace. Una pace armata. Nel 1986 ad esempio, l’Operation Brasstacks, condotta dall’India in Rajastan al confine occidentale col Pakistan, mette immediatamente Islamabad in allarme: Delhi del resto, in quelle che ha annunciato come normali “esercitazioni”, ha schierato 600mila uomini e tutto il dispositivo della marina e dell’aeronautica. Una sorta di prova generale in caso di attacco al Pakistan. A Islamabad fanno i conti. Delhi può colpire le centrali pachistane in 3 minuti, i pachistani in 8. La tensione è alle stelle. Non è la prima volta. Non sarà l’ultima. Nel 1988, sui due fronti, si assiste a una dimostrazione di forza: cinque esplosioni nucleari in India l’11 maggio seguite da altrettante in Pakistan il 28 e da una sesta il 30. Il confronto fortunatamente rientrerà, scongiurando uno scontro tra i due colossi nucleari, ma l’episodio segna indelebilmente i rapporti tra i due Paesi che, nel 2001 con l’attacco al parlamento indiano, e nel 2008, dopo gli attentati nel cuore di Bombay, tornano a farsi bollenti: la guerra, fortunatamente solo diplomatica, agita più o meno apertamente lo spauracchio del first strike nucleare. Soprattutto nel 2001 lo spettro di un conflitto con la possibilità dell’uso di testate nucleari (circa un centinaio a testa), diventerà una possibilità reale per mesi e sarà la diplomazia internazionale a raffreddare gli animi di due Paesi retti allora da governi forti (il dittatore militare Musharraf in Pakistan) e molto nazionalisti (il Bjp al governo di Delhi). Da allora la tensione si è allentata ma il processo di riconciliazione tra i due Paesi continua ad essere in alto mare mentre non rallenta la corsa agli armamenti, un pericolo che, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche la Russia, vorrebbero scongiurare.
 Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Se quella della simmetria nucleare tra India e Pakistan è la prima preoccupazione (è difficile stabilire quale delle due potenze abbia la maggior capacità di offesa) è emersa negli ultimi anni una nuova questione: ossia la possibilità che in un Paese dove la minaccia terroristica è elevata, un’eventuale vittoria dei jihadisti doti l’islam radicale della bomba nell’unica nazione a maggioranza musulmana che la possieda. Ovviamente si tratta di un pericolo teorico anche se molto temuto (recentemente ribadito da un rapporto dell’Harvard Kennedy School): attualmente la catena di comando in caso di conflitto nucleare è condivisa e porta alla National Command Authority cui è a capo il primo ministro e che è formata da cinque ministri coadiuvati dal capo di Stato maggiore dell’esercito e dai quattro comandanti delle forze armate (terra, mare, cielo, corpi speciali). Durante l’epoca di Zia – un dittatore di ispirazione islamista – la preoccupazione poteva forse essere legittima anche se il generale si limitò a usare lo spauracchio nucleare contro l’India. E’ anche vero però che Al Qaeda ha studiato un possibile piano di sviluppo dell’arma nucleare e Daesh potrebbe fare altrettanto, utilizzando infiltrati nel programma nucleare o sfruttando i legami con settori deviati dei servizi. Fittizia o reale che sia l’ipotesi, gli Stati Uniti si sono mossi per cercare un accordo simile a quello siglato con l’India proprio per attenuare le tensioni tra i due Paesi asiatici e per garantire un maggior controllo internazionale sul nucleare pachistano e sulla possibilità che sia copiato da terzi. C’è dell’altro.
.
Il Pakistan è in effetti molto corteggiato, in primis dall’Arabia saudita, proprio per la sua capacità offensiva nucleare. Quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra i due Paesi: la presenza del Pakistan a fianco di Riad significa di fatto per i sauditi poter contare sulla capacità nucleare del Pakistan, anche solo per utilizzarla come deterrente.
 Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
India e Pakistan. Paura della bomba.
 La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
Le tensioni tra i due Paesi, al di là delle guerre (1947-1965-1971) o degli “incidenti” (Kargil 1999), non sono mai mancate neppure in tempo di pace. Una pace armata. Nel 1986 ad esempio, l’Operation Brasstacks, condotta dall’India in Rajastan al confine occidentale col Pakistan, mette immediatamente Islamabad in allarme: Delhi del resto, in quelle che ha annunciato come normali “esercitazioni”, ha schierato 600mila uomini e tutto il dispositivo della marina e dell’aeronautica. Una sorta di prova generale in caso di attacco al Pakistan. A Islamabad fanno i conti. Delhi può colpire le centrali pachistane in 3 minuti, i pachistani in 8. La tensione è alle stelle. Non è la prima volta. Non sarà l’ultima. Nel 1988, sui due fronti, si assiste a una dimostrazione di forza: cinque esplosioni nucleari in India l’11 maggio seguite da altrettante in Pakistan il 28 e da una sesta il 30. Il confronto fortunatamente rientrerà, scongiurando uno scontro tra i due colossi nucleari, ma l’episodio segna indelebilmente i rapporti tra i due Paesi che, nel 2001 con l’attacco al parlamento indiano, e nel 2008, dopo gli attentati nel cuore di Bombay, tornano a farsi bollenti: la guerra, fortunatamente solo diplomatica, agita più o meno apertamente lo spauracchio del first strike nucleare. Soprattutto nel 2001 lo spettro di un conflitto con la possibilità dell’uso di testate nucleari (circa un centinaio a testa), diventerà una possibilità reale per mesi e sarà la diplomazia internazionale a raffreddare gli animi di due Paesi retti allora da governi forti (il dittatore militare Musharraf in Pakistan) e molto nazionalisti (il Bjp al governo di Delhi). Da allora la tensione si è allentata ma il processo di riconciliazione tra i due Paesi continua ad essere in alto mare mentre non rallenta la corsa agli armamenti, un pericolo che, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche la Russia, vorrebbero scongiurare.
 Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Se quella della simmetria nucleare tra India e Pakistan è la prima preoccupazione (è difficile stabilire quale delle due potenze abbia la maggior capacità di offesa) è emersa negli ultimi anni una nuova questione: ossia la possibilità che in un Paese dove la minaccia terroristica è elevata, un’eventuale vittoria dei jihadisti doti l’islam radicale della bomba nell’unica nazione a maggioranza musulmana che la possieda. Ovviamente si tratta di un pericolo teorico anche se molto temuto (recentemente ribadito da un rapporto dell’Harvard Kennedy School): attualmente la catena di comando in caso di conflitto nucleare è condivisa e porta alla National Command Authority cui è a capo il primo ministro e che è formata da cinque ministri coadiuvati dal capo di Stato maggiore dell’esercito e dai quattro comandanti delle forze armate (terra, mare, cielo, corpi speciali). Durante l’epoca di Zia – un dittatore di ispirazione islamista – la preoccupazione poteva forse essere legittima anche se il generale si limitò a usare lo spauracchio nucleare contro l’India. E’ anche vero però che Al Qaeda ha studiato un possibile piano di sviluppo dell’arma nucleare e Daesh potrebbe fare altrettanto, utilizzando infiltrati nel programma nucleare o sfruttando i legami con settori deviati dei servizi. Fittizia o reale che sia l’ipotesi, gli Stati Uniti si sono mossi per cercare un accordo simile a quello siglato con l’India proprio per attenuare le tensioni tra i due Paesi asiatici e per garantire un maggior controllo internazionale sul nucleare pachistano e sulla possibilità che sia copiato da terzi. C’è dell’altro.
.
Il Pakistan è in effetti molto corteggiato, in primis dall’Arabia saudita, proprio per la sua capacità offensiva nucleare. Quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra i due Paesi: la presenza del Pakistan a fianco di Riad significa di fatto per i sauditi poter contare sulla capacità nucleare del Pakistan, anche solo per utilizzarla come deterrente.
 Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
India e Pakistan. Paura della bomba.
 La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
La firma del presidente Bush suggella, nel dicembre del 2006, l’accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. E’ un accordo che consente al governo indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano in fatto di tecnologie avanzate. L’iter ha richiesto diversi mesi ma alla fine Delhi e Washington si dicono soddisfatte. E’ una capitolo centrale della politica asiatica in tema di armamento nucleare, in un continente dove l’atomica fa parte del patrimonio militare cinese e russo ma il nucleare “illegale”, ossia fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), conta almeno quattro Paesi (India, Pakistan, Corea del Nord e Israele). Per India e Pakistan la bomba è comunque una realtà dichiarata e rivendicata in un equilibrio precario che, con l’accordo del 2006, assiste a un’accelerazione. Pechino e Islamabad hanno seguito l’iter dell’accordo con apprensione: i pachistani soprattutto. L’equilibrio del terrore, garantito dal possesso dell’atomica, è sempre stato il filo rosso sul quale si è giocata la partita tra India e Pakistan, gemelli separati nel 1947 dalla Partition dell’India britannica. E Islamabad si sente sempre un passo indietro.
Le tensioni tra i due Paesi, al di là delle guerre (1947-1965-1971) o degli “incidenti” (Kargil 1999), non sono mai mancate neppure in tempo di pace. Una pace armata. Nel 1986 ad esempio, l’Operation Brasstacks, condotta dall’India in Rajastan al confine occidentale col Pakistan, mette immediatamente Islamabad in allarme: Delhi del resto, in quelle che ha annunciato come normali “esercitazioni”, ha schierato 600mila uomini e tutto il dispositivo della marina e dell’aeronautica. Una sorta di prova generale in caso di attacco al Pakistan. A Islamabad fanno i conti. Delhi può colpire le centrali pachistane in 3 minuti, i pachistani in 8. La tensione è alle stelle. Non è la prima volta. Non sarà l’ultima. Nel 1988, sui due fronti, si assiste a una dimostrazione di forza: cinque esplosioni nucleari in India l’11 maggio seguite da altrettante in Pakistan il 28 e da una sesta il 30. Il confronto fortunatamente rientrerà, scongiurando uno scontro tra i due colossi nucleari, ma l’episodio segna indelebilmente i rapporti tra i due Paesi che, nel 2001 con l’attacco al parlamento indiano, e nel 2008, dopo gli attentati nel cuore di Bombay, tornano a farsi bollenti: la guerra, fortunatamente solo diplomatica, agita più o meno apertamente lo spauracchio del first strike nucleare. Soprattutto nel 2001 lo spettro di un conflitto con la possibilità dell’uso di testate nucleari (circa un centinaio a testa), diventerà una possibilità reale per mesi e sarà la diplomazia internazionale a raffreddare gli animi di due Paesi retti allora da governi forti (il dittatore militare Musharraf in Pakistan) e molto nazionalisti (il Bjp al governo di Delhi). Da allora la tensione si è allentata ma il processo di riconciliazione tra i due Paesi continua ad essere in alto mare mentre non rallenta la corsa agli armamenti, un pericolo che, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche la Russia, vorrebbero scongiurare.
 Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Il programma nucleare pachistano inizia nel 1972 quando al potere c’è Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir e l’uomo che il generale-dittatore Zia ul Haq farà impiccare. Bhutto è un civile, modernista e di idee socialiste, ma teme la supremazia militare dell’India, il vicino che è grande quattro volte più del Pakistan e il cui programma nucleare è iniziato nel 1967. Bhutto darà l’incarico di preparare la bomba a Munir Ahmad Khan, a capo della Pakistan Atomic Energy Commission dal 1972 al 1991 e che aveva già coperto un posto di rilievo nell’International Atomic Energy Agency (Aiea). Il premier pachistano la vuole entro quattro anni, impresa che però riuscirà solo ad Abdul Qadeer Khan – il padre del Progetto Kahuta e dell’atomica pachistana – nel 1984, due anni prima – non a caso – dell’operazione Brasstacks. Nell’88 Islamabad è in grado di fare i primi test. Attualmente la preoccupazione pachistana è legata all’attesa che l’India sviluppi definitivamente il suo primo sottomarino nucleare il che ha già portato il Paese dei puri a lavorare su un simile progetto. Non è un mistero che la tecnologia che riguarda il nucleare provenga in buona parte dalla Cina, la principale alleata del Pakistan nel quadrante, anche se Pechino ha sempre smentito.
Se quella della simmetria nucleare tra India e Pakistan è la prima preoccupazione (è difficile stabilire quale delle due potenze abbia la maggior capacità di offesa) è emersa negli ultimi anni una nuova questione: ossia la possibilità che in un Paese dove la minaccia terroristica è elevata, un’eventuale vittoria dei jihadisti doti l’islam radicale della bomba nell’unica nazione a maggioranza musulmana che la possieda. Ovviamente si tratta di un pericolo teorico anche se molto temuto (recentemente ribadito da un rapporto dell’Harvard Kennedy School): attualmente la catena di comando in caso di conflitto nucleare è condivisa e porta alla National Command Authority cui è a capo il primo ministro e che è formata da cinque ministri coadiuvati dal capo di Stato maggiore dell’esercito e dai quattro comandanti delle forze armate (terra, mare, cielo, corpi speciali). Durante l’epoca di Zia – un dittatore di ispirazione islamista – la preoccupazione poteva forse essere legittima anche se il generale si limitò a usare lo spauracchio nucleare contro l’India. E’ anche vero però che Al Qaeda ha studiato un possibile piano di sviluppo dell’arma nucleare e Daesh potrebbe fare altrettanto, utilizzando infiltrati nel programma nucleare o sfruttando i legami con settori deviati dei servizi. Fittizia o reale che sia l’ipotesi, gli Stati Uniti si sono mossi per cercare un accordo simile a quello siglato con l’India proprio per attenuare le tensioni tra i due Paesi asiatici e per garantire un maggior controllo internazionale sul nucleare pachistano e sulla possibilità che sia copiato da terzi. C’è dell’altro.
.
Il Pakistan è in effetti molto corteggiato, in primis dall’Arabia saudita, proprio per la sua capacità offensiva nucleare. Quando l’anno scorso il Pakistan si è rifiutato di mandare le sue forze armate nello Yemen o quando Islamabad si è dimostrata fredda all’appello di Riad nicchiando sulla sua partecipazione alla grande coalizione contro il terrorismo nata con evidenti intenzioni anti-iraniane, per i sauditi si è trattato di uno schiaffo che ha turbato le tradizionalmente solide relazioni tra i due Paesi: la presenza del Pakistan a fianco di Riad significa di fatto per i sauditi poter contare sulla capacità nucleare del Pakistan, anche solo per utilizzarla come deterrente.
 Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
Il futuro per ora non sembra promettere grandi sorprese. I rapporti con l’India restano tesi benché il premier indiano Narendra Modi, la cui politica interna non si può dire certo aperta verso la minoranza musulmana indiana, abbia visitato il Pakistan. Il test indiano dell’11 maggio di un avanzato intercettatore balistico, incidenti ripetuti lungo la frontiera (lunga oltre duemila chilometri), un recente attacco terroristico nella base indiana di Pathankot, la continua tensione nel Kashmir e la costruzione del sottomarino non promettono nulla di buono. Il Pakistan inoltre, se è colpevole di un mancato controllo (quando non di un’etero direzione) sui gruppi jihadisti attivi in India, ha fatto a Delhi sei proposte per un accordo bilaterale di non proliferazione – dall’adesione di entrambe le nazioni al Npt alla formazione di una South Asia Zero-Missile Zone – che gli indiani hanno finora sempre rigettato.
Alla testa della guerriglia in turbante
 |
| Haibatullah: religioso ex barccio destro di Mansur |
I Talebani hanno un nuovo leader: il mawlawi Haibatullah Akhundzada. È stato eletto ieri, probabilmente a Quetta, in Pakistan, dalla Rabhari shura, il massimo organo di indirizzo politico degli studenti coranici. La sua nomina avviene a pochi giorni dalla morte del predecessore, mullah Mohammad Akhtar Mansur, ucciso da un drone americano mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. Come vice di Haibatullah Akhundzada è stato nominato mullah Yacub, figlio dello storico leader mullah Omar e già a capo di una delle Commissioni talebane sotto la leadership di Mansur, che Yacub aveva poi finito per sostenere dopo averne contestato la nomina, nel luglio 2015; al suo fianco, ieri i barbuti hanno confermato Sirajuddin Haqqani, figlio del fondatore dell’omonimo network di islamisti, attivo dagli anni Ottanta e, oggi, tra i più pericolosi gruppi armati che operano tra Afghanistan e Pakistan, con ramificazioni economiche che arrivano nei Paesi del Golfo.
 |
| Nella scia di mullah Omar |
Le notizie su Haibatullah Akhundzada sono frammentarie, ma sufficienti a capire le ragioni della scelta: sembra che abbia 47 anni, è nato nell’area di Sperwan, distretto di Panjwayi, nella provincia meridionale afghana di Kandahar, storica roccaforte dei Talebani. Membro della potente tribù pashtun dei Noorzai, qualcuno dice che abbia combattuto i sovietici nelle file dell’Hezb-e-Islami Khalis, altri che abbia invece vissuto in Pakistan tra il 1979 e il 1989, negli anni dell’occupazione. Quel che è certo è che vanta credenziali religiose, più che militari. È infatti uno sheikh ul-hadith, un religioso autorevole, specialista nell’esegesi dei detti del profeta Maometto. Secondo Thomas Ruttig, co-direttore dell’Afghanistan Analysts Network di Kabul, Akhundzada avrebbe goduto dell’incondizionata fiducia del mullah Omar, che lo consultava per dirimere le questioni più delicate. Ha ricoperto incarichi rilevanti nel settore della Giustizia al tempo dell’Emirato islamico d’Afghanistan, e negli anni successivi ha usato la propria autorevolezza religiosa per fare propaganda, reclutare giovani guerriglieri e mediare i conflitti interni al movimento, come quelli, recenti, tra gli uomini del leader mullah Mansur e di mullah Rasul, uno degli “scissionisti” (poi arrestato dai pachistani) che contestava la nomina di Mansur.
Con la nomina di Akhundzada, uomo della vecchia guardia, conosciuto e rispettato, simbolo della matrice “kandaharì” da cui è nato il movimento negli anni Novanta, i Talebani puntano alla continuità, a una figura di “compromesso” e di mediazione. Un uomo che, con la sua autorevolezza religiosa, possa fare da collante tra le varie anime politiche, in una delicata fase di transizione iniziata nel luglio 2015, con l’annuncio della morte di mullah Omar.
 |
| La morte di Mansur sembra allontanare la pace ancora di più |
Cosa accadrà adesso è la grande domanda che si mischia a un’altra: cosa rappresentava davvero Mansur e cosa e chi rappresenta adesso Haibatullah? Se del primo si è detto tutto e il contrario di tutto (che era l’uomo del Pakistan e che invece addirittura a ucciderlo sarebbero state proprio le indicazioni dei pachistani che non lo consideravano più il loro cavallo) sul secondo circolano ipotesi altrettanto diverse. La caratura religiosa e l’origine kandahari fanno propendere per una scelta che, nella continuità, dovrà tendere a riunire un movimento da sempre disomogeneo che da anni vive ormai di faide e secessioni e ora anche della concorrenza di Daesh. L’uomo non è però noto per il suo carisma e la sua tribù, per quanto potente, lo è meno di altre e resta comunque un elemento soprattutto locale. Non si sa cosa Haibatullah pensi del processo negoziale né molto si sa dei suoi rapporti col Pakistan ma quel che è certo è che ora, ancora più di Mansur, dovrà dimostrare di essere “il capo”, il nuovo emiro dei credenti. Per farsi accettare e far accettare i suoi ordini dovrà quindi soprattutto, com’è nella logica della guerriglia, puntare sulla vittoria militare anche per dimostrare che il raid che ha ucciso Mansur va vendicato. Si dovrà dunque appoggiare agli Haqqani, la rete jihadista che è stata molto vicina ad Al Qaeda, ai servizi segreti deviati di Islamabad e ai sauditi con cui gli Haqqani hanno un rapporto antico e molto saldo. Se dunque la nomina di Yacub a vice mira a dimostrare che lo spirito di mullah Omar è al fianco di Haibatullah anche materialmente, ecco che la figura di Siraj acquista un rilievo particolare sul piano militare.
Dobbiamo dunque aspettarci una nuova offensiva talebana e per altro in un audio messaggio diffuso dal nuovo leader ai comandanti, il negoziato viene rifiutato e si inneggia invece alla lotta armata. L’offensiva dunque cui sarà anche se il capo di stato maggiore afgano, generale Qadam Shah Shahim, ha bollato di fallimento la campagna “Omari”, la cosiddetta campagna di primavera dei Talebani. Ma è un fallimento tutto da dimostrare mentre l’ennesimo attentato contro un pulmino di funzionari del ministero di Giustizia uccideva ieri dieci persone.
A quattro mani con Giuliano Battiston per il manifesto
Alla testa della guerriglia in turbante
 |
| Haibatullah: religioso ex barccio destro di Mansur |
I Talebani hanno un nuovo leader: il mawlawi Haibatullah Akhundzada. È stato eletto ieri, probabilmente a Quetta, in Pakistan, dalla Rabhari shura, il massimo organo di indirizzo politico degli studenti coranici. La sua nomina avviene a pochi giorni dalla morte del predecessore, mullah Mohammad Akhtar Mansur, ucciso da un drone americano mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. Come vice di Haibatullah Akhundzada è stato nominato mullah Yacub, figlio dello storico leader mullah Omar e già a capo di una delle Commissioni talebane sotto la leadership di Mansur, che Yacub aveva poi finito per sostenere dopo averne contestato la nomina, nel luglio 2015; al suo fianco, ieri i barbuti hanno confermato Sirajuddin Haqqani, figlio del fondatore dell’omonimo network di islamisti, attivo dagli anni Ottanta e, oggi, tra i più pericolosi gruppi armati che operano tra Afghanistan e Pakistan, con ramificazioni economiche che arrivano nei Paesi del Golfo.
 |
| Nella scia di mullah Omar |
Le notizie su Haibatullah Akhundzada sono frammentarie, ma sufficienti a capire le ragioni della scelta: sembra che abbia 47 anni, è nato nell’area di Sperwan, distretto di Panjwayi, nella provincia meridionale afghana di Kandahar, storica roccaforte dei Talebani. Membro della potente tribù pashtun dei Noorzai, qualcuno dice che abbia combattuto i sovietici nelle file dell’Hezb-e-Islami Khalis, altri che abbia invece vissuto in Pakistan tra il 1979 e il 1989, negli anni dell’occupazione. Quel che è certo è che vanta credenziali religiose, più che militari. È infatti uno sheikh ul-hadith, un religioso autorevole, specialista nell’esegesi dei detti del profeta Maometto. Secondo Thomas Ruttig, co-direttore dell’Afghanistan Analysts Network di Kabul, Akhundzada avrebbe goduto dell’incondizionata fiducia del mullah Omar, che lo consultava per dirimere le questioni più delicate. Ha ricoperto incarichi rilevanti nel settore della Giustizia al tempo dell’Emirato islamico d’Afghanistan, e negli anni successivi ha usato la propria autorevolezza religiosa per fare propaganda, reclutare giovani guerriglieri e mediare i conflitti interni al movimento, come quelli, recenti, tra gli uomini del leader mullah Mansur e di mullah Rasul, uno degli “scissionisti” (poi arrestato dai pachistani) che contestava la nomina di Mansur.
Con la nomina di Akhundzada, uomo della vecchia guardia, conosciuto e rispettato, simbolo della matrice “kandaharì” da cui è nato il movimento negli anni Novanta, i Talebani puntano alla continuità, a una figura di “compromesso” e di mediazione. Un uomo che, con la sua autorevolezza religiosa, possa fare da collante tra le varie anime politiche, in una delicata fase di transizione iniziata nel luglio 2015, con l’annuncio della morte di mullah Omar.
 |
| La morte di Mansur sembra allontanare la pace ancora di più |
Cosa accadrà adesso è la grande domanda che si mischia a un’altra: cosa rappresentava davvero Mansur e cosa e chi rappresenta adesso Haibatullah? Se del primo si è detto tutto e il contrario di tutto (che era l’uomo del Pakistan e che invece addirittura a ucciderlo sarebbero state proprio le indicazioni dei pachistani che non lo consideravano più il loro cavallo) sul secondo circolano ipotesi altrettanto diverse. La caratura religiosa e l’origine kandahari fanno propendere per una scelta che, nella continuità, dovrà tendere a riunire un movimento da sempre disomogeneo che da anni vive ormai di faide e secessioni e ora anche della concorrenza di Daesh. L’uomo non è però noto per il suo carisma e la sua tribù, per quanto potente, lo è meno di altre e resta comunque un elemento soprattutto locale. Non si sa cosa Haibatullah pensi del processo negoziale né molto si sa dei suoi rapporti col Pakistan ma quel che è certo è che ora, ancora più di Mansur, dovrà dimostrare di essere “il capo”, il nuovo emiro dei credenti. Per farsi accettare e far accettare i suoi ordini dovrà quindi soprattutto, com’è nella logica della guerriglia, puntare sulla vittoria militare anche per dimostrare che il raid che ha ucciso Mansur va vendicato. Si dovrà dunque appoggiare agli Haqqani, la rete jihadista che è stata molto vicina ad Al Qaeda, ai servizi segreti deviati di Islamabad e ai sauditi con cui gli Haqqani hanno un rapporto antico e molto saldo. Se dunque la nomina di Yacub a vice mira a dimostrare che lo spirito di mullah Omar è al fianco di Haibatullah anche materialmente, ecco che la figura di Siraj acquista un rilievo particolare sul piano militare.
Dobbiamo dunque aspettarci una nuova offensiva talebana e per altro in un audio messaggio diffuso dal nuovo leader ai comandanti, il negoziato viene rifiutato e si inneggia invece alla lotta armata. L’offensiva dunque cui sarà anche se il capo di stato maggiore afgano, generale Qadam Shah Shahim, ha bollato di fallimento la campagna “Omari”, la cosiddetta campagna di primavera dei Talebani. Ma è un fallimento tutto da dimostrare mentre l’ennesimo attentato contro un pulmino di funzionari del ministero di Giustizia uccideva ieri dieci persone.
A quattro mani con Giuliano Battiston per il manifesto
Alla testa della guerriglia in turbante
 |
| Haibatullah: religioso ex barccio destro di Mansur |
I Talebani hanno un nuovo leader: il mawlawi Haibatullah Akhundzada. È stato eletto ieri, probabilmente a Quetta, in Pakistan, dalla Rabhari shura, il massimo organo di indirizzo politico degli studenti coranici. La sua nomina avviene a pochi giorni dalla morte del predecessore, mullah Mohammad Akhtar Mansur, ucciso da un drone americano mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. Come vice di Haibatullah Akhundzada è stato nominato mullah Yacub, figlio dello storico leader mullah Omar e già a capo di una delle Commissioni talebane sotto la leadership di Mansur, che Yacub aveva poi finito per sostenere dopo averne contestato la nomina, nel luglio 2015; al suo fianco, ieri i barbuti hanno confermato Sirajuddin Haqqani, figlio del fondatore dell’omonimo network di islamisti, attivo dagli anni Ottanta e, oggi, tra i più pericolosi gruppi armati che operano tra Afghanistan e Pakistan, con ramificazioni economiche che arrivano nei Paesi del Golfo.
 |
| Nella scia di mullah Omar |
Le notizie su Haibatullah Akhundzada sono frammentarie, ma sufficienti a capire le ragioni della scelta: sembra che abbia 47 anni, è nato nell’area di Sperwan, distretto di Panjwayi, nella provincia meridionale afghana di Kandahar, storica roccaforte dei Talebani. Membro della potente tribù pashtun dei Noorzai, qualcuno dice che abbia combattuto i sovietici nelle file dell’Hezb-e-Islami Khalis, altri che abbia invece vissuto in Pakistan tra il 1979 e il 1989, negli anni dell’occupazione. Quel che è certo è che vanta credenziali religiose, più che militari. È infatti uno sheikh ul-hadith, un religioso autorevole, specialista nell’esegesi dei detti del profeta Maometto. Secondo Thomas Ruttig, co-direttore dell’Afghanistan Analysts Network di Kabul, Akhundzada avrebbe goduto dell’incondizionata fiducia del mullah Omar, che lo consultava per dirimere le questioni più delicate. Ha ricoperto incarichi rilevanti nel settore della Giustizia al tempo dell’Emirato islamico d’Afghanistan, e negli anni successivi ha usato la propria autorevolezza religiosa per fare propaganda, reclutare giovani guerriglieri e mediare i conflitti interni al movimento, come quelli, recenti, tra gli uomini del leader mullah Mansur e di mullah Rasul, uno degli “scissionisti” (poi arrestato dai pachistani) che contestava la nomina di Mansur.
Con la nomina di Akhundzada, uomo della vecchia guardia, conosciuto e rispettato, simbolo della matrice “kandaharì” da cui è nato il movimento negli anni Novanta, i Talebani puntano alla continuità, a una figura di “compromesso” e di mediazione. Un uomo che, con la sua autorevolezza religiosa, possa fare da collante tra le varie anime politiche, in una delicata fase di transizione iniziata nel luglio 2015, con l’annuncio della morte di mullah Omar.
 |
| La morte di Mansur sembra allontanare la pace ancora di più |
Cosa accadrà adesso è la grande domanda che si mischia a un’altra: cosa rappresentava davvero Mansur e cosa e chi rappresenta adesso Haibatullah? Se del primo si è detto tutto e il contrario di tutto (che era l’uomo del Pakistan e che invece addirittura a ucciderlo sarebbero state proprio le indicazioni dei pachistani che non lo consideravano più il loro cavallo) sul secondo circolano ipotesi altrettanto diverse. La caratura religiosa e l’origine kandahari fanno propendere per una scelta che, nella continuità, dovrà tendere a riunire un movimento da sempre disomogeneo che da anni vive ormai di faide e secessioni e ora anche della concorrenza di Daesh. L’uomo non è però noto per il suo carisma e la sua tribù, per quanto potente, lo è meno di altre e resta comunque un elemento soprattutto locale. Non si sa cosa Haibatullah pensi del processo negoziale né molto si sa dei suoi rapporti col Pakistan ma quel che è certo è che ora, ancora più di Mansur, dovrà dimostrare di essere “il capo”, il nuovo emiro dei credenti. Per farsi accettare e far accettare i suoi ordini dovrà quindi soprattutto, com’è nella logica della guerriglia, puntare sulla vittoria militare anche per dimostrare che il raid che ha ucciso Mansur va vendicato. Si dovrà dunque appoggiare agli Haqqani, la rete jihadista che è stata molto vicina ad Al Qaeda, ai servizi segreti deviati di Islamabad e ai sauditi con cui gli Haqqani hanno un rapporto antico e molto saldo. Se dunque la nomina di Yacub a vice mira a dimostrare che lo spirito di mullah Omar è al fianco di Haibatullah anche materialmente, ecco che la figura di Siraj acquista un rilievo particolare sul piano militare.
Dobbiamo dunque aspettarci una nuova offensiva talebana e per altro in un audio messaggio diffuso dal nuovo leader ai comandanti, il negoziato viene rifiutato e si inneggia invece alla lotta armata. L’offensiva dunque cui sarà anche se il capo di stato maggiore afgano, generale Qadam Shah Shahim, ha bollato di fallimento la campagna “Omari”, la cosiddetta campagna di primavera dei Talebani. Ma è un fallimento tutto da dimostrare mentre l’ennesimo attentato contro un pulmino di funzionari del ministero di Giustizia uccideva ieri dieci persone.
A quattro mani con Giuliano Battiston per il manifesto
E’ Haibatullah Akhunzada il nuovo capo dei talebani
 Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
I giochi si riaprono (se non arriverà qualche smentita che rifletta le divisioni interne al movimento). Anche per i talebani, morto un papa se ne fa un altro.
* Secondo fonti pachistane l’attentato contro Mansur risalirebbe persino a mercoledi
E’ Haibatullah Akhunzada il nuovo capo dei talebani
 Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
I giochi si riaprono (se non arriverà qualche smentita che rifletta le divisioni interne al movimento). Anche per i talebani, morto un papa se ne fa un altro.
* Secondo fonti pachistane l’attentato contro Mansur risalirebbe persino a mercoledi
E’ Haibatullah Akhunzada il nuovo capo dei talebani
 Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
Alla fine ha vinto il pragmatismo e la necessità di non lasciare vuoti e a sostituire mullah Mansur – confermando così definitivamente la sua morte in un raid americano sabato scorso* – c’è ora il suo numero due: il mawlawi Haibatullah Akhunzada di Kandahar (tribù dei Nurzai), membro storico della shura di Quetta. Così ha spiegato un portavoce talebano (il sito ufficiale è ancora fuori uso) che ha fatto i nomi anche dei due vice di Haibatullah: si tratta di Sirajuddin Haqqani – figlio del creatore della rete che porta questo nome – e del figlio di mullah Omar, mullah Yaqub, uno fra coloro che inizialmente avevano contestato la leadership di Mansur.
I giochi si riaprono (se non arriverà qualche smentita che rifletta le divisioni interne al movimento). Anche per i talebani, morto un papa se ne fa un altro.
* Secondo fonti pachistane l’attentato contro Mansur risalirebbe persino a mercoledi
In morte di mullah Mansur*
 Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
l’evanescente mullah Omar alla guida dei Talebani è stato ucciso sabato pomeriggio da un drone americano, mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. I Talebani non hanno confermato ufficialmente la notizia, ma i più alti membri dell’amministrazione Usa e i funzionari dell’intelligence afghana si dicono certi: Mansur è stato ucciso. «Perché era l’ostacolo maggiore al processo di pace», ha dichiarato dal Myanmar il segretario di Stato Usa John Kerry, convinto che con l’uscita di scena del loro leader i Talebani siano disposti a sedersi al tavolo negoziale.
 |
| Ashraf Ghani. La svolta dopo l’ennesimo attentato |
Mullah Mansur ha faticato molto, in questi mesi, a tenere le redini del movimento. Nato nel 1960 nella provincia meridionale di Kandahar, roccaforte dei Talebani, già governatore-ombra della sua provincia di nascita e ministro dell’Aviazione civile e dei trasporti all’epoca dell’Emirato islamico d’Afghanistan, dal 2013 Mansur è il leader de facto del movimento. Da allora, ha ristabilito il primato della shura di Quetta, uno dei tre principali centri di potere talebano, sulla shura di Peshawar e su quella di Miran Shah (la rete Haqqani), marginalizzando i principali antagonisti, cooptando gli indecisi e ottenendo il controllo di buona parte dei fondi – in diminuzione – provenienti dai tradizionali sponsor regionali. La sua nomina a leader assoluto, nel luglio 2015, è stata fortemente contestata da alcuni turbanti neri, tra cui il figlio del mullah Omar, Yacub, che poi gli ha concesso l’appoggio; Qayyum Zakir, già a capo della Commissione militare; Tayyeb Aghha, che in polemica con la nomina ha lasciato l’Ufficio di rappresentanza politica di Doha, di cui era responsabile. Tutti e tre, ora, vantano le credenziali giuste per potergli succedere.
 |
| La regione beluci in Pakistan. Mansur veniva dall’Iran? |
I più accreditati rimangono gli uomini scelti nel luglio 2015 come vice di Mansur. Uno è il maulawi Haibatullah Akhundzada, religioso rispettato e autorevole, già uomo di fiducia del mullah Omar, che può vantare ottime doti da mediatore e la provenienza da Kandahar, l’area da cui proviene la “vecchia guardia” talebana. L’altro è Sirajuddin Haqqani, che dal 2005 ha sostituito il padre Jalaluddin alla guida della rete Haqqani, il network di islamisti che opera principalmente nelle province di confine tra Afghanistan e Pakistan. Capo di un vero e proprio impero finanziario, spietato sul campo di battaglia e abile negoziatore, Sirajuddin Haqqani può vantare rapporti consolidati con i servizi segreti pakistani, che di certo non rinunceranno a “esprimere” il proprio candidato.
Ma che partita si gioca dietro la presunta morte del capo talebano? Tutti guardano a Islamabad che ha condannato la violazione del suo spazio areo in Belucistan, una linea rossa oltrepassata solo in rarissimi casi dai droni statunitensi che concentrano la loro azione nelle aree tribali del Pakistan occidentale. Islamabad protesta sempre ma questa volta tutto fa supporre che non si tratti di uno sdegno di maniera. L’uomo al centro del caso è un mullah da sempre indicato come vicino al Pakistan e dunque il cavallo buono per poter controllare un possibile processo negoziale. Ora si dice, dal Pentagono alla Nato, che Mansur era invece l’impedimento principale e che dunque andava eliminato: una svolta iniziata forse nell’aprile scorso quando, dopo l’ennesima strage talebana a Kabul, il presidente afghano Ghani ha cambiato idea sul negoziato e deciso per una stretta senza esclusione di colpi contro il movimento diretto da Mansur che alla pace preferisce gli attentati. In realtà per Mansur decidere il passo negoziale, di cui qualche segnale seppur debole si è visto, richiedeva la necessità di avere alle spalle un movimento compatto diretto da una leadership forte e indiscussa. E non era questo il caso: Mansur era contestato da diverse fazioni e in rotta con elementi chiave del movimento. Sapeva che la sua leadership era tanto fragile quanto poco compatto è il movimento dei turbanti neri. La presa di Kunduz, nell’ottobre del 2015, fu la sua prima prova di forza, la necessità di dimostrare che non era da meno di mullah Omar. E del resto, se Mansur faceva la faccia dura, i suoi nemici – gli invasori americani – non son certo stati da meno: a Kunduz andando a caccia di guerriglieri colpirono un ospedale e in questi mesi – dietro la richiesta del negoziato – gli americani non hanno mai smesso i loro raid segreti sia in Afghanistan, sia in Pakistan. Attività che non conosciamo e che gli stessi afgani e pachistani vedono soltanto ex post quando a chiedere vendetta sono i parenti dei civili uccisi. Ora un raid colpisce e punisce il numero uno della guerriglia, forse l’uomo su cui Islamabad contava e forse persino il più acerrimo nemico di Daesh, vissuto da Mansur come l’ennesima minaccia alla compattezza del movimento. Missione compiuta dunque? Si, ma non certo a favore di un processo negoziale che non è affatto detto possa ripartire dopo la morte del leader talebano.
a due mani con Giuliano Battiston per il manifesto oggi in edicola
In morte di mullah Mansur*
 Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
l’evanescente mullah Omar alla guida dei Talebani è stato ucciso sabato pomeriggio da un drone americano, mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. I Talebani non hanno confermato ufficialmente la notizia, ma i più alti membri dell’amministrazione Usa e i funzionari dell’intelligence afghana si dicono certi: Mansur è stato ucciso. «Perché era l’ostacolo maggiore al processo di pace», ha dichiarato dal Myanmar il segretario di Stato Usa John Kerry, convinto che con l’uscita di scena del loro leader i Talebani siano disposti a sedersi al tavolo negoziale.
 |
| Ashraf Ghani. La svolta dopo l’ennesimo attentato |
Mullah Mansur ha faticato molto, in questi mesi, a tenere le redini del movimento. Nato nel 1960 nella provincia meridionale di Kandahar, roccaforte dei Talebani, già governatore-ombra della sua provincia di nascita e ministro dell’Aviazione civile e dei trasporti all’epoca dell’Emirato islamico d’Afghanistan, dal 2013 Mansur è il leader de facto del movimento. Da allora, ha ristabilito il primato della shura di Quetta, uno dei tre principali centri di potere talebano, sulla shura di Peshawar e su quella di Miran Shah (la rete Haqqani), marginalizzando i principali antagonisti, cooptando gli indecisi e ottenendo il controllo di buona parte dei fondi – in diminuzione – provenienti dai tradizionali sponsor regionali. La sua nomina a leader assoluto, nel luglio 2015, è stata fortemente contestata da alcuni turbanti neri, tra cui il figlio del mullah Omar, Yacub, che poi gli ha concesso l’appoggio; Qayyum Zakir, già a capo della Commissione militare; Tayyeb Aghha, che in polemica con la nomina ha lasciato l’Ufficio di rappresentanza politica di Doha, di cui era responsabile. Tutti e tre, ora, vantano le credenziali giuste per potergli succedere.
 |
| La regione beluci in Pakistan. Mansur veniva dall’Iran? |
I più accreditati rimangono gli uomini scelti nel luglio 2015 come vice di Mansur. Uno è il maulawi Haibatullah Akhundzada, religioso rispettato e autorevole, già uomo di fiducia del mullah Omar, che può vantare ottime doti da mediatore e la provenienza da Kandahar, l’area da cui proviene la “vecchia guardia” talebana. L’altro è Sirajuddin Haqqani, che dal 2005 ha sostituito il padre Jalaluddin alla guida della rete Haqqani, il network di islamisti che opera principalmente nelle province di confine tra Afghanistan e Pakistan. Capo di un vero e proprio impero finanziario, spietato sul campo di battaglia e abile negoziatore, Sirajuddin Haqqani può vantare rapporti consolidati con i servizi segreti pakistani, che di certo non rinunceranno a “esprimere” il proprio candidato.
Ma che partita si gioca dietro la presunta morte del capo talebano? Tutti guardano a Islamabad che ha condannato la violazione del suo spazio areo in Belucistan, una linea rossa oltrepassata solo in rarissimi casi dai droni statunitensi che concentrano la loro azione nelle aree tribali del Pakistan occidentale. Islamabad protesta sempre ma questa volta tutto fa supporre che non si tratti di uno sdegno di maniera. L’uomo al centro del caso è un mullah da sempre indicato come vicino al Pakistan e dunque il cavallo buono per poter controllare un possibile processo negoziale. Ora si dice, dal Pentagono alla Nato, che Mansur era invece l’impedimento principale e che dunque andava eliminato: una svolta iniziata forse nell’aprile scorso quando, dopo l’ennesima strage talebana a Kabul, il presidente afghano Ghani ha cambiato idea sul negoziato e deciso per una stretta senza esclusione di colpi contro il movimento diretto da Mansur che alla pace preferisce gli attentati. In realtà per Mansur decidere il passo negoziale, di cui qualche segnale seppur debole si è visto, richiedeva la necessità di avere alle spalle un movimento compatto diretto da una leadership forte e indiscussa. E non era questo il caso: Mansur era contestato da diverse fazioni e in rotta con elementi chiave del movimento. Sapeva che la sua leadership era tanto fragile quanto poco compatto è il movimento dei turbanti neri. La presa di Kunduz, nell’ottobre del 2015, fu la sua prima prova di forza, la necessità di dimostrare che non era da meno di mullah Omar. E del resto, se Mansur faceva la faccia dura, i suoi nemici – gli invasori americani – non son certo stati da meno: a Kunduz andando a caccia di guerriglieri colpirono un ospedale e in questi mesi – dietro la richiesta del negoziato – gli americani non hanno mai smesso i loro raid segreti sia in Afghanistan, sia in Pakistan. Attività che non conosciamo e che gli stessi afgani e pachistani vedono soltanto ex post quando a chiedere vendetta sono i parenti dei civili uccisi. Ora un raid colpisce e punisce il numero uno della guerriglia, forse l’uomo su cui Islamabad contava e forse persino il più acerrimo nemico di Daesh, vissuto da Mansur come l’ennesima minaccia alla compattezza del movimento. Missione compiuta dunque? Si, ma non certo a favore di un processo negoziale che non è affatto detto possa ripartire dopo la morte del leader talebano.
a due mani con Giuliano Battiston per il manifesto oggi in edicola
In morte di mullah Mansur*
 Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
Mullah Mansur è morto. Almeno così si crede. L’uomo che dal luglio 2015 ha sostituito
l’evanescente mullah Omar alla guida dei Talebani è stato ucciso sabato pomeriggio da un drone americano, mentre era in viaggio nel Belucistan pachistano. I Talebani non hanno confermato ufficialmente la notizia, ma i più alti membri dell’amministrazione Usa e i funzionari dell’intelligence afghana si dicono certi: Mansur è stato ucciso. «Perché era l’ostacolo maggiore al processo di pace», ha dichiarato dal Myanmar il segretario di Stato Usa John Kerry, convinto che con l’uscita di scena del loro leader i Talebani siano disposti a sedersi al tavolo negoziale.
 |
| Ashraf Ghani. La svolta dopo l’ennesimo attentato |
Mullah Mansur ha faticato molto, in questi mesi, a tenere le redini del movimento. Nato nel 1960 nella provincia meridionale di Kandahar, roccaforte dei Talebani, già governatore-ombra della sua provincia di nascita e ministro dell’Aviazione civile e dei trasporti all’epoca dell’Emirato islamico d’Afghanistan, dal 2013 Mansur è il leader de facto del movimento. Da allora, ha ristabilito il primato della shura di Quetta, uno dei tre principali centri di potere talebano, sulla shura di Peshawar e su quella di Miran Shah (la rete Haqqani), marginalizzando i principali antagonisti, cooptando gli indecisi e ottenendo il controllo di buona parte dei fondi – in diminuzione – provenienti dai tradizionali sponsor regionali. La sua nomina a leader assoluto, nel luglio 2015, è stata fortemente contestata da alcuni turbanti neri, tra cui il figlio del mullah Omar, Yacub, che poi gli ha concesso l’appoggio; Qayyum Zakir, già a capo della Commissione militare; Tayyeb Aghha, che in polemica con la nomina ha lasciato l’Ufficio di rappresentanza politica di Doha, di cui era responsabile. Tutti e tre, ora, vantano le credenziali giuste per potergli succedere.
 |
| La regione beluci in Pakistan. Mansur veniva dall’Iran? |
I più accreditati rimangono gli uomini scelti nel luglio 2015 come vice di Mansur. Uno è il maulawi Haibatullah Akhundzada, religioso rispettato e autorevole, già uomo di fiducia del mullah Omar, che può vantare ottime doti da mediatore e la provenienza da Kandahar, l’area da cui proviene la “vecchia guardia” talebana. L’altro è Sirajuddin Haqqani, che dal 2005 ha sostituito il padre Jalaluddin alla guida della rete Haqqani, il network di islamisti che opera principalmente nelle province di confine tra Afghanistan e Pakistan. Capo di un vero e proprio impero finanziario, spietato sul campo di battaglia e abile negoziatore, Sirajuddin Haqqani può vantare rapporti consolidati con i servizi segreti pakistani, che di certo non rinunceranno a “esprimere” il proprio candidato.
Ma che partita si gioca dietro la presunta morte del capo talebano? Tutti guardano a Islamabad che ha condannato la violazione del suo spazio areo in Belucistan, una linea rossa oltrepassata solo in rarissimi casi dai droni statunitensi che concentrano la loro azione nelle aree tribali del Pakistan occidentale. Islamabad protesta sempre ma questa volta tutto fa supporre che non si tratti di uno sdegno di maniera. L’uomo al centro del caso è un mullah da sempre indicato come vicino al Pakistan e dunque il cavallo buono per poter controllare un possibile processo negoziale. Ora si dice, dal Pentagono alla Nato, che Mansur era invece l’impedimento principale e che dunque andava eliminato: una svolta iniziata forse nell’aprile scorso quando, dopo l’ennesima strage talebana a Kabul, il presidente afghano Ghani ha cambiato idea sul negoziato e deciso per una stretta senza esclusione di colpi contro il movimento diretto da Mansur che alla pace preferisce gli attentati. In realtà per Mansur decidere il passo negoziale, di cui qualche segnale seppur debole si è visto, richiedeva la necessità di avere alle spalle un movimento compatto diretto da una leadership forte e indiscussa. E non era questo il caso: Mansur era contestato da diverse fazioni e in rotta con elementi chiave del movimento. Sapeva che la sua leadership era tanto fragile quanto poco compatto è il movimento dei turbanti neri. La presa di Kunduz, nell’ottobre del 2015, fu la sua prima prova di forza, la necessità di dimostrare che non era da meno di mullah Omar. E del resto, se Mansur faceva la faccia dura, i suoi nemici – gli invasori americani – non son certo stati da meno: a Kunduz andando a caccia di guerriglieri colpirono un ospedale e in questi mesi – dietro la richiesta del negoziato – gli americani non hanno mai smesso i loro raid segreti sia in Afghanistan, sia in Pakistan. Attività che non conosciamo e che gli stessi afgani e pachistani vedono soltanto ex post quando a chiedere vendetta sono i parenti dei civili uccisi. Ora un raid colpisce e punisce il numero uno della guerriglia, forse l’uomo su cui Islamabad contava e forse persino il più acerrimo nemico di Daesh, vissuto da Mansur come l’ennesima minaccia alla compattezza del movimento. Missione compiuta dunque? Si, ma non certo a favore di un processo negoziale che non è affatto detto possa ripartire dopo la morte del leader talebano.
a due mani con Giuliano Battiston per il manifesto oggi in edicola
Filippine. Settemila isole per un giustizialista
 Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Ma in queste elezioni – che sceglievano anche senatori e 18mila funzionari locali – c’è anche un’altra famiglia nota che torna: i Marcos da cui esce candidato alla vicepresidenza Bongbong, figlio dell’ex dittatore Ferdinando spodestato decenni fa dalle piazze e sostituito proprio da una Aquino (Corazon). Suo figlio Benigno, presidente uscente, ha provato così – tra un Marcos e un Dutarte – ad agitare il ritorno della dittatura. A spaventarlo era soprattutto Dutarte, tanto che il presidente ha lanciato un appello a unire le forze per batterlo. Nelle Filippine (55 milioni di aventi diritto con quest’anno un’affluenza alle urne senza precedenti) non si va al ballottaggio: vince il più forte e il vicepresidente lo sceglie il popolo non il capo dello Stato. Benigno si è in sostanza rivolto a Grace Poe, ex educatrice e business woman di provata fede cattolica, l’unica nei sondaggi ad avere, con Manuel Roxas (già nel gabinetto Aquino) qualche chance – ma non da sola – rispetto agli altri candidati (cinque in tutto) in lizza.
Poe e Roxas, il pupillo del presidente, non si sono però accordati e così anche lo spauracchio della dittatura ha finito per contare poco, pur se la Poe faceva paura: per squalificarla dal torneo elettorale, alcuni mesi fa venne prodotto un certificato falso sul suo padre naturale (Grace è figlia adottiva di due famosi attori)… che sarebbe addirittura stato Bongbong Marcos! Per metterla in difficoltà è stato tirato fuori anche il fatto che il marito ha la cittadinanza americana, in un Paese da sempre filoamericano ma dove il risentimento per il padrino padrone è sempre forte.
 |
| Il palazzo presidenziale a Manila |
Cosa c’è sul piatto del nuovo presidente? Mali atavici, riforme e tensioni col colosso cinese per quel pugno di atolli sparsi su riserve di gas naturale che da anni fanno venire il mal di pancia ai Paesi affacciati sul Mar cinese meridionale, un nome che a Pechino sembra il riconoscimento evidente che Paracels e Spratlys son roba sua. Le Filippine sono tra i Paesi col contenzioso maggiore, sia sulle Spratlys sia su Scarborough Shoal (Huangyan per i cinesi), un’area a 160 chilometri dalle coste filippine e a 500 miglia marittime dalla Cina. Nonostante uno sviluppo in crescita, l’economia resta sempre un problema per un Paese che ha cento milioni di abitanti ma anche dieci milioni di emigrati che ingrassano le casse con le loro rimesse ma che fanno del Paese uno dei più grandi fornitori di manodopera all’estero. E restano i mali atavici che han fatto coniare proprio per l’economia filippina sin dai tempi di Marcos la locuzione “crony capitalism”, capitalismo di parentela, un refrain che torna a legarsi alla tradizione delle grandi famiglie che si succedono al potere e si scambiano favori. Dutarte promette pulizia e piace forse anche perché non viene dal giro della “Imperial Manila” ma è anzi un uomo della provincia, di quell’isola di Mindanao dove è attiva la guerriglia secessionista e il processo di pace, sempre sul filo del rasoio, al momento è in fase di stallo. Un altro grattacapo per chi siederà al palazzo presidenziale di Malacañang.
Filippine. Settemila isole per un giustizialista
 Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Ma in queste elezioni – che sceglievano anche senatori e 18mila funzionari locali – c’è anche un’altra famiglia nota che torna: i Marcos da cui esce candidato alla vicepresidenza Bongbong, figlio dell’ex dittatore Ferdinando spodestato decenni fa dalle piazze e sostituito proprio da una Aquino (Corazon). Suo figlio Benigno, presidente uscente, ha provato così – tra un Marcos e un Dutarte – ad agitare il ritorno della dittatura. A spaventarlo era soprattutto Dutarte, tanto che il presidente ha lanciato un appello a unire le forze per batterlo. Nelle Filippine (55 milioni di aventi diritto con quest’anno un’affluenza alle urne senza precedenti) non si va al ballottaggio: vince il più forte e il vicepresidente lo sceglie il popolo non il capo dello Stato. Benigno si è in sostanza rivolto a Grace Poe, ex educatrice e business woman di provata fede cattolica, l’unica nei sondaggi ad avere, con Manuel Roxas (già nel gabinetto Aquino) qualche chance – ma non da sola – rispetto agli altri candidati (cinque in tutto) in lizza.
Poe e Roxas, il pupillo del presidente, non si sono però accordati e così anche lo spauracchio della dittatura ha finito per contare poco, pur se la Poe faceva paura: per squalificarla dal torneo elettorale, alcuni mesi fa venne prodotto un certificato falso sul suo padre naturale (Grace è figlia adottiva di due famosi attori)… che sarebbe addirittura stato Bongbong Marcos! Per metterla in difficoltà è stato tirato fuori anche il fatto che il marito ha la cittadinanza americana, in un Paese da sempre filoamericano ma dove il risentimento per il padrino padrone è sempre forte.
 |
| Il palazzo presidenziale a Manila |
Cosa c’è sul piatto del nuovo presidente? Mali atavici, riforme e tensioni col colosso cinese per quel pugno di atolli sparsi su riserve di gas naturale che da anni fanno venire il mal di pancia ai Paesi affacciati sul Mar cinese meridionale, un nome che a Pechino sembra il riconoscimento evidente che Paracels e Spratlys son roba sua. Le Filippine sono tra i Paesi col contenzioso maggiore, sia sulle Spratlys sia su Scarborough Shoal (Huangyan per i cinesi), un’area a 160 chilometri dalle coste filippine e a 500 miglia marittime dalla Cina. Nonostante uno sviluppo in crescita, l’economia resta sempre un problema per un Paese che ha cento milioni di abitanti ma anche dieci milioni di emigrati che ingrassano le casse con le loro rimesse ma che fanno del Paese uno dei più grandi fornitori di manodopera all’estero. E restano i mali atavici che han fatto coniare proprio per l’economia filippina sin dai tempi di Marcos la locuzione “crony capitalism”, capitalismo di parentela, un refrain che torna a legarsi alla tradizione delle grandi famiglie che si succedono al potere e si scambiano favori. Dutarte promette pulizia e piace forse anche perché non viene dal giro della “Imperial Manila” ma è anzi un uomo della provincia, di quell’isola di Mindanao dove è attiva la guerriglia secessionista e il processo di pace, sempre sul filo del rasoio, al momento è in fase di stallo. Un altro grattacapo per chi siederà al palazzo presidenziale di Malacañang.
Filippine. Settemila isole per un giustizialista
 Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Alla mezzanotte di ieri lo spoglio di due terzi delle schede elettorali per la scelta del nuovo presidente filippino non lasciava dubbi. La poltrona più alta già sembrava pronta per Rodrigo Digong Duterte, detto il “giustiziere”, già sindaco di Davao e uomo che ha incentrato la sua campagna elettorale all’insegna dello slogan “macelliamo i criminali”. Se non bastasse, Rody Duterte può contare sulle accuse di Human Right Watch per mille esecuzioni di criminali o supposti tali in 22 anni di servizio mentre le cronache ricordano il suo commento a caldo (poi ritrattato) dopo lo stupro di una missionaria australiana: tanto bella – aveva detto – che valeva la pena essere il primo. Ex magistrato, Duterte ha giocato la carta dell’uomo che viene da una famiglia non blasonata e che – in tre o sei mesi come ha promesso – imporrà legge e ordine spazzando via criminali piccoli e grossi. Se le leggi glielo impedissero? Ha minacciato di chiudere il parlamento. L’uomo che parla alla pancia della gente, un Trump con gli occhi a mandorla o un Salvini in salsa orientale, piace. Semplice e populista quanto basta, pugno duro quando ci vuole e, tanto per cambiare, la promessa di far fuori la corruzione ma soprattutto i criminali, come se la criminalità non fosse uno dei tanti prodotti sociali di un’ineguaglianza lineare tanto quanto il potere finora indiscusso di un pugno di famiglie, come quella degli Aquino da cui proviene il presidente uscente.
Ma in queste elezioni – che sceglievano anche senatori e 18mila funzionari locali – c’è anche un’altra famiglia nota che torna: i Marcos da cui esce candidato alla vicepresidenza Bongbong, figlio dell’ex dittatore Ferdinando spodestato decenni fa dalle piazze e sostituito proprio da una Aquino (Corazon). Suo figlio Benigno, presidente uscente, ha provato così – tra un Marcos e un Dutarte – ad agitare il ritorno della dittatura. A spaventarlo era soprattutto Dutarte, tanto che il presidente ha lanciato un appello a unire le forze per batterlo. Nelle Filippine (55 milioni di aventi diritto con quest’anno un’affluenza alle urne senza precedenti) non si va al ballottaggio: vince il più forte e il vicepresidente lo sceglie il popolo non il capo dello Stato. Benigno si è in sostanza rivolto a Grace Poe, ex educatrice e business woman di provata fede cattolica, l’unica nei sondaggi ad avere, con Manuel Roxas (già nel gabinetto Aquino) qualche chance – ma non da sola – rispetto agli altri candidati (cinque in tutto) in lizza.
Poe e Roxas, il pupillo del presidente, non si sono però accordati e così anche lo spauracchio della dittatura ha finito per contare poco, pur se la Poe faceva paura: per squalificarla dal torneo elettorale, alcuni mesi fa venne prodotto un certificato falso sul suo padre naturale (Grace è figlia adottiva di due famosi attori)… che sarebbe addirittura stato Bongbong Marcos! Per metterla in difficoltà è stato tirato fuori anche il fatto che il marito ha la cittadinanza americana, in un Paese da sempre filoamericano ma dove il risentimento per il padrino padrone è sempre forte.
 |
| Il palazzo presidenziale a Manila |
Cosa c’è sul piatto del nuovo presidente? Mali atavici, riforme e tensioni col colosso cinese per quel pugno di atolli sparsi su riserve di gas naturale che da anni fanno venire il mal di pancia ai Paesi affacciati sul Mar cinese meridionale, un nome che a Pechino sembra il riconoscimento evidente che Paracels e Spratlys son roba sua. Le Filippine sono tra i Paesi col contenzioso maggiore, sia sulle Spratlys sia su Scarborough Shoal (Huangyan per i cinesi), un’area a 160 chilometri dalle coste filippine e a 500 miglia marittime dalla Cina. Nonostante uno sviluppo in crescita, l’economia resta sempre un problema per un Paese che ha cento milioni di abitanti ma anche dieci milioni di emigrati che ingrassano le casse con le loro rimesse ma che fanno del Paese uno dei più grandi fornitori di manodopera all’estero. E restano i mali atavici che han fatto coniare proprio per l’economia filippina sin dai tempi di Marcos la locuzione “crony capitalism”, capitalismo di parentela, un refrain che torna a legarsi alla tradizione delle grandi famiglie che si succedono al potere e si scambiano favori. Dutarte promette pulizia e piace forse anche perché non viene dal giro della “Imperial Manila” ma è anzi un uomo della provincia, di quell’isola di Mindanao dove è attiva la guerriglia secessionista e il processo di pace, sempre sul filo del rasoio, al momento è in fase di stallo. Un altro grattacapo per chi siederà al palazzo presidenziale di Malacañang.
Fermo immagine: il ricordo di Mario dalla sua città d’adozione
 Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.
Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.

Da sabato 7 maggio, inoltre, all’interno del Polo Culturale di Sant’Agostino a Montelparo sarà possibile visitare la mostra permanente “Alla festa di Sant’Antonio, 18 gennaio 2015” donata alla comunità locale e contenente dagli scatti dell’ultimo reportage realizzato da Dondero.
Pubblico qui sopra a sinistra una bellissima immagine di Mario il cui autore è il bravo e fermano Andrea Braconi. Qui sotto a destra invece una foto autoscattata al compleanno di Mario due anni fa a Crema. Buon anniversario vecchio mio!
Fermo immagine: il ricordo di Mario dalla sua città d’adozione
 Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.
Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.

Da sabato 7 maggio, inoltre, all’interno del Polo Culturale di Sant’Agostino a Montelparo sarà possibile visitare la mostra permanente “Alla festa di Sant’Antonio, 18 gennaio 2015” donata alla comunità locale e contenente dagli scatti dell’ultimo reportage realizzato da Dondero.
Pubblico qui sopra a sinistra una bellissima immagine di Mario il cui autore è il bravo e fermano Andrea Braconi. Qui sotto a destra invece una foto autoscattata al compleanno di Mario due anni fa a Crema. Buon anniversario vecchio mio!
Fermo immagine: il ricordo di Mario dalla sua città d’adozione
 Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.
Il 6 maggio 1928 è la data di nascita di Mario Dondero, un amico fotografo scomparso nel dicembre scorso. Ed è in occasione di questa ricorrenza che un nutrito gruppo di suoi amici, guidati da Giorgio Cisbani, ha deciso di dare forma a un volume, intitolato “Fermo racconta Mario”, curato dallo stesso ex Senatore del Pci. E’ un libro con testimonianze e ricordi dei suoi amici. Si comincia alle 18 proprio il 6 maggio con un appuntamento nella Sala della Biblioteca Civica “Spezioli” in Piazza del Popolo a Fermo, dove il volume sarà presentato. Con una sorpresa: nei prossimi mesi, in occasione di una ristampa, verranno aggiunti i contributi scritti da chiunque avrà voglia di dedicare un pensiero alla straordinaria figura di Mario. Poi alle 19 trasferimento al Cinema Sala degli Artisti per un intervento musicale del Battaglione Batà. Alle ore 21.30 proiezione dell’intervista sulla fotografia a Mario Dondero realizzata da Marco Cruciani e a seguire concerto di Daniele Di Bonaventura, Andrea Strappa, Gloria Strappa e Roberto Zechini. All’interno della sala cinematografica saranno esposte alcune fotografie di Dondero selezionate dalla Fototeca Provinciale di Fermo.

Da sabato 7 maggio, inoltre, all’interno del Polo Culturale di Sant’Agostino a Montelparo sarà possibile visitare la mostra permanente “Alla festa di Sant’Antonio, 18 gennaio 2015” donata alla comunità locale e contenente dagli scatti dell’ultimo reportage realizzato da Dondero.
Pubblico qui sopra a sinistra una bellissima immagine di Mario il cui autore è il bravo e fermano Andrea Braconi. Qui sotto a destra invece una foto autoscattata al compleanno di Mario due anni fa a Crema. Buon anniversario vecchio mio!
1 maggio: lavoro e diritti nei Paesi “cerniera” della guerra infinita
 Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Iran
 Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Afghanistan
 L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
Pakistan
 Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
1 maggio: lavoro e diritti nei Paesi “cerniera” della guerra infinita
 Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Iran
 Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Afghanistan
 L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
Pakistan
 Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
1 maggio: lavoro e diritti nei Paesi “cerniera” della guerra infinita
 Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Tra il grande mondo mediorientale, le repubbliche centro asiatiche dell’ex Urss e il subcontinente indiano, tre Paesi – Iran, Afghanistan e Pakistan – rappresentano una sfida aperta tra lavoratori e padronato, che sia rappresentato dall’industria di Stato come in Iran, da landlord e speculatori come in Afghanistan o dal grande settore dell’economia controllato dalle Forze armate in Pakistan. Inoltre queste tre nazioni, oltre alla vicinanza geografica, hanno un elemento comune e cioè sono, seppur a diverso titolo, Paesi in guerra. La guerra, più o meno dichiarata e combattuta in casa o altrove, gioca un elemento fondamentale nel controllo delle istanze di giustizia sociale e dei diritti sul lavoro: leggi speciali, richiami alla difesa della patria, autorità indiscussa delle forze dell’ordine sono infatti tutti elementi che finiscono per governare un mercato del lavoro che con la guerra fa i conti ogni giorno. Questi Paesi “cerniera” tra mondi diversi – il Medio oriente con i suoi conflitti e i suoi governi instabili e autoritari, l’Asia centrale ex sovietica con le sue centrali di potere autocratiche e l’lndia che rappresenta l’eccezione democratica asiatica – stanno vivendo una fase di cambiamento importante in cui la guerra resta però un elemento stabile da decenni. Che finisce a gettare una luce oscura sulle loro economie e soprattutto sui diritti negati di chi lavora.
Iran
 Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Il sindacato ha in Iran una storia antichissima: la prima centrale fu fondata infatti un secolo fa ed ebbe poi un ruolo chiave nella lotta allo Scià. Ma da che esiste la Repubblica islamica, il governo ha fatto del sindacato una sorta di istituzione governativa con limiti fortissimi alla rappresentanza e dove la contrattazione viene regolata non attraverso le lotte ma con un negoziato dove alla fine vince sempre il governo. Dirigenti politici e sindacali vengono arrestati – come nel caso di Ismail Abdi, segretario generale degli insegnanti, imprigionato per aver organizzato “riunioni illegali” – anche se Teheran è un vecchio membro dell’Ilo (l’ufficio Onu del lavoro) di cui ha firmato quasi tutte le convenzioni rifiutandosi di siglare quelle relative alla libertà di associazione (C87) e di organizzazione (C98). Il Paese, che ha ricominciato a crescere nel 2014, sta conoscendo – dopo la fine delle sanzioni – una stagione di apertura che potrebbe farlo uscire da una crisi che si protrae da anni anche in ragione delle altissime spese militari. Non formalmente in guerra, l’Iran sostiene infatti i fronti sciiti nel mondo (dal Libano alla Siria) che rifornisce di armamenti e consiglieri militari.
Afghanistan
 L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
L’Afghanistan, con un mercato del lavoro su cui ogni anno si affacciano 400mila nuovi soggetti, è un Paese in forte crisi (il Pnl che nel 2011 cresceva al 6,1% nel 2014 è calato all’1,3). La sua economia, sostenuta per oltre due terzi dai finanziamenti stranieri, ha subito un contraccolpo non indifferente dopo l’uscita di scena di oltre 100mila soldati della Nato e relativi contractor. La fuoriuscita degli eserciti stranieri, ben più che un problema militare, sembra essere alla base della crisi economica attuale nella quale le commesse sono drasticamente diminuite, il boom edilizio si è fermato, il flusso di valuta pregiata si è ridotto e la moneta ha cominciato per la prima volta a perdere terreno su quelle dei Paesi vicini (l’unico fattore forse che può rilanciare un po’ l’asfittico mercato interno). La crisi, gestita da un governo fragile e in costante calo di consensi, vede aumentare la piccola criminalità e diminuire le occasioni di lavoro formale in un Paese dominato da un settore informale privo di ogni diritto. Il sindacato, eredità dei tempi post sovietici, è debole e con scarsa voce in capitolo. E’ un quadro che spiega l’enorme flusso di migranti afgani alle porte d’Europa (il secondo gruppo dopo la Siria) e il piano europeo che vorrebbe ritrasferirne a casa, via Turchia, almeno 80mila (quasi la metà degli attuali residenti). Tra Pakistan e Iran, altri 2,5 milioni restano fuori dal Paese in cerca di migliori occasioni di vita.
Pakistan
 Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
Il Pakistan ha come l’India una tradizione sindacale importante ma nel Paese islamico, che ha un’altrettanto lunga tradizione di dittature militari e solo da pochi anni conosce governi civili stabili, i diritti sul lavoro, benché abbiano fatto passi avanti, sono ancora molto ignorati specie nel settore informale, una fetta importante dell’economia pachistana. Il costo della guerra, che in Afghanistan è stato sostenuto dagli stranieri e che in Iran è piuttosto sotto traccia e indiretto, è alla luce del sole: nel 2013 il governo valutava in 100 miliardi di dollari le perdite dovute alla sua adesione alla guerra al terrorismo e ai talebani pachistani. Spese che sono aumentate da quando, oltre un anno e mezzo fa, Islamabad si è impegnata in un conflitto senza quartiere nell’area tribale del Waziristan. Il costo umano del terrorismo è enorme: una media di 2mila vittime l’anno e due milioni di sfollati interni. Leggi e corti speciali fanno il resto. E nelle maglie strette ci finiscono anche i sindacalisti.
Il raid su Msf a Kunduz? Errore tecnico dice il Pentagono
 Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Pazienti e membri dello staff di Msf (14) furono dunque vittime di un errore perché l’equipaggio del bombardiere “non sapeva” che stava colpendo un nosocomio ma era invece convinto di stare sbaragliando un covo di talebani situato a 400 metri dall’ospedale. L’azione all’origine della strage non fu pertanto “intenzionale” anche se non è chiaro come mai l’equipaggio non abbia avuto accesso alla lista degli edifici in città che non andavano colpiti (il rapporto fa riferimento a problemi di comunicazione) tra cui era stato da tempo segnalato il centro medico di Msf a Kunduz. E’ molto chiaro invece come i militari abbiano deciso di non procedere penalmente ma solo amministrativamente dal momento che, ha spiegato Votel, l’accusa di crimine di guerra si può applicare solo in presenza di atti deliberati.
Sedici membri dello staff militare e un ufficiale con funzioni di comando sono dunque stati sottoposti a misure disciplinari e in particolare a punizioni che includono la sospensione o la rimozione da posizioni di comando, lettere di monito e attività obbligatorie di training o consultazioni medico-psicologiche. Per cinque fra questi c’è anche l’espulsione dal teatro. Un buffetto sulla guancia insomma e magari un freno alla carriera, non certo un’accusa che li possa spedire davanti a una corte marziale: una risposta che Msf giudica sproporzionata rispetto alla distruzione di una struttura medica protetta, alla morte di 42 persone, al ferimento di decine di altre e alla totale perdita di servizi medici vitali per la popolazione.
Ma non sono certo le pene, più o meno dure, a preoccupare Msf, cui la Difesa statunitense intende pagare, con i risarcimenti ai parenti delle vittime, 5,7 milioni di dollari per ricostruire l’ospedale ridotto a un cumulo di macerie: secondo l’organizzazione umanitaria, quanto affermato dal vertice militare americano “equivale all’ammissione di un’operazione non controllata in un’area urbana densamente popolata, durante la quale le forze statunitensi hanno disatteso le regole di base della guerra” ha detto Meinie Nicolai, presidente di Msf, secondo cui “non si comprende perché, nelle circostanze descritte dagli Stati Uniti, l’attacco non sia stato annullato”. “Il discrimine che può rendere questo incidente mortale una grave violazione del diritto internazionale umanitario non è la sua intenzionalità” aggiunge Nicolai, perché in guerra, si tratti di Afghanistan o di Siria, “i gruppi armati non possono eludere le proprie responsabilità sul campo semplicemente negando l’intenzionalità di un attacco contro strutture protette come un ospedale.” Il Pentagono non la pensa così.
Il raid su Msf a Kunduz? Errore tecnico dice il Pentagono
 Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Pazienti e membri dello staff di Msf (14) furono dunque vittime di un errore perché l’equipaggio del bombardiere “non sapeva” che stava colpendo un nosocomio ma era invece convinto di stare sbaragliando un covo di talebani situato a 400 metri dall’ospedale. L’azione all’origine della strage non fu pertanto “intenzionale” anche se non è chiaro come mai l’equipaggio non abbia avuto accesso alla lista degli edifici in città che non andavano colpiti (il rapporto fa riferimento a problemi di comunicazione) tra cui era stato da tempo segnalato il centro medico di Msf a Kunduz. E’ molto chiaro invece come i militari abbiano deciso di non procedere penalmente ma solo amministrativamente dal momento che, ha spiegato Votel, l’accusa di crimine di guerra si può applicare solo in presenza di atti deliberati.
Sedici membri dello staff militare e un ufficiale con funzioni di comando sono dunque stati sottoposti a misure disciplinari e in particolare a punizioni che includono la sospensione o la rimozione da posizioni di comando, lettere di monito e attività obbligatorie di training o consultazioni medico-psicologiche. Per cinque fra questi c’è anche l’espulsione dal teatro. Un buffetto sulla guancia insomma e magari un freno alla carriera, non certo un’accusa che li possa spedire davanti a una corte marziale: una risposta che Msf giudica sproporzionata rispetto alla distruzione di una struttura medica protetta, alla morte di 42 persone, al ferimento di decine di altre e alla totale perdita di servizi medici vitali per la popolazione.
Ma non sono certo le pene, più o meno dure, a preoccupare Msf, cui la Difesa statunitense intende pagare, con i risarcimenti ai parenti delle vittime, 5,7 milioni di dollari per ricostruire l’ospedale ridotto a un cumulo di macerie: secondo l’organizzazione umanitaria, quanto affermato dal vertice militare americano “equivale all’ammissione di un’operazione non controllata in un’area urbana densamente popolata, durante la quale le forze statunitensi hanno disatteso le regole di base della guerra” ha detto Meinie Nicolai, presidente di Msf, secondo cui “non si comprende perché, nelle circostanze descritte dagli Stati Uniti, l’attacco non sia stato annullato”. “Il discrimine che può rendere questo incidente mortale una grave violazione del diritto internazionale umanitario non è la sua intenzionalità” aggiunge Nicolai, perché in guerra, si tratti di Afghanistan o di Siria, “i gruppi armati non possono eludere le proprie responsabilità sul campo semplicemente negando l’intenzionalità di un attacco contro strutture protette come un ospedale.” Il Pentagono non la pensa così.
Il raid su Msf a Kunduz? Errore tecnico dice il Pentagono
 Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Fu un “errore di procedura”, un errore “tecnico e umano” il bombardamento che nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del 2015 prese ripetutamente di mira l’ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Un raid aereo in cui furono uccise 42 persone e altre decine furono ferite. E’ questa la conclusione presentata venerdi dal generale americano Joseph Votel in una conferenza stampa in cui sono stati resi noti i risultati di un rapporto di 3mila pagine con cui il Pentagono ritiene di aver scritto la parola fine sulla vicenda. La reazione di Msf, che si riserva nuovi commenti alla fine di un esame approfondito del dossier, non si è fatta attendere: l’organizzazione umanitaria ritiene infatti che molte domande siano rimaste senza risposta e continua a chiedere un’indagine indipendente che stabilisca nettamente le responsabilità e soprattutto il peso di una delle pagine più buie della storia recente del conflitto afgano.
Pazienti e membri dello staff di Msf (14) furono dunque vittime di un errore perché l’equipaggio del bombardiere “non sapeva” che stava colpendo un nosocomio ma era invece convinto di stare sbaragliando un covo di talebani situato a 400 metri dall’ospedale. L’azione all’origine della strage non fu pertanto “intenzionale” anche se non è chiaro come mai l’equipaggio non abbia avuto accesso alla lista degli edifici in città che non andavano colpiti (il rapporto fa riferimento a problemi di comunicazione) tra cui era stato da tempo segnalato il centro medico di Msf a Kunduz. E’ molto chiaro invece come i militari abbiano deciso di non procedere penalmente ma solo amministrativamente dal momento che, ha spiegato Votel, l’accusa di crimine di guerra si può applicare solo in presenza di atti deliberati.
Sedici membri dello staff militare e un ufficiale con funzioni di comando sono dunque stati sottoposti a misure disciplinari e in particolare a punizioni che includono la sospensione o la rimozione da posizioni di comando, lettere di monito e attività obbligatorie di training o consultazioni medico-psicologiche. Per cinque fra questi c’è anche l’espulsione dal teatro. Un buffetto sulla guancia insomma e magari un freno alla carriera, non certo un’accusa che li possa spedire davanti a una corte marziale: una risposta che Msf giudica sproporzionata rispetto alla distruzione di una struttura medica protetta, alla morte di 42 persone, al ferimento di decine di altre e alla totale perdita di servizi medici vitali per la popolazione.
Ma non sono certo le pene, più o meno dure, a preoccupare Msf, cui la Difesa statunitense intende pagare, con i risarcimenti ai parenti delle vittime, 5,7 milioni di dollari per ricostruire l’ospedale ridotto a un cumulo di macerie: secondo l’organizzazione umanitaria, quanto affermato dal vertice militare americano “equivale all’ammissione di un’operazione non controllata in un’area urbana densamente popolata, durante la quale le forze statunitensi hanno disatteso le regole di base della guerra” ha detto Meinie Nicolai, presidente di Msf, secondo cui “non si comprende perché, nelle circostanze descritte dagli Stati Uniti, l’attacco non sia stato annullato”. “Il discrimine che può rendere questo incidente mortale una grave violazione del diritto internazionale umanitario non è la sua intenzionalità” aggiunge Nicolai, perché in guerra, si tratti di Afghanistan o di Siria, “i gruppi armati non possono eludere le proprie responsabilità sul campo semplicemente negando l’intenzionalità di un attacco contro strutture protette come un ospedale.” Il Pentagono non la pensa così.
Blogger nel mirino
 A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
Sempre secondo le prime ricostruzioni della polizia, il massacro sarebbe avvenuto in tempi rapidissimi e il team di assassini si sarebbe poi allontanato indisturbato facendo perdere le tracce.
La lista di queste uccisioni mirate – a volte firmate da Daesh a volte da altri gruppi radicali a volta ancora senza nessuna rivendicazione – è lunga. L’estate scorsa era toccato a Niloy Neel, il quarto blogger dell’anno preso di mira – anche lui a colpi di machete – dopo Avijit Roy, Washiqur Rahman e Ananta Bijoy Das. La loro colpa: quella di essere considerati “atei” (per la cronaca la figlia di Siddique ha smentito che il padre lo fosse) e di utilizzare internet per polemizzare sull’esistenza di Dio ma anche semplicemente per discutere di politica o sfidare le regole dell’islam, religione ufficiale del Bangladesh. Come ha fatto notare la Bbc, con Niloy c’era stato un salto di qualità, ora ripetutosi col direttore di Roopbaan, il primo magazine Lgbt del Bangladesh: prima si uccideva in pubblico, adesso si entra nelle case. Ma la differenza è relativa anche se fa pensare a piani studiati con maggior dettaglio.
La verità evidente è che nel mirino entrano sempre più persone anche se non è mai stato esattamente chiarito il legame tra i vari delitti né se vi sia un filo rosso che li lega alle uccisioni o agli attentati contro stranieri di cui sono stati vittima anche due italiani: prima Cesare Tavella, ucciso a colpi di pistola nella capitale mentre faceva jogging, poi, nel novembre scorso, padre Piero Parolari, fortunatamente solo ferito a Dinajpur, 350 chilometri a Nord di Dacca, dove il sacerdote svolgeva, oltre al servizio pastorale, anche l’attività di medico nell’ospedale della missione locale e come volontario al Dinajpur Medical College Hospital.
Gli stranieri sono comunque stati target occasionali mentre quella dei blogger sembra adesso sempre di più una pista credibile che si serve di una lista da “spuntare” poco per volta. Questa comunità ora si sente, e forse si sentiva già da tempo, in pericolo soprattutto da quando una lista con 84 nomi di “blogger atei” è saltata fuori dopo che la polizia ha compiuto arresti in qualche madrasa e tra i gruppi giovanili islamisti del Paese. In realtà la lista è nota dal 2013 ed era stata addirittura presentata alle autorità per chieder l’arresto dei blogger e processi per blasfemia. Poi si è passati dalla lista ai fatti anche se diversi gruppi islamisti – che l’avevano sostenuta – hanno smentito che vi sia un nesso con il killeraggio organizzato. Ma resta evidente che tra una lista stilata per mettere all’indice i blogger e che li uccide ci sta in mezzo un contesto che spinge a condannare, isolare socialmente e infine punire chi devia dalla retta via. Molti infatti condannano le uccisioni ma nel contempo non assolvono i blogger, accusati di minare le basi della fede religiosa. Un’altra ipotesi la fa il ministro dell’Informazione del Bangladesh, Hasanul Haq, secondo il quale questi attacchi ai blogger sarebbero solo un modo per distrarre l’attenzione degli inquirenti dai gruppi islamisti con un’agenda eversiva anti statale che in questo modo cercherebbe di far focalizzare gli sguardi su blasfemi e anti islamici e non su di loro. Sta di fatto che i blogger non si sentono affatto protetti da un governo per il quale le priorità sembrano altre.
In mezzo a tutto ciò spunta Daesh o chi utilizza il brand, più o meno d’accordo con gli uomini di Al Bagdadi, da qualche tempo in difficoltà nella loro opera di proselitismo dopo le sconfitte nei territori conquistati dal neonato califfato. Ma Daesh o non Daesh, il Bangladesh sta facendo i conti con una vera e propria campagna assassina contro atei e “blasfemi”. E adesso anche contro chi difende i diritti di gay, lesbiche e trasgender.
Blogger nel mirino
 A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
Sempre secondo le prime ricostruzioni della polizia, il massacro sarebbe avvenuto in tempi rapidissimi e il team di assassini si sarebbe poi allontanato indisturbato facendo perdere le tracce.
La lista di queste uccisioni mirate – a volte firmate da Daesh a volte da altri gruppi radicali a volta ancora senza nessuna rivendicazione – è lunga. L’estate scorsa era toccato a Niloy Neel, il quarto blogger dell’anno preso di mira – anche lui a colpi di machete – dopo Avijit Roy, Washiqur Rahman e Ananta Bijoy Das. La loro colpa: quella di essere considerati “atei” (per la cronaca la figlia di Siddique ha smentito che il padre lo fosse) e di utilizzare internet per polemizzare sull’esistenza di Dio ma anche semplicemente per discutere di politica o sfidare le regole dell’islam, religione ufficiale del Bangladesh. Come ha fatto notare la Bbc, con Niloy c’era stato un salto di qualità, ora ripetutosi col direttore di Roopbaan, il primo magazine Lgbt del Bangladesh: prima si uccideva in pubblico, adesso si entra nelle case. Ma la differenza è relativa anche se fa pensare a piani studiati con maggior dettaglio.
La verità evidente è che nel mirino entrano sempre più persone anche se non è mai stato esattamente chiarito il legame tra i vari delitti né se vi sia un filo rosso che li lega alle uccisioni o agli attentati contro stranieri di cui sono stati vittima anche due italiani: prima Cesare Tavella, ucciso a colpi di pistola nella capitale mentre faceva jogging, poi, nel novembre scorso, padre Piero Parolari, fortunatamente solo ferito a Dinajpur, 350 chilometri a Nord di Dacca, dove il sacerdote svolgeva, oltre al servizio pastorale, anche l’attività di medico nell’ospedale della missione locale e come volontario al Dinajpur Medical College Hospital.
Gli stranieri sono comunque stati target occasionali mentre quella dei blogger sembra adesso sempre di più una pista credibile che si serve di una lista da “spuntare” poco per volta. Questa comunità ora si sente, e forse si sentiva già da tempo, in pericolo soprattutto da quando una lista con 84 nomi di “blogger atei” è saltata fuori dopo che la polizia ha compiuto arresti in qualche madrasa e tra i gruppi giovanili islamisti del Paese. In realtà la lista è nota dal 2013 ed era stata addirittura presentata alle autorità per chieder l’arresto dei blogger e processi per blasfemia. Poi si è passati dalla lista ai fatti anche se diversi gruppi islamisti – che l’avevano sostenuta – hanno smentito che vi sia un nesso con il killeraggio organizzato. Ma resta evidente che tra una lista stilata per mettere all’indice i blogger e che li uccide ci sta in mezzo un contesto che spinge a condannare, isolare socialmente e infine punire chi devia dalla retta via. Molti infatti condannano le uccisioni ma nel contempo non assolvono i blogger, accusati di minare le basi della fede religiosa. Un’altra ipotesi la fa il ministro dell’Informazione del Bangladesh, Hasanul Haq, secondo il quale questi attacchi ai blogger sarebbero solo un modo per distrarre l’attenzione degli inquirenti dai gruppi islamisti con un’agenda eversiva anti statale che in questo modo cercherebbe di far focalizzare gli sguardi su blasfemi e anti islamici e non su di loro. Sta di fatto che i blogger non si sentono affatto protetti da un governo per il quale le priorità sembrano altre.
In mezzo a tutto ciò spunta Daesh o chi utilizza il brand, più o meno d’accordo con gli uomini di Al Bagdadi, da qualche tempo in difficoltà nella loro opera di proselitismo dopo le sconfitte nei territori conquistati dal neonato califfato. Ma Daesh o non Daesh, il Bangladesh sta facendo i conti con una vera e propria campagna assassina contro atei e “blasfemi”. E adesso anche contro chi difende i diritti di gay, lesbiche e trasgender.
Blogger nel mirino
 A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
A pochi giorni dalla morte di Rezaul Karim Siddique, un docente di inglese della Rajshahi University nel Nordest del Bangladesh, ucciso da affiliati di Daesh che lo accusavano di “ateismo”, ieri è stata la volta di Xulhaz Mannan e di un suo compagno, massacrati in un appartamento di Dacca nella zona metropolitana di Kalabagan. Mannan era noto per aver fondato il primo magazine Lgbt del Paese e per essersi forse anche macchiato del delitto di lavorare per Usaid, l’agenzia di cooperazione statunitense. Del suo compagno non si sa per ora molto altro se non il solo nome: Tonmoy. Xulhaz e Tonmoy sarebbero stati aggrediti – secondo le prime ricostruzioni – da almeno cinque persone, spacciatesi per uomini dello staff di Usaid che, con questa scusa, forse la consegna di materiale, si sono introdotti verso le cinque e un quarto del pomeriggio nel suo appartamento armati di machete, riservando ai due uomini la stessa morte riservata ad altri attivisti, blogger o, come nel caso di Siddique (anche lui ucciso a colpi di machete), a gente che lavora nell’ambito culturale o dello spettacolo.
Sempre secondo le prime ricostruzioni della polizia, il massacro sarebbe avvenuto in tempi rapidissimi e il team di assassini si sarebbe poi allontanato indisturbato facendo perdere le tracce.
La lista di queste uccisioni mirate – a volte firmate da Daesh a volte da altri gruppi radicali a volta ancora senza nessuna rivendicazione – è lunga. L’estate scorsa era toccato a Niloy Neel, il quarto blogger dell’anno preso di mira – anche lui a colpi di machete – dopo Avijit Roy, Washiqur Rahman e Ananta Bijoy Das. La loro colpa: quella di essere considerati “atei” (per la cronaca la figlia di Siddique ha smentito che il padre lo fosse) e di utilizzare internet per polemizzare sull’esistenza di Dio ma anche semplicemente per discutere di politica o sfidare le regole dell’islam, religione ufficiale del Bangladesh. Come ha fatto notare la Bbc, con Niloy c’era stato un salto di qualità, ora ripetutosi col direttore di Roopbaan, il primo magazine Lgbt del Bangladesh: prima si uccideva in pubblico, adesso si entra nelle case. Ma la differenza è relativa anche se fa pensare a piani studiati con maggior dettaglio.
La verità evidente è che nel mirino entrano sempre più persone anche se non è mai stato esattamente chiarito il legame tra i vari delitti né se vi sia un filo rosso che li lega alle uccisioni o agli attentati contro stranieri di cui sono stati vittima anche due italiani: prima Cesare Tavella, ucciso a colpi di pistola nella capitale mentre faceva jogging, poi, nel novembre scorso, padre Piero Parolari, fortunatamente solo ferito a Dinajpur, 350 chilometri a Nord di Dacca, dove il sacerdote svolgeva, oltre al servizio pastorale, anche l’attività di medico nell’ospedale della missione locale e come volontario al Dinajpur Medical College Hospital.
Gli stranieri sono comunque stati target occasionali mentre quella dei blogger sembra adesso sempre di più una pista credibile che si serve di una lista da “spuntare” poco per volta. Questa comunità ora si sente, e forse si sentiva già da tempo, in pericolo soprattutto da quando una lista con 84 nomi di “blogger atei” è saltata fuori dopo che la polizia ha compiuto arresti in qualche madrasa e tra i gruppi giovanili islamisti del Paese. In realtà la lista è nota dal 2013 ed era stata addirittura presentata alle autorità per chieder l’arresto dei blogger e processi per blasfemia. Poi si è passati dalla lista ai fatti anche se diversi gruppi islamisti – che l’avevano sostenuta – hanno smentito che vi sia un nesso con il killeraggio organizzato. Ma resta evidente che tra una lista stilata per mettere all’indice i blogger e che li uccide ci sta in mezzo un contesto che spinge a condannare, isolare socialmente e infine punire chi devia dalla retta via. Molti infatti condannano le uccisioni ma nel contempo non assolvono i blogger, accusati di minare le basi della fede religiosa. Un’altra ipotesi la fa il ministro dell’Informazione del Bangladesh, Hasanul Haq, secondo il quale questi attacchi ai blogger sarebbero solo un modo per distrarre l’attenzione degli inquirenti dai gruppi islamisti con un’agenda eversiva anti statale che in questo modo cercherebbe di far focalizzare gli sguardi su blasfemi e anti islamici e non su di loro. Sta di fatto che i blogger non si sentono affatto protetti da un governo per il quale le priorità sembrano altre.
In mezzo a tutto ciò spunta Daesh o chi utilizza il brand, più o meno d’accordo con gli uomini di Al Bagdadi, da qualche tempo in difficoltà nella loro opera di proselitismo dopo le sconfitte nei territori conquistati dal neonato califfato. Ma Daesh o non Daesh, il Bangladesh sta facendo i conti con una vera e propria campagna assassina contro atei e “blasfemi”. E adesso anche contro chi difende i diritti di gay, lesbiche e trasgender.
C’è una lacrima nel mio tè / 2
 Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
La storia del tè a Sri Lanka è dunque britannica e tale rimarrà sino agli anni Settanta del secolo scorso quando, nel 1972 e nel 1975, due leggi dello Stato ormai indipendente dal 1948 nazionalizzeranno le piantagioni sottraendole alle Corporation e decretando la fine dello sfruttamento coloniale.
C’è una lacrima nel mio tè / 2
 Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
La storia del tè a Sri Lanka è dunque britannica e tale rimarrà sino agli anni Settanta del secolo scorso quando, nel 1972 e nel 1975, due leggi dello Stato ormai indipendente dal 1948 nazionalizzeranno le piantagioni sottraendole alle Corporation e decretando la fine dello sfruttamento coloniale.
C’è una lacrima nel mio tè / 2
 Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
Quando nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione, Sri Lanka era ancora famosa per la produzione del caffè che, trapiantato nell’isola dagli olandesi, era diventato una coltura davvero importante coi britannici e doveva raggiungere il suo picco produttivo nel 1870 con oltre 100mila ettari coltivati. Ma la Hemileia vastatrix, un fungo che “arrugginisce” le foglie del caffè, era in agguato e nel giro di pochi anni “Devasting Emily”, come era soprannominata la malattia del caffè, fece piazza pulita del chicco di Arabica che, agli inizi del 1900, resisteva solo su un decimo degli ettari un tempo coltivati. Il tè diventò la chiave di volta dell’economia di piantagione della Lacrima dell’Oceano indiano. La pianta era arrivata dalla Cina nel 1824 ed era stata interrata, a scopo ornamentale, nel Royal Botanical Garden di Kandy (nella foto in alto), forse il posto ancor oggi più affascinante della città. James Taylor, uno scozzese arrivato a Sri Lanka nel 1854, ebbe l’intuizione vincente e provò a fare del tè una coltura intensiva. Taylor, che aveva studiato in India i sistemi di coltivazione del tè, cominciò con meno di un ettaro nel 1867 mentre la “Emily” devastava le piantagioni di caffè. Nel 1872 impiantò la prima fabbrica che essiccava e impacchettava il tè e nel 1875 fece partire la sua prima nave per il Regno Unito. L’epopea del tè srilankese era cominciata ma l’accelerazione vera arriverà qualche anno dopo, quando nel 1890 il milionario Sir Thomas Johnstone Lipton – un nome che è ancora oggi associato all’intramontabile bevanda – sbarcò a Ceylon e conobbe Taylor. I due studiarono come fare del nero liquido derivato dal decotto della Camellia sinensis un oro nero che trasformasse le tenere foglioline della pianta asiatica in sonanti monete d’argento con l’effigie della regina Vittoria. E ci riuscirono. Un anno dopo la morte di Taylor, un milione di pacchetti del suo tè raggiungevano gli Stati Uniti.
La storia del tè a Sri Lanka è dunque britannica e tale rimarrà sino agli anni Settanta del secolo scorso quando, nel 1972 e nel 1975, due leggi dello Stato ormai indipendente dal 1948 nazionalizzeranno le piantagioni sottraendole alle Corporation e decretando la fine dello sfruttamento coloniale.
C’è una lacrima nel mio tè/ 1
Lo Sri Lanka è uno dei grandi produttori mondiali di tè. Adesso in crisi perché l’oro nero in tazza segue l’andamento dei prezzi del petrolio e i suoi profitti sono in caduta libera. E chi lo comprava ne sta acquistando meno
Kandy (Sri Lanka)- Il baracchino lungo la strada apre alle sei del mattino. La gente passa per le frittelle e un tè nero o col latte. Ma è una piccola delusione il primo sorso del prodotto che, con la bellezza della sue coste, ha reso nota la Lacrima dell’Oceano indiano. Il tè che si beve a Sri Lanka è solo una cattiva imitazione di quello che, con un ampio gesto del braccio, viene miscelato al latte da una tazza all’altra nei cay shop indiani da Peshawar a Calcutta. E’ scadente persino a Kandy, la capitale del tè, una cittadina di 100mila abitanti arrampicata su colline di un verde intenso e affacciata su un lago. Ci si arriva in treno o con qualche autobus mal in arnese dove la costante di ogni fermata è la tazza di oro nero. Sì, perché Kandy è famosa per due cose: un dente del Budda, conservato con religiosa attenzione in un enorme palazzo sul lago, e il tè. Un tempo era anche un buen retiro, prima che il turismo di massa, impennatosi dopo la fine della guerra civile nel 2009, portasse orde di viaggiatori e il relativo lavorio di ruspe e betoniere. Oggi, un albergo con vista lago – nella parte alta della città – è un hotel con vista albergo: uno davanti all’altro con una gara a quale sarà più alto.
Se la città ha perso un po’ della sua magia, come per altro accade ad altri luoghi del sogno cartolina del subcontinente – da Goa a Kovalam Beach per citare i più noti – i dintorni riscattano la fama di una città che da antica capitale del Paese è diventata la capitale del tè del pianeta. Benché si possa comprare nel caotico bazar della città, un piccolo edificio a due piani compresso da negozietti che vendono spezie e tè a prezzi esorbitanti, vale al pena di andare a cercarlo nelle colline dove nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione. E gli disse bene. Oggi si coltiva su quasi 200mila ettari: la qualità per l’estero è famosa e Sri Lanka è tra i primi produttori ed esportatori del pianeta. Circa un milione di persone lavorano nell’industria del tè, un capitolo torbido della sua Storia passata e recente.
 Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Il tè è in crisi un po’ ovunque. E’ la Cina a detenere la palma del primo produttore mondiale e il vanto di una storia millenaria. Racconta la sinologa Isabella Doniselli che «allo stato selvatico il tè è una pianta che può superare i 10 metri: ecco perché il mitico sovrano Shennong, addormentatosi sotto un albero, vide cadere nel bollitore le sue foglie», facendo nascere la seconda bevanda al mondo dopo l’acqua. Ma anche in Cina la preziosa fogliolina vale sempre meno perché il governo ha levato i sussidi mentre la crisi ha contratto la domanda di importazioni in un Paese dove il tè non è mai abbastanza. E per lo Sri Lanka, per un Paese che è il quarto produttore mondiale e dove il tè è il principale prodotto di esportazione (che val quasi 1,4 miliardi di dollari l’anno), minor richiesta e calo del prezzo del petrolio sono un serio problema. Tè e petrolio? Si, perché da che il prezzo dell’oro nero è calato fino a soglie inaspettate, anche il prezzo dell’altro oro nero (o verde) è precipitato. Per la Lacrima dell’Oceano indiano son lacrime amare.
 |
| La Regina Vittoria: quando regna il tè diventa uno dei grandi prodotti delle colonie d’oltremare |
Se è vero che gli italiani risparmiano circa 500 euro l’anno quando vanno a fare il pieno, è vero anche che per un produttore di alimenti la caduta del prezzo del petrolio è una cattiva notizia. L’agroalimentare, di cui il tè è uno dei grandi protagonisti, è ormai petrolio-dipendente grazie alle “rivoluzioni verdi” con trattori e mietitrebbie. Ciò significa che ora si produce di più a meno ma l’eccesso di offerta globale fa cadere il prezzo. Se poi, per altri motivi, la domanda sul mercato si contrae, il prezzo si abbassa ulteriormente. Il tè costa meno ma lo beve anche meno gente e i margini di profitto si riducono. Specie tra i grandi compratori, come Russia, Arabia saudita o Paesi dell’Asia ex sovietica che sono anche produttori di petrolio. Guadagnano meno e, in proporzione, comprano meno tè anche se il prezzo è basso. Molti altri grandi consumatori affrontano invece crisi di altro tipo: la Siria ad esempio, o l’Irak. Durante la guerra americana nel Paese di Saddam, la contrazione della domanda mandò in crisi i produttori srilankesi che vendevano agli iracheni il 15% del loro export. Chiesero aiuto al governo che dovette intervenire. Come sta facendo adesso, ricomprando tè per stabilizzarne il prezzo. Di quanto è caduto? Sul mercato americano, largo consumatore in crescita (come l’Italia), è passato dai quasi 4 dollari al chilo del luglio 2015 ai 3,20 di gennaio. Alla borsa del tè di Londra (il secondo importatore mondiale) siamo a circa 3 dollari e mezzo. Variazioni così, moltiplicate per tonnellate acquistate o vendute, produce differenze esorbitanti. E lacrime amare anche sulle dolci colline di Kandy.
C’è una lacrima nel mio tè/ 1
Lo Sri Lanka è uno dei grandi produttori mondiali di tè. Adesso in crisi perché l’oro nero in tazza segue l’andamento dei prezzi del petrolio e i suoi profitti sono in caduta libera. E chi lo comprava ne sta acquistando meno
Kandy (Sri Lanka)- Il baracchino lungo la strada apre alle sei del mattino. La gente passa per le frittelle e un tè nero o col latte. Ma è una piccola delusione il primo sorso del prodotto che, con la bellezza della sue coste, ha reso nota la Lacrima dell’Oceano indiano. Il tè che si beve a Sri Lanka è solo una cattiva imitazione di quello che, con un ampio gesto del braccio, viene miscelato al latte da una tazza all’altra nei cay shop indiani da Peshawar a Calcutta. E’ scadente persino a Kandy, la capitale del tè, una cittadina di 100mila abitanti arrampicata su colline di un verde intenso e affacciata su un lago. Ci si arriva in treno o con qualche autobus mal in arnese dove la costante di ogni fermata è la tazza di oro nero. Sì, perché Kandy è famosa per due cose: un dente del Budda, conservato con religiosa attenzione in un enorme palazzo sul lago, e il tè. Un tempo era anche un buen retiro, prima che il turismo di massa, impennatosi dopo la fine della guerra civile nel 2009, portasse orde di viaggiatori e il relativo lavorio di ruspe e betoniere. Oggi, un albergo con vista lago – nella parte alta della città – è un hotel con vista albergo: uno davanti all’altro con una gara a quale sarà più alto.
Se la città ha perso un po’ della sua magia, come per altro accade ad altri luoghi del sogno cartolina del subcontinente – da Goa a Kovalam Beach per citare i più noti – i dintorni riscattano la fama di una città che da antica capitale del Paese è diventata la capitale del tè del pianeta. Benché si possa comprare nel caotico bazar della città, un piccolo edificio a due piani compresso da negozietti che vendono spezie e tè a prezzi esorbitanti, vale al pena di andare a cercarlo nelle colline dove nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione. E gli disse bene. Oggi si coltiva su quasi 200mila ettari: la qualità per l’estero è famosa e Sri Lanka è tra i primi produttori ed esportatori del pianeta. Circa un milione di persone lavorano nell’industria del tè, un capitolo torbido della sua Storia passata e recente.
 Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Il tè è in crisi un po’ ovunque. E’ la Cina a detenere la palma del primo produttore mondiale e il vanto di una storia millenaria. Racconta la sinologa Isabella Doniselli che «allo stato selvatico il tè è una pianta che può superare i 10 metri: ecco perché il mitico sovrano Shennong, addormentatosi sotto un albero, vide cadere nel bollitore le sue foglie», facendo nascere la seconda bevanda al mondo dopo l’acqua. Ma anche in Cina la preziosa fogliolina vale sempre meno perché il governo ha levato i sussidi mentre la crisi ha contratto la domanda di importazioni in un Paese dove il tè non è mai abbastanza. E per lo Sri Lanka, per un Paese che è il quarto produttore mondiale e dove il tè è il principale prodotto di esportazione (che val quasi 1,4 miliardi di dollari l’anno), minor richiesta e calo del prezzo del petrolio sono un serio problema. Tè e petrolio? Si, perché da che il prezzo dell’oro nero è calato fino a soglie inaspettate, anche il prezzo dell’altro oro nero (o verde) è precipitato. Per la Lacrima dell’Oceano indiano son lacrime amare.
 |
| La Regina Vittoria: quando regna il tè diventa uno dei grandi prodotti delle colonie d’oltremare |
Se è vero che gli italiani risparmiano circa 500 euro l’anno quando vanno a fare il pieno, è vero anche che per un produttore di alimenti la caduta del prezzo del petrolio è una cattiva notizia. L’agroalimentare, di cui il tè è uno dei grandi protagonisti, è ormai petrolio-dipendente grazie alle “rivoluzioni verdi” con trattori e mietitrebbie. Ciò significa che ora si produce di più a meno ma l’eccesso di offerta globale fa cadere il prezzo. Se poi, per altri motivi, la domanda sul mercato si contrae, il prezzo si abbassa ulteriormente. Il tè costa meno ma lo beve anche meno gente e i margini di profitto si riducono. Specie tra i grandi compratori, come Russia, Arabia saudita o Paesi dell’Asia ex sovietica che sono anche produttori di petrolio. Guadagnano meno e, in proporzione, comprano meno tè anche se il prezzo è basso. Molti altri grandi consumatori affrontano invece crisi di altro tipo: la Siria ad esempio, o l’Irak. Durante la guerra americana nel Paese di Saddam, la contrazione della domanda mandò in crisi i produttori srilankesi che vendevano agli iracheni il 15% del loro export. Chiesero aiuto al governo che dovette intervenire. Come sta facendo adesso, ricomprando tè per stabilizzarne il prezzo. Di quanto è caduto? Sul mercato americano, largo consumatore in crescita (come l’Italia), è passato dai quasi 4 dollari al chilo del luglio 2015 ai 3,20 di gennaio. Alla borsa del tè di Londra (il secondo importatore mondiale) siamo a circa 3 dollari e mezzo. Variazioni così, moltiplicate per tonnellate acquistate o vendute, produce differenze esorbitanti. E lacrime amare anche sulle dolci colline di Kandy.
C’è una lacrima nel mio tè/ 1
Lo Sri Lanka è uno dei grandi produttori mondiali di tè. Adesso in crisi perché l’oro nero in tazza segue l’andamento dei prezzi del petrolio e i suoi profitti sono in caduta libera. E chi lo comprava ne sta acquistando meno
Kandy (Sri Lanka)- Il baracchino lungo la strada apre alle sei del mattino. La gente passa per le frittelle e un tè nero o col latte. Ma è una piccola delusione il primo sorso del prodotto che, con la bellezza della sue coste, ha reso nota la Lacrima dell’Oceano indiano. Il tè che si beve a Sri Lanka è solo una cattiva imitazione di quello che, con un ampio gesto del braccio, viene miscelato al latte da una tazza all’altra nei cay shop indiani da Peshawar a Calcutta. E’ scadente persino a Kandy, la capitale del tè, una cittadina di 100mila abitanti arrampicata su colline di un verde intenso e affacciata su un lago. Ci si arriva in treno o con qualche autobus mal in arnese dove la costante di ogni fermata è la tazza di oro nero. Sì, perché Kandy è famosa per due cose: un dente del Budda, conservato con religiosa attenzione in un enorme palazzo sul lago, e il tè. Un tempo era anche un buen retiro, prima che il turismo di massa, impennatosi dopo la fine della guerra civile nel 2009, portasse orde di viaggiatori e il relativo lavorio di ruspe e betoniere. Oggi, un albergo con vista lago – nella parte alta della città – è un hotel con vista albergo: uno davanti all’altro con una gara a quale sarà più alto.
Se la città ha perso un po’ della sua magia, come per altro accade ad altri luoghi del sogno cartolina del subcontinente – da Goa a Kovalam Beach per citare i più noti – i dintorni riscattano la fama di una città che da antica capitale del Paese è diventata la capitale del tè del pianeta. Benché si possa comprare nel caotico bazar della città, un piccolo edificio a due piani compresso da negozietti che vendono spezie e tè a prezzi esorbitanti, vale al pena di andare a cercarlo nelle colline dove nel 1867 il britannico James Taylor impiantò la prima piantagione. E gli disse bene. Oggi si coltiva su quasi 200mila ettari: la qualità per l’estero è famosa e Sri Lanka è tra i primi produttori ed esportatori del pianeta. Circa un milione di persone lavorano nell’industria del tè, un capitolo torbido della sua Storia passata e recente.
 Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Non è difficile accorgersene passeggiando in collina dove è facile incontrare chi il tè lo raccoglie, soprattutto donne e quasi tutte tamil che la gente come Taylor “importò” dall’India per creare una colonia di coltivatori estranea alla popolazione locale, singalese e riluttante. Gli abiti sono sfilacciati ma eleganti. E il sorriso di queste signore di raffinata bellezza è incoraggiante ma spesso manca una fila di denti. Oggi non sono più le schiave che furono ai tempi di Taylor e un trattato ha riportato in India molte famiglie. Ma altre non se ne son volute andare. Semmai restare – finalmente con un documento di identità riconosciuto da Colombo – come cittadini srilankesi che ormai avevano qui le proprie radici. Con salari minimi e nella scala più bassa della forza lavoro locale, le donne del tè (quasi l’80% del settore) vivono coi famigliari in baracche allineate con abitazioni di una o due stanze. Ma c’è chi è riuscito a comprare casa o un pezzo di terra. Sorridono ma non parlano volentieri. Fino a un anno fa Sri Lanka era uno Stato di polizia. I giornalisti non erano benvenuti per via della guerra con le Tigri tamil del Nord. Men che meno i sindacalisti. Le cose stanno lentamente cambiando e forse stanno migliorando, da quando il nuovo presidente Maithripala Sirisena ha scalzato Mahinda Rajapaksa, signore e padrone del Paese, vincitore della guerra civile, assertore di una vulgata nazional-buddistico-singalese e amico dei cinesi. Perse le elezioni del gennaio dell’anno scorso, aveva tentato un colpo di Stato ma Delhi e Washington si misero di mezzo sostenendo Sirisena che, appena seduto sullo scranno più alto, ha disdetto tutti i contratti con la Cina. Nemmeno il piccolo Sri Lanka sfugge alle regole della geopolitica. Quanto al tè, le vendite vanno maluccio. O meglio, il prezzo del tè sul mercato internazionale è in calo costante da un paio d’anni. Segue, paradossalmente, la parabola del petrolio. L’oro nero alle pompe di benzina si riflette nell’oro nero in tazza grande.
Il tè è in crisi un po’ ovunque. E’ la Cina a detenere la palma del primo produttore mondiale e il vanto di una storia millenaria. Racconta la sinologa Isabella Doniselli che «allo stato selvatico il tè è una pianta che può superare i 10 metri: ecco perché il mitico sovrano Shennong, addormentatosi sotto un albero, vide cadere nel bollitore le sue foglie», facendo nascere la seconda bevanda al mondo dopo l’acqua. Ma anche in Cina la preziosa fogliolina vale sempre meno perché il governo ha levato i sussidi mentre la crisi ha contratto la domanda di importazioni in un Paese dove il tè non è mai abbastanza. E per lo Sri Lanka, per un Paese che è il quarto produttore mondiale e dove il tè è il principale prodotto di esportazione (che val quasi 1,4 miliardi di dollari l’anno), minor richiesta e calo del prezzo del petrolio sono un serio problema. Tè e petrolio? Si, perché da che il prezzo dell’oro nero è calato fino a soglie inaspettate, anche il prezzo dell’altro oro nero (o verde) è precipitato. Per la Lacrima dell’Oceano indiano son lacrime amare.
 |
| La Regina Vittoria: quando regna il tè diventa uno dei grandi prodotti delle colonie d’oltremare |
Se è vero che gli italiani risparmiano circa 500 euro l’anno quando vanno a fare il pieno, è vero anche che per un produttore di alimenti la caduta del prezzo del petrolio è una cattiva notizia. L’agroalimentare, di cui il tè è uno dei grandi protagonisti, è ormai petrolio-dipendente grazie alle “rivoluzioni verdi” con trattori e mietitrebbie. Ciò significa che ora si produce di più a meno ma l’eccesso di offerta globale fa cadere il prezzo. Se poi, per altri motivi, la domanda sul mercato si contrae, il prezzo si abbassa ulteriormente. Il tè costa meno ma lo beve anche meno gente e i margini di profitto si riducono. Specie tra i grandi compratori, come Russia, Arabia saudita o Paesi dell’Asia ex sovietica che sono anche produttori di petrolio. Guadagnano meno e, in proporzione, comprano meno tè anche se il prezzo è basso. Molti altri grandi consumatori affrontano invece crisi di altro tipo: la Siria ad esempio, o l’Irak. Durante la guerra americana nel Paese di Saddam, la contrazione della domanda mandò in crisi i produttori srilankesi che vendevano agli iracheni il 15% del loro export. Chiesero aiuto al governo che dovette intervenire. Come sta facendo adesso, ricomprando tè per stabilizzarne il prezzo. Di quanto è caduto? Sul mercato americano, largo consumatore in crescita (come l’Italia), è passato dai quasi 4 dollari al chilo del luglio 2015 ai 3,20 di gennaio. Alla borsa del tè di Londra (il secondo importatore mondiale) siamo a circa 3 dollari e mezzo. Variazioni così, moltiplicate per tonnellate acquistate o vendute, produce differenze esorbitanti. E lacrime amare anche sulle dolci colline di Kandy.
Quel giorno d’aprile a Giava quando nacque il Terzo Polo
Bandung è una città indonesiana di Giava famosa per i suoi giardini. I notabili ci andavano e ci
vanno in vacanza perché le verdi colline di quel paesaggio riposano la vista e in qualche modo rinfrescano l’aria. A un certo punto della Storia, quella con la S maiuscola, diventò una capitale. La capitale di un movimento. Il movimento dei non allineati. Era il 18 aprile del 1955, la seconda guerra mondiale era finita da dieci anni e il nuovo assetto uscito da Yalta aveva diviso il pianeta in due grandi sfere di influenza e dato le racchette per giocare a palla col mondo a due soli tennisti: gli Stati Uniti e l’Unione sovietica. Si prospettava un pianeta pacificato e retto su un equilibrio geostrategico, garantito dalla guardia dei due grandi blocchi: il ”mondo libero”, come si chiamava allora, e il “mondo comunista”. Ognuno poteva dipingere il suo nemico come preferiva.
E si perché, nonostante tutto il mondo pacificato restava un mondo in guerra e l’equilibrio era un equilibrio del terrore dopo che le bombe a Hiroshima e Nagasaki avevano dimostrato che l’uomo può uccidere milioni di persone e contaminare il territorio dove vivono per secoli premendo un bottone.
 |
| Nehru |
La Guerra Fredda, combattuta soprattutto con la deterrenza del terrore fornita dal possesso dell’atomica, non fu un tempo senza guerra. Si combatteva lontano – come in Vietnam o nell’Africa della decolonizzazione – oppure con armi apparentemente meno letali: la propaganda, gli 007, lo strangolamento commerciale, la fornitura di armi a piccoli gruppi insurrezionalisti o a eserciti che agivano anche in conto terzi. Era un mondo strano quello della Guerra Fredda. Per noi era un tempo congelato. Per altri un periodo bollente e colorato di sangue. Urss e Usa, gli acronimi sulla bocca di tutti, comandavano. Gli altri eseguivano, con agende nazionali che potevano funzionare solo se in linea con gli interessi delle due grandi potenze. Ma qualcosa stava per cambiare. Qualcuno voleva minare le regole del gioco o, se volete, prendervi parte. Qualcuno voleva smettere di essere solo un comprimario, smettere di lavorare come fa un mezzadro col suo padrone. L’appuntamento venne deciso a Bandung.
 |
| Krishna Menon |
L’infanzia del movimento dei paesi non allineati si fa risalire alla conferenza di Bandung del 1955, nella quale 29 Stati asiatici e africani sottoscrissero una dichiarazione a sostegno della pace e del disarmo internazionale, per il superamento del colonialismo e il rispetto dei principi di autodeterminazione dei popoli, di uguaglianza fra gli Stati e di non ingerenza nei reciproci affari interni. Alla conferenza di Belgrado del 1961, in cui il movimento si costituì ufficialmente, si respingeva la logica dei due blocchi contrapposti, si proponeva di dare impulso al processo di decolonizzazione e al miglioramento delle condizioni economiche del Terzo Mondo. Gli Stati aderenti si proponevano una politica di ‘neutralismo attivo’ che rivendicava un «nuovo ordine economico internazionale».
Bandung doveva essere in realtà solo il luogo preparatorio di quella che che poi doveva diventare, a Belgrado appunto nel 1961, la nascita ufficiale del Movimento dei non allineati, di questo terzo incomodo che vedeva un pericolo nel bipolarismo Usa Urss e che, a un’opposizione Est – Ovest preferiva una dottrina che divideva in mondo in Nord e Sud: poveri contro ricchi in due parole. Ma Bandung fu qualcosa di più di una semplice Conferenza afroasiatica cui parteciparono gli asiatici. Venne coniato il termine “spirito di Bandung” ed è a Bandung che fu coniata la locuzione Terzo mondo, dove quel terzo indicava bene cosa i non allineati avevano in mente. Un documento in dieci punti concluse la Conferenza che segnò anche il primo incontro tra strategie diverse che cercavano un punto comune: dal pacifismo dell’indiano Nehru, al neutralismo del cinese Zhou Enlai. Il messaggio di apertura fu affidato all’indonesiano Sukarno, l’anfitrione dell’incontro
Sukarno era uno dei grandi artefici della nascita del Movimento e con lui il primo premier dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru. Ma c’era anche il secondo presidente egiziano, Gamal Abdel Nasser, il presidente iugoslavo Tito e il primo presidente del Ghana, Kwame Nkrumah, nomi noti per quella che è stata chiamata: The Initiative of Five, l’iniziativa dei cinque. Ma non ci sono solo loro: c’è anche il grande artefice della politica estera cinese, Zhou Enlai. C’era il Pakistan, l’India, l’Iran, il Vietnam – del Sud ovviamente – e persino l’Afghanistan. C’è il regno cambogiano di Norodom Sihanuk. L’Africa è invece largamente sottorappresentata anche se ci sono figure di spicco come Nkrumah e ovviamente l’Egitto di Nasser. Chi erano questi protagonisti? Chi erano i cinque o più di quell’iniziativa? Lo vedremo e vedremo anche chi, dietro le quinte, aveva lavorato a costruire la dottrina e chi, ancora dietro le quinte, aveva organizzato l’evento. Due persone in particolare: l’indiano Krishna Menon – il vero architetto teorico del non allineamento – e l’indonesiano Ali Sastroamidjojo, il primo ministro che presiederà i lavori che si concluderanno il 24 aprile.
Gli anni Cinquanta sono gli anni della decolonizzazione e dell’imperialismo. La prima non è ancora
 |
| Il movimento esiste ancora ma non è più la stessa cosa |
finita se è vero che dovremo aspettare sino al 1994 per vedere in Sudafrica la fine dell’apartheid, l’aspetto più odioso della tradizione coloniale. L’imperialismo invece è il modo – negli occhi dei non allineati – con cui il bipolarismo ricatta il resto del mondo. Molti di questi Paesi hanno in realtà rapporti sia col mondo americano, sia – soprattutto – con quello sovietico, ma il nuovo equilibrio che propongono ha un suo senso. Talmente reale che la caduta del muro e la fine dei blocchi renderanno quasi vuoto il significato di un movimento che esiste ancora oggi e di cui è segretario generale il presidente iraniano Rohani. L’architettura del non allineamento nasce da più menti e in più nazioni ma la Storia riconosce a Krishna Menon il merito principale: il merito di averla compiutamente già elaborata a partire dai prima anni Cinquanta, facendone un pilastro della politica estera indiana e citando il termine in un discorso alle Nazioni unite. Menon è un nazionalista, amico di Nehru, l’uomo che, con Gandhi e il Partito del Congresso, è adesso a capo di un India indipendente dal 1947. Di Nehru si sa tutto e così della sua dinastia, continuata con la figlia Indira, lei pure presente alla Conferenza di Bandung. Di Krishna Menon si sa poco. Ma alcune sue frasi piccanti sono rimaste nella storia come quella riguardo alla sincerità degli Stati Uniti equiparabile – dice Menon – alla possibilità di “incontrare una tigre vegetariana”
A Bandung gli onori di casa li fa Kusno Sosrodihardjo Sukarno, Bung Karno, il compagno Sukarno. A Bandung, dove la via centrale della cittadina si chiama Jalan Asia Afrika, Sukarno è all’apice della sua carriera politica e del consenso. Anche se ci sono voluti quattro anni per strappare definitivamente il potere agli olandesi nel 1949, Bung karno ha proclamato l’indipendenza dell’Indonesia già nel 1945. Governa da dieci anni: è un eroe nazionale che ha saputo corteggiare più di un amicizia e tenere in piedi un equilibrio precario tra il Partito comunista, uno dei più forti dell’Asia, un mondo rurale arretrato e spesso conservatore e un movimento islamico che non sempre gli è amico. Bandung è il suo trionfo in politica estera. Dieci anni dopo, il 1965 segnerà la sua fine e la fine dell’esperimento di “democrazia guidata” che, per i generali golpisti indonesiani, era il segno di una debolezza filocomunista. Quanto ad Ali Sastroamidjojo, il suo primo ministro, è uomo che conosce la politica estera quanto quella interna. E’ stato ambasciatore negli Stati Uniti, in Canada, in Messico ed è capo del Partito nazionalista di Sukarno. Dal 1957 al ’60 è il Rappresentante dell’Indonesia all’Onu. Il colpo di stato del 1965 gli risparmierà la vita ma chiuderà, come per Sukarno, la sua carriera politica. Era stato lui a comperare negli Stati Uniti l’attuale residenza diplomatica indonesiana. Costava circa 300mila dollari. Altri tempi.
 |
| Zhou Enlai |
Un uomo per tutte le stagioni è invece il primo ministro e ministro degli esteri cinese Zhou Enlai. Per lui, l’uomo che aveva partecipato alla conferenza di Ginevra del ’54 sulla questione indocinese e corena, che aveva negoziato coi nazionalisti di Chang Kai Shek e che negli anni Settanta negozierà l’ingresso della Cina all’Onu e darà luce verde al processo che porterà Washington e Pechino a parlarsi, Bandung è l’occasione per far uscire il suo Paese dall’isolamento internazionale. Per dare statura alla rivoluzione di Mao che Zhou ha contribuito a creare. La sua carta è la parola “neutralità”, una formula che ha poi marcato per sempre la politica estera dell’Impero di mezzo. L’11 aprile del 1955 Zhou Enlai ha una carta d’imbarco per la Kashmir Princess, un aereo affitato dall’Air India alla Cina per la Conferenza di Bandung. Sull’aereo, dove ci sono funzionari e giornalisti, viene piazzata una bomba che esplode mentre l’apparecchio è in volo. Si salvano in tre. Ma Zhou Enlai, la probabile vittima sacrificale di un probabile team di attentatori nazionalisti, non è su quella lista. Ma non è nemmeno tra i morti. Ha cambiato programma all’ultimo minuto e sulla Princess non è mai salito
 A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
 |
| Nasser e, sopra, Tito Sotto: Nkrumah |
C’era Fidel Castro ai funerali di Tito ma non c’era Sukarno, né Nehru, e nemmeno Gamal Abdel Nasser, il secondo segretario generale del Movimento dal 1964 al 1970. Nasser diventa presidente dell’Egitto in realtà nel 1956 ma nel 1955 a Bandung viene accolto assai più che come un capo di Stato. E’ l’uomo leader del mondo arabo, un fervente anticolonialista, un uomo che ha una visione panaraba e coraggio. L’uomo che avrà il coraggio di proclamare la nazionalizzazione del Canale di Suez, il simbolo allora della servitù nei confronti degli ex padroni coloniali. Paradossalmente, a risolvere la crisi di Suez nel ’56, dopo il bombardamento del Cairo e l’occupazione di Port Said da parte degli anglo-francesi, saranno proprio Usa e Urss. La crisi segna una battuta d’arresto ma a Bandung è stato un trionfo: prima di arrivare in Indonesia, Nasser viaggia in Afghanistan, Pakistan, India e Birmania. A Bandung media tra filo occidentali, prosovietici e neutralisti e fa passare risoluzioni che appoggiano la lotta anti francese in Tunisia, Marocco e Algeria e il diritto al ritorno dei palestinesi. C’è una foto a Bandung che lo ritrae coi notabili yemeniti, sauditi e palestinesi. Gamal è l’unico a non portare il capo coperto
 L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
E’ l’ora di tirare le somme. Quali? Il Movimento esiste ancora ma non esiste più, forse, lo spirito di Bandung. E in un mondo ormai non più bipolare e che oscilla tra l’unipolarismo e il grande caos, forse ha ancora senso quella battuta di Krishna Menon: abbiamo ancora da incontrare una tigre vegetariana!
* Ascolta la puntata su Wikiradio
Quel giorno d’aprile a Giava quando nacque il Terzo Polo
Bandung è una città indonesiana di Giava famosa per i suoi giardini. I notabili ci andavano e ci
vanno in vacanza perché le verdi colline di quel paesaggio riposano la vista e in qualche modo rinfrescano l’aria. A un certo punto della Storia, quella con la S maiuscola, diventò una capitale. La capitale di un movimento. Il movimento dei non allineati. Era il 18 aprile del 1955, la seconda guerra mondiale era finita da dieci anni e il nuovo assetto uscito da Yalta aveva diviso il pianeta in due grandi sfere di influenza e dato le racchette per giocare a palla col mondo a due soli tennisti: gli Stati Uniti e l’Unione sovietica. Si prospettava un pianeta pacificato e retto su un equilibrio geostrategico, garantito dalla guardia dei due grandi blocchi: il ”mondo libero”, come si chiamava allora, e il “mondo comunista”. Ognuno poteva dipingere il suo nemico come preferiva.
E si perché, nonostante tutto il mondo pacificato restava un mondo in guerra e l’equilibrio era un equilibrio del terrore dopo che le bombe a Hiroshima e Nagasaki avevano dimostrato che l’uomo può uccidere milioni di persone e contaminare il territorio dove vivono per secoli premendo un bottone.
 |
| Nehru |
La Guerra Fredda, combattuta soprattutto con la deterrenza del terrore fornita dal possesso dell’atomica, non fu un tempo senza guerra. Si combatteva lontano – come in Vietnam o nell’Africa della decolonizzazione – oppure con armi apparentemente meno letali: la propaganda, gli 007, lo strangolamento commerciale, la fornitura di armi a piccoli gruppi insurrezionalisti o a eserciti che agivano anche in conto terzi. Era un mondo strano quello della Guerra Fredda. Per noi era un tempo congelato. Per altri un periodo bollente e colorato di sangue. Urss e Usa, gli acronimi sulla bocca di tutti, comandavano. Gli altri eseguivano, con agende nazionali che potevano funzionare solo se in linea con gli interessi delle due grandi potenze. Ma qualcosa stava per cambiare. Qualcuno voleva minare le regole del gioco o, se volete, prendervi parte. Qualcuno voleva smettere di essere solo un comprimario, smettere di lavorare come fa un mezzadro col suo padrone. L’appuntamento venne deciso a Bandung.
 |
| Krishna Menon |
L’infanzia del movimento dei paesi non allineati si fa risalire alla conferenza di Bandung del 1955, nella quale 29 Stati asiatici e africani sottoscrissero una dichiarazione a sostegno della pace e del disarmo internazionale, per il superamento del colonialismo e il rispetto dei principi di autodeterminazione dei popoli, di uguaglianza fra gli Stati e di non ingerenza nei reciproci affari interni. Alla conferenza di Belgrado del 1961, in cui il movimento si costituì ufficialmente, si respingeva la logica dei due blocchi contrapposti, si proponeva di dare impulso al processo di decolonizzazione e al miglioramento delle condizioni economiche del Terzo Mondo. Gli Stati aderenti si proponevano una politica di ‘neutralismo attivo’ che rivendicava un «nuovo ordine economico internazionale».
Bandung doveva essere in realtà solo il luogo preparatorio di quella che che poi doveva diventare, a Belgrado appunto nel 1961, la nascita ufficiale del Movimento dei non allineati, di questo terzo incomodo che vedeva un pericolo nel bipolarismo Usa Urss e che, a un’opposizione Est – Ovest preferiva una dottrina che divideva in mondo in Nord e Sud: poveri contro ricchi in due parole. Ma Bandung fu qualcosa di più di una semplice Conferenza afroasiatica cui parteciparono gli asiatici. Venne coniato il termine “spirito di Bandung” ed è a Bandung che fu coniata la locuzione Terzo mondo, dove quel terzo indicava bene cosa i non allineati avevano in mente. Un documento in dieci punti concluse la Conferenza che segnò anche il primo incontro tra strategie diverse che cercavano un punto comune: dal pacifismo dell’indiano Nehru, al neutralismo del cinese Zhou Enlai. Il messaggio di apertura fu affidato all’indonesiano Sukarno, l’anfitrione dell’incontro
Sukarno era uno dei grandi artefici della nascita del Movimento e con lui il primo premier dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru. Ma c’era anche il secondo presidente egiziano, Gamal Abdel Nasser, il presidente iugoslavo Tito e il primo presidente del Ghana, Kwame Nkrumah, nomi noti per quella che è stata chiamata: The Initiative of Five, l’iniziativa dei cinque. Ma non ci sono solo loro: c’è anche il grande artefice della politica estera cinese, Zhou Enlai. C’era il Pakistan, l’India, l’Iran, il Vietnam – del Sud ovviamente – e persino l’Afghanistan. C’è il regno cambogiano di Norodom Sihanuk. L’Africa è invece largamente sottorappresentata anche se ci sono figure di spicco come Nkrumah e ovviamente l’Egitto di Nasser. Chi erano questi protagonisti? Chi erano i cinque o più di quell’iniziativa? Lo vedremo e vedremo anche chi, dietro le quinte, aveva lavorato a costruire la dottrina e chi, ancora dietro le quinte, aveva organizzato l’evento. Due persone in particolare: l’indiano Krishna Menon – il vero architetto teorico del non allineamento – e l’indonesiano Ali Sastroamidjojo, il primo ministro che presiederà i lavori che si concluderanno il 24 aprile.
Gli anni Cinquanta sono gli anni della decolonizzazione e dell’imperialismo. La prima non è ancora
 |
| Il movimento esiste ancora ma non è più la stessa cosa |
finita se è vero che dovremo aspettare sino al 1994 per vedere in Sudafrica la fine dell’apartheid, l’aspetto più odioso della tradizione coloniale. L’imperialismo invece è il modo – negli occhi dei non allineati – con cui il bipolarismo ricatta il resto del mondo. Molti di questi Paesi hanno in realtà rapporti sia col mondo americano, sia – soprattutto – con quello sovietico, ma il nuovo equilibrio che propongono ha un suo senso. Talmente reale che la caduta del muro e la fine dei blocchi renderanno quasi vuoto il significato di un movimento che esiste ancora oggi e di cui è segretario generale il presidente iraniano Rohani. L’architettura del non allineamento nasce da più menti e in più nazioni ma la Storia riconosce a Krishna Menon il merito principale: il merito di averla compiutamente già elaborata a partire dai prima anni Cinquanta, facendone un pilastro della politica estera indiana e citando il termine in un discorso alle Nazioni unite. Menon è un nazionalista, amico di Nehru, l’uomo che, con Gandhi e il Partito del Congresso, è adesso a capo di un India indipendente dal 1947. Di Nehru si sa tutto e così della sua dinastia, continuata con la figlia Indira, lei pure presente alla Conferenza di Bandung. Di Krishna Menon si sa poco. Ma alcune sue frasi piccanti sono rimaste nella storia come quella riguardo alla sincerità degli Stati Uniti equiparabile – dice Menon – alla possibilità di “incontrare una tigre vegetariana”
A Bandung gli onori di casa li fa Kusno Sosrodihardjo Sukarno, Bung Karno, il compagno Sukarno. A Bandung, dove la via centrale della cittadina si chiama Jalan Asia Afrika, Sukarno è all’apice della sua carriera politica e del consenso. Anche se ci sono voluti quattro anni per strappare definitivamente il potere agli olandesi nel 1949, Bung karno ha proclamato l’indipendenza dell’Indonesia già nel 1945. Governa da dieci anni: è un eroe nazionale che ha saputo corteggiare più di un amicizia e tenere in piedi un equilibrio precario tra il Partito comunista, uno dei più forti dell’Asia, un mondo rurale arretrato e spesso conservatore e un movimento islamico che non sempre gli è amico. Bandung è il suo trionfo in politica estera. Dieci anni dopo, il 1965 segnerà la sua fine e la fine dell’esperimento di “democrazia guidata” che, per i generali golpisti indonesiani, era il segno di una debolezza filocomunista. Quanto ad Ali Sastroamidjojo, il suo primo ministro, è uomo che conosce la politica estera quanto quella interna. E’ stato ambasciatore negli Stati Uniti, in Canada, in Messico ed è capo del Partito nazionalista di Sukarno. Dal 1957 al ’60 è il Rappresentante dell’Indonesia all’Onu. Il colpo di stato del 1965 gli risparmierà la vita ma chiuderà, come per Sukarno, la sua carriera politica. Era stato lui a comperare negli Stati Uniti l’attuale residenza diplomatica indonesiana. Costava circa 300mila dollari. Altri tempi.
 |
| Zhou Enlai |
Un uomo per tutte le stagioni è invece il primo ministro e ministro degli esteri cinese Zhou Enlai. Per lui, l’uomo che aveva partecipato alla conferenza di Ginevra del ’54 sulla questione indocinese e corena, che aveva negoziato coi nazionalisti di Chang Kai Shek e che negli anni Settanta negozierà l’ingresso della Cina all’Onu e darà luce verde al processo che porterà Washington e Pechino a parlarsi, Bandung è l’occasione per far uscire il suo Paese dall’isolamento internazionale. Per dare statura alla rivoluzione di Mao che Zhou ha contribuito a creare. La sua carta è la parola “neutralità”, una formula che ha poi marcato per sempre la politica estera dell’Impero di mezzo. L’11 aprile del 1955 Zhou Enlai ha una carta d’imbarco per la Kashmir Princess, un aereo affitato dall’Air India alla Cina per la Conferenza di Bandung. Sull’aereo, dove ci sono funzionari e giornalisti, viene piazzata una bomba che esplode mentre l’apparecchio è in volo. Si salvano in tre. Ma Zhou Enlai, la probabile vittima sacrificale di un probabile team di attentatori nazionalisti, non è su quella lista. Ma non è nemmeno tra i morti. Ha cambiato programma all’ultimo minuto e sulla Princess non è mai salito
 A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
 |
| Nasser e, sopra, Tito Sotto: Nkrumah |
C’era Fidel Castro ai funerali di Tito ma non c’era Sukarno, né Nehru, e nemmeno Gamal Abdel Nasser, il secondo segretario generale del Movimento dal 1964 al 1970. Nasser diventa presidente dell’Egitto in realtà nel 1956 ma nel 1955 a Bandung viene accolto assai più che come un capo di Stato. E’ l’uomo leader del mondo arabo, un fervente anticolonialista, un uomo che ha una visione panaraba e coraggio. L’uomo che avrà il coraggio di proclamare la nazionalizzazione del Canale di Suez, il simbolo allora della servitù nei confronti degli ex padroni coloniali. Paradossalmente, a risolvere la crisi di Suez nel ’56, dopo il bombardamento del Cairo e l’occupazione di Port Said da parte degli anglo-francesi, saranno proprio Usa e Urss. La crisi segna una battuta d’arresto ma a Bandung è stato un trionfo: prima di arrivare in Indonesia, Nasser viaggia in Afghanistan, Pakistan, India e Birmania. A Bandung media tra filo occidentali, prosovietici e neutralisti e fa passare risoluzioni che appoggiano la lotta anti francese in Tunisia, Marocco e Algeria e il diritto al ritorno dei palestinesi. C’è una foto a Bandung che lo ritrae coi notabili yemeniti, sauditi e palestinesi. Gamal è l’unico a non portare il capo coperto
 L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
E’ l’ora di tirare le somme. Quali? Il Movimento esiste ancora ma non esiste più, forse, lo spirito di Bandung. E in un mondo ormai non più bipolare e che oscilla tra l’unipolarismo e il grande caos, forse ha ancora senso quella battuta di Krishna Menon: abbiamo ancora da incontrare una tigre vegetariana!
* Ascolta la puntata su Wikiradio
Quel giorno d’aprile a Giava quando nacque il Terzo Polo
Bandung è una città indonesiana di Giava famosa per i suoi giardini. I notabili ci andavano e ci
vanno in vacanza perché le verdi colline di quel paesaggio riposano la vista e in qualche modo rinfrescano l’aria. A un certo punto della Storia, quella con la S maiuscola, diventò una capitale. La capitale di un movimento. Il movimento dei non allineati. Era il 18 aprile del 1955, la seconda guerra mondiale era finita da dieci anni e il nuovo assetto uscito da Yalta aveva diviso il pianeta in due grandi sfere di influenza e dato le racchette per giocare a palla col mondo a due soli tennisti: gli Stati Uniti e l’Unione sovietica. Si prospettava un pianeta pacificato e retto su un equilibrio geostrategico, garantito dalla guardia dei due grandi blocchi: il ”mondo libero”, come si chiamava allora, e il “mondo comunista”. Ognuno poteva dipingere il suo nemico come preferiva.
E si perché, nonostante tutto il mondo pacificato restava un mondo in guerra e l’equilibrio era un equilibrio del terrore dopo che le bombe a Hiroshima e Nagasaki avevano dimostrato che l’uomo può uccidere milioni di persone e contaminare il territorio dove vivono per secoli premendo un bottone.
 |
| Nehru |
La Guerra Fredda, combattuta soprattutto con la deterrenza del terrore fornita dal possesso dell’atomica, non fu un tempo senza guerra. Si combatteva lontano – come in Vietnam o nell’Africa della decolonizzazione – oppure con armi apparentemente meno letali: la propaganda, gli 007, lo strangolamento commerciale, la fornitura di armi a piccoli gruppi insurrezionalisti o a eserciti che agivano anche in conto terzi. Era un mondo strano quello della Guerra Fredda. Per noi era un tempo congelato. Per altri un periodo bollente e colorato di sangue. Urss e Usa, gli acronimi sulla bocca di tutti, comandavano. Gli altri eseguivano, con agende nazionali che potevano funzionare solo se in linea con gli interessi delle due grandi potenze. Ma qualcosa stava per cambiare. Qualcuno voleva minare le regole del gioco o, se volete, prendervi parte. Qualcuno voleva smettere di essere solo un comprimario, smettere di lavorare come fa un mezzadro col suo padrone. L’appuntamento venne deciso a Bandung.
 |
| Krishna Menon |
L’infanzia del movimento dei paesi non allineati si fa risalire alla conferenza di Bandung del 1955, nella quale 29 Stati asiatici e africani sottoscrissero una dichiarazione a sostegno della pace e del disarmo internazionale, per il superamento del colonialismo e il rispetto dei principi di autodeterminazione dei popoli, di uguaglianza fra gli Stati e di non ingerenza nei reciproci affari interni. Alla conferenza di Belgrado del 1961, in cui il movimento si costituì ufficialmente, si respingeva la logica dei due blocchi contrapposti, si proponeva di dare impulso al processo di decolonizzazione e al miglioramento delle condizioni economiche del Terzo Mondo. Gli Stati aderenti si proponevano una politica di ‘neutralismo attivo’ che rivendicava un «nuovo ordine economico internazionale».
Bandung doveva essere in realtà solo il luogo preparatorio di quella che che poi doveva diventare, a Belgrado appunto nel 1961, la nascita ufficiale del Movimento dei non allineati, di questo terzo incomodo che vedeva un pericolo nel bipolarismo Usa Urss e che, a un’opposizione Est – Ovest preferiva una dottrina che divideva in mondo in Nord e Sud: poveri contro ricchi in due parole. Ma Bandung fu qualcosa di più di una semplice Conferenza afroasiatica cui parteciparono gli asiatici. Venne coniato il termine “spirito di Bandung” ed è a Bandung che fu coniata la locuzione Terzo mondo, dove quel terzo indicava bene cosa i non allineati avevano in mente. Un documento in dieci punti concluse la Conferenza che segnò anche il primo incontro tra strategie diverse che cercavano un punto comune: dal pacifismo dell’indiano Nehru, al neutralismo del cinese Zhou Enlai. Il messaggio di apertura fu affidato all’indonesiano Sukarno, l’anfitrione dell’incontro
Sukarno era uno dei grandi artefici della nascita del Movimento e con lui il primo premier dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru. Ma c’era anche il secondo presidente egiziano, Gamal Abdel Nasser, il presidente iugoslavo Tito e il primo presidente del Ghana, Kwame Nkrumah, nomi noti per quella che è stata chiamata: The Initiative of Five, l’iniziativa dei cinque. Ma non ci sono solo loro: c’è anche il grande artefice della politica estera cinese, Zhou Enlai. C’era il Pakistan, l’India, l’Iran, il Vietnam – del Sud ovviamente – e persino l’Afghanistan. C’è il regno cambogiano di Norodom Sihanuk. L’Africa è invece largamente sottorappresentata anche se ci sono figure di spicco come Nkrumah e ovviamente l’Egitto di Nasser. Chi erano questi protagonisti? Chi erano i cinque o più di quell’iniziativa? Lo vedremo e vedremo anche chi, dietro le quinte, aveva lavorato a costruire la dottrina e chi, ancora dietro le quinte, aveva organizzato l’evento. Due persone in particolare: l’indiano Krishna Menon – il vero architetto teorico del non allineamento – e l’indonesiano Ali Sastroamidjojo, il primo ministro che presiederà i lavori che si concluderanno il 24 aprile.
Gli anni Cinquanta sono gli anni della decolonizzazione e dell’imperialismo. La prima non è ancora
 |
| Il movimento esiste ancora ma non è più la stessa cosa |
finita se è vero che dovremo aspettare sino al 1994 per vedere in Sudafrica la fine dell’apartheid, l’aspetto più odioso della tradizione coloniale. L’imperialismo invece è il modo – negli occhi dei non allineati – con cui il bipolarismo ricatta il resto del mondo. Molti di questi Paesi hanno in realtà rapporti sia col mondo americano, sia – soprattutto – con quello sovietico, ma il nuovo equilibrio che propongono ha un suo senso. Talmente reale che la caduta del muro e la fine dei blocchi renderanno quasi vuoto il significato di un movimento che esiste ancora oggi e di cui è segretario generale il presidente iraniano Rohani. L’architettura del non allineamento nasce da più menti e in più nazioni ma la Storia riconosce a Krishna Menon il merito principale: il merito di averla compiutamente già elaborata a partire dai prima anni Cinquanta, facendone un pilastro della politica estera indiana e citando il termine in un discorso alle Nazioni unite. Menon è un nazionalista, amico di Nehru, l’uomo che, con Gandhi e il Partito del Congresso, è adesso a capo di un India indipendente dal 1947. Di Nehru si sa tutto e così della sua dinastia, continuata con la figlia Indira, lei pure presente alla Conferenza di Bandung. Di Krishna Menon si sa poco. Ma alcune sue frasi piccanti sono rimaste nella storia come quella riguardo alla sincerità degli Stati Uniti equiparabile – dice Menon – alla possibilità di “incontrare una tigre vegetariana”
A Bandung gli onori di casa li fa Kusno Sosrodihardjo Sukarno, Bung Karno, il compagno Sukarno. A Bandung, dove la via centrale della cittadina si chiama Jalan Asia Afrika, Sukarno è all’apice della sua carriera politica e del consenso. Anche se ci sono voluti quattro anni per strappare definitivamente il potere agli olandesi nel 1949, Bung karno ha proclamato l’indipendenza dell’Indonesia già nel 1945. Governa da dieci anni: è un eroe nazionale che ha saputo corteggiare più di un amicizia e tenere in piedi un equilibrio precario tra il Partito comunista, uno dei più forti dell’Asia, un mondo rurale arretrato e spesso conservatore e un movimento islamico che non sempre gli è amico. Bandung è il suo trionfo in politica estera. Dieci anni dopo, il 1965 segnerà la sua fine e la fine dell’esperimento di “democrazia guidata” che, per i generali golpisti indonesiani, era il segno di una debolezza filocomunista. Quanto ad Ali Sastroamidjojo, il suo primo ministro, è uomo che conosce la politica estera quanto quella interna. E’ stato ambasciatore negli Stati Uniti, in Canada, in Messico ed è capo del Partito nazionalista di Sukarno. Dal 1957 al ’60 è il Rappresentante dell’Indonesia all’Onu. Il colpo di stato del 1965 gli risparmierà la vita ma chiuderà, come per Sukarno, la sua carriera politica. Era stato lui a comperare negli Stati Uniti l’attuale residenza diplomatica indonesiana. Costava circa 300mila dollari. Altri tempi.
 |
| Zhou Enlai |
Un uomo per tutte le stagioni è invece il primo ministro e ministro degli esteri cinese Zhou Enlai. Per lui, l’uomo che aveva partecipato alla conferenza di Ginevra del ’54 sulla questione indocinese e corena, che aveva negoziato coi nazionalisti di Chang Kai Shek e che negli anni Settanta negozierà l’ingresso della Cina all’Onu e darà luce verde al processo che porterà Washington e Pechino a parlarsi, Bandung è l’occasione per far uscire il suo Paese dall’isolamento internazionale. Per dare statura alla rivoluzione di Mao che Zhou ha contribuito a creare. La sua carta è la parola “neutralità”, una formula che ha poi marcato per sempre la politica estera dell’Impero di mezzo. L’11 aprile del 1955 Zhou Enlai ha una carta d’imbarco per la Kashmir Princess, un aereo affitato dall’Air India alla Cina per la Conferenza di Bandung. Sull’aereo, dove ci sono funzionari e giornalisti, viene piazzata una bomba che esplode mentre l’apparecchio è in volo. Si salvano in tre. Ma Zhou Enlai, la probabile vittima sacrificale di un probabile team di attentatori nazionalisti, non è su quella lista. Ma non è nemmeno tra i morti. Ha cambiato programma all’ultimo minuto e sulla Princess non è mai salito
 A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
A Bandung l’Occidente non c’è. Con qualche eccezione. C’è infatti la Iugoslavia di Josip Broz Tito: l’uomo che sarà il primo segretario generale del Movimento eletto a Belgrado nel 1961 al primo vertice che segue di qualche anno Bandung. Il comandante partigiano è a capo della Federazione iugoslava dal 1945 e qualche anno dopo ha rotto con Stalin e l’Unione sovietica pur essendo tra i fondatori del Cominform, il primo forum internazionale comunista nato nel ’47. Proprio il Cominform, su pressione di Mosca, espellerà la Iugoslavia di Tito mettendolo in difficoltà ma non per questo distogliendolo dal suo progetto di una via nazionale al socialismo. Per Tito dunque, la carta di Bandung ha un peso importante. L’uomo che ha tenuto assieme serbi e croati riesce a creare l’ambito di alleanze dove potersi muovere e fare affari senza essere obbligato a sottostare ai diktat di Mosca. Tito morirà in una clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º compleanno e dieci anni prima che il suo Paese sprofondi nel caos e torni alle antiche divisioni. In base al numero di politici e delegazioni di Stato presenti alle sue esequie, il suo sembra sia stato il maggiore funerale di Stato della Storia dopo quello di Papa Woytila. C’erano quattro re, 31 presidenti, sei principi. 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, rappresentanti di 128 Paesi. Ma i suoi vecchi amici di Bandung non ci sono già più. Il grande vecchio li ha seppelliti quasi tutti.
 |
| Nasser e, sopra, Tito Sotto: Nkrumah |
C’era Fidel Castro ai funerali di Tito ma non c’era Sukarno, né Nehru, e nemmeno Gamal Abdel Nasser, il secondo segretario generale del Movimento dal 1964 al 1970. Nasser diventa presidente dell’Egitto in realtà nel 1956 ma nel 1955 a Bandung viene accolto assai più che come un capo di Stato. E’ l’uomo leader del mondo arabo, un fervente anticolonialista, un uomo che ha una visione panaraba e coraggio. L’uomo che avrà il coraggio di proclamare la nazionalizzazione del Canale di Suez, il simbolo allora della servitù nei confronti degli ex padroni coloniali. Paradossalmente, a risolvere la crisi di Suez nel ’56, dopo il bombardamento del Cairo e l’occupazione di Port Said da parte degli anglo-francesi, saranno proprio Usa e Urss. La crisi segna una battuta d’arresto ma a Bandung è stato un trionfo: prima di arrivare in Indonesia, Nasser viaggia in Afghanistan, Pakistan, India e Birmania. A Bandung media tra filo occidentali, prosovietici e neutralisti e fa passare risoluzioni che appoggiano la lotta anti francese in Tunisia, Marocco e Algeria e il diritto al ritorno dei palestinesi. C’è una foto a Bandung che lo ritrae coi notabili yemeniti, sauditi e palestinesi. Gamal è l’unico a non portare il capo coperto
 L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
L’ultimo giro di giostra è per Kwame Nkrumah, al secolo Francis Nwia-Kofi Ngonloma. E’ noto anche con l’appellativo di Osagyefo, il redentore. E’ un rivoluzionario del Ghana di cui diventa presidente ed è famoso per essere stato il primo leader dell’Africa nera a far ottenere al suo paese l’autogoverno. E’ un panafricano convinto. La sua idea era che i Paesi africani dovessero federarsi e, solo in questo modo, sfuggire alle logiche che avevano fatto del continente africano la più grande colonia del pianeta. Bandung era per Nkrumah l’esportazione ideale della sua idea di indipendenza. E’ morto lontano dal suo Paese, rovesciato da un colpo di Stato a cui aveva fornito consenso la sua gestione autoritaria del Paese. Ma la sua presenza a Bandung fu determinante per dare a quell’incontro anche la patente di africano. Il suo sogno è adesso nelle mani di sua figlia Samia, a capo del ricostruito Partito della Convenzione del popolo.
E’ l’ora di tirare le somme. Quali? Il Movimento esiste ancora ma non esiste più, forse, lo spirito di Bandung. E in un mondo ormai non più bipolare e che oscilla tra l’unipolarismo e il grande caos, forse ha ancora senso quella battuta di Krishna Menon: abbiamo ancora da incontrare una tigre vegetariana!
* Ascolta la puntata su Wikiradio











































































