Se è terribile il dramma di chi è costretto a spostare la propria vita oltre un confine – a causa di una guerra, di una carestia, della mancanza di prospettive nel suo Paese – è ancor più terribile il dramma di chi viene scacciato. E ancora più devasta…
Anno: 2017
Quando arriva la Pace…
mcc43 In tutta la loro tragicità emergono le rovine e si omette la domanda: Perché? ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ La guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri. Hannah Arendt Google+ Annunci Archiviato in:Interrogativi Tagged: Civiltà, worldwide…
Le molte virtù degli asini
Le immagini sono tratte da thedonkeysanctuary.org.uk«L’insaziabile richiesta in Cina di asini da tutto il mondo – scriveva qualche giorno fa l’Agenzia Italia – sta provocando conseguenze inattese sui lavoratori nigeriani che fanno affidamento su q…
Iraq: Hayv Kahraman e la sua mostra di ventagli che evocano antichi ricordi
Il nuovo lavoro artistico di Kaharama è un’ esplorazione magistrale delle questioni di identità, difficoltà personale e coscienza umana.
Le reazioni degli Emirati Arabi Uniti in risposta alla “crisi” con la Tunisia
Il comportamento della compagnia Emirates nei confronti delle donne e l’indignazione tunisina.
L’articolo Le reazioni degli Emirati Arabi Uniti in risposta alla “crisi” con la Tunisia sembra essere il primo su Arabpress.
Lo Stato islamcio nel caos permanente afgano
Sfiora i cento morti la prima grande strage da iscrivere allo Stato islamico e al suo progetto del Grande Khorasan. Avviene a Kabul, nel luglio del 2016. Al Baghdadi ha già tentato di insediarsi sulla frontiera orientale e sta cercando adepti in Pakist…
Le molestie sessuali e la piaga delle spose bambine continuano ad affliggere l’Egitto
“Le molestie sessuali sono un problema serio in Egitto. Diversi studi dimostrano che moltissime donne sono vittime di molestie e il problema ha radici profonde”.
Chi ha paura di Razan Zaitouneh?
Questo articolo è stato pubblicato in inglese con il titolo Who’s afraid of Razan Zaitouneh? sul sito aljumhuriyya in occasione del quarto anniversario del rapimento del gruppo Douma4. di Karam Nachar, traduzione di Filomena Annunziata C’è stato un mom…
Recensione: “Diario del asedio a Duma, 2013” (Diario dell’assedio a Douma) di Samira Khalil
di Giovanna De Luca La Ghouta Est è sotto assedio da quasi cinque anni. Quasi 2000 giorni di continui bombardamenti e completa chiusura delle vie d’accesso per e dalla regione. La regione conta mezzo milione di abitanti, 398 (di cui 206 bambini) sono l…
Il regime siriano perderà il controllo sul suo sistema economico a favore della Russia e dell’Iran
Il Regime non può sopravvivere senza il sostegno dell’Iran e della Russia. E gli alleati di Assad stanno già chiedendo il conto per i servizi resi, pretendendo le ricchezza nel sottosuolo, diritti nelle operazioni offshore e il controllo di una parte i…
Come i Caschi Bianchi siriani sono diventati vittime di una macchina di propaganda
La campagna mediatica sostenuta dalla Russia per collegare i soccorritori volontari con al-Qaeda espone le radici delle teorie della cospirazione: “È come una fabbrica” SCRITTO DA OLIVIA SOLON TRADOTTO DA RINA COPPOLA I soccorritori siriani volontari c…
Soha Bechara: la guerra civile in Libano fu un grande inganno
mcc43 SOHA BECHARA: RESISTENZA, la mia vita per il Libano da Capitolo 4: La guerra è follia “Dopo la primavera del 1975, i combattimenti tra Israele e l’OLP (Organizzazione per La liberazione della Palestina) si intrecciarono con la guerra…
Il veto americano, tra vittoria e sconfitta
La risoluzione presentata dall’Egitto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU contro la decisione americana di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele rappresenta una vittoria diplomatica e politica per il mondo arabo e un imbarazzo storico per gli USA, ormai isolati sul piano internazionale.
L’articolo Il veto americano, tra vittoria e sconfitta sembra essere il primo su Arabpress.
Talebani a Kabul
L’immagine è tratta da TolonewsLa guerra in Afghanistan continua ogni giorno con azioni sia dei talebani – ieri nell’Helmand 14 militari feriti da un’autobomba – sia dello Stato islamico – che a Natale ha colpito a Kabul un ufficio dell’intelligence af…
In memoria di Aleppo
Sul muro di un cimitero, una volta abbiamo scritto: “Siamo vivi e rimaniamo; restiamo per realizzare un sogno.”
L’Arabia Saudita e l’investimento fallimentare nella politica estera
La monarchia saudita continua i suoi investimenti fallimentari nella politica estera, perdendo il suo ruolo nella regione e collezionando insuccessi, nonostante la propaganda ufficiale la dipinga come vittoriosa
L’articolo L’Arabia Saudita e l’investimento fallimentare nella politica estera sembra essere il primo su Arabpress.
Egypte: des militants laïcs dénoncent la mosquée al-Azhar
Des militants laïcs égyptiens ont lancé lundi 25 décembre une contre-attaque indirecte contre la campagne visant l’athéisme. Ils ont dénoncé les autorités islamiques et notamment la grande mosquée d’al-Azhar qui, selon eux, participe au climat d’intolé…
Book Review – Humanitarian Rackets and their Moral Hazards: The Case of the Palestinian Refugee Camps in Lebanon (December 20, 2017)
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/20/12/2017/book-review-humanitarian-rackets-and-their-moral-hazards-case-palestinian-refugee-ca Humanitarian Rackets and their Moral Hazards: The Case of the Palestinian Refugee Camps in Lebanon by Rayyar Marron. Abingdon and New York: Routledge 2016. 188 pp., £110 hardcover 9781472457998, £36.99 paperback 9780815352570, £36.99 e-book 9781315587615 Rayyar Marron’s book provides a critique of how academic and activist accounts of Palestinian refugee camps end up reinforcing the humanitarian […]![]()
Turista o viaggiatore?
Ecco, nella foto a fianco, la mirabile sintesi del dibattito che si è tenuto ieri a Esc/Livre (Roma) dove abbiamo chiacchierato di Viaggio all’Eden con l’ottimo Giacomo Salerno, che faceva gli onori di casa, e il grande viaggiatore e amico G…
Egitto – Aggiornamento sulla detenzione di Mahienour
Fonte: Free Mahienour La famiglia di Mahienour è andata a farle visita dopo il suo trasferimento dal carcere di al-Qanater a quello di Damanhour. La sorella ci ha aggiornate sulla sua situazione che è allarmante. I familiari che fanno visita … Co…
Viaggio all’Eden a Roma nella tana di ESC
A Livre Esc AtelierVia dei Volsci 159Romaalle 18.30Presentazione di Viaggio all’Eden. Il mitico percorso dall’Europa a Kathmandu negli anni Settanta e quarant’anni dopoNe discute con l’autore Giuliano Battiston Di seguito la sua recensione per il manif…
Il graphic journalism e i fumettisti creano narrazioni alternative della realtà in Siria
I fumetti posso aiutare ad affrontare temi seri e difficili. Così che il fumettista diventa lui stesso parte della storia, come narratore e anche personaggio.
Take the names
Come i Caschi Bianchi siriani sono diventati vittime di una macchina di propaganda
La campagna mediatica sostenuta dalla Russia per collegare i soccorritori volontari con al-Qaeda espone le radici delle teorie della cospirazione: “È come una fabbrica” SCRITTO DA OLIVIA SOLON TRADOTTO DA RINA COPPOLA I soccorritori siriani…
Pregiudizio n. 13. “L’intervento occidentale in Siria ripeterebbe solo gli errori dell’Iraq e dell’Afghanistan”
Un’importante distinzione tra Iraq e Siria è che la questione delle armi nucleari in Iraq è stata una fabbricazione totale. Ora è ampiamente riconosciuto che l’Occidente ha mentito per giustificare una politica che ha voluto attuare a proprio vantaggio…
Dichiarazione della Dignità, oggi più che mai
Nel novembre del 2011, i Comitati di Coordinamento Locale (auto-governo della società civile) ha rilasciato un dichiarazione per la libertà e la dignità. Oggi, più che mai, teniamo presente queste parole, che guidano il nostro sostegno alla rivoluzione…
Egitto – Lettera di Mahienour dal carcere in solidarietà con chi lotta in Palestina
Il prossimo 30 dicembre si terranno in Egitto tre processi differenti in cui saranno giudicati la compagna Mahienour, Moatasim ed altrx 3 imputati, l’avvocato Muhammad Ramadan (tra l’altro avvocato difensore della stessa Mahienour) ad Aless…
Egitto – Lettera di Mahienour dal carcere in solidarietà con chi lotta in Palestina
Il prossimo 30 dicembre si terranno in Egitto tre processi differenti in cui saranno giudicati la compagna Mahienour, Moatasim ed altrx 3 imputati, l’avvocato Muhammad Ramadan (tra l’altro avvocato difensore della stessa Mahienour) ad Aless…
Grido strozzato
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Grido strozzato sembra essere il primo su Arabpress.
Nessun confronto tra Washington e Teheran
Le ultime parole del segretario della Difesa americano James Mattis circa un confronto diplomatico con Teheran fanno credere a un ritiro USA dallo scenario mondiale.
L’articolo Nessun confronto tra Washington e Teheran sembra essere il primo su Arabpress.
La musica di Nour Eddine Fatty per il ciclo #senzaconfini di UNINETTUNO
L’Università telematica internazionale Uninettuno presenta la prima nazionale di “Hijra – L’esilio del flautista” di Nour Eddine Fatty
L’articolo La musica di Nour Eddine Fatty per il ciclo #senzaconfini di UNINETTUNO sembra essere il primo su Arabpress.
Pregiudizio n. 12. “Intervenire in Siria significa mandare truppe sul terreno”
A causa di una narrativa mediatica sulla Siria polarizzata e spesso disinformata, è facile supporre che il coinvolgimento occidentale in Siria equivalga automaticamente all’intervento militare diretto – cioè truppe sul terreno. Tuttavia, i sostenitori …
Il regime siriano perderà il controllo sul suo sistema economico a favore della Russia e dell’Iran
Originally posted on Le Voci della Libertà:
Putin sulla guerra in Siria: “Non riesco ad immaginare un’esercitazione migliore. Possiamo continuare le nostre esercitazioni lì per un tempo molto lungo senza intaccare il nostro budget in modo significativo” http://euromaidanpress.com/2015/12/22/top-5-putin-quotes-from-an-annual-briefing/#arvlbdata Mosca pretende…![]()
Il regime siriano perderà il controllo sul suo sistema economico a favore della Russia e dell’Iran
Il Regime non può sopravvivere senza il sostegno dell’Iran e della Russia. E gli alleati di Assad stanno già chiedendo il conto per i servizi resi, pretendendo le ricchezza nel sottosuolo, diritti nelle operazioni offshore e il controllo di una parte i…
L’invasione dei rifugiati, i numeri di un mito d’oggi
In questa infografica abbiamo raccolto alcuni dati fondamentali che aiutano a smontare uno dei principali argomenti della retorica populista nel nostro paese (e non solo): è in corso un’invasione via mare.
Egitto: American University cancella divieto di portare velo
AUC rivede decisione di vietare il niqab, che copre volto
Pregiudizio n. 11. “Gli obiettivi principali di ISIS sono le minoranze religiose ed etniche”
La minaccia di ISIS dunque è diretto contro qualsiasi gruppo che resiste il suo potere e non è diretto solo contro le comunità delle minoranze. Neanche i musulmani sunniti, che costituiscono il 74% della popolazione siriana, sono protetti dall’ISIS, e …
Siriana e libanese: una riflessione sul conflitto di identità
“Essere metà libanese e metà siriana equivale ad essere un bambino di genitori separati che ti odiano entrambi perché ciascuna tua metà ricorda l’altra metà…”
Nabeel Rajab, noto difensore dei diritti umani detenuto in Bahrein, rischia altri 15 anni di carcere
Rajab si trova in prigione per le sue attività a difesa dei diritti umani e per aver espresso liberamente le sue opinioni.
Pregiudizio n. 10. “ISIS è un ‘gruppo di opposizione’”
ISIS ha sempre considerato come un nemico qualsiasi gruppo (compreso il regime di Assad) che non si sottomette al suo potere.[5] Tuttavia, il suo obiettivo primario non è correlato alla rivolta popolare siriana contro la dittatura di Assad e quindi non…
Indonesia: il golpe del ’65 e quel che sapevano a Washington
Un giovane Suharto al comando della repressione«Sulawesi sudorientale. Leader protestante indonesiano riferisce di notevoli violenze anti-PKI nella zona bughinese di Sulawesi. Musulmani a Bone sono entrati in un campo di detenzione e hanno ucciso 200 …
Il vecchio club imperialista
Donald Trump tratta il mondo come il leader di un club imperialista, interessato solo al profitto, senza pensare alle ripercussioni dei suoi atti.
L’articolo Il vecchio club imperialista sembra essere il primo su Arabpress.
Memorie dall’harem imperiale persiano
http://www.edizionilavoro.it/collane/l-altra-riva/memorie-dallharem-imperiale-persiano. Taj as-Soltaneh (1884-1936), figlia del sovrano Naser ad-Din Shah Qajar, racconta attraverso le pagine del suo diario trent’anni di storia di un paese, l’Iran, che, a cavallo tra Otto e Novecento, passa dall’ordine tradizionale alle prime importanti riforme di modernizzazione. Il salto culturale e politico che investe la società si riflette anche su di lei, … Continua la lettura di Memorie dall’harem imperiale persiano →
“L’insulto” di Ziad Doueiri è un film sul bisogno di restare umani
Questo post è un po’ OFF TOPIC perchè parla di un film (libanese) e non di un libro. Ma naturalmente i libri c’entrano comunque. Nell’ultimo periodo mi sono accorta di avere sempre più delle difficoltà a giudicare se un libro scritto …
4 iraniane di successo….
https://ilmanifesto.it/quattro-iraniane-di-successo/
The Muslim Metropolis
Network ReOrient/CMS
The Muslim Metropolis
The Muslim Metropolis
The Muslim Metropolis
Author: Piro Rexhepi & Ajkuna Tafa
Date: 2nd October 2017
Duration: 17 mins 54 secs
Descripti…
«Les réfugiés syriens pourraient reprendre le chemin de l’Europe»
Les pays limitrophes de la Syrie ne reçoivent que la moitié des financements attendus pour faire face aux 5,3 millions de réfugiés qu’ils accueillent. Amin Hawad, responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique au Haut Commissariat des Nations unies pour l…
Syrian Activist Mansour Omari Speaks About His Experience in Prison
In a recent interview with NPR, thirty-eight-year-old activist and journalist, Mansour Omari, discussed his experience as a captive in an underground dungeon run by the Syrian regime. In 2012, Omari was abducted by government forces and sent to “one of…
Top Iraqi Shiite cleric calls for scaling back militia influence, backing prime minister
Grand Ayatollah Ali Sistani urged armed groups that fought the Islamic State to hand over their weapons.
In Egypt, Both Sexual Harassment and Child Marriages Continue to Plague the Country
Women line up to vote in Egypt’s 2011 parliamentary elections. Photo posted by UN Women on December 2, 2011. Used under a Creative Commons license.
In 2015, Hala Yousef, the Minister of Population in Egypt, reported that out of all marriages in Egypt,…
Hundreds of thousands of displaced Ethiopians are caught between ethnic violence and shadowy politics
Turning sideward, a displaced Ethiopian woman lifts the hem of her dress to reveal scars running up her leg — shrapnel wounds from the grenade she says local police tossed at her and three other women.
“We’d always lived with the Oromo peacefully unti…
Città elettrica
Originally posted on ariannapoletti:
Dichiarare Gerusalemme capitale di Israele equivale a lanciare un fiammifero in una tanica di benzina. I palestinesi scendono in strada : si manifesta a Gerusalemme, nei Territori Occupati, a Gaza. Accorrono le telecamere dal mondo intero.…![]()
Colpirne uno per educarne cento
Non sono stati 400 i morti dell’ultimo pogrom scatenato in Myanmar contro la minoranza musulmana dei Rohingya. In un mese, dal 25 agosto al 24 settembre 2017, sono morte per cause violente nello Stato birmano del Rakhine, almeno 6.700 persone tra cui …
Un ‘Detenuto di tutte le epoche’: l’importante caso dell’attivista egiziano Alaa Abdelfattah
L’ attivista e blogger egiziano Alaa Abdelfattah. Fonte: screenshot da un video su Youtube.
Gli arresti sistematici e su ampia scala di dissidenti politici [en, come tutti i link a seguire] che stanno avvenendo in Egitto, hanno permesso al governo di …
I paesi del blocco e il vertice islamico: problemi con la Turchia o con Gerusalemme?
Il rispetto per il mondo islamico stesso e dei suoi luoghi di culto, di cui Gerusalemme rappresenta uno dei simboli più grandi, può andare oltre i conflitti e impedire a Israele e al pregiudizio americano di sfruttare questa spaccatura tra i paesi arabi e islamici?
L’articolo I paesi del blocco e il vertice islamico: problemi con la Turchia o con Gerusalemme? sembra essere il primo su Arabpress.
Un ‘Detenuto di tutte le epoche’: l’importante caso dell’attivista egiziano Alaa Abdelfattah
“Il suo processo è un tentativo di mettere a tacere le critiche a un sistema giudiziario che è diventato fonte di violazione dei diritti umani.”
Colpirne uno per educarne cento
Non sono stati 400 i morti dell’ultimo pogrom scatenato in Myanmar contro la minoranza musulmana dei Rohingya. In un mese, dal 25 agosto al 24 settembre 2017, sono morte per cause violente nello Stato birmano del Rakhine, almeno 6.700 persone tra cui …
The Runnymede Trust: Islamophobia is still a significant issue in the UK
20 years on from their ground-breaking report on the topic, the Runnymede Trust has published a new report stating Islamophobia is “still a challenge for us all”
The post The Runnymede Trust: Islamophobia is still a significant issue in the UK appear…
Twitter reacts to halal supermarket’s ordered closure
The Good Price mini-market in Colombes, located in Paris, is required to be a “general food store” according to its license and must meet the needs of all of its inhabitants, meaning it must sell pork and alcohol, but that defeats the purpose of its ha…
Egyptian Social Democratic Party member sentenced to 3 years on charges of terrorism, criticizing the statewas
A prominent member of the Egyptian Social Democratic Party was sentenced to three years in prison on Wednesday, according to lawyers, despite the judge announcing he would receive a one-year sentence during a court session on Tuesday.
Defendant Isla…
Chi ha incoraggiato Trump a dichiarare Gerusalemme come capitale di Israele?
Le dichiarazioni del presidente americano Trump sono frutto di una posizione strategica che aspettava solo di essere annunciata
L’articolo Chi ha incoraggiato Trump a dichiarare Gerusalemme come capitale di Israele? sembra essere il primo su Arabpress.
Pregiudizio n. 9. “Assad combatte il terrorismo”
Se da un lato il problema del terrorismo esiste all’interno della Siria, dall’altro Assad e i suoi alleati lo utilizzano chiaramente per portare avanti i propri obiettivi strategici (vale a dire rafforzare la propria posizione come alternativa valida) …
La guerra in Siria non è finita ma già si pensa alla ricostruzione
A Ginevra i negoziati di pace vanno a rilento, ma i profughi siriani hanno ricominciato a tornare nel loro paese. Dove tutto dev’essere ricostruito. Leggi
“La capitale della Palestina è Gerusalemme”: correva il tredicesimo secolo d.C.
“La Palestina è l’ultima delle province della Siria verso l’Egitto. La sua capitale è Gerusalemme“. Così scriveva nel tredicesimo secolo il biografo e geografo arabo Yaqut al-Hamawi nel suo “Mu’jam al-buldan“, cioè “dizionario dei paesi”, citato nel 18…
Rohingya a Como
Pregiudizio n. 8. “L’Occidente sta cercando un cambio di regime in Siria”
Mentre Assad ha intensificato la sua campagna di repressione nel 2011, uccidendo i manifestanti e imprigionando e torturando attivisti, gli Stati Uniti non avevano altra scelta se non allontanarsi da lui e intraprendere qualche azione. Le sanzioni sono…
Gerusalemme come città, Gerusalemme come questione
Il caso di Gerusalemme sottolinea l’ingiustizia che affligge i palestinesi, la politica irrazionale di Trump, così come l’espansionismo e l’arroganza di Israele. Tuttavia, la composizione culturale delle città nel panorama del Levante e dell’Oriente di cui Gerusalemme fa parte è un aspetto che rimane tuttora in ombra
L’articolo Gerusalemme come città, Gerusalemme come questione sembra essere il primo su Arabpress.
From Ancient Gates to Postmodern Drawbridges
I came back recently to Italy after an interesting and captivating book tour in some of the most prestigious US universities (UC Irvine, Harvard, Columbia, Georgetown). I presented (timing, unfortunately…) my book on Jerusalem, Jerusalem without …
Un dibattito sul caso Rohingya con Msf a Roma il 14 dicembre
* Per motivi di lavoro Amedeo Ricucci non potrà essere presenteModererà l’incontro Junko Terao, giornalista di Internazionale, media partner dell’evento
A proposito di Trump e Gerusalemme
Non puoi essere “pro-Palestinese” e contro i diritti dei siriani, o dei palestinesi della Siria. Semplicemente, in parole povere, non andrò mai ad una protesta per la Palestina in cui si alza le bandiere dell’Iran e dell’Hezbollah. Lascia che vi ricord…
La Tunisia nella Black List europea
La recente accusa europea rivolta alla Tunisia definendola un “paradiso fiscale” spingerà il Paese a rivedere la sua politica con il vicino?
L’articolo La Tunisia nella Black List europea sembra essere il primo su Arabpress.
Trump a Gerusalemme: una dichiarazione di guerra
Santiago Alba Rico Sull’incendiaria dichiarazione di Donald Trump, che riconosce Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, mi vengono in mente tre rapide riflessioni. La prima riguarda l’irrilevanza – e l’inutilità storica – degli appelli alla …
Senza vie legali, in Tunisia si diventa “harraga”
Giulia Bertoluzzi “Ho provato due volte a chiedere il visto per la Francia”, racconta Hafez, un percussionista di 27 anni sopravvissuto al naufragio dell’8 ottobre di quest’anno, quando una fregata della Marina militare tunisina ha urtato un pescherecc…
Sono stato torturato. Ero innocente.
mcc43 Convenzione contro la Tortura, Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, …
Riesumato lo psyop 2000: Abu Dis capitale dello stato di Palestina
mcc43 “Come capitale prendetevi ABU DIS invece di Gerusalemme”. Così avrebbe detto il principe Mohamed Bin Salman d’Arabia Saudita a Mahmoud Abbas, dandogli due mesi di tempo per decidere e lasciandolo, si suppone, impietrito. “…
Lettere da Washington a Giordania e Abbas: spostamento dell’ambasciata posticipato, gioco del martello Trump con Netanyahu e discorso su Gerusalemme Ovest
In un paese come la Giordania che dal punto di vista geopolitico è il più vicino alla questione di Gerusalemme, sorge una domanda tecnica: di quale Gerusalemme stanno parlando esattamente gli americani?
L’articolo Lettere da Washington a Giordania e Abbas: spostamento dell’ambasciata posticipato, gioco del martello Trump con Netanyahu e discorso su Gerusalemme Ovest sembra essere il primo su Arabpress.
Il progetto del Califfato da Kabul a Giacarta
Martedi a Napoli, su invito di Antonia Soriente, avrò il piacere di raccontare ai suoi studenti dell’Orientale, il nostro “A Oriente del Califfo”, un libro che tratta del progetto dello Stato islamico da Kabul a Dacca. Posto sotto la locandina invito …
…e allora entriamo nei dettagli di Gerusalemme
Mi sono quasi sempre astenuta dal pubblicare mappe di Gerusalemme. Troppo complicato, veramente troppo complicato spiegare quello che succede in una città che molti sognano, alcuni conoscono, altri ancora immaginano. Niente di mistico, di affascinante….
Non pubblicare senza permesso!
Trovo veramente sconcertante trovare i miei articoli pubblicati su alcuni siti senza che io sia stata contattata e abbia dato il mio permesso di pubblicazione, traduzione, eccetera. Contestiamo spesso a grandi imprese editoriali di non pagare, o non pa…
Buddismo ecologismo
Chetsang Rinpoche: ambientalista monaco e ambasciatore della Fao Chetsang Rinpoche è un monaco tibetano abbastanza singolare. Non è solo il rappresentante di una scuola e uno studioso molto apprezzato per la sua ricerca spirituale: è anche un …e…
Gerusalemme, città senza piazze
Questa è la seconda e ultima parte delle letture che ho tenuto nel mio tour negli Stati Uniti, Messe insieme, rielaborate, e soprattutto ritradotte. Tra una sezione e l’altra è passata un brandello di storia, e cioè la dichiarazione di Donald Tru…
Quando cambiano le regole del gioco
Donald Trump è stato molto chiaro, nella sua dichiarazione su Gerusalemme capitale di Israele. Per l’ennesima volta, durante la sua presidenza, ha messo da parte la comunità internazionale, le convenzioni firmate anche dagli Stati Uniti, le risoluzioni…
La guerra in Yemen dopo Saleh
Dopo l’uccisione dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh avvenuta il 4 dicembre a Sanaa, la città e l’intero paese attendono un destino ignoto.
L’articolo La guerra in Yemen dopo Saleh sembra essere il primo su Arabpress.
A Oriente del Califfo all’Orientale di Napoli
Non è tutta colpa di Trump
Non è tutta colpa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti poggia la sua decisione di trasferire l’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme su un preciso atto legislativo del Congresso americano, approvato nell’autunno del lontano 1995…
Un’ambasciata USA a Gerusalemme, e poi molto di più
mcc43 “Con la sua decisione, quindi, Donald Trump rompe il fronte ma, soprattutto, riconoscendo di fatto Gerusalemme come capitale indivisa dello Stato ebraico sdogana e approva la politica degli insediamenti che da decenni Israele conduce a spes…
L’assurdo Trump: volere pace in Palestina regalando Gerusalemme a Netanyahu
mcc43 Risoluzione ONU 181, 29 Novembre 1947 “Gli Stati indipendenti arabo ed ebraico e il regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme, esposti nella parte III di questo piano, entreranno in vigore in Palestina due mesi dopo che l&#…
Un ricordo di Giovanni Bensi
L’ISIS: DALLE RADICI AL CROLLOIn ricordo di Giovanni BensiLa Biblioteca Archivio del CSSEO, in collaborazione con il Centro studi sul Caspio e il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, organizza mercoledì 6 dicembre alle ore 12, 30, nell’Au…
Siria: alcune considerazioni su “Ginevra 8”
La nuova sessione di negoziati di Ginevra 8 sulla questione siriana sarà l’inizio della fine della rivoluzione nella sua chiave politica oppure segnerà il via a veri negoziati per uscire dalla crisi?
L’articolo Siria: alcune considerazioni su “Ginevra 8” sembra essere il primo su Arabpress.
Lettera aperta alla redazione della trasmissione di Rai 2 “Nemo”
Siamo un gruppo di persone che a vario titolo si occupano o si sono occupate della Tunisia. Alcun* tra noi ci vivono e lavorano da diversi anni. Alcuni hanno anche avuto diversi rapporti con giornalist* italiani in visita in Tunisia per effettua…
L’inferno in Marocco si chiama TEMARA
mcc43 Sebbene ratificata dal Marocco nel 1993, la Convenzione Onu Contro la Tortura è carta straccia nel regno di Muhamad VI. A testimoniarlo sono decine di rapporti Amnesty International, Human Right Watch e del Working Group on Arbitrary Detention de…
Le graphic novel parlano arabo: “Cette historie se passe” di Mazen Kerbaj
Oggi pubblico un interessantissimo articolo di Alì Raffaele Matar su Mazen Kerbaj, artista visivo e musicista libanese che di recente è stato a Roma a presentare i suoi lavori nell’ambito della mostra HOME BEIRUT, in esposizione al MAXXI. Kerbaj …
L’escalation nella guerra infinita (e silenziosa)
Un Falcon F-16. I bombardamentiin Afghanistan sono triplicatiLa guerra infinita sta vivendo una nuova escalation purtroppo solo sotto gli occhi degli afgani. E’ stato Trump a dare il via libera a quella che sembra ormai – oggi assai più di ieri – compl…
Making Lives: Refugee Self-Reliance and Humanitarian Action in Cities
Today I am launching Making Lives: Refugee Self-Reliance and Humanitarian Action in Cities, the final publication of a year-long research project into refugee self-reliance and humanitarian action in cities, which I carried out last year with the Humanitarian Affairs Team (Save the Children), the Bartlett Development Planning Unit (University College London), and Jindal School of International Affairs (O. P. Jindal Global University). […]![]()
L’Arabia Saudita: la guerra in Yemen e il dilemma delle alleanze
Nel gioco camaleontico delle alleanze, l’Arabia Saudita è chiamata a ritrovare sé stessa, dopo aver perso il controllo sullo Yemen e averlo consegnato agli storici nemici iraniani.
L’articolo L’Arabia Saudita: la guerra in Yemen e il dilemma delle alleanze sembra essere il primo su Arabpress.
Mentre il governo siriano celebra le sue vittorie militari, la paura attanaglia ancora i cittadini di Damasco
“Cercano negli archivi che hanno salvato sui loro computer. Se trovano il tuo nome, ti mandano in uno dei fronti aperti.”
La lotta al traffico di migranti è solo un diversivo
I governi europei hanno fatto del contrasto ai trafficanti di migranti una priorità. Ma i veri obiettivi sono altri: ostacolare la circolazione delle persone, criminalizzare le ong e confondere l’opinione pubblica. Leggi
L’Est e l’Ovest. I punti cardinali e la revisione della storia a Gerusalemme
La questione di Gerusalemme va ben oltre il Giro d’Italia, ma il Giro d’Italia offre una occasione insperata per parlarne. E dunque parliamone. Devo chiarire, prima di proseguire, qual è la mia posizione. Come giornalista e come storica, la mia descriz…
L’esercito ed il futuro politico dell’Egitto
Le prospettive del paese dipendono dalle scelte che prenderà l’esercito.
L’articolo L’esercito ed il futuro politico dell’Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
Il Giro d’Italia e la gaffe di Gerusalemme
E così, è scoppiato il caso politico-diplomatico del Giro d’Italia. Tenuto volutamente basso sino ad ora, il caso della più importante gara ciclistica italiana che nel 2018 partirà da Gerusalemme è arrivato infine sulle prime pagine dei giornali…
invisiblearabs 2017-11-30 14:37:46
Ecco i 3 video contro Isis e immigrati islamici condivisi da Trump
Il presidente americano, Donald Trump, ha rilanciato su Twitter tre video anti-musulmani postati da Jayda Fransen, esponente dell’estrema destra britannica, suscitando rabbia e polemiche. In un filmato si vede un gruppo di uomini con barba lunga e band…
L’azzardo di Erdoğan: riabilitare Asad e fidarsi di Putin per salvare la Turchia
Il vertice Turchia-Russia-Iran di Soči è stato in realtà un incontro a quattro. Al Sanatorium Rus c’era anche il fantasma di Bashar al-Asad. Due giorni prima, sempre a Soči, il presidente siriano aveva incontrato il leader russo Vladimir Putin a due an…
Dissenso e repressione in Bahrein
Manama sempre meno propensa al dialogo con le opposizioni Al-Manama (Russia Today in arabo). Shaykh Ali Salman, il leader dell’associazione al-Wifaq, il principale partito di opposizione sciita messo al bando in Bahrein, si è rifiutato di comparire in …
Pakistan, la vittoria degli islamisti
Il corpo senza vita di un poliziotto, probabilmente sequestrato dagli islamisti radicali durante l’assedio di Faizabad, è stato ritrovato con segni di tortura. E’ solo l’ultimo degli episodi di un blocco stradale durato oltre venti giorni che si è conc…
La parola rohingya
Il papa e la Nobel in una foto tratta dal sitodellaa Radio Vaticana. Il Consiglio cittadinodella città di Oxford ha appena ritirato a Suu Kyi un riconoscimentoRohingya. Alla fine la parola proibita Francesco Bergoglio non la pronuncia. O perlomeno non …
Violenza sulle donne: gli arabi non cambiano?
L’hashtag #MeToo contro la violenza sulle donne, condiviso da milioni di donne e uomini, ha portato alla luce una questione che coinvolge istituzioni politiche, magistratura e arte interrogandosi in maniera creativa ed efficace sui problemi profondi della società
L’articolo Violenza sulle donne: gli arabi non cambiano? sembra essere il primo su Arabpress.
Vite mediterranee: racconti dal Mare Nostrum
Vite Mediterranee è una raccolta di racconti che ha coinvolto autori italiani, francesi e arabi. I protagonisti sono giovani tra i 18 e i 30 anni, che abbiano, o abbiano avuto, una qualche relazione con il Mar Mediterraneo.
L’articolo Vite mediterranee: racconti dal Mare Nostrum sembra essere il primo su Arabpress.
La parola rohingya
Il papa e la Nobel in una foto tratta dal sitodellaa Radio Vaticana. Il Consiglio cittadinodella città di Oxford ha appena ritirato a Suu Kyi un riconoscimentoRohingya. Alla fine la parola proibita Francesco Bergoglio non la pronuncia. O perl…
Pakistan, la vittoria degli islamisti
Il corpo senza vita di un poliziotto, probabilmente sequestrato dagli islamisti radicali durante l’assedio di Faizabad, è stato ritrovato con segni di tortura. E’ solo l’ultimo degli episodi di un blocco stradale durato oltre venti giorni che si è concluso con l’arresa dello Stato, dell’esercito e di tutte le istituzioni (con l’esclusione della magistratura) del Pakistan. Un fatto senza precedenti e di estrema gravità, quanto il fatto che la sua eco sia stata (non parliamone in Italia) del tutto secondaria. Gli islamisti, qualche centinaio, chiedevano la testa di un ministro è molte altre richieste e hanno ottenuto tutto anche se si trattava di tre minuscole organizzazioni radicali e violente. Quando, dopo uno stallo di tre settimane, la polizia è intervenuta, alcune migliaia di dimostranti sono scesi in strada in appoggio al blocco stradale e hanno iniziato una fitta sassaiola. Anziché rispondere, la polizia è arretrata. Alla fine, dal governo all’esercito, tutti hanno ceduto alle richieste di un gruppetto di radicali. Una delle pagine più buie della storia del Paese.
Emigrazione, traffico di esseri umani e schiavitù nel mondo arabo
Il nuovo mercato degli “schiavi” associato agli immigrati clandestini in Libia dimostra che la cultura della schiavitù e delle sue pratiche è sempre diffusa e ancorata al passato.
L’articolo Emigrazione, traffico di esseri umani e schiavitù nel mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
Giulio Regeni, 250 accademici firmano una lettera di supporto alla sua tutor: “L’articolo di Repubblica è fuorviante”
“Giulio voleva fare ricerca sui sindacati indipendenti da anni, cioè da prima del colpo di Stato del 2013, e questo argomento non era assolutamente pericoloso”. Gilbert Achcar è professore alla Soas, la School of Oriental and African Studies, di Londra e ha conosciuto Giulio Regeni diversi anni fa, quando il giovane italiano si recò nel […]
L’articolo Giulio Regeni, 250 accademici firmano una lettera di supporto alla sua tutor: “L’articolo di Repubblica è fuorviante” proviene da Il Fatto Quotidiano.
W.A.R. sbarca ad Algeri
 C’è la storia di un giovane egiziano che scopre “El Houma, caposaldo della controcultura algerina”, reportage su uno spazio di condivisione e produzione collaborativa dei rapper di Algeri. E decide di partire, con un clic, verso Roma, Tunisi, Beirut, Casablanca… per ammirare i lavori degli street artist, assistere a una performance o visitare uno di questi spazi creativi dove gli artisti connotano di un nuovo segno la cultura urbana.
C’è la storia di un giovane egiziano che scopre “El Houma, caposaldo della controcultura algerina”, reportage su uno spazio di condivisione e produzione collaborativa dei rapper di Algeri. E decide di partire, con un clic, verso Roma, Tunisi, Beirut, Casablanca… per ammirare i lavori degli street artist, assistere a una performance o visitare uno di questi spazi creativi dove gli artisti connotano di un nuovo segno la cultura urbana.
Egitto – Lettera di Mahienour dal carcere di al-Qanater
Fonte: الحرية لماهينور – Free Mahienour Vi scrivo dalla mia nuova cella, la numero 12 dal carcere di Al-Qanater. So quanto può essere faticoso per la mia famiglia, i miei amici e amiche e tutte le persone che amo che questo … Continue reading →
Accordo sui rohingya
 |
| La firma del protocollo in una foto del DailyStar di Dacca |
Bangladesh e Myanmar firmano un protocollo per il rientro della minoranza. Ma senza una data. Il controesodo dovrebbe iniziare entro la fine di gennaio
C’è un accordo tra Bangladesh e Myanmar per il rientro dei rohingya scacciati dal Paese delle mille pagode e dell’infinita compassione. C’è un accordo che per ora è un pezzo di carta e che non ha nemmeno una data certa entro la quale dovrebbe ricomporsi l’esodo più massiccio della Storia recente da un Paese non in conflitto.
 |
| Il confine col Bangladesh sul fiume Naf e gli incendi rilevati dal satellite nel Rakhine |
L’accordo è stato firmato ieri mattina nell’ufficio della Nobel Aung San Suu Kyi, sotto pressione da mesi: da quando a fine agosto è iniziato l’esodo forzato che ha catapultato in Bangladesh oltre 600mila rohingya, la minoranza musulmana senza diritti che in Myanmar non ha nemmeno quello di chiamarsi così. I “senza nome”, ammassati in campi che sono in condizioni spaventose – come finalmente si comincia a documentare con una certa costanza – dovrebbero cominciare a rientrare -prevede il protocollo siglato dalla Nobel e dal ministro degli Esteri di Dacca Mahmood Ali – entro due mesi. Per il Bangladesh è una vittoria e ieri la premier Sheikh Hasina ha rinnovato il suo invito a Naypyidaw a far si che i rohingya tornino a casa. Ai 625 mila arrivati da agosto ne vanno infatti aggiunti forse un altro mezzo milione che, nei decenni, hanno scelto la via che passa dal fiume Naf e che porta in Bangladesh.
La decisione del governo birmano, di cui Suu Kyi è il personaggio di spicco, si deve alle pur blande pressioni della comunità internazionale. E quando anche gli Stati Uniti – per bocca del segretario di Stato Rex Tillerson – hanno minacciato sanzioni e utilizzato la parola “pulizia etnica” qualcosa, per altro già nell’aria, dev’essersi mosso (l’ambasciata Usa nel Paese ha anche cancellato i voli ufficiali
nello Stato del Rakhine)
 |
| Tillerson ha preso posizione: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? |
La Nobel aveva annunciato diverso tempo fa la costituzione di una sorta di agenzia ad hoc ed era sempre stata lei a chiamare Kofi Annan mesi prima chiedendogli un rapporto sulla situazione nel Rakhine, l’area dove vivono i rohingya, anche se gli aveva esplicitamente chiesto di non riferirsi a “loro” con quel nome. Ma in tutto ciò l’esodo non ha fatto che ingigantirsi e governo e militari hanno sposato la tesi del terrorismo islamico, accusando l’Arsa – l’organizzazione autonomista islamica responsabile degli attacchi di agosto contro posti di polizia – di essere un gruppo jihadista che vorrebbe fare del Rakhine uno Stato islamico. Poi però le pressioni internazionali, ma soprattutto le reiterate denunce di gruppi della società civile, hanno fatto emergere in tutta la loro violenza la responsabilità sia dei militari sia del governo. Ad appoggiare incondizionatamente Naypyidaw ci sono comunque i potenti vicini – India e Cina – e l’amico lontano, la Russia, che ieri ha criticato le parole di Tillerson. Anche Thailandia e Giappone han lasciato correre mentre Malaysia e Indonesia si sono spesi in diversi modi: la Malaysia ospita 150mila rohingya (anche se non possono aspirare a cariche pubbliche e i loro bambini non hanno accesso che a “scuole speciali”) e ospita una delle sedi di corrispondenza di Rohingya Vision, una tv con sede in Arabia Saudita. La Cina in particolare, assetata di energia e che vuole il Myanmar nella sua nuova Via della seta, è l’amico più fedele: soprattutto dei militari. Propri in questi giorni, è a Pechino in visita ufficiale il generale Min Aung Hlaing, l’uomo forte che controlla da vicino l’operato della Nobel e che invece, da un mese a questa parte, si è visto interdire i suoi viaggi in Europa.
Se l’accordo bangla-birmano funzionerà si saprà dunque a gennaio. Ma la domanda è anche un’altra. Ammesso e non concesso che un rohingya voglia tornare nel suo villaggio magari dato alle fiamme, che situazione troverà ad accoglierlo? Proprio due giorni fa, Amnesty International ha spiegato, dopo un’inchiesta durata due anni, che i rohingya in Myanmar vivono intrappolati «in un sistema vizioso di discriminazione istituzionalizzata sponsorizzata dallo Stato che equivale all’apartheid». I contadini rohingya rischiano dunque di tornare in uno Stato che non solo non li vuole e li considera “immigrati bangladesi”, ma che non gli riconosce cittadinanza, documenti né quindi titoli di proprietà su una terra magari lavorata nella consuetudine di secoli. Forse nel Myanmar c’è chi spera che questo basti a tenerli lontani.
Il romanzo e la rivelazione del pensiero terrorista
Forse il romanzo può avere un ruolo nel denudare il pensiero terrorista, svelando l’ipocrisia della società che contribuisce a coprire i veri crimini commessi da diversi suoi figli
L’articolo Il romanzo e la rivelazione del pensiero terrorista sembra essere il primo su Arabpress.
Il viaggio difficile di Francesco Bergoglio
Non è un viaggio facile per papa Francesco Bergoglio quello che inizia lunedi in Myanmar per proseguire poi in Bangladesh. Il papa, che incontrerà il presidente birmano Htin Kyaw e la sua premier “de facto” Aung San Suu Kyi, prevede anche un incontro…
Viaggio all’Eden al Premio Volponi di Fermo
Peppino Buondonno e Angelo Ferracuti,coordinatori del Premio in una foto del Corriere AdriaticoAlle ore 18 alla Sala Castellani di Porto San Giorgiocon Peppino BuondonnoViaggio all’EdenIl programma del Festival qui
Da Riad a Sochi: la geografia schiaccia la politica?
Per Russia, Siria e Iran, la geografia costituisce uno degli elementi più importanti da considerare per l’enorme influenza che questa esercita sui rapporti tra le parti in conflitto.
L’articolo Da Riad a Sochi: la geografia schiaccia la politica? sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto, nel mirino finiscono i sufi. Dietro l’attentato il fallimento della politica di Al-Sisi nel Sinai
L’attentato contro la moschea di Bir al-Adb, oltre ad essere il più grave degli ultimi anni contro la popolazione civile in Egitto, segna un nuovo colpo contro la politica securitaria del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Nonostante ad ora non ci sia alcuna rivendicazione, gli analisti puntano il dito sullo Stato Islamico, il cui nucleo più […]
L’articolo Egitto, nel mirino finiscono i sufi. Dietro l’attentato il fallimento della politica di Al-Sisi nel Sinai proviene da Il Fatto Quotidiano.
Egitto – Libertà per Mahienour e Moatassem! Libertà per tutti e tutte!
Il 18 novembre scorso un giudice di Alessandria ha ordinato la custodia cautelare della compagna Mahienour el-Masry e di un altro imputato, Moatassem Medhat, accusati di aver partecipato a una protesta pacifica del giugno 2017. I due avvocat* per i … Continue reading →
Besieged Syrians eating trash, fainting from hunger: UN survey
Language
Undefined
At least four people have died from starvation, including child in Douma who took his own life because of hunger, report says
Refugees in Libya Are Being Sold at Slave Auctions
After Italy signed a memorandum with the UN and U.S.-backed government of Libya, known as the Government of National Accord (GNA), in Tripoli to reduce sea migration in February 2017, migrant crossings to Italy from the North African coastline decreased by 87 percent. This seemingly positive result, however, has obscured the fact that refugees intercepted by […]
Israel’s Complicity in Myanmar’s Crimes Against Rohingya Muslims
Israel is directly assisting the violent persecution of Myanmar’s Rohingya Muslim population, by providing arms and training to the country’s military. The latest military crackdown against the Rohingya – a stateless minority population that remains officially unrecognized by the government of Myanmar – was launched in 2016. Since then, violence against the group has only […]
Arbitrary Charges and Arrests Continue in Egypt, Even Towards Pop Singers
This past week, a number of high-profile charges and arrests took place against long-time human rights activists, as well as a widely admired pop singer in Egypt. In a stunning and puzzling move, beloved Egyptian pop singer Sherine Abdel Wahab was charged, with “insulting the Egyptian state,” and is set to stand trial at the court […]
Bangladesh and Myanmar sign deal to start repatriating Rohingya refugees
Bangladesh and Myanmar will start repatriating refugees in two months, Dhaka said Thursday, as global pressure mounts over a crisis that has forced more than 600,000 Rohingya to flee across the border.
The United Nations says 620,000 Rohingya have arrived in Bangladesh since August to form the world’s largest refugee camp after a military crackdown in Myanmar that Washington has said clearly constitutes “ethnic cleansing.”
Related: Bangladesh says China will help resolve the Rohingya crisis
The statement from Secretary of State Rex Tillerson is the strongest US condemnation yet of the crackdown, accusing Myanmar’s security forces of perpetrating “horrendous atrocities” against the group.
Following talks between Myanmar’s civilian leader Aung San Suu Kyi and Bangladeshi Foreign Minister A.H. Mahmood Ali, held after weeks of tussling over the terms of repatriation, the two sides inked a deal in Myanmar’s capital, Naypyidaw, on Thursday.

A Rohingya refugee man holding children walks towards the shore as they arrive on a makeshift boat after crossing the Bangladesh-Myanmar border, at Shah Porir Dwip near Cox’s Bazar, Bangladesh, Nov. 9, 2017.
Credit:
Navesh Chitrakar/Reuters
In a brief statement, Bangladesh said it had agreed to start returning the refugees to mainly Buddhist Myanmar in two months.
It said that a working group would be set up within three weeks to agree to the arrangements for the repatriation.
“This is a primary step. [They] will take back [Rohingya]. Now we have to start working,” Ali told reporters in Naypyidaw.
Related: In Myanmar, fake news spread on Facebook stokes ethnic violence
Impoverished and overcrowded, Bangladesh won international praise for allowing the refugees into the country, but has imposed restrictions on their movements and said it does not want them to stay.
Suu Kyi’s office called Thursday’s agreement a “win-win situation for both countries,” saying the issue should be “resolved amicably through bilateral negotiations.”
However, it remains unclear how many Rohingya will be allowed back and how long the process will take.
Life in Bangladesh
Shelley Thakral, a UN World Food Program spokesperson is based in the port town of Cox’s Bazar, Bangladesh, where a mega-camp of hundreds of thousands of Rohingya refugees has sprung up.
“Five weeks ago, six weeks ago, this was a forest, a forest that’s now become peoples’ homes, sheet by sheet of corrugated iron, of bamboo walls,” Thakral says. “Families live side by side, some families are five, but some families are up to eight and more.”
Tourists once flocked to Cox’s Bazar to relax on what some consider the world’s longest beach. But an hour’s drive from the coast, the refugees squeeze together in densely packed settlements. More desperate Rohingya, sometimes dozens, sometimes hundreds, arrive every day.
“Families make this treacherous journey by foot from Myanmar, escaping the persecution there,” Thakral says. “Some tell us that they’ve walked for six days, they’ve walked for 10 days with just the possessions that they have.”
Aid groups say it’s a struggle just to provide basic essentials in the mega-camp. One in four children there suffer from malnutrition, according to the WFP. It offers as many families as possible shelter and hot meals.
“We’re trying to make sure whatever trauma that they’ve encountered that they have something to settle into that’s dignified, that that makes them feel welcome and makes them feel that they are being looked after,” Thakral says.
Return to Myanmar
Rights groups have raised concerns about the process, including where the refugees will be resettled after hundreds of their villages were razed, and how their safety will be ensured in a country where anti-Muslim sentiment is surging.
“The most important thing that would have to be addressed is that those returning would have to have some ability to move within [Myanmar’s] Rakhine State and they would need to have their basic needs met,” said Carolyn Miles, president and CEO of Save the Children, one of several aid organizations working with Rohingya refugees in Bangladesh
But Miles says she’s skeptical the agreement will address those challenges.
“I don’t know that this agreement is actually gviing them either the rights of movement or that the conditions are going to be much better than what they fled,” Miles said. “I think it’s unlikely you’ll have a lot of people — given what they went through when they were in Myanmar — choosing … to return.”
‘Won’t go back’

Credit:
Adnan Abidi/Reuters
The stateless Rohingya have been the target of communal violence and vicious anti-Muslim sentiment in mainly Buddhist Myanmar for years.
They have also been systematically oppressed by the government, which stripped them of their citizenship and severely restricted their movement, as well as their access to basic services.
Tensions erupted into bouts of bloodshed in 2012 that pushed more than 100,000 Rohingya into grim displacement camps.
Related: Myanmar’s critics call Rohingya-only enclaves ’21st-century concentration camps’
Despite the squalid conditions in the overcrowded camps in Bangladesh, many of the refugees say they are reluctant to return to Myanmar unless they are granted full citizenship.
“With full rights like any other Myanmar nationals,” said Abdur Rahim, 52, who was a teacher at a government-run school in Buthidaung in Rakhine state before fleeing across the border.

Credit:
Mohammad Ponir Hossain/Reuters
“We won’t return to any refugee camps in Rakhine,” he told AFP in Bangladesh.
The signing of the deal came ahead of a highly-anticipated visit to both nations from Pope Francis, who has been outspoken about his sympathy for the plight of the Rohingya.
The latest unrest occurred after Rohingya rebels attacked police posts on Aug. 25.
The army backlash rained violence across northern Rakhine, with refugees recounting nightmarish scenes of soldiers and Buddhist mobs slaughtering villagers and burning down entire communities.
The military denies all allegations but has restricted access to the conflict zone.
Suu Kyi’s government has blocked visas for a UN-fact finding mission tasked with probing accusations of military abuse.
Agence France-Presse contributed to this report.
IsDB and AfDB partner to boost agriculture and fight drought in Africa

By WAM
JEDDAH, Nov 23 2017 (WAM)
A joint initiative of the Islamic Development Bank (IsDB) and African Development Bank (AfDB) will boost agriculture value chains and enhance drought resilience in Nigeria, Somalia and Uganda.
The initiative is part of a broad coalition to boost collaboration between the two institutions in agriculture, water and sanitation. The combined active portfolio of both institutions in these sectors in Nigeria, Somalia and Uganda is worth US$1 billion, with several projects in the pipelines to expand their support.
“It is good to see this strong partnership between the African Development Bank and the Islamic Development Bank further evolving, in terms of depth, breath, resource commitments, leverage and speed of delivery”
Khaled Sherif, AfDB Vice-President for Regional Development, Integration and Business Delivery
Stronger ties between AfDB and IsDB will help ramp up agricultural production along important crop and livestock value chains while preventing and mitigating climate change induced droughts will help achieve the objectives of “Say No To Famine/Alliance to End Famine in Africa.”
“It is good to see this strong partnership between the African Development Bank and the Islamic Development Bank further evolving, in terms of depth, breath, resource commitments, leverage and speed of delivery” said AfDB Vice-President for Regional Development, Integration and Business Delivery, Khaled Sherif.
Sherif said the presidents of the two institutions had signed a Memorandum of Understanding that clearly outlines the way forward to strengthen the partnership.
IsDB Vice President, Mansur Muhtar, stated: “Indeed, there is much to gain from the collaboration between our organizations. It is here that we can utilize our respective competitive advantages best and maximize the utilization of available resources.”
“This can be achieved in particular by avoiding duplication and concentrating the stipulated initiatives in support of our member countries in the identified sectors and areas that promise to be most impactful for local populations. We will also expand this partnership throughout the operationalization of upcoming initiatives by bringing in additional partners, especially the private sector,” he added.
[Image credit: Islamic Development Bank (IsDB) Twitter: @isdb_group]
WAM/Tariq alfaham
The post IsDB and AfDB partner to boost agriculture and fight drought in Africa appeared first on Inter Press Service.
Qualche breve osservazione sul dramma di Essaouira in Marocco
Il 19 novembre a Essaouira 15 donne sono state uccise in una calca durante una distribuzione di generi di aiuto alimentari
L’articolo Qualche breve osservazione sul dramma di Essaouira in Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
“Donne palestinesi in guerra: da madri della nazione a shahidat” di Maria Antonietta Crapsi
Dal blog Con altre parole d Beatrice Tauro
L’articolo “Donne palestinesi in guerra: da madri della nazione a shahidat” di Maria Antonietta Crapsi sembra essere il primo su Arabpress.
Accordo sui rohingya
La firma del protocollo in una foto del DailyStar di DaccaBangladesh e Myanmar firmano un protocollo per il rientro della minoranza. Ma senza una data. Il controesodo dovrebbe iniziare entro la fine di gennaioC’è un accordo tra Bangladesh e Myanmar per…
La poetica dell’Etna tra suoni e immagini di Yuval Avital
 Fiumi di lava, nuvole di vapore, centinaia di voci, volti, antiche declamazioni dialettali e foreste umane – tutto questo e molto di più in un immenso quadro allegorico che attraversa un territorio unico nel suo genere. Si chiama…
Fiumi di lava, nuvole di vapore, centinaia di voci, volti, antiche declamazioni dialettali e foreste umane – tutto questo e molto di più in un immenso quadro allegorico che attraversa un territorio unico nel suo genere. Si chiama…
Viaggio all’Eden e Califfo a Mendrisio sabato 25 novembre
America spleen
Apartheid, un nuovo termine per i rohingya
Si chiama “In gabbia senza un tetto” l’ultimo rapporto di Amnesty International sui Rohingya, la minoranza musulmana cacciata dal Myanmar nell’esodo forzato più recente della Storia da un Paese non in conflitto. E aggiunge una nuova parola a un vocabolario dove si è letto di stupri, eccidi, violenze, incendi, disastri umanitari, genocidio e pulizia etnica: apartheid. Questa volta Amnesty, che lavorava al caso da due anni, documenta infatti la condizione interna dei rohingya in Myanmar, dove fino a qualche mese fa viveva poco più di un milione di questa minoranza ora ridotta drasticamente a meno della metà (oltre centomila vivono in campi profughi nel Paese mentre 600mila sono stati espulsi). Chi vive in Myanmar era ed è intrappolato «in un sistema vizioso di discriminazione istituzionalizzata sponsorizzata dallo Stato che equivale all’apartheid». Il rapporto (in italiano sul sitowww.amnesty.it) disegna il contesto della recente ondata di violenze, quando le forze di sicurezza hanno incendiato interi villaggi e hanno costretto centinaia di migliaia di rohingya a fuggire verso il Bangladesh. Molti, non si sa quanti, sono stati uccisi o sono morti cercando di attraversare la frontiera.
Fa un salto in avanti la condanna che per ora ha visto soprattutto la società civile impegnata in un’operazione di denuncia (Amnesty, Human Rights Watch, il Tribunale permanente dei popoli e diverse Ong come Msf ad esempio) con le Nazioni Unite (molte le prese di posizione e le denunce) ma, per il momento, non si sono viste forti pressioni internazionali anche se, nel suo recente viaggio in Myanmar, l’Alto commissario Federica Mogherini non è stata tenera con Aung San Suu Kyi. Nondimeno per ora, l’Unione europea si è limitata a confermare il divieto alla vendita di armi e ha riattivato il meccanismo (soppresso quando i militari hanno ceduto il potere) che vieta agli alti gradi dell’esercito birmano di venire nel Vecchio Continente. Poco o nulla ha invece fatto il Consiglio di sicurezza, come se la questione riguardasse semplicemente i rapporti tra Myanmar e Bangladesh.
 |
| La foto è tratta dal sito di Amnesty Italia |
Il rapporto di Amnesty dice chiaramente che il Myanmar ha confinato i rohingya in un’esistenza ghettizzata dove è difficilissimo avere accesso a istruzione e cure mediche in un quadro di esodo forzato dalle proprie case. Questa situazione – secondo Ai – corrisponde da ogni punto di vista alla definizione giuridica di apartheid, «un crimine contro l’umanità». «Questo sistema appare destinato a rendere la vita dei rohingya umiliante e priva di speranza – dice in una nota Anna Neistat, direttrice di Amnesty per le ricerche – e la brutale campagna di pulizia etnica portata avanti dalle forze di sicurezza del Myanmar negli ultimi tre mesi è l’ennesima, estrema dimostrazione di questo atteggiamento agghiacciante. Le cause di fondo della crisi in corso devono essere affrontate per rendere possibile il ritorno dei rohingya a una situazione in cui i loro diritti e la loro dignità siano rispettati». Difficile, anche perché, dice il rapporto, i rohingya vivono esclusi da qualsiasi contatto col mondo esterno.
Sebbene i rohingya subiscano da decenni una sistematica discriminazione promossa dal governo, la ricerca rivela come la repressione sia aumentata drammaticamente dal 2012, quando la violenza tra la comunità musulmana e quella buddista ha sconvolto lo stato di Rakhine. Queste limitazioni sono contenute in una serie di leggi nazionali, “ordinanze locali” e politiche attuate da funzionari statali che mostrano un’evidente attitudine razzista. Un regolamento in vigore nello stato di Rakhine dice chiaramente che gli “stranieri” e le “razze bengalesi” (un’espressione dispregiativa usata per indicare i rohingya) hanno bisogno di un permesso speciale per spostarsi da un luogo a un altro.
Durante la violenza del 2012, decine di migliaia di rohingya vennero espulsi dalle zone urbane dello stato di Rakhine, in particolare dalla capitale Sittwe. Attualmente 4000 di loro restano – dice ancora Ai – in città, in una sorta di ghetto isolato, circondato dal filo spinato e sorvegliato da posti di blocco, e rischiano costantemente di essere arrestati o aggrediti dalle comunità che li circondano.
“Fuori da Gaza”, fuori da tutto, fuori da qui
C’è che di libri ambientati a Gaza e che parlano di Gaza in italiano ne sono usciti pochissimi. Forse due, negli ultimi cinque anni, ma vado a memoria e potrei sbagliarmi. C’è che il secondo, dei due, è un libro rabbiosissimo e tenero che è stato eletto Guardian Book of The Year nel 2012. L’autrice […]![]()
The roof is gone: esplosioni ed evasioni letterarie
 |
| Roberta Mazzanti* |
Pubblico qui il contributo di Roberta Mazzanti, una cara e vecchia amica, al Convegno “Abitare, corpi, spazi, scritture” che si è tenuto a Roma a metà Novembre organizzato dalla Società italiana delle letterate. In cui si parla anche di Viaggio all’Eden
 |
| Grace Slick |
 Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10
Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10Immagini dalla mostra italiana Mogador in corso ad Essaouira
“Mogador: mostra italiana ad Essaouira (Marocco) di Veronica Gaido e Vito Tongiani
L’articolo Immagini dalla mostra italiana Mogador in corso ad Essaouira sembra essere il primo su Arabpress.
Chi sta distruggendo la cultura in Libia
Sulla scena libica ci sono tanti personaggi venuti fuori dal nulla. Sono diventati eroi nella Libia postbellica, arrivando a occupare cariche pubbliche. E qualcuno di loro ha deciso di mettere la parola fine alla libertà di espressione. Leggi
La marcia dei migranti contro il sistema di accoglienza in Veneto
Si protesta da giorni nell’ex base militare di Conetta: i richiedenti asilo denunciano le terribili condizioni di vita in uno dei centri più grandi della regione. Leggi
L’assenza di Bashar al-Assad dallo scenario libanese
L’incapacità del leader siriano Assad di influenzare le ultime vicende politiche in Libano indicano la perdita di influenza del regime anche all’interno della Siria nonché l’approssimarsi della sua fine.
L’articolo L’assenza di Bashar al-Assad dallo scenario libanese sembra essere il primo su Arabpress.
Se l’islamista sequestra la capitale
 |
| Lo svincolo della discordia: unisce Islamabad a Pindi |
Lo svincolo di Faizabad è la porta principale tra le due città pachistane di Islamabad, la capitale
amministrativa del Pakistan col suo milione di abitanti, e Rawalpindi, uno snodo commerciale importante del Punjab con oltre tre milioni di residenti. Bloccarlo con un sit-in, come ormai avviene da tre settimane, vuol dire creare un caos che divide le due città gemelle su un’importante arteria che collega la capitale all’aeroporto. A sequestrare lo svincolo è un manipolo di qualche centinaio di radicali che chiedono la testa del ministro Zahid Hamid, considerato dagli zeloti di alcune formazioni islamiste alla stregua di un apostata. Il caso, innescato dalla protesta degli islamisti, è un emendamento apportato alla legge che regola le candidature in vista delle prossime elezioni generali che si terranno in Pakistan l’anno prossimo.
L’emendamento, che riguarda l’atteggiamento del candidato verso il messaggio del Profeta Maometto, ha sostituito con la locuzione “I belief” (credo) la precedente “I solemnly swear” (giuro solennemente). La nuova viene considerata assai meno forte e rispettosa dell’originaria e una porta aperta a credenti troppo tiepidi. Nel formulario per candidarsi, secondo gli ulema radicali, chi si dichiara musulmano (se non lo è viene aggiunto in una lista apposita) lo deve fare in una forma solenne e non con una semplice professione di fede. Cavilli da dottori della legge e, secondo alcuni, un modo per preparare la campagna elettorale. Ma sufficienti a scatenare una bufera.
 |
| Zeloti: un momento del raduno che va avanti da un mese pubblicato da Pakistan Today A destra sotto un’immagine del posto |
La legge è stata rapidamente emendata dall’emendamento ed è tornata alla formula originaria, un cedimento che laici e progressisti non hanno visto di buon occhio. Ma gli ulema non mollano e continuano a chiedere che il ministro si dimetta altrimenti il blocco continuerà. Quel che è peggio è che, in un Paese dove le manifestazioni politiche o di rivendicazione sindacale vengono messe sotto schiaffo dalla polizia per molto meno, nessuno ha osato sgomberare manifestanti noti per le loro dichiarazioni al vetriolo. All’Alta corte di Islamabad però non l’hanno digerita e hanno chiamato il ministro dell’Interno a rendere conto dello stallo. Così, il ministro Ahsan Iqbal, d’accordo con i magistrati, ha reso nota l’ultima data utile per lo sgombero: giovedi 23 novembre, ma senza che si capisca cosa accadrà se gli islamisti delle tre formazioni (Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat, Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, Sunni Tehreek Pakistan) insisteranno.
 La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro
La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro
emendamento che cancellava l’ipotesi che un uomo condannato all’interdizione dai pubblici uffici potesse capeggiare un partito politico: un modo per riaprire la porta a Nawaz Sharif, l’ex premier costretto a lasciare in luglio su ordine della Corte suprema per via dello scandalo che lo vede implicato in transazioni poco ortodosse (Panama Papers). Ma sulle prime pagine campeggiano gli zeloti e ora ci si chiede cosa potrà accadere il 23 novembre se gli islamisti non molleranno.
Lo scrittore iracheno Ali Bader al festival salentino “La città del Libro”
Il prossimo 26 novembre, lo scrittore iracheno Ali Bader sarà ospite della manifestazione culturale salentina “La città del Libro”, il festival letterario internazionale di Campi Salentina, che quest’anno è dedicato alla figura di Abramo. Bader dialogherà con Monica Ruocco, docente di Letteratura araba dell’Università L’Orientale di Napoli che ha appena tradotto il suo romanzo Il […]![]()
Impegno, passione e tecnica nell’attività creativa e culturale di Giuseppe Montanucci
 L’iniziativa ha come significativo obiettivo di presentare al pubblico, attraverso l’opera creativa e culturale dell’artista grafico, alcuni aspetti dell’evoluzione della comunicazione grafica e dell’arte visiva in Italia dal Secondo Dopoguerra fino agli anni Ottanta.
L’iniziativa ha come significativo obiettivo di presentare al pubblico, attraverso l’opera creativa e culturale dell’artista grafico, alcuni aspetti dell’evoluzione della comunicazione grafica e dell’arte visiva in Italia dal Secondo Dopoguerra fino agli anni Ottanta.
L’avvicinamento tra Israele e l’Arabia Saudita assegnerà all’Iran un ruolo maggiore nel mondo islamico?
L’inaspettato riallacciarsi delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita potrebbe rafforzare la posizione dell’Iran nell’area, consentendogli di affermarsi come guida di tutto il mondo musulmano contro Israele e la coalizione occidentale.
L’articolo L’avvicinamento tra Israele e l’Arabia Saudita assegnerà all’Iran un ruolo maggiore nel mondo islamico? sembra essere il primo su Arabpress.
Una campagna per avere Abiti Puliti
 Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.
Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.
Perché?
Perché
In alcune fabbriche che producono per grandi marchi le operaie sono arrivate a dover indossare gli assorbenti per non assentarsi neppure per andare in bagno.
Più di 500 operaie sono svenute in un anno in alcune fabbriche Cambogiane che producono per notissimi marchi della moda e dello sport. Esauste e malnutrite l avoravano con almeno 37 gradi , senza neppure un ventilatore.
Le fabbriche del Bangladesh dove vengono cuciti i tuoi jeans, sono palazzi di molti piani con centinaia di operaie e dove le uscite di sicurezza sono spesso assenti o bloccate.
Un’operaia albanese deve lavorare un’ora intera per poter comprare un litro di latte , mentre a un’operaia inglese bastano 4 minuti di lavoro…
Fai una donazione qui
Il Bangladesh alle porte di casa
 |
| L’Europa dello sfruttamento: l‘ultimo rapporto della Campagna Abiti puliti |
Il Made in Europe della moda anche italiana investe e delocalizza in Europa Orientale. Ma il conto lo paga chi lavora
In Serbia, alle porte di casa nostra, la “soglia di povertà” per una famiglia di quattro persone viene calcolata a 256 euro. Ma il salario medio netto di un lavoratore dell’industria del cuoio e delle calzature arriva a 227 e a soli 218 nell’industria dell’abbigliamento. Se poi viene applicato il salario minimo legale netto, siamo a 189 euro. E’ la politica di incentivi che Belgrado ha deciso di applicare a diversi settori industriali per rilanciare l’economia e attirare investimenti. Regali alle aziende straniere, tra cui molte italiane, formalmente pagati dallo Stato ma di fatto dai lavoratori. Qualche nome? Armani, Burberry, Calzedonia, Decathlon, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Golden Lady, Gucci, H&M, Inditex/Zara, Louis Vuitton/LVMH, Next, Mango, Max Mara, Marks & Spender, Prada, s’Oliver, Schiesser, Schöffel, Top Shop, Tesco, Tommy Hilfiger/PVH, Versace. E ancora Benetton, Esprit, Geox e Vero Moda. Solo questione di soldi?
Nel luglio scorso la stampa locale riferiva di lavoratrici costrette a indossare gli assorbenti per evitare di interrompere il lavoro per andare in bagno. L’episodio era riferito alla fabbrica Technic Development Ltd di Vranje, società controllata di Geox, marchio italiano di abbigliamento per uomo, donna e bambino, noto per le scarpe “traspiranti”. La denuncia è costata il lavoro a Gordana Krstic, eppure quella storia non ha trovato eco sulla stampa italiana, un po’ distratta sulle questioni del lavoro delocalizzato. Ma non siamo in Bangladesh o in Cambogia e la fabbrica in questione occupa 1400 operai. Con salari netti medi (compresi straordinari e indennità) di 248 euro, meno della soglia di povertà. Straordinari che arrivano anche a 32 ore settimanali contro le 8 ammesse dalla legge. Sono i conti della moda.
Se sappiamo queste cose è perché un gruppo di attivisti della Clean Clothes Campaign (in Italia Abiti puliti) ha appena pubblicato un rapporto sui salari e le dure condizioni di lavoro nell’industria tessile e calzaturiera dell’Est e Sud-Est Europa. Non solo Serbia: in Ucraina, nonostante gli straordinari, alcuni lavoratori guadagnano appena 89 euro al mese in un Paese in cui il salario dignitoso dovrebbe essere di oltre 400. E anche se in in Slovacchia si arriva a 374 euro siamo sempre sulla soglia del salario minimo legale, quello – per intendersi – che non serve a mantenere una famiglia e forse nemmeno una persona. Anche tra i clienti di queste fabbriche ci sono marchi globali come Benetton, Esprit, Geox, Triumph e Vera Moda.
Più di 1,7 milioni di persone lavorano nell’industria dell’abbigliamento/calzature in Europa centrale, orientale e sud-orientale e spesso la differenza tra i salari reali e il costo della vita è drammatica in una situazione in cui – dice il rapporto L’Europa dello sfruttamento – l’attuazione della legislazione sul lavoro è “fallimentare”, con un impatto negativo sulla vita di chi, più o meno direttamente, cuce i nostri vestiti e le nostre scarpe. Per questi marchi, dice il rapporto, i Paesi dell’Europa Orientale sono paradisi per i bassi salari. E anche se molte firme della moda enfatizzano l’appartenenza al Made in Europe, cioè con condizioni di lavoro eque, molti lavoratori “vivono in povertà, affrontano condizioni di lavoro pericolose, straordinari forzati, indebitamento”. I salari minimi legali in questi Paesi sono attualmente al di sotto delle loro rispettive soglie di povertà e dei livelli di sussistenza. Le conseguenze, dice la Campagna, “sono terribili. I salari bastano appena per pagare le bollette elettriche, dell’acqua e del riscaldamento in Paesi dove ai marchi che investono vengono praticati grossi sconti proprio sulle utenze. Per loro le pagan gli operai.
Libye: le président de l’Union africaine s’insurge face à la situation des réfugiés

Alpha Condé, président de la Guinée et président en exercice de l’Union africaine, se dit indigné face à la vente d’esclaves en Libye. Il condamne ce qu’il qualifie de « commerce abject » et de « pratique d’un autre âge ». L’Union africaine usera, dit-il, tous les moyens à sa disposition pour mettre un terme à cette « ignominie ».
Libya ‘slave market’ probe called for by African Union
Language
Undefined
CNN footage of live auction in Libya where black youths are sold off for as little as $400 prompted outcry
Migrant crisis: Europe should stop using Libya as a dumping ground
With no central government and its own crises, Libya is ill-equipped to deal with an influx of returned migrants requiring shelter
Le Premier ministre du Liban Saad Hariri et sa famille à Paris

Le chef du gouvernement libanais Saad Hariri a atterri ce 18 novembre à Paris, en provenance de Riyad. Il doit rencontrer le président Emmanuel Macron à l’Elysée à la mi-journée. Ce dernier a affirmé qu’il le recevrait bien en sa qualité de Premier ministre du Liban, deux semaines après sa démission surprise en Arabie saoudite. Il sera rejoint par des membres de sa famille à la table du chef de l’Etat français. Au Liban, on oscille entre soulagement et interrogations.
Alleanza del Golfo: un nuovo approccio per il CCG
The Second Edition of “The Islamophobia Industry” Is Updated for the Age of Trump
The second edition of the Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Hatred of Muslims, first published in 2012, is not simply a re-release of the original, but has been significantly updated by author Nathan Lean to reflect the deep connections between President Donald Trump and the major drivers of Islamophobic propaganda and “research” in the United States, as well as the surge of anti-Muslim hate […]
Barcellona, documento di quartiere per migranti irregolari
Lo darà il Comune Barcellona agli stranieri irregolari residenti
Siria: all’Onu nuovo veto Russia su armi chimiche, ira Usa
Ambasciatrice Haley minaccia uso forza in caso di altri attacchi
I contractors italiani accusati di combattere per Haftar in Libia
Benghazi (Shabakat Akhbar al-Maarek – BNN) Il capitano Ahmad al-Aquri, identificato come un disertore dell’esercito libico comandato dal generale Khalifa Haftar nella Cirenaica, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le foto di un gruppo di presunti contractors italiani arruolati dal figlio del generale, Saddam Khalifa Haftar, nella battaglia in corso a Bengasi contro alcune formazioni jihadiste (il cosiddetto […]
Petition for Maha Abderrahman (November, 2017)
Cambridge, 10th November 2017 We, the undersigned, categorically reject the malicious and totally unfounded allegations made against Dr Maha Abdelrahman in the Italian newspaper La Repubblica on 2 November 2017. Dr Abdelrahman, an internationally highly-regarded scholar at Cambridge University, was the supervisor of Giulio Regeni, an Italian PhD student, who was conducting research on Egyptian […]![]()
Il Califfo a BookCity
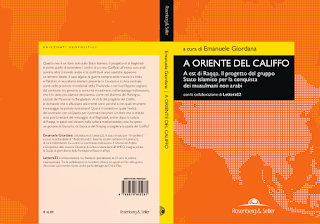 Autori Vari (Lettera22)
Autori Vari (Lettera22)
A cura di E. Giordana
“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei
musulmani non arabi”
– Rosenberg & Sellier 2017
Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5
Emanuele Giordana con Massimo Campanini
Non è un libro solo sullo Stato Islamico.
Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i
confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il
mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno
ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e
Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia
centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel
Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità
musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà
musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei
rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del
progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il
messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale
l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.
Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-
Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti
dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di
Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Emanuele Giordana cofondatore di Lettera22, collaboratore de “il manifesto” e voce di “Radio3mondo”. Con altri redattori di Lettera22, ha scritto La scommessa indonesiana,
Diversi ma uguali, A Oriente del Profeta, Il Dio della guerra, Geopolitica dello tsunami e Tibet. Lotta e compassione sul tetto del mondo. Già docente di cultura indonesiana all’IsMEO, insegna alla
Scuola di giornalismo della Fondazione Basso e all’Ispi. È presidente dell’associazione Afgana.
Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25 anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno anche parte dell’agenzia China Files.
Teheran e le scadenze dell’inverno decisivo
Sarà questo l’inverno decisivo per l’Iran? Alla luce dei tanti segnali lanciati dal Paese nei confronti degli abitanti della regione e a livello internazionale, sembrerebbe di sì.
L’articolo Teheran e le scadenze dell’inverno decisivo sembra essere il primo su Arabpress.
Viaggio all’Eden a BookCity
Il grande viaggio da Milano a Kathmandu ripercorso da un giornalista a distanza di 40 anni
Con Emanuele Giordana e Guido Corradi. A cura di Centro di Cultura Italia-Asia
Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il “grande viaggio” in India fatto da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Un sogno che portò migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa, fino ai templi della valle di Kathmandu.
DATA:
Venerdì, 17. Novembre 2017 – 15:00
SEDE:
MUDEC – Museo delle Culture Spazio delle Culture – via Tortona 56, Milano
RELATORI:
Emanuele Giordana
Guido Corradi
 |
| Illustrazione di Maurizio Sacchi |
Il Califfo e Viaggio all’Eden a BookCity
Emanuele Giordana
“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” – Laterza
con Guido Corradi
MUDEC Venerdi ore 15
Autori Vari (Lettera22)
“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei
musulmani non arabi”
– Rosenberg & Sellier
Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5
Emanuele Giordana con Massimo Campanini
SDF spokesman ‘defects’ to Turkish-backed rebels in Syria
Language
Undefined
Turkish-aligned Syrian opposition reportedly suggests Talal Silo was concerned about Kurdish dominance of Syrian Democratic Forces
La lezione saudita
L’Arabia Saudita sente di poter manipolare Hariri e la politica sunnita in Libano; tuttavia, l’influenza dell’Iran si è affermata attraverso la formazione di un governo libanese in cui Hezbollah detiene il potere politico e militare
L’articolo La lezione saudita sembra essere il primo su Arabpress.
Piccola pubblicità: perchè sostengo DINAMOpress
DINAMOpress è un progetto editoriale di informazione indipendente nato l’11 novembre 2012 dalla
cooperazione tra diversi spazi sociali di Roma, giornalisti professionisti, ricercatori universitari, video maker e attivisti. “Racconta e approfondisce – spiegano i suoi promotori – le questioni principali che riguardano il presente: politica locale e internazionale, precarietà e sfruttamento, femminismi, emergenze razziste e fasciste, forme di vita giovanili, produzioni culturali cinematografiche e musicali, migrazioni internazionali, problematiche ecologiche, cortei e mobilitazioni, beni comuni…”
Quello che viene presentato in questi giorni è il progetto di finanziamento alla luce del sole di un’iniziativa editoriale che ha lo scopo di allargare l’informazione su ciò che avviene. Può piacervi e anche non piacervi ma credo che vada sostenuta. Date un’occhiata al sito e poi se credete andate alla pagina dov’è spiegato il progetto e dove è possibile fare una donazione. Se posso aggiungere un pensiero, riguarda il fatto che oggi siamo bombardati da informazioni ma molto spesso di bassa qualità. Lasciamo stare le fake news, le bufale evidenti e le coglionate (al mondo c’è posto per tutti) ma quel che è da temere è la disinformazione: ben cucinata, professionalmente perfetta e apparentemente asettica. DinamoPress asettica non è. Professionale si. E’ una lampadina (o una dinamo se preferite) accesa nel buio dell’informazione mainstream. Anche 5 euro possono fare la differenza.
L’incontro in Vietnam non metterà fine alla crisi siriana
Il presidente americano e russo si sono accordati in Vietnam su una soluzione pacifica per la fine della guerra in Siria. Ma quali saranno le conseguenze per un Paese diviso tra varie influenze regionali e internazionali?
L’articolo L’incontro in Vietnam non metterà fine alla crisi siriana sembra essere il primo su Arabpress.
Gli iracheni chiedono al governo di aiutare un orfanotrofio che cura i bambini con l’arte
“Il governo dovrebbe aiutare Hisham al-Dhahabi a costruire una fondazione, perché questi bambini sono il futuro dell’Iraq e hanno il diritto di sentirsi al sicuro”.
Syrian government guilty of crimes against humanity: Amnesty
Language
Undefined
Amnesty appeals to international community to refer Syria to ICC and demand unhindered access for those investigating abuses
Rifugiati siriani in Armenia: non c’è ritorno
Sono 17.000 i siriani della comunità armena ad aver cercato rifugio in Armenia. Molti di loro non hanno intenzione di tornare nel paese d’origine. Un reportage
Egitto – Intervista dal carcere ad Alaa Abdel Fattah
Alaa Abdel Fattah è uno delle e degli attivisti egiziani che il regime di Sisi ha condannato a 5 anni di carcere per manifestazione non autorizzata. Si trattava di una manifestazione contro i processi militari ai civili (NoMilTrials) che si … Continue reading →
La prossima guerra
Il perpetuarsi e l’acutizzarsi del conflitto settario nello scenario mediorientale sembra avvicinare una nuova guerra
L’articolo La prossima guerra sembra essere il primo su Arabpress.
Cosa succede ai ‘foreign fighter’ montenegrini che rientrano in patria?
Il documentario “The Road of No Return?” punta l’obiettivo sul problema dei Montenegrini che rientrano in patria dopo aver combattuto in Siria e Ucraina,
La proposta per carcerare i gay in Egitto e altre notizie che non leggerete sui giornali
In Egitto una proposta di legge per criminalizzare omosessualità
il Cairo – Un parlamentare egiziano ha intenzione di presentare una proposta di legge che propone la carcerazione di chiunque promuova o sia impegnato in una relazione con persone dello stesso sesso. Questo provvedimento prevederebbe l’introduzione di pene detentive fino a 10 anni di reclusione per le persone impegnate in una relazione omosessuale, secondo l’agenzia di stampa Reuters, venuta in possesso della bozza di tale disegno di legge.
Amnesty International ha definito questa proposta “un altro ‘chiodo nella bara’ per i diritti delle persone omosessuali in Egitto”. “Se dovesse passare, questa legge rafforzerebbe ulteriormente lo stigma sociale e gli abusi contro le persone, basati sul loro orientamento sessuale”, ha detto a Reuters, Najia Bounaim, direttrice delle campagne per il nord Africa di Amnesty International. “Le autorità egiziane devono immediatamente rigettare questo progetto di legge e porre fine a questa allarmante ondata di persecuzioni omofobiche”, ha aggiunto Bounaim.
In Egitto l’omosessualità non è esplicitamente vietata, ma questo non ferma la repressione della polizia. L’articolo 9 della legge numero 10 del 1961, che punisce la prostituzione e “gli atti contro la decenza e la morale pubblica”, è spesso usato per reprimere la comunità LGBT.
La Nigeria apre un’inchiesta sulle 26 donne trovate morte a Salerno
di Bosun Odedina da Lagos, Nigeria
Lagos – L’Assemblea Nazionale nigeriana ha lanciato oggi un’inchiesta per appurare la cause della morte delle 26 donne trovate senza vita a bordo di una nave spagnola nel porto di Salerno. Le risultanze dell’indagine dovranno essere presentate entro quattro settimane. I membri della commissione d’inchiesta sentiranno le autorità libiche per appurare le circostanze della tragedia.
Marocco: violenze contro gli insegnanti, indetto uno sciopero nazionale
Rabat – In Marocco gli insegnanti hanno indetto uno sciopero di due giorni per protestare contro casi di violenza che hanno colpito in docenti, chiedendo maggiore protezione al governo. Lo sciopero nazionale di due giorni è stato indetto da diversi sindacati degli insegnanti e ha registrato adesioni tra il 70% e l’80% secondo quanto dichiarato da uno dei sindacati. Secondo quanto riporta l’Associated Press, il ministero dell’Educazione non ha ancora rilasciato dati ufficiali sulla partecipazione alla protesta.
Togo: continuano violenti le proteste dell’opposizione
Lomé – In Togo continuano le proteste dell’opposizione contro il presidente Faure Gnassingbe, in carica da 12 anni. Giovedì 9 novembre l’opposizione ha manifestato contro il governo per la terza volta in una settimana, promettendo di continuare fino alle dimissioni del presidente. Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso per i propri cittadini in viaggio per il Togo, evidenziando la violenza delle proteste, soprattutto nella città settentrionale di Sokodé. Il padre dell’attuale presidente del Togo, ha governato il Paese dal 1967 al 2005 e da allora Faure Gnassngbe ha ereditato la posizione, consolidando un potere che da 50 anni rimane nella stessa famiglia.
George Weah chiede nuove elezioni in Liberia
Monrovia – In Liberia il partito del candidato alle elezioni George Weah ha chiesto che il processo elettorale sia ripristinato in maniera “tempestiva”, dichiarando che rispetterà la decisione della corte suprema di rimandare il ballottaggio. La Liberia sta affrontando con difficoltà il primo passaggio pacifico di potere da oltre 70 anni. Lunedì 6 novembre la corte suprema ha sospeso il secondo turno delle elezioni presidenziali previste per il giorno successivo, per consentire lo svolgimento di indagine su accuse di frode elettorale.
Uno dei candidati del primo turno, Charles Brumskine, aveva chiesto al tribunale di rimandare il voto per permettere di indagare possibili frodi avvenute durante il voto del 10 ottobre. Al primo turno Brumskine, candidato del Liberty Party era arrivato terzo. Al ballottaggio, rimandato a data da destinarsi, si sarebbero dovuti affrontare l’ex calciatore George Weah e il vicepresidente in carica Joseph Boakai. I candidati si sfidano per succedere a Ellen Johnson Sirleaf, premio Nobel per la pace nel 2011.
La Turchia ricostruirà 26mila case distrutte durante la guerra al Pkk
di Giuseppe di Donna da Ankara, Turchia
Ankara – Il governo turco ricostruirà 26 mila abitazioni distrutte durante gli ultimi anni del conflitto tra le forze di sicurezza turche e l’organizzazione terroristica separatista del Pkk. L’annuncio è stato dato dal ministro dell’Urbanistica turco Mehmet Ozhaseki, che ha rivelato che, dalla ripresa del conflitto nel luglio 2015 ad oggi circa 70 mila abitazioni hanno subito danni, in molti casi talmente gravi da imporre una ricostruzione ex novo. “Non è giusto che tanta gente soffra dei danni del terrorismo, per questo costruiremo 26 mila nuove abitazioni in sei mesi – ha dichiarato Ozhaseki – i compound militari saranno rimossi dalle città e dai centri abitati“.
Secondo il ministro è precisa responsabilità dello stato risarcire i propri concittadini dopo il duro intervento delle forze di sicurezza turche nel sud est del Paese, caratterizzato da mesi di coprifuoco tra la fine del 2015 e la prima metà del 2016. “Da un lato c’è il pugno dello stato, che deve far sentire la propria forza e colpire i terroristi. Dall’altro c’è la mano dello stato che con compassione ripara le ferite di chi è stato vittima del conflitto”, ha dichiarato Ozhaseki.
Nigeria: “I leader africani riciclano 50 miliardi di dollari ogni anno”
di Bosun Odedina da Lagos, Nigeria
L’ex presidente della Nigeria, Olusegun Obasanjo ha dichiarato che leader politici e esponenti sia del settore pubblico che del privato in Africa, riciclano illegalmente ogni anno una somma monstre pari a 50 miliardi di dollari. L’ex presidente ha spiegato che l’aumento di queste cifre, destinate alla crescita socio-economica e lo sviluppo del continente africano, danno grandi preoccupazioni a tutti i leader, del presente e del passato. Ha aggiunto che tutti devono contribuire a lottare questo trend preoccupante.
Turchia: Il Paese ricorda Ataturk a 79 anni dalla morte
di Giuseppe di Donna da Ankara, Turchia
Ankara – Il 10 novembre è un giorno in cui la Turchia svela il proprio volto e la propria identità: ricorre infatti in questa data l’anniversario della morte di Mustafa Kemal, “Ataturk“, il padre della Repubblica, guida nella difficile transizione del Paese dal collasso dell’impero ottomano allo Stato che voleva repubblicano, laico, moderno. L’uomo che insegnò ai turchi che, per affrontare le sfide di un mondo in cambiamento, bisognava guardare ai modelli occidentali: aderire a uno stile di vita europeo abbandonando influenze orientali, a partire da alfabeto arabo, calendario islamico e abbigliamento che potesse connotare la fede islamica.
Il Ghana celebra regina madre centenaria nel rispetto tradizioni
di Francesca Spinola da Accra, Turchia
Accra – Nana Yaa Anamah II porta una pezza di stoffa bianca sul capo e un numero imprecisato di pesanti collane di “beads“, grani di vetro o altre pietre dure colorate, che non sono indossate a caso, ma hanno ciascuna un significato. Lei è una regina, una “queen mother” e in Ghana è venerata e rispettata come una vera regnante. Nana Yaa Anamah sta per compiere 102 anni e ha governato la sua gente per ben 75 anni. In questi giorni la sua foto campeggia su tutti i quotidiani di questo paese dell’Africa Occidentale dove l’etnia Akhan, circa il 60% della popolazione, parla diverse lingue ed è guidata da diversi “chiefs and queens“, in base all’area in cui vivono.
Ghana: ‘Big data for good‘ per uno sviluppo sostenibile
di Francesca Spinola da Accra, Turchia
Accra – Predire cosa serve per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che il Ghana si è dato. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Big Data for Good“, promossa da Vodafone Ghana, insieme al Ghana Statistical Service e alla Vodafone Group Foundation. Iniziativa che vuole usare i cosiddetti “insights“, le informazioni che derivano dall’utilizzo della telefonia mobile, “per migliorare le previsioni legate allo sviluppo sostenibile”.
Per Joakim Reiter, capo degli affari esterni del Gruppo Vodafone, questa iniziativa “no profit” è legata al concetto ormai diffuso che usare i dati prodotti dalle reti di telefonia cellulare può aiutare a prendere decisioni in grado di migliorare la vita delle persone. Il modo è semplice, i “big data for good” servono, secondo il portavoce di Vodafone, a far prendere decisioni più mirate ai cosiddetti “decision maker“, su temi importanti come la salute e la sanità, l’agricoltura, i trasporti, solo per citarne alcuni.
Israele: tre startup raccolgono $180 milioni in un giorno
Gerusalemme – In Israele in una sola giornata tre startup hanno annunciato di aver ottenuto fondi per centinaia di milioni di dollari. Mercoledì 8 novembre Compass (compra vendita immobili online), Yotpo (gestione dei commenti dei consumatori per azinede) e Mitrassist (assistente via app per chi soffre di rigurgito mitralico) hanno annunciato di aver ottenuto finanziamenti per circa 180 milioni di dollari, mentre una startup israeliana si prepara a affrontare in tribunale la principale azienda tech al mondo per valore di mercato, Apple.
L’app nigeriana che permette di navigare gratis su internet
Abuja – Sliide Airtime è una popolarissima app in Nigeria che permette a chi la scarica di navigare gratis dal proprio smartphone mostrando contenuti personalizzati sul lock screen degli utenti. È stata nominata l’app più innovativa al mondo al Global World Congress di quest’anno, la migliore app africana nel 2016 ai premi Apps Africa e Corbyn Munnik, il suo ad e cofondatore, è stato inserito da Forbes nella lista dei 30 under 30 africani da tenere d’occhio.
Saudis forced out Hariri over refusal to tackle Hezbollah in Lebanon: Sources
Language
Undefined
Sources close to the ‘resigned’ prime minister say the Saudis had been upset at Hariri stressing the need for entente with Hezbollah
Arabie saoudite: Saad Hariri en résidence surveillée à Riyad?

L’incertitude continue de planer sur la situation du Premier ministre libanais Saad Hariri, une semaine après sa démission surprise annoncée de Riyad. On commence à avoir plus d’informations sur les circonstances de l’arrivée de Saad Hariri en Arabie saoudite. Une convocation qui ressemble à un kidnapping.
Perché i giovani egiziani sono arrabbiati?
#WeWantToTalk: la nuova battaglia via rete dei giovani egiziani
L’articolo Perché i giovani egiziani sono arrabbiati? sembra essere il primo su Arabpress.
“Sono Gesù”: entra in Chiesa e distrugge la statua di Santa Rita
on è stato un estremista musulmano a distruggere – al grido di Allah Akbar – le statue sacre di Santa Maria del Popolo, chiesa ubicata nell’omonima …
Nature Based Solutions to Big Dams Can Help the Mesopotamian Region and the World
Bonn, Germany – 11 November 2017
During a session of the COP23 on “Managing water scarcity for agriculture”, the Save the Tigris campaign posed a question to Mr. Olcay Ünver, the Deputy Director of Land and Water Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): “Don’t you think that it’s time to state clearly that there is an urgent need to review water management policies in the Mesopotamian basin, particularly in relation to the building of big dams which have been proved to cause many serious problems for rivers systems, water resource sustainability, and climate change?”
Syria’s Decision to Sign the Paris Climate Agreement Is a Cynical Political Move
Syria surprised the world on Tuesday, November 7, when it announced during UN-led climate talks in Bonn, Germany that it would sign onto and uphold the Paris Climate Agreement. Led by former U.S. President Barack Obama, the Paris Climate Agreement was inaugurated in 2015 in order to reduce and restrict harmful emissions responsible for global climate change. Endorsed […]
Tragedies on the Mediterranean Highlight Dire Situation for Refugees and Migrants
On November 6, 2017, a dinghy set sail from Libya, carrying 140 refugees and migrants fleeing to Italy. Like many of the flimsy vessels making the dangerous journey to Europe, this one capsized thirty miles from the north of the Libyan capital, Tripoli, in international waters. As the vessel struggled, a Libyan coast guard boat […]
L’Arabia Saudita, il Sudan e la guerra nello Yemen
Il ruolo dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen e le sue responsabilità morali e umanitarie.
L’articolo L’Arabia Saudita, il Sudan e la guerra nello Yemen sembra essere il primo su Arabpress.
Arabie saoudite: les autorités libanaises exigent le retour de Saad Hariri

Une semaine après sa démission surprise, samedi 4 novembre dernier, alors qu’il se trouvait à Riyad, en Arabie saoudite, le Premier ministre libanais n’est toujours pas rentré à Beyrouth. Dans son pays, les voix se font de plus en plus fortes au sein de la classe politique et de l’opinion publique pour qu’il revienne.
Allarme in mare
 Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.
Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.
In Indonesia, ad esempio, cui Al Jazeera (vedi il video qui sotto) dedicava ieri un reportage dal villaggio di Bahagia (che significa…felice) a Sumatra, uno dei tanti minacciati dal livello dei mare, l’innalzamento degli Oceani è un serio pericolo per un un Paese eminentemente insulare dove 42 milioni di abitazioni costiere corrono rischi enormi e non solo per la violenza di uno tsunami (come avvenne in modo gravissimo proprio a Sumatra nel dicembre del 2004). La storia non è nuova. Già due anni fa, nel dicembre del 2015, lo specialista per le politiche pubbliche del ministero indonesiano per la Marina e la Pesca, Achmad Purnomo, aveva lanciato l’allarme, ripreso dall’Agenzia nazionale di notizie Antara e dalla stampa locale. E quel dato, 42 milioni di abitazioni con l’aggiunta di 2mila isole, non è dunque una congettura di stampa ma la proiezione degli esperti del ministero. Con una data: 2050 per vedere sommerse migliaia di isole e la scomparsa di interi villaggi, molti dei quali sorgono su palafitte, le tradizionali rumah panggung.
Anche in questo caso, seppur in maniera indiretta, c’entra l’uomo. Gli esperti del ministero di Giacarta puntano il dito sui cambiamenti climatici che, non è una novità, stanno sciogliendo i ghiacciaia e facendo salire il livello delle acque. Il primissimo allarme fu lanciato per le Maldive, isole coralline che sfiorano la superficie marina. Ma 42 milioni di villaggi non sono uno scherzo: se nel piccolo arcipelago turistico vive poco meno di mezzo milione di abitanti, l’Indonesia di milioni di residenti ne conta 255, sparsi in gran parte sulle coste che si estendono per 80mila chilometri su circa 17mila isole.
Al ministero sono preoccupati perché il Paese non ha le risorse sufficienti (anche dal punto di vista della formazione dei quadri) per affrontare un’emergenza che, nel giro di meno di 35 anni, vedrà innalzarsi il livello delle acqua di 90 centimetri con effetti devastanti per molti villaggi costieri e per 2mila piccole isole a rischio di essere inghiottite dall’Oceano. Oltre a ciò, dicono al ministero, altri effetti del riscaldamento globale incidono sulle attività economiche di questi stessi villaggi: le sempre più incerte le stagioni della pesca e i cambiamenti negli schemi della migrazione ittica oltre a un crescente numero di pesci che sono stati uccisi dal fenomeno dello spiaggiamento: si arenano sulle spiagge dopo aver smarrito la via.
Gli indonesiani chiamano il loro Paese, il più vasto mondo insulare del pianeta proprietà di un singolo Stato, tanah air kita, la “nostra terra d’acque”. E in effetti di acqua ce n’è parecchia perché ufficialmente l’Indonesia si estende su un milione e 900mila kmq quadrati di suolo in gran parte circondato dal mare. Il fatto è che questo suolo è formato sia da grandi isole, sia da strisce di terra sino ad atolli che misurano solo qualche centinaio di metri quadri. Molte sono abitate e altre non conoscono l’intervento umano. Quante? Secondo una stima del 1969, il più vasto arcipelago del mondo ne conterebbe 17.508 ma è una stima appunto e non tutte le isole hanno uno status giuridico riconosciuto a livello internazionale. Di queste, inoltre, solo 13.466 hanno un nome. Adesso Giacarta si sta dando da fare per fare i conti definitivi sulla base di un criterio accettato in sede internazionale e sancito dalla Un Convention on the Law of the Sea, secondo la quale un’isola è una formazione naturale di territorio circondata dal mare e che non sparisce con l’alta marea. Se non sparirà per effetto dell’innalzamento delle acque.
Appello per Ahmadreza Djalali, ricercatore universitario a Novara, condannato a morte in Iran
“Facciamo appello a tutti coloro che ci possono ascoltare e aiutare a usare tutti i mezzi a disposizione per salvare la vita ad Ahmadreza Djalali”.
I giornalisti marocchini continuano a lottare per occuparsi del movimento Hirak, nonostante le intimidazioni statali
I giornalisti che si occupano delle proteste del movimento Hirak devono fronteggiare una miriade di limitazioni.
The “Syrianisation” of the world
In his book “The Impossible Revolution – Making Sense of the Syrian Tragedy”, Syrian dissident Yassin al-Haj Saleh chronicles the Syrian revolution and explains how it was destroyed. His analysis shows all too clearly how little the West knows about Syria to this day. By Emran Feroz
Final verdict issued to uphold activist Alaa Abd El Fattah’s 5-year prison sentence

Egypt’s Court of Cassation issued a final ruling on Wednesday to uphold political activist Alaa Abd El Fattah’s five-year prison sentence on charges related to protesting. However, the court commuted the mandate that the term be carried out in a maximum security prison to assign Abd El Fattah to a general population prison.
Abd El Fattah will also have to undergo five years of probation after his release, in addition to an LE100,000 fine, as was decided in the February 2015 criminal court sentence Abdel Fattah appealed.
Lawyer Mokhtar Mounir told Mada Masr that the penalty change basically means that Abd El Fattah would serve his sentence in a general population prison without the rigorous conditions of a hard-labor imprisonment.
Mounir also added that a one-year sentence in a general population prison is nine months, in comparison to 12 months in hard-labor, but added that this difference is usually disregarded in the cases of political prisoners, such as the 6 April Youth Movement’s Ahmed Maher and Mohamed Adel.
Lawyer Mahmoud Belal told Mada Masr that the penalty change will have no real implications, insisting that the ruling is tantamount to the court rejecting the appeal, as types of prisons in Egypt do not differ greatly.
Abd El Fattah’s appeal was originally set to be heard on October 19, but the judge in the Court of Cassation circuit presiding over the case recused himself, citing “discomfort,” which lawyers believe suggests an issue of impartiality.
In February 2015, Cairo Criminal Court sentenced Abd El Fattah and Ahmed Abdel Rahman to five years in prison for charges of protesting in front of the Shura Council, with an additional five years probation and a LE100,000 fine each. It also sentenced each of the remaining defendants to three years in prison, three years probation and a LE100,000 fine.
All 21 defendants in the Shura council case appealed the verdict, and were released pursuant to a presidential pardon, except Abd El Fattah.
Abd El Fattah is awaiting another verdict on December 30 for charges of insulting the judiciary, along with 24 other defendants, including former Islamist president Mohamed Morsi.
Islamophobia, 20 years later: How we can hope to defeat it
We wish for an end to the hurts and harms of Islamophobia, and to the demonising of others, writes Robin Richardson. We wish for a new us
The world-famous Louvre museum starts a lucrative new chapter in Abu Dhabi
In Abu Dhabi, it’s viewed as a status enhancer. In France, critics decry what they see as a beloved museum selling out to the highest bidder.
La battaglia navale tra le Ong e i libici
Rassegna stampa italiana ed estera del 10 novembre 2017
L’ Asia Centrale e la rivoluzione russa del 1917
La rivoluzione russa del 1917 ebbe in Asia Centrale effetti profondi, le cui conseguenze perdurano ancora oggi. Un periodo turbulento che ha sconvolto questa regione affascinante e complessa. Leggine su East Journal!
L’articolo L’ Asia Centrale e la rivoluzione russa del 1917 sembra essere il primo su East Journal.
Tunisia: il Parlamento cederà alla pressioni del sindacato di polizia?
Sadri Khiari Come è ormai consuetudine, ogni nuovo attentato diventa il pretesto per un nuovo giro di vite securitario. Lo stato d’emergenza e la legge anti-terrorismo ne costituiscono sicuramente il quadro generale. L’assassinio, il 1° novembre, di un graduato della polizia, il comandante Riadh Barrouta per mano di un presunto membro dell’Isis, ha dunque riportato all’ordine del giorno il progetto […]
“Borderlife” di Dorit Rabinyan
Dal blog Con altre parole d Beatrice Tauro
L’articolo “Borderlife” di Dorit Rabinyan sembra essere il primo su Arabpress.
Jerusalem Without God in NYC
Eravamo in centomila…
Eravamo in centomila, cantava Adriano Celentano nel 1967. Lui si riferiva allo stadio dove aveva visto una ragazza che gli piaceva. Ma questo è anche il bel ricordo dei generali della Nato e del Pentagono e, chissà, di Via XX Settembre. La voglia di stivali sul terreno cresce e la Nato annuncia che da 13.400 soldati passeremo a 14.400 circa. Che con i nuovi arrivi americani (3mila più 11mila già presenti) farà circa 30mila uomini. Non sono i quasi 150mila di una volta ma son pur sempre di più dei 15mila di qualche mese fa. Per fare che? La nebulosa dice che faremo assistenza tecnica ma questo termine vago preannuncia un lavoro in cui ci si sporcano le mani. Cambia la strategia però: bombe dal cielo, sempre di più, sempre più mirate (?), sempre più potenti, sempre meno segrete. Nell’indifferenza del mondo che guarda stupefatto ai deliri calcolati dei Kim, alla macelleria saudita, e all’America first di Trump – che si traduce in profitti per il comparto industrial militare – l’Afghanistan sta conoscendo una nuova escalation. In sordina. Ssssssssssssstttt. Che nessuno se ne accorga. Eravamo centomila e abbiam perso la guerra. Ci riproviamo in 30mila e poi vediamo.
Medfilm – Il festival del cinema mediterraneo
“Lo sgurado delle donne”, questo il titolo della XXIII edizione del Medfilm Festival, il primo evento in Italia dedicato alla promozione e diffusione del cinema mediterraneo. Appuntamento dal 10 al 18 novembre a Roma.
Identikit del Populismo
mcc43 -Il popolo è buono e onesto -Il popolo è stato tradito -Il leader carismatico restaurerà la sovranità popolare Fra gli intellettuali della Russia zarista nacque un movimento per riscattare il mondo contadino oppresso dalla burocrazia imperiale; da “narod”, popolo, assunse il nome di narodničestvo: populismo. La parola ha percorso una lunga strada, ha cambiato soggetti […]![]()
Arabia Saudita: Mohamed Ben Salman cambia le regole del gioco e consolida il proprio potere nel Regno
La nomina di Al-Muqrin come capo delle milizie nazionali per rafforzare la regola tribale su cui si basa
L’articolo Arabia Saudita: Mohamed Ben Salman cambia le regole del gioco e consolida il proprio potere nel Regno sembra essere il primo su Arabpress.
Chi sono i Rohingya?
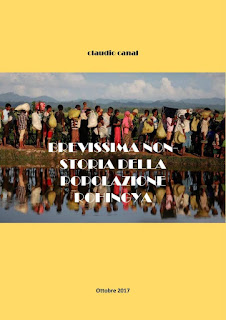 Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:
Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:
qui può essere sfogliata come un libretto
qui scorre come un pdf.
Il trono di spade in Arabia Saudita
Rassegna stampa italiana ed estera del 7 novembre 2017
Le dimissioni di Hariri e il golpe strisciante
Le dimissioni del primo ministro libanese hanno annunciato la sottomissione totale del Libano a Hezbollah, consegnando tutto il potere nelle mani del suo rivale iraniano.
L’articolo Le dimissioni di Hariri e il golpe strisciante sembra essere il primo su Arabpress.
“Il libro di Dot” di Hisham Matar e altri libri per bambini di autori arabi
Lo scrittore anglo-libico Hisham Matar, Premio Pulitzer 2017, ha firmato un libro per bambini illustrato da Gianluca Buttolo: si intitola Il libro di Dot ed esce il prossimo 15 dicembre per l’editore Renoir Comics. Dot (“punto” in inglese) è un puntino che non si rassegna a fare solo il puntino: “Dot si stava chiedendo quale […]![]()
Egitto – Scioperi della fame e morti nelle carceri egiziane
Sono centinaia i prigionieri delle diverse carceri egiziane che nel mese di ottobre hanno deciso di cominciare lo sciopero della fame a oltranza per denunciare la lunghezza dei tempi della detenzione preventiva e i diversi maltrattamenti di cui sono vittime. … Continue reading →
Libano: le dimissioni di Hariri annunciano una nuova guerra?
Dopo le dimissioni del premier libanese, Saad Hariri, si teme che il Libano possa ripresentarsi come l’arena del conflitto nella regione. E non mancano i presupposti di una nuova guerra.
L’articolo Libano: le dimissioni di Hariri annunciano una nuova guerra? sembra essere il primo su Arabpress.
Mazen Kerbaj alla Libreria Griot di Roma
Sono lietissimissima di annunciarvi che questo giovedì, a partire dalle 18,30, la Libreria Griot (via di Santa Cecilia 1/A, Roma) ospita l’artista libanese Mazen Kerbaj, che verrà introdotto da Maria Camilla Brunetti, giornalista capo redattrice de Il Reportage, esperta di Libano e cultura libanese. Mazen Kerbaj (Beirut, 1975) è uno dei principali artisti libanesi contemporanei. […]![]()
Save the date – Center for Middle Eastern Studies at Harvard
At the Center for Middle Eastern Studies at Harvard. Hosted by the wonderful Sara Roy From Ancient Gates to Postmodern Drawbridges: Exclusivity and Exclusion in Contemporary Jerusalem Date: Tuesday, November 7, 2017, 12:30pm to 2:30pm Location: CMES, R…
CfP BRISMES 2018: Southern-led Responses to Displacement in the MENA Region
Southern-led Responses to Displacement in the MENA Region The longstanding human displacement and forced migration flows in the Middle Eastern region have invited scholars and researchers to think in new ways about the collective and individual meanings of mobility, culture-oriented models of care, and the role of transnational and local networks in mobilising people, ideas […]![]()
Dopo la Rivoluzione (d’ottobre)
C’era una volta la Rivoluzione d’Ottobre. E in occasione del centennale della rivoluzione russa, dal 7 al 10 novembre si terrà a Torino, nel Campus Luigi Einaudi, il convegno internazionale Dopo la Rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917, organizzato dall’associazione Memorial Italia e dall’Università degli Studi di Torino
Il tema del Convegno*
La rivoluzione russa: difficile dire quando è iniziata, quando è finita, e di cosa si è trattato. Il centennale dell’ottobre 1917 diventa occasione per rileggere i fatti di allora rispettandone la complessità e per osservarli con punti di vista differenti. Crisi, rivoluzioni e controrivoluzioni, ritorno all’ordine, caos, fame e violenze si intrecciarono per un lungo periodo, quantomeno dalla prima guerra mondiale agli anni ’50. Proprio per discutere e riflettere su aspetti significativi di questo periodo storico, l’associazione Memorial, che in Russia opera per la difesa dei diritti, e l’Università degli Studi di Torino organizzano il convegno internazionale Dopo la rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917 che si terrà a Torino, dal 7 al 10 novembre, nel Campus Luigi Einaudi. Non quindi una commemorazione, ma una riflessione con cent’anni di distacco dalla rivoluzione.
Il convegno è diviso in due parti. Nella prima si affrontano in modo del tutto innovativo gli eventi della rivoluzione; lo studio della guerra civile sul territorio dell’ex-Impero russo ci spiega quanto il paese fosse lontano dagli avvenimenti della rivoluzione: il partito, le discussioni rivoluzionarie, l’organizzazione politica operaia. Nelle periferie dell’Impero la rivoluzione arriva come crollo dello stato, bande armate, fame. La formazione dell’URSS poggia sulla riconquista militare del territorio, sull’imposizione di una dittatura militare-politica, sulla repressione di ogni istanza autonomista e di ogni richiesta di elezioni.
La seconda parte del convegno è dedicata alla sopravvivenza della cultura e al suo rapporto complesso con la rivoluzione. Interverranno studiosi italiani e stranieri, che esamineranno le conseguenze del 1917 da diversi punti di vista, complementari e variegati, a testimonianza della complessità e della varietà di suggestioni intellettuali e culturali del periodo.
Per approfondire questi temi e confrontarsi con studiosi italiani e stranieri appuntamento a Torino dal 7 al 10 novembre nel Campus Luigi Einaudi.
* Riproduco qui la scheda di invito
Avviso di reato
 |
| Fatou Bensouda. Sotto, Donald Trump |
«La situazione nella Repubblica Islamica d’Afghanistan è stata assegnata a una Camera preliminare della Corte Penale Internazionale (Icc) a seguito della mia decisione di chiedere l’autorizzazione ad avviare un’inchiesta sui reati che si suppone siano stati commessi in relazione al conflitto armato». La dichiarazione della procuratrice capo del Tribunale penale internazionale Fatou Bensouda rimbalza nelle agenzie di stampa nella notte di venerdi, giorno della partenza di Trump per il suo viaggio in Asia, il più lungo – recita la velina della Casa Bianca – che un presidente americano abbia fatto nell’ultima quarto di secolo. Ma Trump non andrà in Afghanistan e del resto la tegola era attesa da circa un anno: da quando, a metà novembre 2016, la giurista del Gambia a capo della Corte dal 2012, aveva annunciato nel suo Rapporto preliminare di attività (quel che in sostanza si intendeva fare) che il dito era puntato anche contro gli Stati Uniti per i quali c’erano «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che in Afghanistan avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Con loro, sotto la lente, polizia e 007 afgani e parte dei talebani. Ma adesso il passo è diventato formale e dunque esecutivo, con una richiesta di autorizzazione a procedere per le accuse di crimini di guerra in Afghanistan dopo l’invasione guidata dagli Usa 17 anni fa.
L’indagine, col mandato alla procura di sentire testimoni, interrogare vittime, avere accesso a informazioni riservate (almeno in teoria anche perché né gli Usa né i talebani riconoscono l’autorità dell’Icc), riguarda le attività della Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento talebano); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (Nds); militari e agenti americane. Il testo del rapporto preliminare diceva che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Cia, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram.
Se per i talebani (nella dichiarazione non si specifica se l’indagine riguarderà altre ali del
movimento diretto da mullah Akhundzada) le accuse di crimini di guerra non sono una novità, per Washington e Kabul la questione è seria, al netto della possibile collaborazione tra le due intelligence. Bensouda sostiene che durante gli interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citavano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania .
 |
| Il Nyt di ieri: 13 civili uccisi in un raid. Non si sa se gli “effetti collaterali” siano inclusi nelle indagini |
Probabilmente, nell’anno intercorso tra il rapporto preliminare e la richiesta formale di indagine, la procura deve averne esaminati assai di più e comunque già un anno fa si chiariva che i crimini presunti «non sono stati abusi di pochi individui isolati (ma)… commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… (con) una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli…». Quanto a polizia e intelligence afgani, la tortura sarebbe un fatto sistematico: tra il 35 e il 50% dei detenuti vi sarebbero stati sottoposti.
Adesso la procura deve convincere i giudici della Camera preliminare della fondatezza delle accuse. Poi toccherà ai magistrati dare l’ultimo via libera che, considerata l’ampiezza delle prove raccolte in un arco di tempo sufficiente a non correre rischi, pare scontata. Una volta terminato l’iter, toccherà allora alla procuratrice formulare le accuse e chiamare alla sbarra i responsabili. Sarà quello il momento più difficile ma sembra ormai solo questione di tempo.
La Siria e la ricostruzione di una nazione
Quale approccio per la ricostruzione del paese?
L’articolo La Siria e la ricostruzione di una nazione sembra essere il primo su Arabpress.
Viaggio d’affari nel Rakhine
Il viaggio è a sorpresa. Lo annuncia il portavoce del governo mentre Aung San Suu Kyi è già a Sittwe, capitale dello stato birmano del Rakhine; da lì si muoverà verso Maungdaw e Buthiduang. Il comunicato è scarno e anche la Nobel, al comando del nuovo Myanmar democratico, non fa grandi concessioni. Le cronache dicono che parla con qualche abitante dei villaggi e probabilmente vuole tentare di rilanciare il suo piano per far rientrare quei 600mila rohingya che da agosto sono fuggiti oltre confine. Come non è chiaro e comunque nessun accenno alle responsabilità dell’esodo forzato più massiccio della storia recente da un Paese in pace. Invita la gente a “non litigare” e a rivolgersi al governo se ci sono problemi. Più che altro sfodera il blando rimedio dello sviluppo. Con lei, su un elicottero militare, scrive la Bbc, ha preso posto infatti anche uno dei più ricchi imprenditori birmani. E’ un viaggio in un cono d’ombra: la sua visita nel Rakhine avviene mentre il Tribunale Permanente dei popoli ha emesso la sua sentenza su quanto avviene nel Paese. Il documento è un pesante atto d’accusa per due gruppi a rischio: i Kachin e i Rohingya. Ma se nel caso dei Kachin, dice la sentenza dei giudici della società civile, si rileva un intento genocidario, nel caso dei Rohingya la responsabilità di atti di genocidio è chiara. Fatti, non intenti.
 E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).
E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).
Per ora le pressioni sul governo birmano sono relativamente poche e nei luoghi dove si decide – come il Consiglio di sicurezza dell’Onu – oltre alle prese di posizione e a qualche blanda misura, non si è andati. In un quadro che vede in difficoltà anche le agenzie umanitarie che non sempre hanno accesso alle zone dove si sono verificati – documenta il tribunale – stupri, incendi, esecuzioni. Anche la via di fuga è un problema: il Bangladesh, Paese già in difficoltà, non sa come far fronte all’esodo e vorrebbe anche rispedirli a casa, ma quale casa?
 |
| Il segretario dell’Onu Guteres. Sopra Aung San Suu Kyi. Al centro un manifesto storico del Tribunale dei popoli |
Il ritorno sembra impossibile. L’incontro promosso dalla Lega per la democrazia nei giorni scorsi – una preghiera interreligiosa di pace – non ha sollevato la questione rohingya è Suu Kyi gode di un enorme consenso che la giustifica. Tutti sanno per altro che le sue responsabilità sono relative e che il vero potere è saldamente in mano ai militari che devono averle concesso il contentino del viaggio. Quanto accade sul terreno però parla chiaro e riguarda, ancora una volta, la terra. Non dunque solo l’odio razziale o l’intolleranza religiosa. Da sabato i soldati hanno iniziato a supervisionare la raccolta del riso – dice la stampa locale – su un’area di circa 300 kmq dove viveva chi è fuggito. E non si tratta solo di qualche tonnellata di cereali: il ministro per lo Sviluppo sociale, soccorso e reinsediamento, Win Myat Aye, ha detto in settembre – riportava Simon Lewis di Reuters – che «Secondo la legge, la terra bruciata diventa terra gestita dal governo». Quindi vendibile e acquistabile. Terra bruciata appunto specie se il suo proprietario è all’estero.
Giulio Regeni: chi è Maha Abdelrahman, la tutor di Cambridge che seguiva le sue ricerche in Egitto
Una lunga esperienza di ricerca sul campo nell’ambito delle scienze politiche e della sociologia, numerose consulenze con prestigiose organizzazioni internazionali quali Oxfam e Unicef e una posizione da professore associato all’American University del Cairo, poi lasciata per l’Università di Cambridge. Maha Abdelrahman è un’accademica egiziana e vanta una carriera di lungo corso. Tuttavia, per le […]
L’articolo Giulio Regeni: chi è Maha Abdelrahman, la tutor di Cambridge che seguiva le sue ricerche in Egitto proviene da Il Fatto Quotidiano.
Cento anni di Balfour, dove e come è iniziato tutto
Il 2 novembre 1917, la Gran Bretagna si impegnava con il Congresso sionista mondiale a garantire l’esistenza di un “focolare nazionale ebraico” in Palestina. La decisione venne ufficializzata con la Dichiarazione di Balfour, dal nome dal conte Arthur J. Balfour,… Continue Reading →![]()
Russia non raccontata: Putin e le milizie del Patriarca
mcc43 Putin e l’uso dei media Putin, Kiril I e gli Ortodossi Putin e Cattolicesimo, Islam, Testimoni di Geova – Putin e l’uso dei media Sappiamo tutto di Putin e della sua politica estera, poco di quello che accade dentro la Russia. E’ l’effetto di un meccanismo creato per distrarre la nostra attenzione. Quando, […]![]()
Perché Al-Sisi ha sostituito il suo consuocero con un amico?
Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha stupito il proprio consuocero Mahmoud Hegazy, Capo di Stato Maggiore dell’esercito egiziano fino allo scorso sabato, nominando al suo posto Mohamed Farid Hegazy, uno dei suoi amici più stretti.
L’articolo Perché Al-Sisi ha sostituito il suo consuocero con un amico? sembra essere il primo su Arabpress.
Documentario: Tra le rovine dell’industria del tè della Georgia sovietica
“Non c’era nemmeno un disoccupato a Laituri. Tutti lavoravano o nelle piantagione o nella fabbrica.”
Diario americano – Segnali sonori (globali)
Suoni globali, oppure segnali sonori globali. Bisognerebbe trovare un termine per quei suoni che, ovunque nel mondo, ci parlano un linguaggio familiare, e ci fanno sentire – allo stesso tempo – parte di un unico contesto. Se Marc Augé definisce nonluoghi i luoghi della globalizzazione, come definiamo i suoni? Soprattutto i suoni meriterebbero una riflessione,Continua a leggere
Perché gli USA stanno celebrando un wrestler iraniano socialista?
“Takhti rappresentava un comportamento morale, una tradizione, un universo di valori con antiche e intense origini e in grande contraddizione con lo status quo”.
Siria: Onu, 13 milioni nel Paese hanno bisogno assistenza
6,3 mln in stato necessità. Allarme per 50 mila in campo Rukban
Jerusalem without God on American tour – dates & locations
Let’s start, watching the Pacific Ocean and seeking inspiration. Jerusalem is very far away, from here. Will it be difficult to explain Jerusalemites’ life and pain, historical and political paths, bleak present and the need for recognition, justice, lasting peace? I guess and I hope not. Here is my schedule in the US. Very thrilledContinua a leggere
Che fine ha fatto la rivoluzione siriana?
Caduta Raqqa, la guerra continua. Ma la partita non è solo militare. Anche se la rivolta civile che scosse il regime sembra lontana. E c’è chi pensa non ci sia mai stata. Chiedetelo ai siriani che quella rivoluzione l’hanno fatta. E hanno ancora in testa un’idea di futuro per la Siria
- Lorenzo Declich
- Martedì, 31 Ottobre 2017
 Manifestazioni durante la rivoluzione siriana. REUTERS/Majed Jaber
Manifestazioni durante la rivoluzione siriana. REUTERS/Majed Jaber
La città di Raqqa, la cosiddetta capitale siriana dell’organizzazione dello Stato Islamico, è caduta. A conquistarla sono le Syrian Democratic Forces, guida curda, contingenti arabi, aviazione – sempre più letale e sempre meno “intelligente” – degli americani. È uno dei tanti capitoli di una guerra della quale ancora non vediamo la fine, una delle molte guerre siriane, per l’esattezza: quella di Is contro tutti.
LEGGI ANCHE : Raqqa, il senso di una fine
Una guerra che perderà di intensità ma permarrà a lungo: i perdenti di oggi sono annichiliti ma ben lungi dall’essere sconfitti anzi, intuiamo che i terroristi in Siria vanno sempre più radicandosi, riproducendo ciò che in Iraq è già da tempo una realtà: una sotteranea rete di relazioni basata su interessi economico-criminali. (Su questo tema consigliamo la lettura di questa importante testimonianza apparsa sul New Yorker.)
La partita in Siria non è solo militare, anzi. Quello di Raqqa, e con Raqqa gran parte dell’area orientale del Paese, è solo un esempio: mentre ci si incammina verso un qualcosa che sarebbe bene definire “pacificazione” più che “pace”, si aprono i file a medio termine più importanti: sociale, politico, economico.
E’ in frangenti come questi che ci si chiede quale sarà davvero il futuro della Siria, se ci sarà spazio per qualcosa di più di un regime tirannico che maltratta i suoi sudditi e si fa imporre l’agenda dai propri alleati esterni (Russia, Iran, Cina). Ed è a questo punto del ragionamento che ci chiederemo “che fine ha fatto la rivoluzione siriana?”. Che fine hanno fatto quelle decine di migliaia di persone che scendevano in piazza per chiedere riforme sociali, politiche, economiche? Sono ancora in grado di fare qualcosa? Di cambiare le carte in tavola?
Per prima cosa, rispondendo a queste domande, non bisogna dare per scontato che tutti siano d’accordo sul suo “frame”. Molti, cioè, diranno che la rivoluzione siriana non c’è stata, che era tutto un complotto internazionale contro la “ridente Siria” di Bashar al-Asad, poi tradottosi in un attacco imperialista in grande stile.
Invece ciò che in Siria è avvenuto a partire dai primi mesi del 2011 è molto chiaro: un rivolta pacifica che, dopo una repressione violentissima e cieca, è divenuta una vera e propria rivoluzione le cui due anime nonviolenta e armata hanno convissuto fino all’irruzione, da ambo le parti, delle potenze straniere piccole e grandi che hanno trasformato il conflitto da “guerra in Siria” a “guerra per la Siria” e hanno letteralmente cancellato dallo scenario i siriani stessi.
L’antidoto migliore per capire se qualcosa di quella rivoluzione rimane, e per smascherare i cospirazionismi, si ottiene tracciando solchi nella storia, solchi che attraversano i luoghi comuni. Si pensi un uomo come Mazen Darwish, ad esempio, uno dei più importanti attivisti per i diritti umani della Siria. La sua attività politica inizia ben prima della rivolta, nel 2004 (quando fondò il Syrian Center for Media and Freedom of Expression). Lo ritroviamo oggi, dopo anni di carcere nelle prigioni di Asad (l’ultima volta è stato detenuto dal 2013 al 2015). E quando si tratta di parlare di vincitori e vinti in Siria dice: “Non si tratta di decidere chi ha vinto. Si tratta di capire come facciamo a liberare i detenuti, a far cessare la tortura, a ritrovare le persone scomparse”.
Darwish, cioè, dice le stesse cose che diceva prima, durante e dopo la rivolta, la rivoluzione e la guerra siriane. Dice di essere ancora in lotta per vincere la pace, non la guerra: questo da sempre fa. Quest’uomo non è parte di chissà quale complotto, è semplicemente una persona che vuole cambiare le cose nel suo Paese e nessuno lo ferma, mai, se non con le cattive.
Quindi, alla domanda “che fine ha fatto la rivoluzione siriana”, si potrebbe semplicemente rispondere: chiedi a Mazen Darwish, a Yara Badr, a Yassin al-Haj-Saleh, a Razan Ghazzawi e a quelli come loro, che sono ancora tanti. Chiedi a quei siriani che la rivoluzione l’hanno fatta e che non sono scomparsi nelle carceri di Asad, non sono finiti nelle mani dello Stato Islamico o di qualche altro gruppo jihadista, non sono morti sotto i bombardamenti e ancora vogliono libertà, dignità e cittadinanza, le tre parole chiave della rivoluzione.
Questi siriani, sebbene non li vediamo quasi mai comparire in televisione o sui giornali, hanno costruito in questi anni un’idea di futuro per il loro Paese, un’idea ben diversa da quella che possono avere un Putin, un Ruhani, un Trump, un Erdogan o un petromonarca a scelta fra i più vieti.
Certo le circostanze non sono favorevoli. Si pensi che una delle nuove iniziative per la costruzione di una Siria civile e democratica si intitola “Noi esistiamo“.
A causa della loro debolezza dovremmo rivolgerci ai “padroni del mondo?” Cioè a leader politici che hanno dimostrato tutto il loro cinismo e una peculiare mancanza di scrupoli? Da cittadini, da persone democratiche che conoscono il significato dell’espressione “diritti umani”, la nostra risposta dovrebbe essere un sonorissimo “no”.

Esperto di mondo islamico contemporaneo, Lorenzo Declich è autore del recente “Siria, la rivoluzione rimossa” (edizioni Alegre)
ARTICOLI CORRELATI
Le macchine da guerra che strangolano il Sahel
In Africa occidentale è in corso una crisi militare, alimentare e ambientale, accentuata dalla presenza di trafficanti di armi, droga, uranio ed esseri umani. Leggi
Astana, settimo round: questioni militari e umanitarie
Rassegna stampa italiana ed estera del 31 ottobre 2017
Aid enters besieged Syria region hit by hunger crisis
Language
Undefined
UN and the Syrian Arab Red Crescent enter Ghouta with enough food for 40,000 people
“L’esercito del Sahel” contro jihadisti e trafficanti
Rassegna stampa italiana ed estera del 30 ottobre 2017
Visita a Milano dei familiari dei migranti scomparsi e vittime di scomparsa forzata nel Mediterraneo
 Anno dopo anno assistiamo al macabro conteggio delle vittime lungo le frontiere del mondo. Soltanto nel Mediterraneo, dalla fine degli anni ’80 al 2017 oltre 35 mila persone migranti sono morte, scomparse o sono state vittime di scomparsa forzata nel tentativo di raggiungere l’Europa.
Anno dopo anno assistiamo al macabro conteggio delle vittime lungo le frontiere del mondo. Soltanto nel Mediterraneo, dalla fine degli anni ’80 al 2017 oltre 35 mila persone migranti sono morte, scomparse o sono state vittime di scomparsa forzata nel tentativo di raggiungere l’Europa.
France and Egypt: Allies of convenience

The exact dates of the presidential visit remained unconfirmed until the last minute, as usual. On October 23, though, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi entered French airspace with great pomp, escorted by several Rafale French fighter jets bearing the tricolor cockade and the Egyptian flag.
Sisi was on his first official visit to Paris since the election of French President Emmanuel Macron. Although the two men had met briefly before — at the 72nd General Assembly of United Nations in New York in September — bilateral relations have mostly been negotiated through their respective ministers, who are by now familiar with one another. Both Jean-Yves Le Drian, the French minister of foreign affairs, and Florence Parly, French minister of the Armed Forces, have already met with the Egyptian strongman and various Egyptian ministers on visits to Egypt over the last few months.
On Sisi’s arrival in Paris, the red carpet was rolled out by none other than Eric Trappier, the CEO of Dassault, manufacturer of the same Rafale aircraft that gave Sisi the guard of honor on his way to Paris, and welcomed the Egyptian president after his arrival on French soil. The enthusiastic businessman also congratulated Egyptian pilots for “their high quality performance,” and for training in “record time” to fly Rafale aircraft.
Sisi met with Parly the day he arrived at the Armed Forces’ headquarters, making reference to the “fruitful cooperation” between the two nations and adding that he eagerly anticipates the development of such collaboration in the future. In the meetings that followed, he reiterated this desire several times — to Hervé Guillou, CEO of the Naval group, to the head of the national railway company Guillaume Pepy, and to the French president himself.
Macron echoed Sisi’s desires for greater collaboration in a joint press conference: “Your presence here in Paris, by my side, is a testimony to the friendship you have for our country, and your busy program […] demonstrates the importance of your visit for France, and the very close cooperation that binds us.”
The two men have amassed an impressive portfolio of joint initiatives: Investment in Egypt’s new Suez Canal passageway, potential contracts for energy diversification, consultancy regarding improving Egypt’s railways, as well as academic and cultural ties.
The postcard is picture perfect. No one could dream of a better diplomatic relationship, right? But what is scribbled on the reverse of the enthusiastic smiles?
The verso of this glowing picture shows at least 60,000 political prisoners, proven cases of torture and sexual violence by Egyptian authorities and security forces, forced disappearances and extrajudicial executions. At least 434 websites have been blocked in Egypt, and the state is waging an ongoing crackdown on LGBTQ individuals, NGO workers, artists, atheists, researchers and journalists. Basically a blacked out square of human rights violations implemented by Sisi’s regime, with no French address to send complaints to.
“Emmanuel Macron should end now this era of indulgence towards Cairo,” Human Rights Watch stressed in a statement on the day of the presidential meeting. “Continuing to support Egypt’s repressive government would betray the country’s brave activists, who face grave risks trying to make their country better,” added HRW France’s director Bénédicte Jeannerod.
The relationship between the two countries in recent years has centered on military and security cooperation and counterterrorism, while France has turned a blind eye to Egypt’s worrying human rights record. Macron defended this position during Sisi’s visit, saying it is not his place to “lecture” Egypt on civil liberties. “I believe in the sovereignty of states and therefore. Just as I don’t accept being lectured on how to govern my country, I don’t lecture others […] My deeply held conviction is that it’s in President Sisi’s interests to address defense and human rights in a way that only he can be the judge of,” the French president said.
France rolls out the red carpet every single time Egypt asks for it, as for this most recent autumnal visit. The dust is, meanwhile, conveniently and repeatedly swept underneath.
Allies in fighting terrorism, however badly
After dropping historical ally President Hosni Mubarak and publically supporting Egypt’s January 25 revolution against authoritarian rule, France has again backed Egypt’s military establishment, in the form of Sisi and his generals.
The current French administration has a belief that it must support Egypt in regaining its traditional place as a regional power, says Agnes Levallois, consultant and vice-president of the Iremmo institute. This has been usurped by Saudi Arabia recently, she adds, so the feeling in France is, “Okay, Saudi Arabia plays its role, but it does not have the same cards as Egypt. It does not have the same experience. It does not have the same history to be able to take up this responsibility on its own. Therefore, we must help Egypt.”
This isn’t altruism. Western nations like France need a partner they can rely on in an unstable region, preferably with a strong leader at its head. Egypt shares 1,200 km of its borders with Libya, and is therefore on the front line to block waves of refugees and migrants attempting to enter Europe. Macron’s government, which has made Libya and the influx of refugees from its shores to Europe a major priority, is keen to support and utilize Egypt in this effort.
The motivation is domestic politics, says a French diplomat who spoke on condition of anonymity, adding that Macron spares no expense on Libya because he doesn’t want to be blamed for immigration by his people. The French president forgets, however, that Egyptians are also increasingly trying to leave via their own shores, as illustrated last year when a boat trying to leave from the coast of Rashid sank with a large number of Egyptian passengers. Many refugees coming from the Horn of Africa have also opted to make their journeys to Europe via Alexandria and other Egyptian port cities.
Another hope that France is pinning on bilateral ties with Egypt is that militant cells and individuals will be contained and not spread to Europe. But here too, France is short sighted in imagining such individuals would have to travel through Egypt, or even that the Egyptian regime is managing to influence or reduce their activity. Until recently, this threat was largely confined to Egypt’s North Sinai Peninsula, but militant attacks and operations by security forces have since spread to other areas of Sinai and into the heart of the Nile Valley, the Delta, Upper Egypt and the Western Desert, in its proximity to the Libyan border.
That Egypt is not as strong or stable as authorities would like their French counterparts to believe isn’t particularly an issue in choosing regional allies, as Paris doesn’t see another option, says Agnès Levallois. Supporting Arab leaders willing to fight the immediate threat of militant groups is a shortsighted strategy that France has always had, without consideration for the underlying political issues, she adds.
Commonly described as discreet, cautious and a hard worker, French Foreign Affairs Minister Jean-Yves Le Drian (former minister of defense under François Hollande) is the architect of this play-it-by-ear strategy, and despite the change in French leadership, he has forged ahead his agenda of “assertive political realism,” as described by his collaborators.
“We are employing a short-term strategy,” admit several French diplomats, who spoke on condition of anonymity. Short-term and tinged with cynicism. What we refer to as “realpolitik” in the jargon.
The crafty foreign affairs minister
The French minister of foreign affairs visited Egypt for the eighth time in June, officially to offer his condolences following an attack on a bus carrying Copts in Upper Egypt. Having just taken on his new role, Le Drian addressed a crowd of Egyptian journalists and media representatives on the 26th floor of the infamous Foreign Ministry building in Cairo. “It’s not a coincidence that I’m here again,” he said, ignoring hands waving in front of him with questions. Later on he visited with Coptic Pope Tawadros II and hailed the visit a “friendly gesture” towards his Egyptian counterpart. But purely friendly gestures never happen in diplomacy.
The visit was, of course, about more than was officially claimed. For Le Drian, the motivation for his trip was undoubtedly the situation in Libya, with which the minister has been concerned for many years. Sisi had ordered several missions in eastern Libya led by Rafale aircraft after the bus attack. “We cannot let terrorists and traffickers of any kind prosper on Egypt’s borders, at the gates of Europe,” Le Drian said during a press briefing. Libya plays an important role in the progress of peaceful solutions to which Egypt and France are very attached, he added.
Juicy defense contracts
Many stones have been placed carefully onto the tower of collaboration during these eight visits. Since 2014, Egypt has signed a US$1 billion deal with France for four warships and a $6 billion deal for 24 Rafale jet fighters. France has also sold weapons and military services to Egypt, including a $700 million military satellite, two Mistral helicopter carriers at $1 billion, originally built for sale to Russia, and rockets, firearms and ammunition amounting to almost $1 billion.
French policies regarding the export of arms are supposedly informed by rights-related regulations, including the December 2008 European Council Common Position that defines eight criteria for arms exports. This includes a requirement that EU countries “deny export licenses if there is a clear risk that the military technology or equipment exported might be used for internal repression,” or for “serious violations of international humanitarian law.” At least 13 EU countries are violating this requirement, including France, despite the EU Foreign Affairs Council urging members to suspend export licenses to Egypt in 2013 and 2014.
All military equipment exported by France has to be authorized by the prime minister. Such talks are classified and confidential, explains Aymeric Elluin, advocacy officer for weapons and international justice at Amnesty International.
“France doesn’t have any obligation to provide a public report on why certain exports were made or not,” he says, adding that Amnesty has one request: That the French government reveals what its reasons are for continuing to export military equipment and services to Egypt.
“It is time for French diplomats to stop playing VRP weapons manufacturers at the risk of seriously violating the provisions of the Treaty on the Arms Trade, ratified by Paris in 2013, and of international law more generally,” says Dimitris Christopoulos, director of FIDH. “If France is to maintain a ‘privileged’ relationship with Egypt, it can only continue in a climate of transparency, and any trade agreements must be conditional on a strict respect for human rights.”
Meanwhile, more stones are being added to the pile and Egypt’s shopping list is growing. Sisi raised the matter of acquiring 12 new Rafale aircraft, telecoms satellites and new Falcon aircraft during his latest trip to Paris.
“Amnesty International’s research has shown that armored vehicles exported by the US and France were used to facilitate extra judicial executions and the unlawful killing of protestors,” says Aymeric Elluin. The Egyptian military has also carried out a number of operations against armed groups in North Sinai with armored vehicles, tanks, Apache helicopters and F-16 aircrafts. HRW has published evidence showing that civilians are often victimized during such operations.
“President Macron should refuse to continue France’s disgraceful policies of indulgence toward Sisi’s repressive government,” Benedicte Jeannerod from HRW says.
France needs answers too, or does it?
The French obsession for “security everywhere” has had the effect of making Paris ignore its grievances with Egypt and its need for answers. The investigation into the crash of aircraft MS804 was stalled after a year and a half. Cairo tried to blackmail Paris into claiming the crash was the result of a terrorist attack, with no evidence to support such a claim. France even sent a number of diplomats to attend a tribute ceremony to the victims in Egypt, despite their families’ refusal to participate.
Also stalled with no resolution is an investigation into the death of French teacher Eric Lang, who died in an Egyptian police station in 2013, reportedly killed by his cellmates with encouragement from their jailers. Neither was there any official explanation for the death of Cécile Vannier in 2009 in a terrorist attack in Cairo, or for the deporting of a French journalist in spring 2016.
French authorities explain this lack of follow up through the current administration’s policy of not openly criticizing other nations for their human rights records, and maintaining that private diplomacy is more effective in solving such cases.
But, according to a French senior diplomat, who spoke on condition of anonymity, many senior French officials, including Macron, don’t really understand the Middle East, and those who do are not often heard. There have been small improvements recently, as members of the French delegation at least remembered who they had met in Egyptian rights organizations on their return from Cairo to Paris last time.
The policy is to satisfy French commercial interests, even if they contradict regional interests, and even though Egypt is on a financial drip from Gulf countries and pays on credit.
The two countries also prefer to exchange medals of honor on the sly. Le Drian was publicly recognized last February in Cairo for his contribution to an “unprecedented boom” in military cooperation, according to a statement from the Egyptian presidency. Sisi decorated him with “the order of the Republic of the first category.” In exchange, Le Drian awarded the Egyptian minister in charge of military production, Mohamed al-Asar, “Commander of the Legion of Honor” — the highest French distinction for his role in strengthening relations between France and Egypt. Asar is among a few ministers who has remained in government since the days of Mubarak. He has been accused of having a hand in the Maspero massacre in October 2011. Asar’s award is not listed in the registers of the Legion d’Honneur. When asked about this, an employee merely remarked that some medals exchanged between officials don’t appear publicly in the listings.
In recent years, France’s relationship with Egypt has been developed for the sake of fighting terrorism, preventing unwanted migrants from arriving on European coasts and agreeing arms deals. But does this relationship have any benefits besides contributing to the legitimation of a repressive power? Absolutely not, and many Egyptians are well aware of this. During Sisi’s French visit, Egyptians commented on social networks: “Shame on you France,” and the “France of Macron is an international disgrace.”
Success Stories in Nonviolence from Iraqi Youth
A youth panel on non-violence, organized by the Iraqi Social Forum and the Iraqi Civil Society Solidarity Initiative
Baghdad – October 2017
On 21 October, in a unique event in Baghdad, the Baghdad La-Onf group, which works closely with the Iraqi Social Forum to promote nonviolent principles and action, organized their first youth panel. The panel gave individuals the opportunity to share their own success stories in nonviolence and peace-building through art, sport and social networking. The event was held in Karrada, the heart of Baghdad, in celebration of the International Day of Nonviolence and the birth of the leader, Gandhi.

The talk show presented many different experiences from young people who engaged in nonviolent actions as a way to rebuild peace in Iraq. The show included theatrical and musical performances as well, and highlighted the way these young activists are working actively to change social reality through personal effort and cooperative volunteer work.
At the start of the show, Mahmood al-Hiti, an activist from the Shakoufyan Initiative active in Hit, presented his experience of peace-building as he and a team of volunteers worked to rehabilitate a number of schools in the city for the returnees after the liberation of Hit from Daesh.

Bara, part of the Sports Against Violence team in Iraq, presented her experience helping to organize a range of sports activities, and explained the positive impact of those activities on both members of the team and on the broader community.
Salman Khairallah described his work with the team, Humat Dijlah, and their efforts to protect the Tigris River. He stressed the importance of preserving the environment and protecting bodies of water for these are elements that contribute directly to the stability of the community. A flourishing natural environment contributes to peace-building, and builds solidarity among the residents of those cities through which the Tigris and Euphrates rivers flow.
Rawan, the youngest participant in the talk show, shared her experiences of volunteer work with her father in the city of Babylon. Together they put a smiles on the faces of children, showing them how to change their lives for the better by giving them greater opportunities for their futures. More specifically, with a volunteer team, Rawan helps displaced children and fights for children’s rights, and led more than 200 children in a demonstration calling for the right of Iraqi children to live decent lives. The volunteers have also organized campaigns promoting music and reading. Rawan is also working on a humanitarian project to help 150 displaced children in her hometown who fled from Daesh. In the future, she hopes to establish a children’s parliament to ensure children’s voices are heard.
The Mashofna team from Nasiriyah put on a theatrical performance about the protection of migratory birds and aquatic life in the marshes of Iraq, in which they warned of the dangers of overfishing, and raised awareness about the need to preserve biological diversity within the marshes.

Fatima and Hassan shared their beautiful story about their volunteer team called ‘Baghdad City of Peace’. Every year, this team organizes a special festival to celebrate International Peace Day in Baghdad. They spoke of their efforts to spread word of their festival through social networking sites, in hopes of reaching other volunteers in governorates beyond Baghdad who might put on festivals as well. And in fact, many youth teams in the other Iraqi cities were able to organize festivals that promoted beauty and art, thus helping to change the image of Iraq as a country of war and destruction.
Ahmed Abdul Salam, member of HHU, a rap group from the city of Hit, shared his experience of positive rap, and how his band was launched from the Upper Euphrates. He spoke of the prospects for the development of this art within the youth community.

The talented musician Hussein Samah from Diyala city shared his experience of how he managed to transcend the image of blood and destruction with his dear friend, the Piano, and talked about his dreams and his message to re-present sophisticated music and singing to the younger generation.
The show ended with a performance of a rap song by Ahmed from HHU band, as well as the number of beautiful songs that dazzled the audience by Hussein Samah, ending with Ali Taqi, who presented “beat box” show with the rapper Ahmad.
The Baghdad Nonviolence Team presented this event within the space of the Iraqi Social Forum, in collaboration with Sawtona Organization, Information Center for Research and Development, the Italian Organization Un Ponte Per… and the Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, as part of a project funded by the Swiss FAI Foundation. The aim was to disseminate experiences and success stories of youth groups that contribute to the spread of nonviolence and promote peace, igniting youth energy that looks to the future with optimism and believes that ‘Another Iraq is Possible’.
Egypt court orders ban of ‘anti-Islam’ TV broadcast
Language
Undefined
Grand imam demands ban of ‘With Islam,’ presented by controversial intellectual reformer Islam Behairy
Yemen UAE-backed force takes Al-Qaeda stronghold
Language
Undefined
Truck driven by suicide bomber explodes when elite forces enter Mahfad, killing one soldier, wounding five
L’Arabie saoudite accorde la citoyenneté à un robot

Lors du forum économique Future Investment Initiative qui s’est déroulé à Riyad du 24 au 26 octobre, l’Arabie saoudite a accordé la citoyenneté à un robot. Une première dans le monde, qui n’est pas sans provoquer une certaine polémique.
Syrie/Irak: des armes chimiques trouvées sur une zone contrôlée par le groupe EI
La coalition internationale dirigée par les États-Unis a découvert et détruit des armes chimiques utilisées par le groupe terroriste Etat islamique sur le territoire de la Syrie et de l’Irak, a déclaré le porte-parole de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.
Yémen: l’ONU «choquée» par la situation humanitaire dans le pays

En visite au Yémen, Mark Lowcock, responsable de l’aide humanitaire aux Nations unies, dénonce une situation alarmante dans le pays. C’était la première visite de ce haut responsable de l’ONU, en poste depuis seulement deux mois, dans cet Etat ravagé par la guerre.
Egypte: Sissi remanie la tête de l’appareil sécuritaire

En Egypte, le chef d’état-major des armées ainsi que le chef de la direction de la sécurité nationale ont été remplacés samedi 28 octobre à l’issue d’une réunion du président Abdel Fattah al-Sissi avec les ministres de la Défense et de l’Intérieur ainsi que des chefs des services de renseignement. Des changements liés à l’embuscade tendue par des jihadistes et qui avait officiellement coûté la vie à 16 policiers dans les oasis vendredi 20 octobre.
Irak: vers un accord entre Bagdad et Erbil

A l’issue de la trêve de 24h accordée par le Premier ministre irakien aux forces kurdes, des représentants des deux forces ont affirmé avoir fait un pas en avant vers un accord définitif entre le gouvernement national et le gouvernement de la région indépendantiste.
Ius soli birmano
 Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
La maggior parte delle volte le storie di confine sono drammatiche. Dove un cartografo disegna una frontiera, approfittando di un fiume, di una catena montuosa o semplicemente tracciando una linea retta su un territorio che la mappa geografica rende asettico, vivono persone e animali e si dipana la storia infinita della biodiversità. La geopolitica tiene poco in conto le persone (gli animali e la biodiversità) ed è semmai attenta alla proprietà (se è in mano a uomini potenti) o ai prodotti della terra, siano essi agricoli o fossili. Le vicende che in questi giorni hanno a che vedere con la fuga dal Myanmar verso il Bangladesh di 500mila rohingya, una minoranza musulmana che vive (o meglio viveva) nello Stato birmano del Rakhine, hanno molto a che vedere con la storia di un confine – quello tra il mondo birmano e quello bengalese – che nei secoli si è spostato, cambiando di mano e di segno in seguito a guerre, dispute, cambi della guardia al vertice dei poteri che, di volta in volta, hanno comandato su questi territori.
Tutti conoscono la storia di violenze che i rohingya subiscono dal 2012, quando il primo pogrom recente (la persecuzione ha radici antiche) ha prodotto oltre centomila sfollati interni. Allora pareva soprattutto una vicenda di intolleranza religiosa alimentata da gruppi identitari buddisti che vedevano nei rohingya, considerati non birmani e immigrati bengalesi per di più musulmani, un pericolo per l’integrità di un Paese che è stato la culla del buddismo. Nel 2016 una nuova ondata di violenze si doveva nuovamente abbattere su quel milione di rohingya ancora in possesso di una casa e un campo da coltivare o una capra da mungere. L’attacco di un gruppo secessionista ad alcuni posti di frontiera scatena una reazione che produce allora un esodo di circa 80mila persone verso il Bangladesh. Passato qualche mese, nell’agosto di quest’anno, in seguito a un altro attacco dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), una nuova spropositata reazione dell’esercito (sono parole dell’Onu che non ha esitato a utilizzare anche la locuzione “pulizia etnica”) ha invece prodotto un nuovo massiccio esodo di circa mezzo milione di profughi. A far le somme, e considerato che ormai la diaspora di questa comunità conta nel mondo quasi due milioni di persone, non solo la maggioranza dei rohingya risiede ormai all’estero (oltre un milione nel solo Bangladesh) ma i numeri di questa popolazione nel Myanmar sono ormai così ridotti che la scomparsa dei rohingya dai territori birmani è ormai forse solo questione di qualche anno. Forse di mesi.
Cosa c’entrano in tutto ciò le frontiere e la loro eredità?
 |
| Il Rakhine oggi, area birmana. Cosa è stato nei secoli? |
Dobbiamo fare un passo indietro. Fino al 1700 l’Arakan, l’attuale Stato birmano del Rakhine, era un regno indipendente che alla fine di quel secolo doveva finire sotto i monarchi birmani. I birmani però volevano espandersi sempre più a Ovest ed entrarono in conflitto con le mire di Calcutta, la capitale della British India, che voleva invece allargarsi sempre più a Est. Sono però i birmani a perdere e nel 1824 – in seguito al trattato di Yandabo che conclude la prima guerra anglo-birmana – l’Arakan e altri territori sotto influenza birmana passano sotto l’India britannica. I rohingya, chissà da quanto tempo nell’Arakan, si ritrovano dunque, dall’essere stati sudditi di un regno indipendente prima e delle monarchie birmane poi, a diventare vassalli di Sua Maestà britannica, o meglio dell’amministrazione coloniale della Regina in India. Nei primi mesi del 1886 l’intera Birmania diventa una provincia dell’India britannica e nel 1887 diventa sede di un vice governatorato che solo nel 1937 passa direttamente a un’amministrazione separata, sotto la direzione del Burma Office di Londra (segretariato di Stato per l’India e la Birmania). Dunque i rohingya sono adesso sudditi britannici sotto un’altra formula e lo saranno sino al 1948 quando la Birmania, come la chiamavamo allora, diventerà indipendente. C’è anche da notare che, seppur brevemente, i rohingya, come i birmani, sono stati anche sudditi dell’Imperatore Hirohito – dal 1942 al 1945 – quando le forze nipponiche dell’Asse avevano invaso la Birmania per “liberarla” dal giogo coloniale britannico con la parola d’ordine “L’Asia agli asiatici”. In poche parole, più che essere i rohingya a spostarsi (cosa sicuramente avvenuta in passato nel corso di quel flusso migratorio universale che ha interessato e interessa tutti i popoli del mondo che si muovono per i più svariati motivi), sono stati i confini a tendersi o contrarsi come un elastico. La sola colpa dei rohingya, vine da dire, è quella di essere sempre stata una minoranza debole, non in grado di far sentire la propria voce.
Ora, le legge sulla cittadinanza del Myanmar, varata durante la dittatura militare nel 1982, riconosce tre categorie di cittadini: cittadini propriamente detti, associati o naturalizzati. Ma i rohingya non sono riconosciuti in nessuna delle categorie. La legge dice che, come recita la Costituzione del 1947, è cittadino birmano chi ha radici in una “razza indigena” o viveva nella “British Burma” prima del 1942, ossia prima dell’arrivo dei giapponesi. A quell’epoca chi abitava nell’Arakan era già da tempo sotto dominio britannico: un dominio strappato ai birmani e ancor prima a un regno indipendente aracanese. Autoctoni o meno dell’Arakan-Rakhine, nel 1942 la presenza dei rohingya nel Rakhine – che questi ultimi chiamano Rohang – datava probabilmente da secoli. E comunque, al di là delle polemiche sul termine “rohingya” che alcuni storici birmani dicono sia apparso solo negli anni Cinquanta del XX secolo, nel 1942 erano stati già stati sudditi britannici ben due volte: in un primo tempo sotto Calcutta (e dal 1911 Delhi) e in seguito direttamente sotto l’Ufficio Birmania a Londra. Benché sia certo che durante la dominazione britannica molte popolazioni, tra cui i bengalesi, si siano mosse all’interno dell’Impero, cosa è successo prima e durante gli inglesi? Non è difficile immaginare che nei secoli vi sia stata una sorta di osmosi tra le pianure e le colline del Bengala e le limitrofe aree birmane. E se è difficile determinare quando il primo rohingya sia nato e dove, si perde nella notte dei tempi la loro presenza (e quella più in generale musulmana) in un’area che un tempo confini non ne aveva affatto: tutt’al più fiumi, mari, colline o catene montuose. Barriere naturali geografiche che la Storia deve aver visto attraversare più volte, in questa o quella direzione: dal cacciatore nomade al pescatore, dal pastore transumante allo stesso agricoltore sedentario in cerca di luoghi dove eleggere domicilio.
Questa legge è dunque una cattiva legge – imperfetta, astorica, obsoleta e ingiusta – e andrebbe
 |
| Terrore buddista. Un’analisi sufficente? |
riformata anche perché originariamente i rohingya avevano assai più diritti: potevano votare e candidarsi. Al netto delle colpe del governo civile birmano non si può dimenticare che proprio nei giorni del pogrom di fine agosto, l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, incaricato da Aung San Suu Kyi, lo abbia detto a chiare lettere alla conclusione di un’inchiesta svolta proprio per affrontare la questione rohingya, un nome che in Bangladesh non si può nemmeno menzionare. Ma i militari, autori delle peggiori leggi del Paese, non solo non vogliono riconoscere il lavoro di Annan, che hanno definito “fazioso” e dunque falso, ma hanno spinto i partiti d’opposizione al governo di Suu Kyi, nato dalle elezioni del 2015 (con la vittoria della Lega nazionale per la democrazia), a una campagna contro il dossier Annan che ha tutta l’aria di una minaccia. La minaccia è che, se Suu Kyi, il suo partito e il suo governo dovessero tirare troppo la corda, i militari potrebbero ricorrere a un altro articolo della Costituzione, emendata dai generali nel 2008, che prevede (oltre a una quota a loro riservata in parlamento di un quarto dei seggi) che l’esercito possa ribaltare il governo in carica nel momento in cui esiste un pericolo reale per la stabilità del Paese. Il richiamo dell’opposizione a un dossier definito un’operazione che favorisce le forze straniere che minacciano il Myanmar non è, in altre parole, che la proiezione sulla situazione attuale dell’ombra di questo emendamento. Che garantisce un golpe costituzionale, dunque legittimo. Se finora non si è verificato è solo perché i militari controllano tre dicasteri chiave: Interno, Difesa, Frontiere.
 |
| Aung San Suu Kyi: immagine tratta da BigThink |
E’ questo il motivo per cui una paladina dei diritti umani e Nobel per la pace come Aung San Suu Kyi, e così i vertici del suo partito, sta tanto attenta a come parla (non li chiama rohingya ma semplicemente musulmani) e a cosa fa (oltre alla commissione Annan ne ha nominate altre ma con limitatissimo potere) a costo di attirarsi le ire del mondo intero. I militari vegliano sul Paese e, nel consesso internazionale, ci pensa Pechino – e in parte Mosca – a frenare eventuali prese di posizione del Consiglio di sicurezza (che finora ha adoperato un gergo assolutamente debole). Infine c’è l’India, non più britannica ma retta da un campione anti musulmano come Narendra Modi. Che, non solo ritiene al pari di Pechino il Myanmar un partner strategico ma che vorrebbe espellere tutti i rohingya immigrati in India (circa 40mila).
C’è un’ultima domanda ancora senza risposta. Perché? Basta una legge restrittiva? Una sorta di suprematismo buddista? Forme di xenofobia etnica e religiosa? C’è altro e ci sono altre leggi su cui merita soffermarsi. Le immagini satellitari diffuse recentemente da Human Rights Watch e da Amnesty International su vaste aree incendiate nella zona rohingya dello Stato del Rakhine riportano alla memoria fotogrammi più antichi come quelli con cui Hrw aveva stimato, nell’autunno scorso, ad almeno 1500 gli edifici dei rohingya dati alle fiamme. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto, ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, unità amministrative dello Stato del Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya o quel che ne rimane.
Quei fotogrammi, ieri come oggi, rendono più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma anche con l’ipotesi che, dietro alla cacciata di persone senza cittadinanza, ci sia anche un piano per accaparrarsi la loro terra. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione di terre considerate mal sfruttate per affidarle a grosse compagnie private al fine di metterle a profitto. E’ quello che – in altri termini – si scrive “sviluppo” ma si legge “land grabbing” a beneficio di società con grandi mezzi. Dal 2012 un nuovo pacchetto legislativo ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari e che ora possono anche aprirsi al capitale estero sempre affamato di terra. E’ un vero assalto sia alla foresta, che ogni anno perde 400mila ettari, e a piccoli appezzamenti di terreno o ad aree di utilizzo consuetudinario. Col vantaggio che questa legge ne ha anche abolita un’altra del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya il passaggio di mano conterebbe ora oltre un milione e duecentomila ettari con un balzo rilevante rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012. Se si mettono assieme le due cose, l’aspetto razzista e islamofobico passa in secondo piano e sembra semmai una concausa benché con radici antiche che risalgono al periodo coloniale e forse anche a prima.
E’ una lettura naturalmente ma non priva di suggestione anche se, in settembre, le tesi della Sassen,
 |
| Saskia Sassen |
riprese anche da un gruppo di ricercatori (Forino, von Meding, Johnson) sulla rivista britannica The Conversation, sono state duramente criticate sul sito NewMandala – e tacciate di “marxismo volgare” – da Lee Jones, un noto esperto di cose birmane (su land grabbing e legislazione birmana si può comunque vedere il sito https://library.ecc-platform.org). Ciò che per altro merita una riflessione è il fatto che chi se ne va perde ogni diritto, persino quello della consuetudine. E se non ha cittadinanza e passaporto non avrà mai più, ammesso che possa tornare nel Myanmar, un documento valido per reclamare la sua terra e la sua casa. Qualcuno, non casualmente, l’ha definita una politica della “terra bruciata”. Bruciata oggi perché domani cambi di padrone. Una storia di frontiere e confini. A danno di uomini, animali, biodiversità.
* Con cui sono onorato di collaborare
Quale sarà il piano di Tillerson contro la famiglia Assad?
Il ministro degli Esteri americano ha annunciato che la fine degli Assad è vicina. Dovremmo davvero credere alle sue parole?
L’articolo Quale sarà il piano di Tillerson contro la famiglia Assad? sembra essere il primo su Arabpress.
Essere un editore e libraio in Libia, oggi
Essere un editore e un libraio in Libia non è affatto semplice ora. Né, a dirla tutta, lo è stato negli ultimi 60 anni. A raccontarlo sul numero di autunno di Index on Censorship (l’articolo, a firma di Charlotte Bialey, è stato ripreso da Literary Hub) è Ghassan Fergiani, erede di una famiglia di librai […]![]()
Israele: una clinica legale per far progredire il diritto internazionale nelle zone in conflitto
La giustizia transizionale è il futuro del diritto durante i conflitti? Intervista a Yaël Vias Gvirsman, della Clinica Legale per il Diritto Penale e Umanitorio.
Diario americano – 1 – San Francisco
Sì, veramente incredibile, la Davies Hall. È la sala della San Francisco Symphony, poco meno di duemila posti, difficile da descrivere per l’ampiezza dello spazio e per la bellezza dell’acustica. Ieri l’orchestra della SFS suonava Sibelius e Sciostachovic, diretta con maestria da Osmo Vänskä, conduttore finlandese con una capacità rara di unire in un abbraccioContinua a leggere
Lo spettacolo del dolore
 A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).
A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).
Qui accanto vedete una delle immagini del servizio, forse la più gettonata (che mi fa piacere Internazionale non abbia scelto per la copertina). Vogliamo provare a commentarla? Immaginate di non sapere di cosa si parla: c’è l’acqua, una madre che indica l’infinito o la speranza, un padre col bimbo e una croce sullo sfondo. Un amico, cui l’ho mostrata decontestualizzata, mi ha detto “E’ un battesimo!” E’ rimasto male sapendo di chi si tratta: gente in fuga da omicidi, stupri, incendi… La foto in sé può piacere o non piacere (la scelta della luce, il bianco e nero, i ritocchi, il taglio etc) ma una foto difficilmente è “in sé”. C’è sempre un contesto a maggior ragione se si tratta di un reportage. Ma come lo si comunica?
Mario Dondero (il mio grande maestro che sulla fotografia mi ha insegnato tutto) è noto per aver (anche) detto che “fotografare la guerra a colori è immorale”. Kevin segue il suo consiglio perché, anche se non dichiarata, quella fatta ai rohingya è proprio una guerra. Ma tra lui e Mario c’è una differenza enorme. In questo reportage di Frayer c’è il dolore, il dramma, la speranza ma raffigurati come in una sorta di grande affresco in cui è più il fotografo a essere il protagonista che non i suoi soggetti. Di Mario Dondero si è detto che era un fotografo “senza uno stile”. E’ vero, perché il “suo stile” era quello di non apparire. Se guardate le sue foto sulla guerra, vi soffermate sempre sui soggetti non sulla bravura del fotografo. Nei suoi fotogrammi il fotografo proprio non c’è. Come se il fotoreporter fosse solo passato di li e avesse fatto…clic. Nella foto di Frayer c’è prima di tutto Frayer e poi, magari, anche i suoi soggetti. La sua presenza però, la presenza dell’autore, finisce col distrarvi: restate colpiti dalla sua bravura nel catturare le luci, dalla capacità di “scolpire” i volti, dalla forza delle espressioni come se lui avesse messo tutti in posa. Venite colpiti dallo spettacolo. Se poi è uno spettacolo del dolore (e non un battesimo), il dolore arriva dopo. Prima c’è lo spettacolo. Direi che questa è proprio una foto spettacolare. Tanto spettacolare che dolore, guerra, incendi e stupri restano sulla sfondo. Come quella croce che evidentemente non è una croce visto che siamo in territori del Budda o di Maometto.
 Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.
Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.
Insomma dopo tutta questa tirata e questa professione di modestia (chissà se poi io predico bene ma razzolo altrettanto) vorrei proporvi la foto qui sotto tratta dal bangladese Daily Star. Nella sua semplicità mi dice (guardate i piedi di questa ragazzina) più che abbastanza sul dramma di questa gente e mi commuove (dunque mi spinge a saperne di più). Non c’è compiacimento e nemmeno spettacolo. Anzi, apparentemente non c’è neppure dolore (anche se quei piedini nudi e segnati raccontano tutto). Il fotografo questa volta è talmente in disparte che, tanto per cambiare, non c’è neanche il credito della foto. Chi l’ha scattata è ingiustamente anonimo: è purtroppo il solito discorso per cui la maggior parte delle foto servono solo a occupare uno spazio in pagina. Il loro modesto autore scompare – come in questo caso – più di quanto avrebbe dovuto.
* Ecco a proposito a questo link fb uno dei rarissimi filmati sui Rohingya, realizzato a A. Ricucci e S. Bianchi per Tv7 (provate a scommettere a che ora è andato in onda…)
Ius soli birmano
 Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*
La maggior parte delle volte le storie di confine sono drammatiche. Dove un cartografo disegna una frontiera, approfittando di un fiume, di una catena montuosa o semplicemente tracciando una linea retta su un territorio che la mappa geografica rende asettico, vivono persone e animali e si dipana la storia infinita della biodiversità. La geopolitica tiene poco in conto le persone (gli animali e la biodiversità) ed è semmai attenta alla proprietà (se è in mano a uomini potenti) o ai prodotti della terra, siano essi agricoli o fossili. Le vicende che in questi giorni hanno a che vedere con la fuga dal Myanmar verso il Bangladesh di 500mila rohingya, una minoranza musulmana che vive (o meglio viveva) nello Stato birmano del Rakhine, hanno molto a che vedere con la storia di un confine – quello tra il mondo birmano e quello bengalese – che nei secoli si è spostato, cambiando di mano e di segno in seguito a guerre, dispute, cambi della guardia al vertice dei poteri che, di volta in volta, hanno comandato su questi territori.
Tutti conoscono la storia di violenze che i rohingya subiscono dal 2012, quando il primo pogrom recente (la persecuzione ha radici antiche) ha prodotto oltre centomila sfollati interni. Allora pareva soprattutto una vicenda di intolleranza religiosa alimentata da gruppi identitari buddisti che vedevano nei rohingya, considerati non birmani e immigrati bengalesi per di più musulmani, un pericolo per l’integrità di un Paese che è stato la culla del buddismo. Nel 2016 una nuova ondata di violenze si doveva nuovamente abbattere su quel milione di rohingya ancora in possesso di una casa e un campo da coltivare o una capra da mungere. L’attacco di un gruppo secessionista ad alcuni posti di frontiera scatena una reazione che produce allora un esodo di circa 80mila persone verso il Bangladesh. Passato qualche mese, nell’agosto di quest’anno, in seguito a un altro attacco dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), una nuova spropositata reazione dell’esercito (sono parole dell’Onu che non ha esitato a utilizzare anche la locuzione “pulizia etnica”) ha invece prodotto un nuovo massiccio esodo di circa mezzo milione di profughi. A far le somme, e considerato che ormai la diaspora di questa comunità conta nel mondo quasi due milioni di persone, non solo la maggioranza dei rohingya risiede ormai all’estero (oltre un milione nel solo Bangladesh) ma i numeri di questa popolazione nel Myanmar sono ormai così ridotti che la scomparsa dei rohingya dai territori birmani è ormai forse solo questione di qualche anno. Forse di mesi.
Cosa c’entrano in tutto ciò le frontiere e la loro eredità?
 |
| Il Rakhine oggi, area birmana. Cosa è stato nei secoli? |
Dobbiamo fare un passo indietro. Fino al 1700 l’Arakan, l’attuale Stato birmano del Rakhine, era un regno indipendente che alla fine di quel secolo doveva finire sotto i monarchi birmani. I birmani però volevano espandersi sempre più a Ovest ed entrarono in conflitto con le mire di Calcutta, la capitale della British India, che voleva invece allargarsi sempre più a Est. Sono però i birmani a perdere e nel 1824 – in seguito al trattato di Yandabo che conclude la prima guerra anglo-birmana – l’Arakan e altri territori sotto influenza birmana passano sotto l’India britannica. I rohingya, chissà da quanto tempo nell’Arakan, si ritrovano dunque, dall’essere stati sudditi di un regno indipendente prima e delle monarchie birmane poi, a diventare vassalli di Sua Maestà britannica, o meglio dell’amministrazione coloniale della Regina in India. Nei primi mesi del 1886 l’intera Birmania diventa una provincia dell’India britannica e nel 1887 diventa sede di un vice governatorato che solo nel 1937 passa direttamente a un’amministrazione separata, sotto la direzione del Burma Office di Londra (segretariato di Stato per l’India e la Birmania). Dunque i rohingya sono adesso sudditi britannici sotto un’altra formula e lo saranno sino al 1948 quando la Birmania, come la chiamavamo allora, diventerà indipendente. C’è anche da notare che, seppur brevemente, i rohingya, come i birmani, sono stati anche sudditi dell’Imperatore Hirohito – dal 1942 al 1945 – quando le forze nipponiche dell’Asse avevano invaso la Birmania per “liberarla” dal giogo coloniale britannico con la parola d’ordine “L’Asia agli asiatici”. In poche parole, più che essere i rohingya a spostarsi (cosa sicuramente avvenuta in passato nel corso di quel flusso migratorio universale che ha interessato e interessa tutti i popoli del mondo che si muovono per i più svariati motivi), sono stati i confini a tendersi o contrarsi come un elastico. La sola colpa dei rohingya, vine da dire, è quella di essere sempre stata una minoranza debole, non in grado di far sentire la propria voce.
Ora, le legge sulla cittadinanza del Myanmar, varata durante la dittatura militare nel 1982, riconosce tre categorie di cittadini: cittadini propriamente detti, associati o naturalizzati. Ma i rohingya non sono riconosciuti in nessuna delle categorie. La legge dice che, come recita la Costituzione del 1947, è cittadino birmano chi ha radici in una “razza indigena” o viveva nella “British Burma” prima del 1942, ossia prima dell’arrivo dei giapponesi. A quell’epoca chi abitava nell’Arakan era già da tempo sotto dominio britannico: un dominio strappato ai birmani e ancor prima a un regno indipendente aracanese. Autoctoni o meno dell’Arakan-Rakhine, nel 1942 la presenza dei rohingya nel Rakhine – che questi ultimi chiamano Rohang – datava probabilmente da secoli. E comunque, al di là delle polemiche sul termine “rohingya” che alcuni storici birmani dicono sia apparso solo negli anni Cinquanta del XX secolo, nel 1942 erano stati già stati sudditi britannici ben due volte: in un primo tempo sotto Calcutta (e dal 1911 Delhi) e in seguito direttamente sotto l’Ufficio Birmania a Londra. Benché sia certo che durante la dominazione britannica molte popolazioni, tra cui i bengalesi, si siano mosse all’interno dell’Impero, cosa è successo prima e durante gli inglesi? Non è difficile immaginare che nei secoli vi sia stata una sorta di osmosi tra le pianure e le colline del Bengala e le limitrofe aree birmane. E se è difficile determinare quando il primo rohingya sia nato e dove, si perde nella notte dei tempi la loro presenza (e quella più in generale musulmana) in un’area che un tempo confini non ne aveva affatto: tutt’al più fiumi, mari, colline o catene montuose. Barriere naturali geografiche che la Storia deve aver visto attraversare più volte, in questa o quella direzione: dal cacciatore nomade al pescatore, dal pastore transumante allo stesso agricoltore sedentario in cerca di luoghi dove eleggere domicilio.
Questa legge è dunque una cattiva legge – imperfetta, astorica, obsoleta e ingiusta – e andrebbe
 |
| Terrore buddista. Un’analisi sufficente? |
riformata anche perché originariamente i rohingya avevano assai più diritti: potevano votare e candidarsi. Al netto delle colpe del governo civile birmano non si può dimenticare che proprio nei giorni del pogrom di fine agosto, l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, incaricato da Aung San Suu Kyi, lo abbia detto a chiare lettere alla conclusione di un’inchiesta svolta proprio per affrontare la questione rohingya, un nome che in Bangladesh non si può nemmeno menzionare. Ma i militari, autori delle peggiori leggi del Paese, non solo non vogliono riconoscere il lavoro di Annan, che hanno definito “fazioso” e dunque falso, ma hanno spinto i partiti d’opposizione al governo di Suu Kyi, nato dalle elezioni del 2015 (con la vittoria della Lega nazionale per la democrazia), a una campagna contro il dossier Annan che ha tutta l’aria di una minaccia. La minaccia è che, se Suu Kyi, il suo partito e il suo governo dovessero tirare troppo la corda, i militari potrebbero ricorrere a un altro articolo della Costituzione, emendata dai generali nel 2008, che prevede (oltre a una quota a loro riservata in parlamento di un quarto dei seggi) che l’esercito possa ribaltare il governo in carica nel momento in cui esiste un pericolo reale per la stabilità del Paese. Il richiamo dell’opposizione a un dossier definito un’operazione che favorisce le forze straniere che minacciano il Myanmar non è, in altre parole, che la proiezione sulla situazione attuale dell’ombra di questo emendamento. Che garantisce un golpe costituzionale, dunque legittimo. Se finora non si è verificato è solo perché i militari controllano tre dicasteri chiave: Interno, Difesa, Frontiere.
 |
| Aung San Suu Kyi: immagine tratta da BigThink |
E’ questo il motivo per cui una paladina dei diritti umani e Nobel per la pace come Aung San Suu Kyi, e così i vertici del suo partito, sta tanto attenta a come parla (non li chiama rohingya ma semplicemente musulmani) e a cosa fa (oltre alla commissione Annan ne ha nominate altre ma con limitatissimo potere) a costo di attirarsi le ire del mondo intero. I militari vegliano sul Paese e, nel consesso internazionale, ci pensa Pechino – e in parte Mosca – a frenare eventuali prese di posizione del Consiglio di sicurezza (che finora ha adoperato un gergo assolutamente debole). Infine c’è l’India, non più britannica ma retta da un campione anti musulmano come Narendra Modi. Che, non solo ritiene al pari di Pechino il Myanmar un partner strategico ma che vorrebbe espellere tutti i rohingya immigrati in India (circa 40mila).
C’è un’ultima domanda ancora senza risposta. Perché? Basta una legge restrittiva? Una sorta di suprematismo buddista? Forme di xenofobia etnica e religiosa? C’è altro e ci sono altre leggi su cui merita soffermarsi. Le immagini satellitari diffuse recentemente da Human Rights Watch e da Amnesty International su vaste aree incendiate nella zona rohingya dello Stato del Rakhine riportano alla memoria fotogrammi più antichi come quelli con cui Hrw aveva stimato, nell’autunno scorso, ad almeno 1500 gli edifici dei rohingya dati alle fiamme. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto, ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, unità amministrative dello Stato del Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya o quel che ne rimane.
Quei fotogrammi, ieri come oggi, rendono più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma anche con l’ipotesi che, dietro alla cacciata di persone senza cittadinanza, ci sia anche un piano per accaparrarsi la loro terra. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione di terre considerate mal sfruttate per affidarle a grosse compagnie private al fine di metterle a profitto. E’ quello che – in altri termini – si scrive “sviluppo” ma si legge “land grabbing” a beneficio di società con grandi mezzi. Dal 2012 un nuovo pacchetto legislativo ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari e che ora possono anche aprirsi al capitale estero sempre affamato di terra. E’ un vero assalto sia alla foresta, che ogni anno perde 400mila ettari, e a piccoli appezzamenti di terreno o ad aree di utilizzo consuetudinario. Col vantaggio che questa legge ne ha anche abolita un’altra del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya il passaggio di mano conterebbe ora oltre un milione e duecentomila ettari con un balzo rilevante rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012. Se si mettono assieme le due cose, l’aspetto razzista e islamofobico passa in secondo piano e sembra semmai una concausa benché con radici antiche che risalgono al periodo coloniale e forse anche a prima.
E’ una lettura naturalmente ma non priva di suggestione anche se, in settembre, le tesi della Sassen,
 |
| Saskia Sassen |
riprese anche da un gruppo di ricercatori (Forino, von Meding, Johnson) sulla rivista britannica The Conversation, sono state duramente criticate sul sito NewMandala – e tacciate di “marxismo volgare” – da Lee Jones, un noto esperto di cose birmane (su land grabbing e legislazione birmana si può comunque vedere il sito https://library.ecc-platform.org). Ciò che per altro merita una riflessione è il fatto che chi se ne va perde ogni diritto, persino quello della consuetudine. E se non ha cittadinanza e passaporto non avrà mai più, ammesso che possa tornare nel Myanmar, un documento valido per reclamare la sua terra e la sua casa. Qualcuno, non casualmente, l’ha definita una politica della “terra bruciata”. Bruciata oggi perché domani cambi di padrone. Una storia di frontiere e confini. A danno di uomini, animali, biodiversità.
* Con cui sono onorato di collaborare
Will Lebanon Follow in Jordan’s Footsteps and Deport Syrian Refugees?
Earlier this month, Human Rights Watch (HRW) published a report detailing the manner in which Syrian refugees were being summarily deported back to their war-torn country. According to the report: [Jordanian] authorities have been deporting refugees—including the collective expulsion of large families—without giving them a meaningful chance to challenge their removal and failing to consider […]
The post Will Lebanon Follow in Jordan’s Footsteps and Deport Syrian Refugees? appeared first on Muftah.
Netizen Report: sarà mai fatta giustizia per gli attivisti egiziani detenuti?
Il Netizen Report di Global Voices Advocacy offre uno spaccato internazionale sulle sfide, vittorie e tendenze emergenti nei diritti di internet a livello mondiale.
È arrivato il turno dell’Iran?
All’indomani della fine della battaglia di Raqqa, l’America distoglie lo sguardo dalla guerra contro Daesh e rivolge la sua attenzione a un’altra sfida mediorientale: l’Iran
L’articolo È arrivato il turno dell’Iran? sembra essere il primo su Arabpress.
Continua il ciclo di violenza e controviolenza in Egitto
L’opinione di Khalil al-Anani sulla più sanguinosa e violenta operazione contro le forze di polizia egiziane dopo il colpo di stato del 3 luglio 2013.
L’articolo Continua il ciclo di violenza e controviolenza in Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
Il turista nudo al Salone dell’editoria sociale
“Istanbul. Immagine e memoria della Città ottomana” di Gabriele Morrione
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Istanbul. Immagine e memoria della Città ottomana” di Gabriele Morrione sembra essere il primo su Arabpress.
In Iran, i siti di musica in streaming Spotify e Soundcloud sono tornati online
I servizi di musica in streamin Spotify e Soundcloud sono tornati di nuovo accessibili agli utenti iraniani.
Viaggio all’Eden a Perugia venerdi 27 ottobre
VIAGGIO ALL’EDEN
Venerdì 27 ottobre 2017
alle ore 18:30
Biblioteca San Matteo degli Armeni
Via Monteripido, 2 – Perugia
Introduzione di
Emmanuel di Tommaso
Ne discute con l’autore
Floriana Lenti
“Mogador”: una mostra italiana in Marocco
Essaouira è il luogo della creazione e del dialogo tra due artisti italiani: Veronica Gaido e Vito Tongiani
Dal 26 ottobre al 26 novembre 2017
L’articolo “Mogador”: una mostra italiana in Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Luce verde ai raid segreti della Cia in Afghanistan
 |
| Mike Pompeo: muscolare come Trump |
Il viaggio lampo del segretario di Stato americano Rex Tillerson, che dopo Irak e Afghanistan è arrivato ieri in Pakistan per visitare poi Nuova Delhi, è la prima vera offensiva diplomatica in casa dell’amico-nemico. L’amico nemico è il Pakistan verso cui Tillerson – assai più morbido a Islamabad – ha avuto parole durissime durante i suoi colloqui afgani. Accusati di essere la sentina della guerra, i pachistani – colpevoli di dare rifugio ai talebani afgani – non la prendono molto bene questa offensiva diplomatica preceduta dalle parole di fuoco di Trump e della sua ambasciatrice all’Onu che sul Paese dei puri han sparato duro. I pachistani – messi in imbarazzo anche da un’intervista di Caitlan Coleman (un’americana liberata col marito canadese Joshua Boyle che ha appena detto al Toronto Star, smentendo Islamabad, che il rapimento afgano si è trasformato in una cattività in Pakistan per più di un anno) sono allarmati soprattutto da due cose: una diplomatica e l’altra militare. Quella diplomatica riguarda l’India, il fratello-coltello oltre confine, la cui espansione in Afghanistan preoccupa molto Islamabad. E da che gli americani hanno addirittura chiesto a Delhi di “tenere d’occhio” il Pakistan, il furore è difficile da nascondere. La seconda è che il viaggio di Tillerson inaugura anche un nuovo stadio della guerra afgana e della sua scia pachistana.
La notizia riguarda la luce verde del presidente alla nuova strategia contro insurrezionale di Michael “Mike” Pompeo, parlamentare repubblicano (di origini italiane) nelle grazie del Tea Party che da gennaio è a capo della Cia. Pompeo, che ha frequentato West Point e ha una carriera militare alle spalle, è un tipo muscolare proprio come Trump. La sua interpretazione del messaggio di Donald (nessuno avrà più un luogo dove nascondersi) è una nuova espansione delle attività dell’Agenzia che superino le restrizioni dell’era Obama, che autorizzava le operazioni coi droni solo all’esercito e che, al massimo, consentiva alla Cia di operare in Pakistan. Negli ultimi tre anni i raid coi droni militari sono comunque aumentati (ammesso che il dato sia veritiero) da 304 nel 2015 a 376 nel 2016 a 362 nei primi otto mesi del 2017 (mentre la Cia ne avrebbe totalizzati solo 3 l’anno scorso e 4 quest’anno e solo in Pakistan). Ma per Pompeo, e per Trump, non bastano né basta più che la Cia addestri la sua controparte (Nds) afgana. Da adesso la Cia potrà fare tutti i raid che vuole in Afghanistan senza rispondere all’esercito schierato al comando del generale Nicholson che guida anche le truppe Nato. La gestazione del progetto Pompeo, che impiega le cosiddette forze paramilitari dell’agenzia o soldati prestati dal Pentagono, non è stata facile: la Cia è nota per andar ancor meno per il sottile in fatto di danni collaterali così che alla Difesa diversi generali – dice la stampa americana – hanno storto il naso: «Cosa possono fare che non possiamo fare noi»? In realtà i servizi segreti fanno solo operazioni “coperte” e dunque bypassano ogni catena di comando. Ma chi pagherà il conto delle vittime civili, già alto durante i raid aerei “normali”? Per l’afgano della strada, un drone è un drone e una pallottola non ha firma. Le colpe della Cia si riverseranno sull’esercito.
Gli afgani dal canto loro plaudono. La pratica hunt and kill (caccia e uccidi) piace al ministero della Difesa che ha espresso apprezzamento. Washington sostiene che la nuova massiccia campagna di omicidi mirati porterà più facilmente i talebani al tavolo del negoziato. Ma è molto più probabile che si limiti a far crescere la guerra e il bilancio delle vittime civili.
Un account social verificato potrebbe proteggere gli attivisti iraniani, sempre che riescano a procurarselo
Le aziende del settore del social media possono fare di più per proteggere le comunità che subiscono attacchi online.
Rappresentanti curdi a Washington chiedono protezione a Trump, la Casa Bianca continua a sostenere l’unità dell’Iraq
La rappresentante ufficiale del governo del Kurdistan a Washington dichiara che i Peshmerga stanno resistendo ad attacchi ingiustificati delle milizie filo-iraniane e dell’esercito iracheno a Kirkuk in attesa di un intervento di Trump
L’articolo Rappresentanti curdi a Washington chiedono protezione a Trump, la Casa Bianca continua a sostenere l’unità dell’Iraq sembra essere il primo su Arabpress.
Il Califfo asiatico a Roma giovedi 26 ottobre alle 18
Il Califfo a Roma: una presentazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio
26 ottobre 2017 ore 18.00
modera: Valeria Martano
A oriente del Califfo
A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi
a cura di
Emanuele Giordana
con la collaborazione di
Lettera 22
Rosenberg&Sellier 2017
Non è un libro solo sullo Stato Islamico.
Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà
musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.
Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?
Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25
anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno
anche parte dell’agenzia China Files.
Sulle relazioni russo-iraniane
Se nel corso della storia le relazioni tra Teheran e Mosca hanno attraversato fasi altalenanti, oggi il vero scenario di scontro sarà in campo siriano.
L’articolo Sulle relazioni russo-iraniane sembra essere il primo su Arabpress.
Italia e Egitto rafforzano i rapporti diplomatici, ma sarà mai fatta giustizia per l’omicidio di Giulio Regeni?
L’Italia rinuncia alla ricerca degli assassini di Giulio Regeni per ottenere l’aiuto egiziano nel bloccare l’immigrazione in Europa?
Usa e Arabia Saudita corteggiano Baghdad per sottrarla all’Iran
Prosegue il disgelo iracheno-saudita Baghdad (al-Roayah). Il ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita Khaled al-Faleh si è recato in visita a Baghdad il 21 ottobre, nella seconda visita ufficiale dopo quella di maggio, nel contesto del graduale riavvicinamento tra il governo Abadi e la monarchia saudita. Faleh ha discusso gli orizzonti di cooperazione energetica elogiando l’Iraq per […]
100XBalfour
100XBalfour dal 27 Ottobre al 3 Novembre 2017: 100 anni di storia e di cultura palestinese Il CAIL – Coordinamento Associazioni Islamiche del Lazio, la Comunità Palestinese a Roma e nel Lazio, e l’Associazione dei Palestinesi in Italia lanciano … Continue reading →
Syrian regime traps 400,000 civilians in east Ghouta
At least two babies die of malnutrition as eastern Ghouta remains under siege by regime forces.
WWE signs first woman wrestler from Arab world in global push
World Wrestling Entertainment Inc. signed its first female performer from the Arab world on Sunday, smashing cultural taboos as the U.S.-based pageant seeks to piledrive its way into lucrative foreign markets.
Shadia Bseiso, a Jordanian versed in jiu-jitsu, dreams of encouraging more Arab women to take up sports – and of one day maybe even crashing a metal chair over WWE mega-star John Cena.
“Female athletes are finally getting the credit they deserve. The world is more open to that, and in terms of how the region will react to it, I‘m hoping its going to be very positive,” said Bseiso.
While women exercising in public is rare in the Arab world and the local entertainment industry often relegates them to docile roles, big companies such as Nike have stepped up advertising geared towards female athletes.
Still, the high octane physicality and outrageous storylines of professional wrestling remain a novelty in the region.
Speaking to Reuters in the WWE’s Dubai office, Bseiso said she made sure to tell her parents about her colorful career choice in person.
After announcing she would join the ranks of the WWE, they paused in disbelief for a moment, she said, worried for her safety in the often bruising shows.
They support her fully, she added, as she now heads to the company’s Orlando, Florida, training center for grueling in-ring training and what WWE calls “character development” – transformation into one of their trademark big personalities.
She has a Jordan-themed persona in mind, she says, declining to elaborate.
For decades a quintessential if curious emblem of Americana, professional wrestling has now won die-hard fans in the Arab world and beyond, and features widely in apparel and toys.
WWE’s reach deeper into new demographics makes plenty of business sense for the $1.5 billion Connecticut company, which has also recently signed several Indian and Chinese athletes in the hope of snaring millions of potential new devotees.
“Recruiting Shadia to join our developmental system underscores WWE’s ongoing commitment to building a talent roster as diverse as our fan base,” said Paul “Triple H” Levesque, WWE Executive Vice President and himself a popular wrestler.
Bseiso insists the quirky genre has room to expand if only fans could find a hero from home.
“As it is, the WWE’s incredibly popular in the Middle East, but I think having athletes from the region who grew up here – it will change things. You finally have someone to root for.”
The post WWE signs first woman wrestler from Arab world in global push appeared first on elan.
The “Butcher of Deir Ezzor,” Issam Zahreddine, Dies 1 Month After Threatening Syrian Refugees
Major General Issam Zahreddine, one of the most prominent military figures in the Syrian Arab Army (SAA), died on Wednesday, October 18, after his vehicle reportedly drove over an active landmine, causing an explosion. The Telegraph claims that “[Zahreddine’s] death will be a major blow to the regime, which has lost huge numbers of high-ranking […]
The post The “Butcher of Deir Ezzor,” Issam Zahreddine, Dies 1 Month After Threatening Syrian Refugees appeared first on Muftah.
Syrie: les FDS s’emparent du plus grand gisement pétrolier du pays

Les Forces démocratiques syriennes, soutenues par les Etats-Unis, ont annoncé avoir pris dimanche 22 octobre le contrôle du plus grand gisement pétrolier de Syrie, dans la province de Deir Ezzor, dans l’est du pays.
Révolte silencieuse pour sauver l’Unesco
L’Unesco doit être défendue et préservée ; c’est pourquoi, de l’intérieur, est dénoncée la politique mise en œuvre ces dix dernières années. L’élection, ce mois-ci, d’un nouveau directeur général revêt une importance cruciale pour l’organisation. / Culture, ONG, Diplomatie – (…)
/ Culture, ONG, Diplomatie – 2009/09
I passaggi nella Siria in frantumi di Samar Yazbek
Quella che segue è la recensione del libro “Passaggi in Siria”, di Samar Yazbek, appena uscito per Sellerio e tradotto dall’inglese da Andrea Grechi. Avete mai pensato a cosa fareste se la vostra casa venisse bombardata e la vostra città occupata dall’esercito del vostro Paese? Avete mai pensato a come reagireste se la stanza di […]![]()
Viaggio all’Eden a Pisa mercoledi 25 ottobre
Con il giornalista Alessandro De Pascale e Alberto Mari, un attivista dell’Osservatorio Antiproibizionista
VIAGGIO ALL’EDEN
La settimana nera di una guerra dietro le quinte
La settimana appena conclusa ha un bilancio di oltre 200 morti, una delle peggiori della guerra afgana. Una guerra che apparentemente non c’è più ma che sta continuando ininterrottamente da 36 anni. Ecco la lista stilata dalla Tv afgana Tolo.
E’ stata una buona occasione, come si rileva dall’articolo, per le polemiche interne.
Saturday’s attack on Ministry of Defense (MoD) cadets in Kabul:
15 cadets killed
4 cadets wounded
Friday’s attack on Imam Zaman Mosque in Dast-e-Barchi in Kabul:
about 70 civilians killed
55 civilians wounded
Attack on mosque in Ghor province on Friday:
10 civilians killed
20 civilians wounded
Thursday’s attack on a base in the Maiwand district of Kandahar:
43 soldiers killed
9 soldiers wounded
Tuesday’s attack in Paktia on the police headquarters:
Over 50 soldiers and civilians killed
Over 150 civilians and soldiers wounded
Monday’s attack on Andar district of Ghazni province:
28 soldiers killed
18 soldiers wounded
5 civilians killed
40 civilians wounded
Oman: un anno dopo l’interdizione di un giornale, i media indipendenti restano sotto assedio
Il giornale Azamn è stato bandito dopo aver pubblicato un articolo sulle interferenze dei politici nel sistema giudiziario. Uno dei suoi giornalisti è in prigione.
Soluzioni russe in Siria
Per il regime siriano, la superiorità russa o iraniana è fondamentale per favorire l’equilibrio e l’espansione della sua sfera d’influenza e far tornare i siriani sotto la sua autorità.
L’articolo Soluzioni russe in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
In Somalia “morte al chilometro”
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo In Somalia “morte al chilometro” sembra essere il primo su Arabpress.
17mila anime a Beit Beirut
Sala dopo sala, un intero piano di Beit Beirut è stato riempito di una foresta di listelli di legno colorati di verde. Tutti diversi, eppure tutti uguali. Sono 17mila, come 17mila sono gli scomparsi, i desaparecidos della guerra civile libanese. Nessun memoriale, spiega Zena al Khalil, l’artista autrice della megainstallazione a Beit Beirut. Nessun memorialeContinua a leggere
Rohingya, l’ultima accusa
 “Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i
“Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i
rohingya”. Dopo che il vocabolario dell’orrore sembrava ormai aver esaurito tutte le parole – esodo forzato, violenza, genocidio, stupro, pulizia etnica – Amnesty International, nel suo ultimo rapporto, aggiunge l’aggettivo “sistematico” a una campagna che ha come risultato il più numeroso esodo della storia recente da un Paese non in conflitto, una nuova biblica cacciata dai propri luoghi di origine. Il popolo senza identità, invisibile nei registri delle autorità birmane, accusato di essere la prole di un’immigrazione illegale dal Bengala, è così fisicamente minacciato che il governo birmano sembra aver in mente un solo obiettivo: cacciarli finché non resti un solo rohingya.
Amnesty non lo dice ma le “nuove prove” raccolte dall’organizzazione, che con Human Rights Watch ha immediatamente preso le difese della minoranza, mettono in chiaro un quadro sistematico di violenza continuata con una “campagna di omicidi, stupri e incendi di villaggi” portata avanti – dicono decine di testimonianze – da “specifiche unità delle forze armate, come il Comando occidentale, la 33ma Divisione di fanteria leggera e la Polizia di frontiera”. La contabilità ha ormai superato quota 530mila, un record possibile solo se, in un Paese apparentemente in pace, c’è in realtà una guerra che ha come obiettivo l’esodo di intere famiglie, tribù, villaggi. “Centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini – scrive Amnesty – sono vittime di un attacco sistematico e massiccio che costituisce un crimine contro l’umanità” così come lo concepisce lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale. Il Tpi elenca 11 atti che, se commessi intenzionalmente durante un attacco, costituiscono il più grave dei reati. E Amnesty ne ha riscontrati almeno sei: “omicidio, deportazione, sfollamento forzato, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione oltre a ulteriori atti inumani come il diniego di cibo e di altre forniture necessarie per salvare vite umane”.
Alla voce di Amnesty si aggiunge quella di organizzazione come Msf:“Le strutture mediche, incluse le nostre cliniche, sono al collasso. E in poche settimane – scrivono i Medici senza frontiere – abbiamo ricevuto 9.602 pazienti in ambulatorio e 3.344 pazienti in pronto soccorso. Tra loro, anche adulti sul punto di morire a causa della disidratazione: il sintomo che una catastrofe sanitaria è dietro l’angolo”. La voce dell’Onu è risuonata molte volte ma con scarsi risultati. E lo sa bene il sottosegretario Jeffrey Feltman che martedi a Yangoon si è sentito fare una reprimenda dal generale Min Aung Hlaing, il capo di stato maggiore birmano, che non vuole l’Onu tra i piedi: la maggior parte delle agenzie del palazzo di Vetro infatti nel Rakhine, il luogo del delitto, non ci può andare. Sono di parte, dicono i generali, che si apprestano a rilasciare un loro dossier su come sono andate le cose. Ai militari birmani non basta evidentemente che, per non turbare troppo gli equilibri, il Programma alimentare mondiale (Wfp) abbia fatto sparire un dossier “imbarazzante” e che per molto tempo, fin dal 2016, le agenzie dell’Onu abbiano fatto di tutto per evitare polemiche e scandali. Una mediazione senza risultati.
La diplomazia comunque batte un colpo e ieri l’Alto commissario Ue Federica Mogherini ha comunicato per telefono ad Aung San Suu Kyi, ministro degli Esteri ma premier de facto, che tutti i 28 membri Ue (inclusa l’Italia che ha recentemente inviato il suo ambasciatore, Pier Giorgio Aliberti, nel Rakhine) hanno chiesto l’immediato accesso alle agenzie umanitarie nel Paese ma che soprattutto, per via dello “sproporzionato uso della forza”, hanno deciso che né il generalissimo, né altri soldati birmani potranno mettere piede in Europa sino a che esista questa situazione (e a breve anche gli Stati Unite potrebbero seguire l’esempio).
L’embargo sulle armi, già in essere da tempo, non solo continuerà ma gli uomini in divisa non potranno nemmeno venire a girare le fiere e i mercati degli armamenti che probabilmente si procurano con oculate triangolazioni. E’ almeno un primo passo e a ridosso di due incontri importanti: il meeting nella capitale birmana dell’Asem il 20 novembre (Asia-Europe Meeting, un processo di dialogo tra i Paesi Ue, altri due paesi europei, e 22 paesi asiatici più il segretariato dell’Asean) e, subito dopo, la visita di papa Francesco il 26. Anche li è già in corso una guerra delle parole: i vescovi locali non vogliono che il pontefice parli di “rohingya”, termine che la stessa Suu Kyi non utilizza mai. I “self-identifying Rohingya Muslims” come li chiamano i giornali più progressisti birmani (anche loro molto attenti a non incorrere nelle maglie della censura) oltre a non aver più la casa non hanno nemmeno più un’identità.
Tunisia: verso la restaurazione di un potere personalistico
Thierry Brésillon Una riforma costituzionale annunciata Lo scorso settembre il presidente della Repubblica Béji Caïd Essebsi ha annunciato un’imminente revisione della Costituzione del 2014 che aveva inciso nella pietra le conquiste del 2011. Secondo il Presidente, la Costituzione bloccherebbe l’azione del Governo. Nello specifico egli denuncia il parlamentarismo costituzionale, istituito per evitare una restaurazione di un qualsiasi potere personale che però […]
Refugee Self-Reliance: Moving Beyond the Marketplace (October, 2017)
https://www.rsc.ox.ac.uk/news/new-research-in-brief-on-refugee-self-reliance I have contributed to this research in brief with my study on Halba in northern Lebanon. You can download the whole paper here: https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/refugee-self-reliance-moving-beyond-the-marketplace. The issue of how to promote refugee self-reliance has become of heightened importance as the number of forcibly displaced people in the world rises and budgets for refugees in long-term situations […]![]()
Rohingya, un incontro ad Arco (Tn) venerdi 20 ottobre
Venerdì 20 ottobre 2017 ore 20.30
Arco (Trento) Palazzo dei Panni
Un incontro sulla questione rohingya
Un filo conduttore tra la fortunata ascesa del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi e le difficoltà nell’estendere i diritti umani a tutta la popolazione birmana, tra interessi economici delle super potenze vicine, India e Cina. Un quadro d’insieme accompagnato da un reportage fotografico e dall’esperienza di un progetto di solidarietà in campo medico da parte di un’associazione trentina.
Promosso da Apibimi Onlus e Biblioteca di Arco
con Emanuele Giordana e il fotografo Ramon Sist
Le ultime raccomandazioni ai migranti
Le rivoluzioni arabe non sono riuscite a fermare i flussi migratori e le ondate di giovani pronti a cercare lavoro, giustizia, libertà e dignità sull’altra sponda del Mediterraneo. Ma ancora una volta è il mare ad accoglierli.
L’articolo Le ultime raccomandazioni ai migranti sembra essere il primo su Arabpress.
Impressioni (e qualche critica) dall’ultima Fiera del Libro di Amman
Annamaria Bianco, storica amica e collaboratrice di editoriaraba, nonché esperta e lettrice di letteratura araba contemporanea, qualche giorno fa ha visitato la Fiera del Libro di Amman, in Giordania, città dove al momento vive per lavoro. Tra una sovrabbondanza di libri religiosi e accademici e qualche gradita sorpresa che ha anche a che fare con […]![]()
I 10 difensori dei diritti umani di Istanbul sono dietro alle sbarre da 100 giorni
“Gharavi e Steudtner sono stati arrestati mentre facevano il loro lavoro, ossia mentre insegnavano […] le competenze necessarie per esercitare i diritti umani nell’era digitale.”
Un’agenzia birmana per aiutare i rohingya: buona idea o foglia di fico?
 Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.
Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.
Penso che quanto Suu Kyi sta facendo sia qualcosa che si può comprendere anche se tutto ciò non giustifica il suo operato. Sono contrario alla campagna per la restituzione del Nobel e sono contrario alle sue dimissioni ma penso che il suo comportamento vada censurato anche se ci sono diversi motivi che rendono comprensibile il suo modo di agire. Si può comprendere ma non si può giustificare. Quello dei rohingya è l’esodo più imponente da un Paese non in conflitto che la storia recente ricordi. Circondato da un assordante silenzio rotto solo dal dolore degli uomini e donne invisibili che attraversano, ormai da un anno, la frontiera maledetta sul fiume Naf.
* A questo link un articolo ben documentato di Francesca sul land grabbing in Myanmar
DOSSIER. Omicidio di Giulio Regeni. Come oscurare informazione e ricerca sociale in Egitto
 Mentre l’Italia e l’Egitto provano a normalizzare i propri rapporti, sullo sfondo degli accordi commerciali che legano i due paesi e del piano Minniti per contenere i flussi migratori nel Mediterraneo, si cerca di spingere l’omicidio di Giulio Regeni nel dimenticatoio. Sui media filogovernativi si costruisce una narrazione che individua capri espiatori e molti media online indipendenti, tra gli altri Mada Masr, da cui è tratto questo dossier, non sono più accessibili dall’Egitto. La ricerca sociale è sempre più sgradita alle autorità. La paura è ovunque, anche e soprattutto in chi fa ricerca. Un meccanismo psicologico profondo, il cui svelamento aggiunge un tassello importante alla comprensione della deriva autoritaria che l’Egitto sta vivendo dopo l’avvento al potere del generale al Sisi.
Mentre l’Italia e l’Egitto provano a normalizzare i propri rapporti, sullo sfondo degli accordi commerciali che legano i due paesi e del piano Minniti per contenere i flussi migratori nel Mediterraneo, si cerca di spingere l’omicidio di Giulio Regeni nel dimenticatoio. Sui media filogovernativi si costruisce una narrazione che individua capri espiatori e molti media online indipendenti, tra gli altri Mada Masr, da cui è tratto questo dossier, non sono più accessibili dall’Egitto. La ricerca sociale è sempre più sgradita alle autorità. La paura è ovunque, anche e soprattutto in chi fa ricerca. Un meccanismo psicologico profondo, il cui svelamento aggiunge un tassello importante alla comprensione della deriva autoritaria che l’Egitto sta vivendo dopo l’avvento al potere del generale al Sisi.
I Palestinesi di Gaza e Cisgiordania riprendono il cammino in comune
mcc43 Il travagliato percorso dal 2014 alla riunificazione politica Perché è stato possibile riavviare il governo comune nel 2017 I punti chiave dell’accordo globale – Il travagliato percorso dal 2014 verso la riunificazione politica Il primo effettivo passo verso la riunificazione è avvenuto con scarso rilancio mediatico nel 2014. I colloqui fra Hamas e Fatah – […]![]()
Egitto – Testimonianza di una detenuta sulle sezioni speciali per le condannate a morte
traduzione da facebook Nella quindicesima giornata contro la condanna a morte, pubblichiamo la testimonianza di una compagna Yasa Sallam, che durante la sua detenzione in carcere si trovava vicina alla sezione “speciale” delle donne recluse condannate a morte. Come ci … Continue reading →
Uno sguardo al patrimonio artistico siriano parzialmente distrutto dalla guerra
“È come far saltare in aria il Taj Mahal o distruggere l’Acropoli di Atene. È un disastro.”
Intervista a Olfa Lamloum e Michel Tabet sul documentario “Voices from Kasserine”
a cura di Patrizia Mancini Il film “Voices from Kasserine” è stato realizzato da Olfa Lamloum et Michel Tabet con Talal Khoury alla videocamera. Patrizia Mancini: Perché avete scelto la regione di Kasserine per il vostro documentario? Olfa Lamloum : Abbiamo scelto questa regione perché International Alert lavora sin dal 2012 in tutto il governatorato. Vi abbiamo condotto numerose […]
Netizen Report: censura online contro la comunità LGBT e minacce in Egitto e Giordania
Il Netizen Report di Global Voices Advocacy offre uno spaccato internazionale sulle sfide, vittorie e tendenze emergenti nei diritti di internet a livello mondiale.
Yemen: ancora nessuna notizia dell’analista politico detenuto dai ribelli Houthi da agosto
Hisham Al-Omeisy è una delle voci più determinanti nel racconto della guerra in atto in Yemen e del suo costo umanitario.
Regeni, Amnesty e Fnsi lanciano la scorta mediatica per Giulio: “Monitoriamo le azioni del governo sulle indagini”
Una scorta mediatica che continui a seguire l’operato del governo italiano sulle indagini per trovare la verità sulla morte di Giulio Regeni. Così Amnesty International, con la collaborazione della Federazione Nazionale della Stampa e dell’associazione Articolo 21, prova a richiamare l’attenzione dei media italiani sulla fine del ricercatore di Fiumicello, ritrovato senza vita il 3 […]
L’articolo Regeni, Amnesty e Fnsi lanciano la scorta mediatica per Giulio: “Monitoriamo le azioni del governo sulle indagini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Chiacchiere, datteri e thè. Tunisi, viaggio in una società che cambia”
Dal blog “Con altre parole” di Beatrice Tauro
L’articolo “Chiacchiere, datteri e thè. Tunisi, viaggio in una società che cambia” sembra essere il primo su Arabpress.
Sinan Antoon vince la quinta edizione del Prix de la littérature arabe
Lo scorso 26 settembre, lo scrittore iracheno-americano Sinan Antoon ha vinto il Prix de la littérature arabe 2017 con il suo romanzo Seul le grenadier (Solo il melograno), tradotto dall’arabo in francese da Leyla Mansour e pubblicato in Francia da Sindbad/Actes Sud. La menzione speciale del Premio è andata invece all’autrice marocchina Yasmine Chami per […]![]()
Il punto a Tunisi sulle migrazioni nel Mediterraneo
Marta Bellingreri “Se il rubinetto è rotto e perde acqua, l’idraulico può venire ad aggiustarlo; o può invece chiudere l’acqua per evitare la perdita e dare delle bottiglie d’acqua da tenere a casa, facendo finta di aver riparato il danno”. Così Blamasi, presidente dell’associazione Union des Leaders Africains, descrive le politiche europee nei confronti dell’Africa. “L’Europa continua a mettere un tappo […]
Il poeta siriano Faraj Bayrakdar vince il Premio alla carriera del Festival internazionale di poesia civile “Città di Vercelli” 2017
«Ma le circostanze erano di pietra e il tintinnio del tempo e del luogo aveva una macchia che somiglia a sangue» (Specchi dell’assenza, F. Bayrakdar, Interlinea 2017, trad. di E. Chiti) Bayrakdar è stato insignito del prestigioso premio del Festival internazionale di poesia civile “Città di Vercelli”, la cui premiazione in anteprima si […]![]()
Magdi Allam, ovvero “come non parlare dell’Islam”
Il 14 settembre scorso ho partecipato alla presentazione di un libro presso il Museo Civico Biagio Greco della città Mondragone, in provincia di Caserta, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla cultura Francesca Gravano e di una ventina di persone… Continue Reading →![]()
Dance in Poetry per salvare l’Ex Lavanderia
 L’Ex Lavanderia si trova nell’ex ospedale psichiatrico di Roma, meglio conosciuto semplicemente come Santa Maria della Pietà. Agli anni di abbandono che hanno fatto seguito alla sua chiusura grazie alla legge Basaglia, sono seguiti anni di riappropriazione cittadina che hanno avuto come motore e fulcro l’impegno culturale e artistico.
L’Ex Lavanderia si trova nell’ex ospedale psichiatrico di Roma, meglio conosciuto semplicemente come Santa Maria della Pietà. Agli anni di abbandono che hanno fatto seguito alla sua chiusura grazie alla legge Basaglia, sono seguiti anni di riappropriazione cittadina che hanno avuto come motore e fulcro l’impegno culturale e artistico.
Presentata a Sharjah la 36° edizione della Fiera internazionale del libro di Sharjah
La 36° edizione della Fiera del Libro internazionale di Sharjah si terrà nell’Expo centre dell’emirato dal 1 all’11 novembre e vedrà la partecipazione di 1.650 case editrici provenienti da 60 Paesi diversi. Alti anche i numeri degli eventi e degli ospiti: ben 393 ospiti da 48 Paesi che prenderanno parte a più di 2.600 eventi. […]![]()
L’esercito algerino di fronte a sfide dall’interno e pressioni dall’esterno
Una grande oscurità circonda l’esercito algerino: dopo la sua fondazione in seguito allo scoppio della Rivoluzione del 1954 e ai momenti di crisi politica prima e dopo l’indipendenza, vengono alla luce alcune funzioni e ruoli di questo esercito sconosciuto.
L’articolo L’esercito algerino di fronte a sfide dall’interno e pressioni dall’esterno sembra essere il primo su Arabpress.
Afghanistan, quanto costa la guerra
La guerra di Afghanistan, secondo un rapporto di Milex, è costata complessivamente 900 miliardi di dollari. Dopo 16 anni di conflitto il costo della partecipazione italiana alle operazioni in Afghanistan a partire da novembre 2001 è stimata dal dossier a “oltre 7,5 miliardi, a fronte di 260 milioni investiti in iniziative di cooperazione civile”.
Scarica il rapporto dal sito di Milex
Viaggio all’Eden a Milano, Mercoledi 11 ottobre
Con Tino Mantarro e i disegni di Maurizio Sacchi su Viaggio all’Eden
Novità editoriale: Fifa nera / Fifa blu di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera
In che modo si può raccontare la paura? Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera, con la collaborazione di Fabio Geda e Marco Aime, l’hanno fatto con penna e matita, dandole due volti e due colori. Fifa nera / Fifa blu narra la storia, anzi, le storie della stessa paura vista dall’una e dall’altra parte. La fifa blu […]
L’articolo Novità editoriale: Fifa nera / Fifa blu di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – Appello in solidarietà con la comunità LGBT
traduzione da facebook Solidarietà con le persone LGBT d’Egitto! Questo è un appello alla protesta! Nelle due settimane passate, l’Egitto è stato testimone di un violento attacco contro le persone in base al loro orientamento sessuale e di genere. 57 … Continue reading →
….ancora Iran….
http://www.rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/baobab/Sveliamo-il-lato-pi%C3%B9-inaspettato-dellIran-9579472.html….ancora Iran….
Viaggio nell’Iran che cambia
http://www.mondoemissione.it/asia/viaggio-nelliran-cambia/
Mejel Bel Abbès: inchiesta su diffusione dell’epatite A e cattiva gestione dell’acqua
Zoé Vernin, Coordinatrice del dipartimento Giustizia sociale e ambiente per il Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) in collaborazione con l’Osservatorio Tunisino dell’Acqua. “I pozzi dei cammelli di Monsieur Abbes”: conosciuta in questo modo in passato, la piccola città di Mejel Bel Abbès oggi è malata. Manca l’acqua, oppure quella disponibile non è più potabile. Lo scorso […]
Egitto – Ancora duri attacchi del regime contro la comunità LGBTQ
Il 23 settembre durante il concerto della band libanese Mashrou’ Leila è stata sventolata da alcune persone la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ. A seguito di questa azione molte persone sono state arrestate e sono ora in stato di … Continue reading →
Lo scrittore siriano Khaled Khalifa a Messina, Catania e Padova
Lo scrittore siriano Khaled Khalifa in questi giorni è in Italia per partecipare ad una serie di incontri in Festival culturali. Dopo essere stato a Ferrara al “Festival di Internazionale”, sarà a Messina e Catania, ospite di “SabirFest”, e a Padova, ospite del Festival “La fiera delle Parole”. Giovedì 5 ottobre, ore 11 @Messina: incontro […]![]()
Un caso sottoposto al tribunale spagnolo mostra i limiti della giurisdizione universale per i siriani
“[Il nostro team] metterà a disposizione tutti i mezzi e le risorse possibili per fare giustizia per le migliaia di vittime del conflitto siriano”.
Il Governo di Unità della Palestina si riunisce a Gaza
mcc43 Si chiude un decennio di insensate ostilità fra Gaza e la West Bank, fra Hamas e Fatah, fra il governo della Striscia e l’ Autorità Palestinese. Inshallah, è bene aggiungere, perché i Palestinesi hanno davanti a sé un percorso assai difficile e l’aiuto che hanno ottenuto, dall’Egitto, per la riconciliazione non è senza prezzi […]![]()
Ondate di sarcasmo senza precedenti in Arabia Saudita e nel mondo arabo per aver concesso alle donne di guidare
Dopo l’annuncio del decreto reale, i social sono sommersi da ondate di sarcasmo e i media mettono in guardia sulle “dure pene” contro chi critica la decisione del re
L’articolo Ondate di sarcasmo senza precedenti in Arabia Saudita e nel mondo arabo per aver concesso alle donne di guidare sembra essere il primo su Arabpress.
Samar Yazbek e Mustafa Khalifa al Festival delle Letterature Migranti di Palermo
Palermo così sontuosa, barocca, araba e mediterranea, con i suoi viali alberati, i mercati ripieni di cibo e cianfrusaglie e quei teatri e monumenti massicci e scenografici che spuntano da dietro un vicolo senza che uno se lo aspetti. Questa nostra bellissima Palermo, dal 4 all’8 ottobre accoglie ancora una volta il Festival delle letterature migranti, […]![]()
La vittoria delle attiviste saudite per la guida alle donne, l’ombra della tutela maschile e gli arresti
Le donne saudite potrebbero presto poter guidare, ma continuano ad affrontare ostacoli e una grande discriminazione sotto il sistema di tutela maschile del regno saudita.
La forza del Qatar nella crisi del Golfo
Quali sono i punti forza e le capacità del Qatar che hanno permesso a questo “piccolo stato” di resistere fino ad oggi?
L’articolo La forza del Qatar nella crisi del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.
Wibu Codemeter Free Dumper on RequestCracks.com
Note: Autodesk software programs products will work on a free of charge Free trial license until finally stimulated. Should you obtained your software program and didn’t make use of it as being a Free Trial Offer, you will still have to begin activation in the software with the Free Trial Offer display screen. Your computer […]
L’articolo Wibu Codemeter Free Dumper on RequestCracks.com sembra essere il primo su Arabpress.
C’era una volta la Guerra Fredda
 Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera
Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera
raccontati da Icei e Radio Popolare”. Lunedì 2 ottobre alle 21, nell’auditorium di via Ollearo 5, il sesto appuntamento, dedicato all’Oriente: “L’Asia, dal Vietnam alla “fabbrica del mondo””. Intervengono i relatori Gabriele Battaglia ed Emanuele Giordana, conduce Chawki Senouci.
Leggi tutto
Aiuto, nei libri di testo scolastici si sponsorizza lo Ius Soli
“Ormai quindi l’Italia è terra di immigrazione e gli immigrati sono una presenza indispensabile, soprattutto in alcuni settori lavorativi come l’edilizia, il lavoro domestico, l’assistenza a bambini e anziani. La convivenza tra italiani e stranieri non è sempre facile e non sempre la legge italiana favorisce l’integrazione. Ad esempio i figli di stranieri nati in Italia continuano a non aver diritto alla cittadinanza italiana, anche se vivono nel nostra Paese da sempre“.
Non so cosa ne pensate di questa frase che è tratta da un libro di testo per la scuola media: Zoom Geografia da vicino scritto a sei mani da tre autori (Brandi, Corradi, Morazzoni). Direi che si tratta di una verità inequivocabile tra l’altro illustrata, nel libro, da tabelle e dati. Che gli immigrati facciano un lavoro che molti italiani non vogliono più fare è del resto un elemento così assodato che penso possa riconoscerlo persino Matteo Salvini. Eppure per il Giornale, con un articolo a firma Giuseppe De Lorenzo, si tratta di uno “spot allo ius” che, se non fosse chiaro, sarebbe lo ius soli, legge appena affossata da Alfano e che lascia nel limbo migliaia di ragazzi che avrebbero diritto alla cittadinanza italiana. Rimando all’articolo di De Lorenzo e alle reazioni (come questo commento sul blog Butac o lo stesso comunicato della casa editrice Loescher): spiegano meglio di me come l’articolo del quotidiano milanese sia non solo riferito a un testo del 2015, ma abbia tutta l’aria di essere uno dei tanti elementi utilizzati ad arte nella campagna contro i migranti, gli stranieri, i loro figli e i loro diritti. Uno spot contro lo ius soli insomma. Aggiungo solo una piccola nota.
Secondo il Giornale il testo di Brandi, Corradi, Morazzoni – che ha stimolato la reazione di un gruppo vicentino che si chiama “Prima Noi” – esprime una “sponsorizzazione” dell’immigrazione atta a “plasmare la malleabile mente di un bambino, propenso com’è a credere a quasi tutto quello che gli viene proposto dagli insegnanti“. In buona sostanza, meglio non pensare. Meglio non farsi domande, in tenera età, su cosa ci fanno persone di altri Paesi nel nostro. Meglio non domandarsi – secondo Prima Noi e l’articolista – come mai queste persone non abbiano i nostri stessi diritti (e da bambino mi sarebbe sembrato normale chiederlo). Che miseria italiana. I libri di testo dovrebbero spiegarci che gli immigrati sono inutili, spesso se non sempre delinquenti, e che, se ci sono problemi di convivenza, è colpa loro. Se l’articolista si fosse limitato a riportare la notizia della reazione oscurantista di Prima Noi – il cui nome è tutto un programma – sarebbe cronaca, ma il pezzo opina, mette in guardia, paventa danni psicologici. E allora non sarebbe stato meglio, visto che si parla di scuola e di bimbi italiani, fare un piccolo ripasso della lingua di Dante? Il libro infatti sarebbe un’opera scritta a “tre mani“. Ma come, gli autori di mani ne hanno una sola a testa? L’altra se la son già presa i migranti? Chi di italiano ferisce, di italiano perisce.
All’indomani del referendum curdo
La vittoria del sì al referendum per l’indipendenza del Kurdistan iracheno apre diverse questioni sul futuro delle relazioni del governo regionale con l’Iraq e i paesi vicini.
L’articolo All’indomani del referendum curdo sembra essere il primo su Arabpress.
Rohingya, melina al Consiglio di sicurezza
 |
| Guterres al CdS: tutte le parole possibili per scardinare l’inazione |
Mentre il numero dei rohingya fuggiti in Bangladesh continua ad aumentare il bilancio di un esodo che sembra senza fine e sarebbero ormai 500mila i profughi di questa minoranza musulmana vittima di una cacciata biblica, il Consiglio di sicurezza dell’Onu aspetta. Riunitosi da giovedi per ora ascolta in attesa di pronunciarsi su possibili sanzioni e passi forti nei confronti del Myanmar da cui i rohingya fuggono in massa. Ma per ora non ci si aspetta molto altro che un messaggio formale forte. Anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres non sa più bene che parole utilizzare: dalla “catastrofe umanitaria” è passato a “incubo dei diritti umani” ma le bocce restano ferme. Gli ha fatto eco l’ambasciatore all’Onu del Bangladesh Masud Bin Momen che, nelle riunioni consultive del Consiglio, ha chiesto alle Nazioni Unite un’indagine su quanto accade. Fatti che stanno facendo del suo Paese la riserva indiana dove cacciare la minoranza musulmana il cui nome, in Myanmar, non si può nemmeno menzionare.
La vicenda dei rohingya, per cui è già stato usato il termine “genocidio” e la locuzione “pulizia etnica”, infiamma però solo i Paesi musulmani e appena un pochino britannici e francesi. Persino gli americani, di solito molto “vocalist” – come si dice in gergo – quando si tratta di diritti umani, stanno un po’ in disparte. Nei discorsi preparatori nessuno è stato comunque avaro di frasi di rito ma al Consiglio di sicurezza, dove si prendono le decisioni che contano, tutti sanno che, soprattutto Pechino – spalleggiata da Mosca – non vuole soluzioni dure contro il Myanmar, alleato di ferro delle sue politiche energetiche. Ha già utilizzato in passato il diritto di veto anche se, si dice, la Cina si sarebbe ammorbidita in questa vicenda dove ormai ogni linea rossa è stata varcata. La gente che fugge, lasciandosi dietro case incendiate, stupri e violenze, arriva in Bangladesh stremata e assai spesso, è accaduto anche ieri, non ce la fa: fragili imbarcazioni che si capottano, gente che affoga nel fiume-mare che divide i due paesi: almeno una sessantina ieri dopo il ribaltamento di una barca.
Guterres, che potrebbe decidere un viaggio in Myanmar su invito del governo, vuole intanto almeno una Conferenza dei donatori e un po’ di quattrini per le sue agenzie. Ma c’è un problema di accesso – nello Stato del Rakhine da cui i rohingya fuggono – che renderebbero il denaro assai poco utile. Il problema è politico non umanitario. O meglio, la catastrofe umanitaria e l’incubo sui diritti, gli stupri e le violenze non sono che gli effetti di una politica disattenta su una vicenda annosa, marcata dall’imbarazzo di avere a che fare questa volta con dei musulmani che non sono dalla parte del torto. I rohingya però sono solo una piccola popolazione senza protezione né protettori, non vivono in deserti petroliferi e le loro terre ormai stanno passando nelle mani di altri padroni: erano un milione e ora son solo la metà. Questione di tempo e il caso, con qualche spicciolo per i campi profughi, si risolverà da solo.
Guterres lo sa e infatti ha paventato il rischio che questa situazione, oltre che catastrofica sul piano umanitario, diventi nuova benzina da gettare sul fuoco – in Bangladesh o in Myanmar – per chi ha interesse ad allevare gruppi armati e terroristici. Intanto Facebook dà una mano: i post dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), il gruppo secessionista rohingya accusato dai birmani di terrorismo, è stato oscurato. Un regalo a chi sta pensando a scelte radicali e ai Paesi che possono essere interessati a creare caos nella regione finanziando chi non ha più nulla da perdere.
Marina Calculli e Francesco Strazzari -Terrore Sovrano
“Terrore sovrano. Stato e jihad nell’era postliberale” è un testo a cura di Marina Calculli, ricercatrice presso l’Institute for Middle Eastern Studies, la Elliott School of International Affairs e la The George Washington University, e Francesco Strazzari, professore associato alla… Continue Reading →![]()
“I tuffatori di Casablanca” di Rosita Ferrato
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “I tuffatori di Casablanca” di Rosita Ferrato sembra essere il primo su Arabpress.
La guerra nello Yemen e le manovre politiche. Siamo vicini a una soluzione?
La situazione attuale nel Paese necessita di un consenso politico urgente tra i poteri conflittuali, e l’amnistia potrebbe essere la chiave delle soluzioni.
L’articolo La guerra nello Yemen e le manovre politiche. Siamo vicini a una soluzione? sembra essere il primo su Arabpress.
Egitto – È fondamentale la solidarietà per #FreeAlaa! Liberx tutti e tutte!
Da pochi giorni è iniziata una campagna sui social network che chiede la scarcerazione di Alaa Abd el-Fattah, un compagno che sta scontando 5 anni di carcere (al momento sono passati tre anni e mezzo) per un corteo non autorizzato … Continue reading →
Egitto – Nuova ondata di repressione contro tutto e tuttx!
In questi ultimi giorni il regime ha dato il via all’ennesima ondata di repressione decidendo di colpire in maniera trasversale tutti e tutte. Sotto dittatura e soprattutto per chi si oppone e resiste non esiste tregua. Così, alla fine di … Continue reading →
Un caffè in Puglia con Mahmud Darwish
Il viaggio di Darwish, un progetto di Bruno Soriato e Iyas Jubeh che vi avevo raccontato qui, volge quasi al termine. Tra le numerose tappe in giro per la Puglia, i due si sono fermati anche a Bitonto (Bari), dove ad assistere allo spettacolo c’era anche Silvia Moresi, arabista e traduttrice, che ne ha scritto […]![]()
La sua storia continua a vivere: l’eredità creativa di Bassel Khartabil
Un mese dopo la conferma della sua esecuzione, gli amici onorano Bassel Khartabil attraverso arte, musica e nuove opportunità per sviluppatori della tecnologia aperta.
Referendum Kurdistan, l’indipendenza resta un’utopia ma il risultato lancia Barzani alle elezioni presidenziali
L’annuncio è arrivato ieri sera mentre il Kurdistan iracheno si riprendeva a rilento dall’ebbrezza del voto per l’indipendenza. Il presidente del governo regionale curdo Masoud Barzani non ha voluto aspettare la comunicazione ufficiale della commissione elettorale. Ha tenuto un discorso in diretta televisiva e ha proclamato la vittoria del sì. Anche se i dati non […]
L’articolo Referendum Kurdistan, l’indipendenza resta un’utopia ma il risultato lancia Barzani alle elezioni presidenziali proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il Califfo e l’Asia al Festival di Internazionale: i Rohingya e il web
 Chiostro di San Paolo
Chiostro di San Paolo
piazzetta Schiatti 7
Festival di Internazionale
VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017
17.00
Il gruppo Stato islamico (Is) vuole estendere i confini del califfato oltre il mondo arabo e alcune regioni asiatiche sembrano un terreno ideale. Una raccolta di saggi per capire il progetto dell’Is per la conquista dei musulmani non arabi e per comprendere chi sta dando una mano al califfato.
Giordana racconterà del suo viaggio alla frontiera Bangladesh/Myanmar di cui ha scritto per Internazionale e di come i secessionisti rohingya possano cadere nella trappola dello Stato islamico. Tiziana Guerrisi racconterà di come la diffusione del verbo di Al Baghdadi si sia diffusa nella Rete sperimentando un nuovo tipo di guerra a tecnologia avanzata
(Sarà presente il cane Fanny)
L’Arabia Saudita alleggerisce le restrizioni su alcune app ma WhatsApp e Viber sono ancora bloccate
Dal 2013 ad oggi, il governo saudita ha parzialmente o integralmente bloccato applicazioni per chat e chiamate, tra cui WhatsApp, Skype, Facebook Messenger e FaceTime.
Humanitarian Pedagogies of Transit (September 2017)
(Syrian refugee children at school in Turkey. Photo credit: worldbulletin.net) http://www.anthropology-news.org/index.php/2017/09/26/humanitarian-pedagogies-of-transit/ Despite the traditionally temporary character of their interventions, humanitarian agencies providing ad hoc services in crisis-affected areas are increasingly viewing education as a necessity. As such, education has been progressively integrated into the standard humanitarian toolkit. Delivering formal education in crises, however, remains an […]![]()
Siria: serena divisione all’orizzonte
Nella confusione delle riunioni e delle proposte avanzate sulla Siria al margine della 72esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sul palcoscenico l’ottimismo sulla soluzione, le elezioni e la fase di transizione. Dietro le quinte, discorsi e proposte più realistiche.
L’articolo Siria: serena divisione all’orizzonte sembra essere il primo su Arabpress.
Condannato per ‘incitazione di proteste’, un giornalista marocchino inizia lo sciopero della fame
Diversi giornalisti sono stati arrestati dalle autorità marocchine mentre stavano coprendo le proteste avvenute nella regione del Rif.
Trump e Macron sull’accordo nucleare con l’Iran
Il programma nucleare iraniano continua tra l’audacia di Trump e l’equilibrio di Macron. Ma quali saranno le conseguenze sul piano regionale e internazionale? Un’analisi di Hasan Tarek al-Hasan.
L’articolo Trump e Macron sull’accordo nucleare con l’Iran sembra essere il primo su Arabpress.
Saleem Haddad, Faraj Bayrakdar e Khaled Khalifa a Internazionale a Ferrara 2017
Al prossimo festival di Internazionale a Ferrara, che comincia questo venerdì, ci sono due incontri (tra i tantissimi da non perdere) con alcuni scrittori arabi a cui vi consiglio di assistere se siete nei paraggi! Sabato 30 settembre ore 14.30: Amore e rivoluzione in Medio Oriente Saleem Haddad (autore di Guapa, edizioni e/o 2016) dialoga […]![]()
La radio racconta
Ho sempre amato Wikiradio, una di quelle trasmissioni che restituiscono alla radio il fascino del tempo in cui era uno dei pochi mezzi di diffusione di massa del racconto. Wikiradio, nello specifico, sta peraltro assolvendo a un compito di documentazio…
Bellezza oltre la guerra a Trani. Afghanistan in terra di Puglia
 |
| Con Soraya sullo sfondo del castello di Federico II a 25 km da Trani |
Il tema della bellezza è al centro di un Festival cui mi sarebbe sempre piaciuto andare e che si intitola Dialoghi di Trani anche se poi gli appuntamenti corrono qui e la in questa bella terra di Puglia. Con mio grande piacere quest’anno sarò li domenica 24 con Soraya d’Afghanistan e Giorgio Zanchini a parlare della “bellezza oltre la guerra” dell’Afghanistan, Paese bellissimo e purtroppo in gran parte distrutto. Di cosa parlerò? Di cos’è ma anche di com’era. Posto dunque il mio ricordo di quella che un afgano definì l'”età dell’oro” ossia il periodo in cui visitammo l’Afghanistan durante il “Viaggio all’Eden”, libro nel quale ho dedicato a questo splendido Paese gran parte delle pagine… Ne pubblico qualche estratto dal 4 Capitolo: L’epopea di chicken street
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
…La notte, a quelle latitudini, arriva velocemente. Avevamo appena lasciato il posto di frontiera iraniano di Tayyebad ed eravamo entrati in Afghanistan mentre le luci del giorno si andavano affievolendo. Il passaggio del confine non era stato indolore ma sapevamo che la vera frontiera del Viaggio all’Eden, la mitica strada che portava dall’Europa sino all’India e a Kathmandu, era finalmente qui. Qui dove il grande altipiano del Khorasan persiano si perde nei deserti dell’Afghanistan, un luogo, un nome che con l’andar del viaggio – nelle storie raccolte a Istanbul o Teheran – stava diventando qualcosa in più di una semplice tappa. Alla frontiera iraniana la polizia dello Scià imponeva, a chi andava o veniva, un passaggio obbligato in un corridoio degli orrori: batterie scoperchiate, scatole di conserva squarciate, gomme rivoltate come calzini, cruscotti smontati, tubetti di dentifricio svuotati. Mentre ti avventuravi nella terra di nessuno tra le due frontiere, quel passaggio obbligato nel museo della punizione divina, ti dava un avvertimento chiaro: stavi entrando nel Paese patria, tra l’altro, dell’ “afgano nero”, l’hascisc più ricercato del pianeta. Lasciavi la Persia del Trono del pavone con le sue lugubri promesse penitenziarie e agenti azzimati dalle divise luccicanti e arrivavi al posto di frontiera de la “République d’Afghanistan”, che allora il francese era la lingua di una monarchia che, appena un anno prima, nel 1973, era diventata repubblica con un golpe bianco dei suoi parenti, mentre il re Zaher Shah era in vacanza a Capri…
 … Dopo qualche chilometro il minibus carico di stranieri zazzeruti e completamente fumati si arrestava in una ciakana, una taverna dove si beve il tè, si può dormire e mangiare sdraiati su tappeti pulciosi ma altrettanto ricchi di fascino, odori e geometrie colorate approntate da abili tessitori. Completamente stravolti dalla potenza dell’afgano nero, i giovani viaggiatori vedevano entrare uomini scesi da cammelli battriani a una sola gobba e avvolti in tabarri – il patu, coperta di finissima lana dell’Hindukush –, fieri pastori delle montagne, abili commercianti della pianura, chapandaz dal prezioso cavallo arabo che ti proiettavano in una sorta di medioevo islamico, dove regole antiche come massicci dirupi e vigili come guardiani occhiuti di una tradizione millenaria, sembravano – complice l’ambiente e l’hascisc – aver costruito a tua misura la magia di una notte stellata perduta nei grandi spazi dell’Oriente che finalmente si era fatto realtà. Altro che scimmiottamenti di un’altra cultura, altro che divise in stile germanico, altro che modernità più o meno digerita: dopo l’Iran dello Scià – dove l’impronta della modernità sapeva di esportazione forzata di un modello del tutto estraneo – l’Afghanistan era una favola perfetta dove ti era consentito immergerti fino al midollo. Dovevi solo rispettare le sue regole scandite dall’adhan, la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno. O dal pashtunwali, le norme rigorose della tradizione. Regole ferree. Una notte, un povero fricchettone di qualche città europea, in nome del leggendario codice d’onore dei pashtun che prevede non si possa negare l’ospitalità a chi la chiede nemmeno se si tratta di un assassino, viene accolto di buon grado in una famiglia cui domanda riparo. Ma il povero giovinastro si sveglia nella notte per la sete e, nel buio, sbaglia stanza entrando in quella delle donne, oggetto di un desiderio irrivelabile e negate alla vista altrui dai dettami della purdah (letteralmente: tenda). Punizione: la morte. Rapida come era stata la grazia con cui era stato accettato e ospitato…
… Dopo qualche chilometro il minibus carico di stranieri zazzeruti e completamente fumati si arrestava in una ciakana, una taverna dove si beve il tè, si può dormire e mangiare sdraiati su tappeti pulciosi ma altrettanto ricchi di fascino, odori e geometrie colorate approntate da abili tessitori. Completamente stravolti dalla potenza dell’afgano nero, i giovani viaggiatori vedevano entrare uomini scesi da cammelli battriani a una sola gobba e avvolti in tabarri – il patu, coperta di finissima lana dell’Hindukush –, fieri pastori delle montagne, abili commercianti della pianura, chapandaz dal prezioso cavallo arabo che ti proiettavano in una sorta di medioevo islamico, dove regole antiche come massicci dirupi e vigili come guardiani occhiuti di una tradizione millenaria, sembravano – complice l’ambiente e l’hascisc – aver costruito a tua misura la magia di una notte stellata perduta nei grandi spazi dell’Oriente che finalmente si era fatto realtà. Altro che scimmiottamenti di un’altra cultura, altro che divise in stile germanico, altro che modernità più o meno digerita: dopo l’Iran dello Scià – dove l’impronta della modernità sapeva di esportazione forzata di un modello del tutto estraneo – l’Afghanistan era una favola perfetta dove ti era consentito immergerti fino al midollo. Dovevi solo rispettare le sue regole scandite dall’adhan, la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno. O dal pashtunwali, le norme rigorose della tradizione. Regole ferree. Una notte, un povero fricchettone di qualche città europea, in nome del leggendario codice d’onore dei pashtun che prevede non si possa negare l’ospitalità a chi la chiede nemmeno se si tratta di un assassino, viene accolto di buon grado in una famiglia cui domanda riparo. Ma il povero giovinastro si sveglia nella notte per la sete e, nel buio, sbaglia stanza entrando in quella delle donne, oggetto di un desiderio irrivelabile e negate alla vista altrui dai dettami della purdah (letteralmente: tenda). Punizione: la morte. Rapida come era stata la grazia con cui era stato accettato e ospitato…
…Oggi a Kabul o a Herat si arriva in aereo. Si può ancora fare quella strada ma l’ossessione della guerra o dei sequestri fanno sì che il viaggiatore sia costretto ad aspettare l’ingresso nel sogno orientale non più a Mashhad ma a Dubai o ad Abu Dhabi, città ad aria condizionata (come Terzani battezzò Singapore nel suo Un indovino mi disse), senza calore umano e in compenso intorpidite da un clima torrido, umido, arrogante e impietoso come la gente del Golfo. L’aeroporto civile della capitale e quello della provincia occidentale – dal 2003 posta sotto controllo italiano – condividono la pista con panciuti aerei militari, grigi come il fumo delle bombe e anonimi come il colore della guerra. C’è poco fascino, se non per gli amanti di elmetti e gagliardetti, nel discendere una scaletta che approda su una terra ostile e polverosa che ospita città militarizzate in piena evoluzione e ormai quasi irriconoscibili. I bulldozer della famiglia Karzai, speculatori di Ankara o Dubai, ostinati ingegneri della sicurezza delle ambasciate, hanno ricoperto la capitale di cemento. I soldi della guerra avevano fatto dell’afghanis una moneta così forte che conveniva convertirla per comprare ovunque – fuorché in Afghanistan – merci che in Iran, Pakistan e Tagikistan costavano la metà. Facevano eccezione le noci di Baghlan o il melone di Kunduz, famoso per la succosa dolcezza, tra i pochi doni agricoli sopravvissuti: per il resto quasi tutto, dai pomodori alle uova, veniva e viene dai vicini. La bolla speculativa dell’economia di guerra – dall’edilizia alle commesse per gli scarponi dell’esercito – è però durata sino a quando i soldati americani e della Nato sono rimasti padroni del campo arrivando a contare 150mila militari e altre migliaia di contractor: con la loro presenza, accanto a una popolazione di diplomatici, umanitari e spioni, son stati una potente macchina per far girare i soldi. Adesso, che i soldati hanno iniziato ad andarsene con la fine nel 2014 della missione Isaf lasciando soltanto qualche migliaio di uomini a guardia del bidone, la bolla si è sgonfiata. E in un mercato del lavoro ormai asfittico dove i soldi facili son finiti e si affacciano ogni anno 400mila nuovi soggetti in cerca di occupazione, forse scenderà anche il prezzo di noci e meloni tanto quanto è scesa la speranza che la guerra, perfida matrigna, un giorno smetta di abbracciare questo Paese…
…Gli afgani sono poeti. Lo erano e lo restano ancora oggi. L’usignolo (bulbul) è un protagonista assoluto nei romanzi, nelle poesie e persino nei serial televisivi. Ne sa qualcosa Parwin Mushthal, attrice afgana di una serie televisiva intitolata appunto Bulbul e a cui gli islamisti hanno ucciso il marito per punirla. Per le donne è dura in questo Paese e lo era ovviamente anche negli anni Settanta. Eppure noi allora, pur essendo accompagnati da fervide femministe che il corpo è mio e lo gestisco io, facevamo poco conto a quella condizione di assoluta esclusione della figura femminile dal consesso sociale. Relativismo culturale? Facevano anche poca attenzione agli usignoli.
Nella casa che per alcuni anni abbiamo affittato a Kabul durante la guerra, sulle pendici di De Afghanan, il quartiere forse più antico della capitale, lo sguardo si perde fuori dalla finestra: si vedono le vette dell’Hindukush che circondano la città e i tetti delle case che in parte ancora sono fatti col sistema tradizionale: un miscuglio di fango e paglia che riveste gli ampi terrazzi e accompagna le balze degli edifici ammantati da un intonaco giallastro che ne segue le curve, come se fosse stato lavorato con le mani, anziché con la cazzuola. Siamo fortunati. Vediamo ancora una Kabul in via di rapida estinzione. Ancora, ma solo in parte, simile a quella città di soli 400mila abitanti (oggi son quattro milioni) che conoscemmo quarant’anni fa. Adesso che è iniziata cilleh-e-qurd, la seconda parte dell’inverno, il sole e il risveglio della natura cominciano a spandersi nei bagh, nei giardini aihmè sempre più rari in una città che ogni giorno costruisce palazzi nuovi e di dubbio gusto. Cilleh-e qalon, la prima parte dell’inverno, inizia invece col nostro solstizio del 21 dicembre e arriva in sostanza fino a fine gennaio. Dura 40 giorni come la fase successiva, cilleh-e-qurd, che segna la transizione di altri 40 giorni e che ci porterà fuori dal freddo secco dell’inverno. Da inguaribile romantico, lo ammetto, continuo a inseguire i segni del passato e dell’impossibile che è anche forse un modo per fingere che la guerra sia lontana e che, anche a Kabul, si possa vivere una vita normale: osservando il volo degli uccelli, spiando le gemme sui rami, indovinando suoni e bisbigli di una natura quotidianamente calpestata….
Carthago miranda est
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Carthago miranda est sembra essere il primo su Arabpress.
Consiglio di lettura: “Chicago” di ‘Ala Al-Aswani
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Consiglio di lettura: “Chicago” di ‘Ala Al-Aswani sembra essere il primo su Arabpress.
Iraq: la sospensione del referendum curdo e il concentramento di truppe militari ai confini del Kurdistan
I diversi scenari a cui deve far fronte il leader Barzani alle porte del referendum curdo previsto per il 25 settembre.
L’articolo Iraq: la sospensione del referendum curdo e il concentramento di truppe militari ai confini del Kurdistan sembra essere il primo su Arabpress.
Come ti insegno a uccidere meglio
Dopo l’assurdo errore del volantino sganciato dal cielo in cui un cane “cattivo”, animale impuro per l’islam, portava una frase del Corano sul corpo mentre era inseguito da un leone “buono” (l’idea era che il cane fossero i talebani), a dimostrazione di una confusa strategia anche mediatica, l’unica certezza all’orizzonte del nuovo surge trumpiano è che dal cielo non cadranno solo volantini ma sempre più bombe
Volantini dal cielo bombe dall’aria
 Dai cieli afgani non piovono solo volantini. La nuova strategia americana, fumosa e incerta, una sicurezza l’ha data: più bombe, più omicidi mirati, miglior utilizzo dell’arma aerea e un maggior impegno – con l’aiuto dei partner Nato – per costruire una forza aerea nazionale con più aerei e piloti meglio addestrati. Non è una novità perché è la stessa politica di Obama (meno soldati più bombe) ma con almeno tre differenze: la prima è che l’impegno di “stivali sul terreno” aumenterà: per ora siamo a oltre 15mila soldati ma potrebbero crescere; la seconda è che l’Afghanistan può essere un buon teatro dove testare nuove armi (come quella da 11 tonnellate sganciata nell’aprile scorso nella provincia orientale di Nangarhar, nella foto a sinistra); la terza è che sono tornati i B-52, le “fortezze volanti” rese note dalla guerra nel Vietnam. Già utilizzati in passato, non erano stati più usati a partire dal 2005 ma sono riapparsi nel 2012 quando giunsero a sganciare sino a 600 bombe nel mese di agosto di quell’anno. Poi c’è stato un nuovo arresto e ora sono ricomparsi con una media di 150 bombe al mese: ad agosto 2017 hanno superato quota 500. I B-52, gli stessi da cui sarebbero stati sganciati i volantini, portano normalmente bombe da 220 chili (Gbu-38/B) fino a una tonnellata (Gbu-31/B). Ogni aereo ne può portare sino a una trentina per un totale di 31 tonnellate, salvo che non si tratti della Gbu-43 Moab da 11 tonnellate di Tnt – quella utilizzata nel Nangarhar – che per la dimensione deve essere lanciata da un C-130.
Dai cieli afgani non piovono solo volantini. La nuova strategia americana, fumosa e incerta, una sicurezza l’ha data: più bombe, più omicidi mirati, miglior utilizzo dell’arma aerea e un maggior impegno – con l’aiuto dei partner Nato – per costruire una forza aerea nazionale con più aerei e piloti meglio addestrati. Non è una novità perché è la stessa politica di Obama (meno soldati più bombe) ma con almeno tre differenze: la prima è che l’impegno di “stivali sul terreno” aumenterà: per ora siamo a oltre 15mila soldati ma potrebbero crescere; la seconda è che l’Afghanistan può essere un buon teatro dove testare nuove armi (come quella da 11 tonnellate sganciata nell’aprile scorso nella provincia orientale di Nangarhar, nella foto a sinistra); la terza è che sono tornati i B-52, le “fortezze volanti” rese note dalla guerra nel Vietnam. Già utilizzati in passato, non erano stati più usati a partire dal 2005 ma sono riapparsi nel 2012 quando giunsero a sganciare sino a 600 bombe nel mese di agosto di quell’anno. Poi c’è stato un nuovo arresto e ora sono ricomparsi con una media di 150 bombe al mese: ad agosto 2017 hanno superato quota 500. I B-52, gli stessi da cui sarebbero stati sganciati i volantini, portano normalmente bombe da 220 chili (Gbu-38/B) fino a una tonnellata (Gbu-31/B). Ogni aereo ne può portare sino a una trentina per un totale di 31 tonnellate, salvo che non si tratti della Gbu-43 Moab da 11 tonnellate di Tnt – quella utilizzata nel Nangarhar – che per la dimensione deve essere lanciata da un C-130.
 Il totale delle bombe sganciate nel 2017 è 2.487, più della metà di quelle lanciate in tutto il 2012 ma solo 271 in meno che in tutto il 2013 e quasi il doppio di quelle del 2016. I B-52 sono coadiuvati nei bombardamenti da caccia F-16 e droni MQ-9. In totale 761 missioni con bombe (su 2.861 uscite) nel 2017. Sul fronte interno – spiega l’Air Power Summary americano del 31 agosto – “ L’Afghan Air Force ha espanso la sua capacità aerea con la prima operazione di sganciamento notturno il 22 agosto con propri C-208”. Train Advise Assist, come vuole l’imperativo della missione Nato “Supporto risoluto”.
Il totale delle bombe sganciate nel 2017 è 2.487, più della metà di quelle lanciate in tutto il 2012 ma solo 271 in meno che in tutto il 2013 e quasi il doppio di quelle del 2016. I B-52 sono coadiuvati nei bombardamenti da caccia F-16 e droni MQ-9. In totale 761 missioni con bombe (su 2.861 uscite) nel 2017. Sul fronte interno – spiega l’Air Power Summary americano del 31 agosto – “ L’Afghan Air Force ha espanso la sua capacità aerea con la prima operazione di sganciamento notturno il 22 agosto con propri C-208”. Train Advise Assist, come vuole l’imperativo della missione Nato “Supporto risoluto”.
Insegnare a bombardare meglio in un paese dove nei primi mesi del 2017, guarda caso, l’Onu ha segnalato un aumento del 43% negli incidenti dovuti ai raid aerei.
Regeni, i legali della famiglia al Cairo: “Polizia ha tentato di chiuderci lo studio”
Avevano chiesto protezione all’Italia la scorsa settimana, ma le loro richieste sono rimaste inascoltate. Nemmeno il ritorno dell’ambasciatore Gianpaolo Cantini al Cairo ha fermato, infatti, gli attacchi del governo egiziano contro l’Egyptian Commission for Rights and Freedom, l’organizzazione che rappresenta legalmente in Egitto la famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello trovato senza vita […]
L’articolo Regeni, i legali della famiglia al Cairo: “Polizia ha tentato di chiuderci lo studio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Cenni di divisione tra i curdi sull’alternativa al Referendum
Le Nazioni Unite propongono i negoziati e il monitoraggio del Consiglio di Sicurezza, al-‘Abadi suggerisce un intervento militare in caso di violenza
L’articolo Cenni di divisione tra i curdi sull’alternativa al Referendum sembra essere il primo su Arabpress.
Fantasmi birmani
Dopo un’attesa durata settimane la Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, sotto i riflettori della cronaca per l’esodo forzato di oltre 400mila rohingya, ha preso la parola e affrontato la questione. Sotto gli occhi delle telecamere e dei parlamentari e militari del Myanmar nel quale conta più di un nemico. L’attesa non è stata tradita e la leader de facto del governo birmano ha affrontato la questione con un lungo discorso, per certi versi anche coraggioso, ma che in sostanza ha difeso l’operato dell’esercito e messo davanti a tutto la stabilità del suo Paese. Un Paese sempre minacciato dal rischio di un golpe militare che non sarebbe nemmeno tale visto che la Costituzione lo prevede in caso la sicurezza nazionale sia compromessa. Suu Kyi dice che il suo governo non teme il “controllo internazionale” sulla gestione della crisi e ha dichiarato di sentirsi profondamente colpita per la sofferenza di “tutte le persone” imprigionate nel conflitto; che il Myanmar è comunque “impegnato in una soluzione sostenibile … per tutte le comunità”. Ha infine detto che non ci sono state “operazioni di pulizia”, la terribile accusa che è piovuta dall’Onu quando il Myanmar è stato appunto accusato di pulizia etnica.
Poche ore dopo il suo discorso, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra – da cui l’accusa è piovuta – ha chiesto l’accesso completo alla regione in modo da poter indagare la situazione “con i propri occhi”. Il suo messaggio al parlamento (con un discorso in inglese) è stato giudicato insufficiente da Amnesty International, che ha lamentato l’assenza di un riferimento diretto ed esplicito al ruolo dell’esercito nelle violenze nel Paese. Human Rights Watch dal canto suo continua invece a testimoniare il contrario di quanto il governo vorrebbe far credere (Suu Kyi ha detto che la maggior parte del Rakhine è in pace) perché, stando all’organizzazione, ci sono ancora “colonne di fumo che si levano dallo Stato del Rakhine”.
Ma l’aspetto forse più inquietante del discorso della Nobel è che non ha mai usato il termine “rohingya”, il nome della comunità che in Myanmar è un tabù perché la minoranza musulmana perseguitata (e ormai ridotta al lumicino dopo l’ennesimo esodo in Bangladesh) viene considerata solo una popolazione di immigrati illegali dal Bengala.
Il video integrale del discorso della Nobel ripreso da Al Jazeera
Vero è che il discorso pubblico richiedeva coraggio in un Paese dove il neo governo civile e democratico è sotto il tiro incrociato dei partiti di opposizione ma soprattutto dei militari. Ci voleva dunque coraggio a citare la missione affidata mesi fa a Kofi Annan che ha chiesto al Myanmar nel suo rapporto di rivedere la legge sulla cittadinanza che vieta ai rohingya di essere “birmani”. Un rapporto che il capo dell’esercito ha rigettato considerandolo “parziale” e per il quale Suu Kyi è stata accusata di avallare chi rema contro la stabilità del Paese. L’equilibrio è difficile: il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, nel ribadire la posizione del suo Paese, lo ha messo in luce: “Non possiamo assistere al ritorno di un regime militare” ed è dunque “vitale che Aung San Suu Kyi e il governo civile dicano chiaramente che questi abusi devono finire”. Una sorta di contraddizione in termini che rivela quanto la faglia sia sottile.
L’anno scorso, all’Assemblea generale delle Nazioni unite, la leader birmana aveva promesso di difendere i diritti delle minoranze e promesso anche impegno contro pregiudizi e intolleranza. Ma quest’anno, anche se il Myanmar non teme il “controllo internazionale”, la Nobel a New York non c’è. Per evitare imbarazzi e, alla fine, tener buoni i militari.
La crescente ondata di estremismo in Siria mette in pericolo la libertà delle donne
I gruppi estremisti minano la libertà di cui godevano le donne siriane e che per molto è stata il punto di forza della società siriana.
Il Ttp e le minoranze birmane
 «Massacri condotti e patrocinati dallo Stato, esecuzioni extragiudiziali, omicidi, sparizioni,
«Massacri condotti e patrocinati dallo Stato, esecuzioni extragiudiziali, omicidi, sparizioni,
annegamenti, stupri e violenze sessuali, distruzione di interi villaggi, negazione dei diritti in un cointesto di terrore promosso dallo Stato, diffuso e sistematico…». La lista delle accuse riempie cinque cartelle nel primo giorno in cui il Tribunale permanente dei popoli (Tpp) si riunisce a Kuala Lumpur per giudicare «…lo Stato del Myanmar, i dipartimenti del governo, il complesso militare nel suo insieme, polizia, polizia di frontiera, membri della Lega Nazionale per la Democrazia, il presidente, Htin Kyaw, e la consigliera, Aung San Suu Kyi, accusati di detti crimini in relazione ai gruppi etnici Kachin e Rohingya e alla popolazione islamica…». C’è altro: pur se non rientra nell’ambito di queste accuse, la Procura riconosce «il ruolo significativo dei media, degli ultranazionalisti del Rakhine e delle organizzazioni buddiste anti-musulmane estremiste nella diffusione di propaganda anti-musulmana e anti-Kachin, nell’incitamento all’odio con discorsi e ideologie atte a promuovere e raccogliere il sostegno pubblico per la persecuzione di questi gruppi…».
Benché le sentenze del Tribunale non siano vincolanti e benché si tratti per ora solo di accuse, per la prima volta in questi anni un gruppo autorevole di ricercatori e magistrati della società civile mette sotto accusa senza mezzi termini la politica birmana sulle minoranze e, in particolare, sui Kachin e i Rohingya per i quali Amnesty International chiede la fine della “pulizia etnica” e Human Right Watch chiede al Consiglio di sicurezza sanzioni e embargo sulla vendita di armi al Myanmar. Intanto la vicenda dei profughi verso il Bangladesh – 400mila – si avvicina alla “catastrofe umanitaria” prevista dal segretario generale dell’Onu Guterres. (Em. Gio.)-
Palestina: verso una riconciliazione con Abbas?
I mesi scorsi hanno fatto sperare in una riconciliazione in Palestina e risoluzione alla situazione della Striscia di Gaza. Ma presto la realtà ha sfatato ogni mito e illusione.
L’articolo Palestina: verso una riconciliazione con Abbas? sembra essere il primo su Arabpress.
Che bestialità vietare il cricket nei parchi italiani!
 |
| Foto tratta da EastWest |
“Il recente ferimento di un bimbo di due anni, colpito alla testa da una pallina vagante mentre era sul balcone di casa, ha indotto il sindaco (di Bolzano) Renzo Caramaschi a vietare lo sport più amato dalla comunità pakistana” rende noto una cronaca del Corsera del 12 settembre. Per ora, scrive Francesco Clementi, il provvedimento di veto sul cricket è limitato a Parco Mignone, ma si valuta l’estensione a tutti gli spazi aperti, dopo una “valutazione con rappresentanti della comunità pakistana”. In effetti una palla di cricket, una sorta di solido agglomerato di pelle di cervo, può arrivare a 150 km/h di velocità anche se questo attrezzo fondamentale del gioco più famoso dell’Impero britannico e delle sue colonie è così costoso che i giovani giocatori gli devono spesso preferire le più volgari palle da tennis. Non sappiamo quanto il bambino sia stato ferito ma sappiamo bene quanto possa far male una pallina da tennis: nella finale junior degli Us Open edizione 1983 per esempio, un giudice di linea fu colpito all’inguine da un “servizio killer” che lo precipitò a terra dove batté la testa e morì. Se invece si avesse la voglia di scorrere google per vedere tutti gli effetti collaterali di un pallone da calcio, si troverebbero circa un paio di milioni di risultati dove la sfera è una truce protagonista, più o meno diretta (“colpito da pallone in spiaggia sviene” “insegue pallone e viene travolto da un’auto” “cerca pallone e cade dal tetto”…). Nessuno però ha mai pensato di vietare il tennis e soprattutto il pallone nei parchi pubblici. Vien da pensare che, come spesso accade con le cose che non conosciamo, l’ignoranza connessa alla diffidenza finisca per produrre scelte sconsiderate…. (continua su EastWest)
Viaggio all’Eden in Trentino
Presento Viaggio all’Eden domenica sera a Flavon (ore 20.30, sala civica del Municipio) – organizzato da La Viaggeria e presentato da Raffaele Crocco.Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ritorna sulla rotta degli anni Settant…
La parità tra sessi in materia d’eredità è possibile e necessaria
La liberalizzazione legislativa delle donne tunisine è legata allo sviluppo interno e ai cambiamenti della società stessa.
L’articolo La parità tra sessi in materia d’eredità è possibile e necessaria sembra essere il primo su Arabpress.
Come ti insegno a uccidere meglio
Dopo l’assurdo errore del volantino sganciato dal cielo in cui un cane “cattivo”, animale impuro per l’islam, portava una frase del Corano sul corpo mentre era inseguito da un leone “buono” (l’idea era che il cane fossero i talebani), a dimostrazione di una confusa strategia anche mediatica, l’unica certezza all’orizzonte del nuovo surge trumpiano è che dal cielo non cadranno solo volantini ma sempre più bombe
Volantini dal cielo bombe dall’aria
 Dai cieli afgani non piovono solo volantini…(continua nei prossimi giorni su il manifesto in un articolo a due mani con Giuliano Battiston)
Dai cieli afgani non piovono solo volantini…(continua nei prossimi giorni su il manifesto in un articolo a due mani con Giuliano Battiston)
Marocco: Il discorso del re per la Festa del Trono non ha convinto molti
“Il re si preoccupa molto della sua immagine. Niente viene lasciato al caso, tutto è molto calcolato”.
Jeu et sport. Comprendre les enjeux entre pratiques de développement, protection et migration
(Photo by Right to Play-Ethiopia). Appel à communications pour l’atelier: Jeu et sport. Comprendre les enjeux entre pratiques de développement, protection et migration WOCMES 2018 Séville (Espagne) 16-20 Juillet 2018. Suite aux derniers flux migratoires provenant de certains pays du Moyen-Orient, les organisations internationales humanitaires mettent en place des projets de développement ayant comme moyen […]![]()
Lo ius soli visto dai rohingya
 Il villaggio di Yandabo si trova nel Myanmar centrale sulle rive del fiume Ayeyarwady ed è famoso oggi per i suoi manufatti in terracotta. Ma il 24 febbraio del 1826 fu il teatro di un trattato tra birmani e britannici a conclusione della prima guerra anglo-birmana.
Il villaggio di Yandabo si trova nel Myanmar centrale sulle rive del fiume Ayeyarwady ed è famoso oggi per i suoi manufatti in terracotta. Ma il 24 febbraio del 1826 fu il teatro di un trattato tra birmani e britannici a conclusione della prima guerra anglo-birmana.
In un certo senso il dramma dei rohingya, la minoranza musulmana di lingua bengalese oggetto in queste settimane di una persecuzione che ne ha espulsi circa 380mila dal Myanmar in Bangladesh, è iniziata a Yandabo oltre duecento anni fa. A quell’epoca l’attuale stato di Rakhine – luogo di residenza dell’ormai sempre più ridotta comunità rohingya – era ancora sotto l’influenza birmana, le cui monarchie avevano sottomesso i regni indipendenti di questo territorio affacciato sul Golfo del Bengala. Gli interessi dei birmani e quelli della East India Company, che da Calcutta dirigeva l’espansione dell’impero commerciale con sede a Londra, entrarono in conflitto a spese del Rakhine e di altre regioni sotto dominio birmano. E la guerra privò i birmani, col trattato di Yandabo, del territorio che un tempo, prima delle invasioni da Est, arrivava fino all’odierna Chittagong, la seconda città dell’attuale Bangladesh….
Continua su Reset
La possibile indipendenza curda fa preoccupare il mondo arabo
Le condizioni per uno stato curdo a pochi giorni dal referendum per l’indipendenza, previsto il 25 settembre
L’articolo La possibile indipendenza curda fa preoccupare il mondo arabo sembra essere il primo su Arabpress.
Il parlamento tunisino approva la legge per l’amnistia dei corrotti
Patrizia Mancini Ieri, 13 settembre 2017, il famigerato progetto per la riconciliazione amministrativa è diventato legge dello Stato con 117 voti a favore, un’astensione, 9 voti contrari e la non partecipazione al voto da parte dell’opposizione. Opposizione che, a più riprese, aveva chiesto che il testo venisse sottoposto all’esame del Consiglio Superiore della Magistratura (in Tunisia ancora non è ancora […]
Catastrofe sui rohingya
 |
| Si aggiungono sempre nuovi campi profughi come spiega l’infografica di Al Jazeera. Sianmo a quota 380mila |
E’ forse stata anche la decisione di Aung San Suu Kyi di non partecipare alla prossima Assemblea dell’Onu a New York a scuotere nuovamente il Palazzo di Vetro sulla questione rohingya. Il segretario generale Antonio Guterres, che già aveva preso posizione nei giorni scorsi ma non si era spinto così avanti, ha usato ieri parole forti: la situazione di questa minoranza si avvia ad essere “catastrofica” e sono “completamente inaccettabili” le azioni dei militari birmani che devono essere sospese. Le parole di Guterres – e nel linguaggio della diplomazia a volte anche un solo termine o un rafforzativo fanno la differenza – segnano un livello sempre più alto nell’asticella che registra gli umori della comunità internazionale e la sensibilità delle agenzie umanitarie – dell’Onu e non – che non riescono a fare il proprio lavoro per dare sollievo alla minoranza rohingya – circa 380mila persone – che nel giro di due settimane sono scappate dal Myanmar. Fuggite per la “spropositata reazione” (sono ancora parole dell’Onu) delle forze dell’ordine birmane all’attacco di un gruppo armato rohingya il 25 agosto scorso a diversi posti di polizia. Il crescendo è iniziato con le dichiarazioni dell’inviato speciale per il Myanmar, la docente coreana Yanghee Lee, che di fatto non ha potuto fare la sua inchiesta. Poi, Zeid Ra’ad Al Hussein – Alto commissario per i diritti umani – ha usato senza girarci troppo intorno la locuzione “pulizia etnica”. Anzi, una pulizia etnica – ha detto – “da manuale”.
La posizione critica dell’Onu ha continuato a inasprirsi riflettendo il contegno del governo e soprattutto della sua leader de facto, la Nobel Aung San Suu Kyi. Che prima ha rotto il suo imbarazzante silenzio per denunciare un “iceberg di disinformazione” in quella che definito “propaganda” sulla questione rohingya. Poi ha deciso di disertare la prossima Assemblea generale dell’Onu, un palco pubblico dove ha già difeso le posizioni del suo governo l’anno scorso (dopo le violenze dell’ottobre 2016) ma che quest’anno rischierebbe di vederla oggetto di pesanti accuse, soprattutto dai Paesi musulmani ma anche da molte organizzazioni della società civile: da Human Rights Watch ad Amnesty, da Msf alle varie organizzazioni rohingya o semplicemente attive nel campo dei diritti.
Guterres comunque, nel rivolgersi al governo e ai militari birmani, stava in realtà mandando anche un segnale al Consiglio di sicurezza dell’Onu, riunito per la seconda volta sulla questione rohingya ma dove soprattutto Cina e Russia frenano prese di posizione troppo dure. Il motivo è chiaro: la situazione nel Myanmar è drammatica per i rohingya ma è estremamente pericolosa anche per il governo di Suu Kyi: un governo debole, nonostante i numeri, e ostaggio del vecchio potere militare. Pechino, soprattutto, non vuole instabilità nei Paesi dove investe. E quanto sia complicata la situazione lo si vede in questi giorni: mentre all’estero il dibattito continua ad allargarsi (sono state Svezia e Gran Bretagna a chiedere al CdS dell’Onu di riunirsi e che però si è limitato a chiedere “passi immediati per por fine alle violenze”) in casa le acque sono agitate. Una coalizione di 29 partiti con a capo l’Union Solidarity and Development Party (erede del vecchio governo militare) ha condannato il governo per aver dato ascolto al consiglio della Rakhine advisory commission, capeggiata su incarico di Suu Kyi dall’ex segretario Onu Kofi Annan, accusato di “parzialità” dal capo dell’esercito birmano, generale Min Aung Hlaing. La commissione chiede che sia rivista la legge del 1982 sulla nazionalità, legge che ne esclude i rohingya. I partiti non solo usano termini minacciosi ma bollano il rapporto di Annan come opera di “traditori e gruppi stranieri che vogliono distruggere la nazione”.
E a dare una mano a chi sulla questione agita lo spettro dell’islamismo radicale ci si mette anche Al Qaeda: in un comunicato reso noto dal sito di intelligence SITE i qaedisti accusano il governo del Myanmar di un “trattamento selvaggio” dei fratelli musulmani che deve essere “punito”. Minacce di altro tipo dunque ma che alimentano la propaganda dei militari secondo cui esiste un piano che si serve di “terroristi” jihadisti per distruggere il Paese. Il gruppo sotto accusa però, l’Arsa, non ha legami – per quanto si sa – né con Al Qaeda né con lo Stato islamico.
“Otto mesi a Ghazzah Street” di Hilary Mantel
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Otto mesi a Ghazzah Street” di Hilary Mantel sembra essere il primo su Arabpress.
Rohingya: chi è questa minoranza musulmana perseguitata in Myanmar?
Numerosi video e foto che circolano sui social mostrano la sanguinosa violenza a cui è sottoposta questa minoranza musulmana da parte dell’esercito birmano, nonostante il silenzio della comunità internazionale
L’articolo Rohingya: chi è questa minoranza musulmana perseguitata in Myanmar? sembra essere il primo su Arabpress.
Caso Regeni, ritrovato l’avvocato egiziano della famiglia. E’ accusato di danneggiare la sicurezza nazionale
Dopo due giorni di ricerche Ibrahim Metwally, l’avvocato per i diritti umani che collabora con l’organizzazione che rappresenta la famiglia Regeni al Cairo, è stato ritrovato. Al momento è detenuto in un edificio dietro il tribunale del 5th Settlement nella periferia est del Cairo. Martedì pomeriggio Metwally ha affrontato un interrogatorio, le accuse sono di danneggiare la […]
L’articolo Caso Regeni, ritrovato l’avvocato egiziano della famiglia. E’ accusato di danneggiare la sicurezza nazionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
Report della riunione del 9 settembre del comitato promotore della manifestazione del 7 ottobre “Pace e libertà per il popolo siriano e tutti i popoli oppressi! Accoglienza, senza condizioni, per tutti i profughi e gli immigrati!”
Siamo ad un mese dalla manifestazione e siamo convinti delle ragioni che ci hanno spinto a convocarla. Salutiamo con soddisfazione la notizia che per lo stesso giorno è convocata una manifestazione sugli stessi contenuti del nostro appello a Barcellona, città così gravemente colpita dalla violenza assassina del terrorismo mentre è stata protagonista della più grande […]![]()
In viaggio in Puglia con la poesia di Mahmud Darwish
Parte oggi Il viaggio di Darwish, progetto di Iyas Jubeh e Bruno Soriato dell’associazione Kuziba, che per 20 giorni porterà per la Puglia la poesia del poeta palestinese Mahmud Darwish, percorrendo l’antica via Francigena fino ad arrivare idealmente allo sbocco sul mare pugliese, antico punto di imbarco dei pellegrini che si mettevano per mare per […]![]()
L’Onu a chiare lettere: in Myanmar pulizia etnica
 |
| L’Alto commissario Zeid Ra’ad Al Hussein |
…According to UNHCR, in less than three weeks over 270,000 people have fled to Bangladesh, three times more than the 87,000 who fled the previous operation. Many more people reportedly remain trapped between Myanmar and Bangladesh. The operation, which is ostensibly in reaction to attacks by militants on 25 August against 30 police posts, is clearly disproportionate and without regard for basic principles of international law. We have received multiple reports and satellite imagery of security forces and local militia burning Rohingya villages, and consistent accounts of extrajudicial killings, including shooting fleeing civilians.
I am further appalled by reports that the Myanmar authorities have now begun to lay landmines along the border with Bangladesh, and to learn of official statements that refugees who have fled the violence will only be allowed back if they can provide “proof of nationality”. Given that successive Myanmar governments have since 1962 progressively stripped the Rohingya population of their political and civil rights, including citizenship rights – as acknowledged by Aung San Suu Kyi’s own appointed Rakhine Advisory Commission – this measure resembles a cynical ploy to forcibly transfer large numbers of people without possibility of return.
Last year I warned that the pattern of gross violations of the human rights of the Rohingya suggested a widespread or systematic attack against the community, possibly amounting to crimes against humanity, if so established by a court of law. Because Myanmar has refused access to human rights investigators the current situation cannot yet be fully assessed, but the situation seems a textbook example of ethnic cleansing…
Estratto da
Darker and more dangerous: High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights issues in 40 countries
Human Rights Council 36th session / Opening Statement by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights/ 11 sept 2017
Le due mappe tematiche sono scelte da un servizio dedicato di Al Jazeera
Regeni, avvocati egiziani della famiglia dopo la sparizione del collega: “L’Italia ci deve proteggere”
“Il governo italiano ci deve proteggere, siamo in pericolo perché le autorità egiziane ci hanno dichiarato guerra”. Ahmed Abdallah, il presidente dell’Egyptian Commission for Rights and Freedom, l’organizzazione che rappresenta legalmente al Cairo la famiglia di Giulio Regeni, lancia un appello disperato dopo la sparizione di un loro collaboratore Ibrahim Metwally, avvocato per i diritti […]
L’articolo Regeni, avvocati egiziani della famiglia dopo la sparizione del collega: “L’Italia ci deve proteggere” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Guerra in Siria: l’inizio della fine?
In linea con i recenti avvenimenti, il conflitto siriano sta entrando nella fase iniziale della sua fine ma il terrorismo resta comunque una minaccia concreta.
L’articolo Guerra in Siria: l’inizio della fine? sembra essere il primo su Arabpress.
La Turchia e la Russia si incontrano in Siria contro Iran e curdi
Il Medio Oriente, e soprattutto la Siria, è oggi conteso tra vari popoli da Oriente e Occidente ma non dagli arabi. Un’analisi della scrittrice libanese Hoda alHusseini.
L’articolo La Turchia e la Russia si incontrano in Siria contro Iran e curdi sembra essere il primo su Arabpress.
Addio a Nancy Dupree
Nancy Hatch Dupree, cittadina americana nata in Kerala nel 1927 è morta ieri a Kabul all età di 89 anni.
All’Afghanistan ha dedicato sforzi, passione e amore anche nei momenti più difficili. E non ha voluto lasciare il Paese per far ritorno negli Usa a farsi curare. Addio Nancy e che onore averti conosciuta! Grazie per il lavoro che hai fatto.
A Mosul si è svolto il primo festival letterario dopo la liberazione dall’Isis
Sono giovani e più anziani, sorridenti, sono uomini, donne e bambini. Sono tantissimi. A centinaia si sono dati appuntamento mercoledì 6 settembre nei giardini della Biblioteca centrale dentro l’Università di Mosul, in Iraq, per partecipare al primo Festival della lettura di Mosul. Sono passati pochi mesi da quando la città, ex roccaforte irachena dell’Isis, è […]![]()
Gruppi locali denunciano l’aumento dei suicidi nella comunità araba impoverita degli Ahwazi
Gli Ahwazi arabi sono sistematicamente discriminati in Iran. Alcune persone hanno dovuto cambiare nome e cognome, nascondendo la propria identità, per trovare lavoro”.
Mosul, sfollati della città martire dell’Isis tra depressione e sete di vendetta: ‘Bimbi pensano di essere stati puniti da Dio’
Gli ottanta chilometri di strada che vanno dalla città di Erbil a Mosul sono sono una piana costellata di campi profughi in cui hanno trovato rifugio parte degli 838.000 sfollati della battaglia che lo scorso luglio ha portato alla caduta della capitale irachena dello Stato Islamico. Agglomerati con migliaia di tende bianche delimitate da una […]
L’articolo Mosul, sfollati della città martire dell’Isis tra depressione e sete di vendetta: ‘Bimbi pensano di essere stati puniti da Dio’ proviene da Il Fatto Quotidiano.
In una città sotto assedio, dei Siriani stanno imparando a coltivare funghi per sopravvivere
“Vogliamo diffondere questa idea al mondo per far conoscere il nostro successo ma anche la nostra lotta contro la fame e l’assedio”
Ci siamo: luce verde ai soldati Usa in Afghanistan
 Un ufficiale delle forze armate americane ha detto ieri ad ABC che il ministro Mattis ha firmato ‘ ordine di invio in Afghanistan per 3500 soldati, poco meno dei 4mila previsti. Mattis, il titolare della Difesa, aveva confermato la firma dell‘ordine ma senza dare dettagli. Bizzarro! E pensare che qualche giorno fa, per dovere di trasparenza, il Pentagono aveva detto che i militari Usa in Afghanistan sono 11mila e non 8.400 come si era sempre detto. Cento più, cento meno, mille più mille meno, che differenza fa del resto? E la guerra bellezza e i dettagli han poca importanza.
Un ufficiale delle forze armate americane ha detto ieri ad ABC che il ministro Mattis ha firmato ‘ ordine di invio in Afghanistan per 3500 soldati, poco meno dei 4mila previsti. Mattis, il titolare della Difesa, aveva confermato la firma dell‘ordine ma senza dare dettagli. Bizzarro! E pensare che qualche giorno fa, per dovere di trasparenza, il Pentagono aveva detto che i militari Usa in Afghanistan sono 11mila e non 8.400 come si era sempre detto. Cento più, cento meno, mille più mille meno, che differenza fa del resto? E la guerra bellezza e i dettagli han poca importanza.
l
Tunisia, in attesa delle elezioni comunali
Con le elezioni previste per dicembre, si potrà riscontrare il peso effettivo sul terreno dei vari partiti tunisini.
L’articolo Tunisia, in attesa delle elezioni comunali sembra essere il primo su Arabpress.
Passaggi: “Canto d’amore per le parole” di Nazik al-Mala’ika
In questi giorni di rientro definitivo dalle vacanze estive, dopo giorni di calma e silenzio, voglio dedicarvi un estratto di questo inno alle parole di Nazik al-Mala’ika, tradotta a Manuela Rasori. Canto d’amore per le parole Perché abbiamo paura delle parole quando sono state mani dal palmo rosa delicate quando ci accarezzano gentilmente […]
L’articolo Passaggi: “Canto d’amore per le parole” di Nazik al-Mala’ika sembra essere il primo su Arabpress.
L’Iran esorta il restauro dell’alleanza sciita
I protagonisti del dialogo tra le forze sciite nel rapporto Iran – Iraq
L’articolo L’Iran esorta il restauro dell’alleanza sciita sembra essere il primo su Arabpress.
Un bookclub di letteratura araba a Sesto San Giovanni
Dal 20 settembre a Sesto San Giovanni parte un club del libro dedicato alla letteratura araba contemporanea: il primo libro del club sarà L’italiano, di Shukri al-Mabkhut (e/o, 2017). Ho fatto qualche domanda a Jolanda Guardi, esperta e traduttrice di letteratura araba, e promotrice dell’iniziativa. Perché un club del libro sulla letteratura araba? Volevo fare […]![]()
Venerdi a Ostuni Viaggio all’Eden
Festival della Letteratura di Viaggio
direttore artistico: Antonio Politano
X edizione
Ostuni 8-10 settembre 2017
Venerdi 8 settembre
Ore 20.30
Fino a Kathmandu e Brindisi, dalla Macedonia alla Siria
Chiostro di San Francesco, Piazza della Libertà
[«Conoscere i luoghi, vicino o lontani, non vale la pena, non è che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica, è vera geografia», Wolfgang Johann Goethe] Visioni locali e globali, in alcune produzioni dell’editoria nata in Puglia, dall’editore di respiro e prestigio nazionale alle piccole case editrici di qualità. Incontro con Emanuele Giordana, autore di Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu (Laterza), Matteo Sabato, per Crocevia, rivista di scritture straniere, migranti e di viaggio (Besa), Pierfrancesco Rescio, autore di Via Appia. Strada di imperatori, soldati e pellegrini e Via Traiana. Una strada lunga duemila anni (Schena Editore). Con accompagnamento musicale e letture.
Visioni locali e globali, in alcune produzioni dell’editoria nata in Puglia, dall’editore di respiro e prestigio nazionale alle piccole case editrici di qualità. Incontro con Emanuele Giordana, autore di Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu (Laterza), Matteo Sabato, per Crocevia, rivista di scritture straniere, migranti e di viaggio (Besa), Pierfrancesco Rescio, autore di Via Appia. Strada di imperatori, soldati e pellegrini e Via Traiana. Una strada lunga duemila anni (Schena Editore). Con accompagnamento musicale e letture.
La diaspora rohingya nel mondo
Fonte: Al Jazeera settembre 2017Oggi 7 settembre: According to the UN office in Cox’s Bazaar, over 164,000 refugees have crossed into Bangladesh since August 25 [Mohammad Ponir Hossain/Reuters]
Rohingya? Una montagna di bugie dice Suu Kyi
 Mentre Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e ministro degli Esteri del Myanmar, liquida la questione rohingya come un “enorme iceberg di disinformazione”, fonti del governo di Dacca citate dalla stampa locale accusano i soldati birmani di aver disseminato mine antiuomo lungo il confine col Bangladesh per impedire ai profughi di far ritorno nel “loro” Paese. Il governo di Dacca ha consegnato ieri pomeriggio una protesta formale ai diplomatici di Naypyidaw e, anche se nelle note ufficiali non si fa menzione di ordigni, nell’incontro al ministero degli Esteri della capitale bangladese la questione sarebbe stata affrontata. Se la notizia fosse confermata (cioè causando vittime) sarebbe di estrema gravità proprio nel momento in cui le prime reazioni alla persecuzione della minoranza musulmana del Myanamr cominciano sempre di più a travalicare i confini nazionali dei due Stati coinvolti: il Myanmar che caccia e il Bangladesh che accoglie. Il flusso dei profughi si sarebbe attestato a oltre 10mila unità al giorno e, secondo le Nazioni unite, martedi scorso il bilancio sarebbe già stato di 125mila. Non è però chiaro quanti riescano di fatto a passare il fiume Naf che divide come frontiera i due Paesi: molti sarebbero infatti imprigionati nello no man’s land tra i due Stati asiatici.
Mentre Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e ministro degli Esteri del Myanmar, liquida la questione rohingya come un “enorme iceberg di disinformazione”, fonti del governo di Dacca citate dalla stampa locale accusano i soldati birmani di aver disseminato mine antiuomo lungo il confine col Bangladesh per impedire ai profughi di far ritorno nel “loro” Paese. Il governo di Dacca ha consegnato ieri pomeriggio una protesta formale ai diplomatici di Naypyidaw e, anche se nelle note ufficiali non si fa menzione di ordigni, nell’incontro al ministero degli Esteri della capitale bangladese la questione sarebbe stata affrontata. Se la notizia fosse confermata (cioè causando vittime) sarebbe di estrema gravità proprio nel momento in cui le prime reazioni alla persecuzione della minoranza musulmana del Myanamr cominciano sempre di più a travalicare i confini nazionali dei due Stati coinvolti: il Myanmar che caccia e il Bangladesh che accoglie. Il flusso dei profughi si sarebbe attestato a oltre 10mila unità al giorno e, secondo le Nazioni unite, martedi scorso il bilancio sarebbe già stato di 125mila. Non è però chiaro quanti riescano di fatto a passare il fiume Naf che divide come frontiera i due Paesi: molti sarebbero infatti imprigionati nello no man’s land tra i due Stati asiatici.
Quanto alla Nobel, accusata di un silenzio imbarazzante e connivente con le scelte dei militari e che è stata fortemente criticata da altri Nobel – come Malala – e dalla stessa Amnesty International (l’organizzazione che per anni ha seguito il suo caso), il suo ufficio ha reso nota una telefonata che Suu Kyi ha avuto con Erdogan, il leader turco che tra i primi ha criticato il Myanmar sulla questione rohingya (pur avendo di che riflettere su quanto Ankara sta facendo con gli oppositori al regime). Suu Kyi sostiene che l’intera vicenda è frutto di disinformazione di cui sarebbero colpevoli “terroristi”, come i militari hanno definito il gruppo armato secessionista responsabile degli attacchi del 25 agosto che hanno dato la stura a una una reazione brutale dell’esercito birmano. Secondo Suu Kyi, il suo Paese sta già difendendo la popolazione dello Stato di Rakhine, dove vive la maggior parte dei rohingya, “nel miglior modo possibile”. Commento assai poco credibile anche perché l’unico in sostanza fatto dalla Nobel sulla vicenda.
 |
| Lelio Basso: Qui le dichiarazioni dei giudici del Tpp al lancio della sessione sul Myanmar che si è tenuta a Londra, nel marzo del 2017 |
Per ora, soprattutto da parte occidentale (con l’esclusione del papa che andrà in Myanmar a fine novembre), le reazioni al dramma della minoranza senza cittadinanza del Myanmar sono state blande e poco più che formali. Solo il Palazzo di Vetro ha preso una posizione chiara e lo stesso stanno facendo soprattutto Paesi a maggioranza musulmana. La Malaysia, la prima nazione ad aver usato per i rohingya il termine “genocidio”, ospiterà tra l’altro dal 18 al 22 settembre una sessione del Tribunale Permanente dei Popoli (Ttp, fondato da Lelio Basso a prosecuzione del lavoro del Tribunale Russell II) che si occuperà dei crimini commessi dal Myanmar nei confronti delle minoranza e in particolare nei casi dei Rohingya, dei Kachin e dei musulmani (5% della popolazione). E’ stata proprio Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia che ha vinto le elezioni del 2015, a non volere candidati musulmani nel suo partito. Allora la questione rohingya aveva già visto le prime violenza – nel 2012 – da parte di gruppi mobilitati da estremisti buddisti anche con l’abito monacale. Ma in seguito, nel 2016, i pogrom si sono ripetuti con l’effetto di cacciare oltre 70mila rohingya. Questa volta il numero dei profughi si è già raddoppiato: si lasciano alle spalle una regione in fiamme e dove questa volta sono già morte 400 persone.
Calais, un anno dopo la Giungla
Calais, ottobre 2016. La Giungla, la più grande bidonville d’Europa, viene smantellata. Si parla di quasi 10.000 persone ricondotte verso i centri d’accoglienza e di orientamento, i famosi CAO, sparsi per tutta la Francia. Immagini di una città in fiamme…. Continue Reading →![]()
UFFICIALE: PER L’O.N.U., ASSAD E’ IL RESPONSABILE DEL BOMBARDAMENTO CHIMICO SU KHAN SHEIKHOUN E DI ALTRI 25 ATTACCHI CON ARMI CHIMICHE
6 settembre 2017 O.N.U.: Le forze governative siriane hanno usato armi chimiche più di due dozzine di volte. Ginevra (REUTERS) – Le forze siriane hanno usato armi chimiche più di due dozzine di volte durante la guerra civile nel Paese, incluso l’attacco mortale di aprile a Khan Sheikhoun, hanno affermato mercoledì i ricercatori dell’O.N.U. sui […]![]()
Adania Shibli, Ali Bader e Mohamed Moksidi al Festival salentino “Alle radici del gesti”
Alle radici dei gesti è un progetto culturale nato in Salento che racchiude l’essenza del Teatro dei Luoghi/Fineterra: è un festival itinerante che si terrà dal 6 al 13 settembre, nato dall’incontro tra le due importanti esperienze culturali salentine, che nel Salento si radica e si sviluppa ma che guarda anche oltre la Puglia. Ad […]![]()
Quale ‘ragion di Stato’? Quella dei diritti o quella degli affari?
Solo chi non conosce l’Egitto può affermare che rimandare il nostro ambasciatore al Cairo possa avvicinare alla verità sull’assassinio di Giulio Regeni. La decisione del governo italiano ha reso il nostro paese più debole di fronte all’Egitto e ha dato il via libera a violazioni ancor più patenti dei diritti umani e civili. Non sonoContinua a leggere
Regeni, l’Egitto oscura il sito dei legali della famiglia: “E’ la vendetta di Al Sisi. Da Roma ok per far dimenticare Giulio”
“Il regime sta iniziando la vendetta contro di noi”. Ahmed Abdallah è il presidente dell’Egyptian Commission for Rights and Freedom, l’organizzazione egiziana che rappresenta legalmente la famiglia di Giulio Regeni in Egitto. La preoccupazione nella sua voce è tangibile perché questa mattina il sito web dell’ECRF è stato bloccato dalle autorità del Cairo. Sorte già toccata […]
L’articolo Regeni, l’Egitto oscura il sito dei legali della famiglia: “E’ la vendetta di Al Sisi. Da Roma ok per far dimenticare Giulio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Marocchini e stupro domestico: un tabù sociale sotto copertura religiosa
Dietro ai casi di violenza sessuale e i tentativi di stupro che hanno interessato l’opinione pubblica marocchina, diversi attivisti sollevano la questione dello stupro domestico
L’articolo Marocchini e stupro domestico: un tabù sociale sotto copertura religiosa sembra essere il primo su Arabpress.
Un gruppo di scrittori libici è in pericolo
Questo post è apparso in inglese sul noto blog di letteratura araba (in inglese) ArabLit, di Marcia L. Qualey. Lo traduco qui in italiano perché credo che possa interessare a tutti sapere cosa succede ai letterati libici che fanno cultura in Libia, oggi (e anche perchè ultimamente si parla spesso di Libia, ma non di […]![]()
Per schierarsi dalla parte dell’amore, il Pride di Beirut ha dovuto prevalere sull’odio
L’hotel dove doveva tenersi il primo evento ha disdetto a causa di pressioni da gruppi religiosi. Ma il Pride di Beirut non si è fermato!
Tunisia, la legge contro la violenza maschile sulle donne: tra diritto e trasformazione radicale
Arianna Taviani Dopo una settimana di accesi dibattiti in seno al parlamento tunisino, il 26 luglio, il progetto di legge organica n. 2016-60 per il contrasto alle violenze di genere è stato adottato all’unanimità dai 146 deputati presenti. Poco più tardi, l’11 agosto, il Presidente della Repubblica, Béji Caïd Essebsi, ha posto la sua firma al testo: la Tunisia si […]
Rohingya/Rakhine. Chi ha appiccato il fuoco? (aggiornato)*
 |
| La bandiera dei secessionisti. Per il governo sono loro ad aver distrutto migliaia di case |
Mentre il Programma alimentare dell’Onu ha deciso di sospendere gli aiuti nello Stato birmano del Rakhine dove, dal 25 agosto, infuria l’ennesimo pogrom contro la minoranza rohingya, i militari del Myanmar hanno innescato anche una guerra di numeri. Fonti governative hanno tracciato un bilancio di 2.625 case date alle fiamme nei villaggi di Kotankauk, Myinlut e Kyikanpyin e in due distretti. Ma sarebbero case incendiate dall’Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army), il gruppo armato definito “terrorista” responsabile degli attacchi di agosto. Un conteggio che non risponde a quanto affermano le testimonianze degli sfollati e le ricerche di Human Rights Watch che accusano i militari della responsabilità degli incendi: «Nuove immagini mostrano la totale distruzione di un villaggio musulmano e fanno crescere seriamente la preoccupazione che tale stato di devastazione nel Nord del Rakhine possa essere ben più vasto di quanto credevamo», ha detto alla Reuters Phil Robertson il vicedirettore Asia dell’organizzazione. In quel villaggio il 99% degli edifici è andato in fumo.
Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati il bilancio di chi è in fuga verso il Bangladesh ha ormai sfondato quota 58mila sabato e quota 75mila domenica e fa pensare che il pogrom sia di proporzioni ancora più vaste di quello dell’ottobre scorso, quando in migliaia scapparono verso il Paese vicino. Ma oggi le condizioni sono cambiate e il Bangladesh oppone resistenza per evitare un’altra invasione di profughi in un Paese dove povertà e sovrappopolazione sono due costanti. La gente resta dunque intrappolata nella no man’s land tra i due Paesi mentre il flusso alla frontiera non si arresta.
 |
| Il lavoro di Hrw attraverso il satellite contraddice la versione dei militari |
Il segretario generale dell’Onu Guterres esprime «seria preoccupazione» ma le sue parole servono a poco. La sua preoccupazione in compenso si è tradotta nello stop all’agenzia con sede a Roma che distribuisce gli aiuti alimentari ai rohingya in Myanmar, la cui popolazione sfollata internamente ha raggiunto quota 250mila, la metà dei quali vive in campi allestiti per dar loro rifugio dal 2012 (quando si scatenò una campagna che vide distruzioni e violenze in diverse aree musulmane del Paese). Nell’ottobre del 2016, a seguito di nuove violenze, i militari vietarono alle agenzie umanitarie di intervenire dando così la stura all’emigrazione di massa. Secondo Al Jazeera, il Pam è stato accusato dal governo di aver fornito razioni alimentari poi finite nelle mani dei ribelli e dello stesso tenore sono state le accuse verso altre agenzie umanitarie. Come il caso italiano ben dimostra, quando i piani di un governo violano le regole elementari del diritto, parte sempre una campagna che demonizza Ong e organizzazioni umanitarie, colpevoli di essere neutrali e di assistere chi ha bisogno senza fare domande.
A volte però succedono anche cose in controtendenza. Se è vero che il governo di Dacca sta cercando di porre un freno all’immigrazione di nuovi sfollati, un corrispondente della Bbc da Cox Bazar, la città al confine dove ha sede il Comitato che si occupa dei rifugiati, sostiene che la polizia bangladese sta in parte ignorando gli ordini che vengono dall’alto e chiude un occhio quando vede la gente in fuga passare la frontiera. Può anche darsi che il Bangladesh tenga due posizioni: una ufficiale, l’altra – nascosta – umanitaria. Un Paese disastrato dalle piogge alluvionali, dove vivono 1145 persone per chilometro quadrato e dove il reddito medio è di 160 dollari al mese, dà una lezione di civiltà, accogliendo non senza difficoltà chi scappa dalla guerra. Nei suoi campi profughi alloggiano decine di migliaia di sfollati e nel Paese i rohingya sono ormai almeno mezzo milione, arrivati a ondate successive. Intanto si aspetta la visita del premier indiano Modi in Myanmar. Si parlerà dei rohingya. L’India ne vuole espellere 40mila. Difficile che Naypyidaw li voglia indietro.
* aggiornato domenica 3 settembre 2017
Una campagna per Santiago Maldonado
Si è svolta a Buenos Aires una grande manifestazione per la scomparsa di Santiago Maldonado, un attivista scomparso in Patagonia. Una richiesta di verità e giustizia come per Giulio Regeni…
La Siria vista da sinistra, ne parliamo con Fiorella Sarti
Partiamo dal contesto: come hanno risposto l’attivismo e gli ambienti di sinistra allo scoppio delle cosiddette “primavere arabe”? Fondamentalmente con l’indifferenza da una parte, e con una presa di distanza ideologica da altre parti. Una posizione che scaturisce da… Continue Reading →![]()
7 OTTOBRE IN PIAZZA
Questa estate non verrà ricordata solo per il caldo soffocante e per la siccità, ma anche e soprattutto per alcuni fatti che hanno reso veramente soffocante il clima politico e sociale del Paese. Fra gli altri, citiamo la vergognosa normalizzazione dei rapporti diplomatici con il regime egiziano, nonostante le sue scoperte responsabilità nel martirio di […]![]()
Rohingya, i generali danno i numeri
 |
| La pagina fb del generale generale Min Aung Hlaing capo delle forze armate |
Tra i corpi dei 15 rohingya che il colonnello Ariful Islam dice all’agenzia Reuters di aver trovato venerdi sulle rive del fiume Naf, che divide il Myanmar dal Bangladesh, ci sono in maggioranza bambini: sono undici a non avercela fatta. Ma non sono da annoverare tra i 399 che, con agghiacciante precisione numerica, i militari birmani hanno fatto sapere di aver ucciso nella settimana di fuoco che ha seguito il “venerdi nero” scorso, quando secessionisti rohingya hanno attaccato alcuni posti di polizia scatenando una ritorsione dal sapore di pulizia etnica. Non si tratta di una dichiarazione “ufficiale” ma di un post sulla pagina FB di uno dei più importanti generali del Paese. La strage dei rohingya ridotta a qualche “like” o a condivisione sul social più diffuso.
 |
| Myanmar, India, Cina e Bangladesh |
Il bilancio ufficiale era 108 morti e sembrava già tanto così come i 3mila scappati oltre confine. Ma da ieri le cifre sono ben altre: 400 i morti dunque tra cui, dicono i militari, 29 “terroristi”. E poi ben 38mila profughi – la cifra aumenta di ora in ora – che si aggiungono agli 87mila già arrivati in Bangladesh dopo il pogrom dell’ottobre 2016 (nel precedente, nel 2012, i morti erano stati 200 con oltre 100mila sfollati interni). I dati li fornisce l’Onu che fino a due giorni fa ne aveva contati “solo” 3mila. Ma non è ben chiaro dove questa gente si trovi: secondo fonti locali almeno 20mila sono ancora intrappolati nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di frontiera bangladesi tengono il piè fermo. Molti fanno la fine di quelli trovati dal colonnello Ariful se non riescono ad attraversare il fiume – a nuoto o con barche dov’è più largo – mentre altri aspettano il momento buono, quando si può sfuggire alle guardie di frontiera. Quel che è certo è che indietro non si può tornare. I rapporti tra i due vicini sono tesi: Dacca ha protestato per ripetute violazioni dello spazio aereo da parte di elicotteri birmani in quella che sembra, una volta per tutte, una sorta di soluzione finale per chiudere il capitolo rohingya, minoranza musulmana che, prima del 2012, contava circa un milione di persone. Adesso, di questa comunità cui è negata la cittadinanza in Myanmar, non è chiaro in quanti siano rimasti in quello che loro considerano, forse obtorto collo, il proprio Paese mentre per il governo non si tratta che di immigrati bangladesi.
 |
| Mappa del Rakhine |
Lontano dal Mediterraneo, lungo un fiume che sfocia nel Golfo del Bengala, si consuma lentamente ma con determinazione la persecuzione di un popolo. I militari agitano lo spettro di uno “stato islamico”, incarnato da un gruppo secessionista armato responsabile degli attacchi. E se anche i residenti locali non musulmani (11mila) sono oggetto di “evacuazione” dalle zone sotto tiro, Human Rights Watch ha documentato la distruzione di case e villaggi rohingya con incendi che hanno tutta l’aria di essere dolosi. Reazione troppo brutale, come dice la diplomazia internazionale, o un piano di eliminazione? «Siamo ormai in una nuova fase – dice a Radio Popolare il responsabile Asia di Hrw – e siamo convinti che dietro alle operazioni dell’esercito ci sia il governo, col piano di chiudere definitamente la questione cacciando la popolazione rohingya grazie alla campagna militare contro gli insorti».
 |
| Modi: settimana prossima in visita d’affari |
Se la diplomazia resta a guardare, i vicini non sono da meno. La Thailandia si richiama al principio di “non ingerenza”. Delhi ha deciso l’espulsione di 40mila rohingya illegali e settimana prossima il premier Modi sarà in Myanmar, Paese strategico per l’economia del colosso asiatico. La decisione ha però suscitato polemiche, editoriali sui giornali e anche il ricorso di due rohingya alla Corte suprema che, proprio, ieri ha accolto la richiesta: pare che Delhi intenda espellere persino chi già gode dello status di rifugiato con l’Acnur (14mila persone).
C’è poi un altro colosso – la Cina – che difende le ragioni del governo birmano a cominciare dalle riunioni del Consiglio di sicurezza dove fa sentire il suo peso perché la questione rohingya resti al palo. Pechino è il maggior investitore e ha interessi anche nel Rakhine, lo Stato dove vive questa scomoda minoranza. E’ interessata al porto di Kyaukphyu, strategico per i rifornimenti di petrolio. Non solo i cinesi stanno acquisendo azioni della società portuale ma finanziano l’oleodotto che dal Rakhine arriva a Kunming, nella Cina del Sud. C’è un altro investimento nella cosiddetta Kyaukphyu Special Economic Zone che prevede una linea ferroviaria. Un corridoio ritenuto vitale nel suo progetto One Belt, One Road, meglio noto come “Nuova via della seta”. E per evitare complicazioni Pechino ha ottimi rapporti con un parlamentare locale dell’Arakan National Party, ritenuto uno dei bastioni del nazionalismo identitario locale. E’ il partito che vorrebbe nel Rakhine lo stato di emergenza.
Sorpresa: in Afghanistan le truppe Usa son già aumentate! (aggiornato)
Con adamantina franchezza e a dimostrazione di un’amministrazione più “trasparente” della guerra afgana, il generale Kenneth McKenzie, joint staff director al Pentagono, ha fatto sapere che le truppe Usa sono 11mila e non 8.400 come si è sempre detto. Solo 2600 soldati in più! Washington chiarisce che non si tratta di un aumento di truppe: semplicemente erano già lì. Intanto si comincia a intravedere la nuova linea della guerra: ancora più soldati e più vittime civili. Ci sono già due casi con una dozzina di civili morti per raid aerei avvenuti recentemente a Logar e a Herat. Raid aerei a caccia di talebani con effetti collaterali. Ecco la nuova guerra dello sceriffo Trump che resta comunque una nebulosa. Pericolosa (le vittime civile sono state confermate venerdi da Uanma, la sede Onu a Kabul.
Ma come la vedono gli alleati nell’area. Cosa ne pensano a Kabul e a Islamabad? C’è chi la approva e chi ne teme gli effetti. Quanto agli americani, sono divisi della nuova strategia presidenziale (vedi foto in basso)?
Lunga gestazione
Il 22 agosto, a oltre un mese dalla data in cui i nuovi obiettivi americani sull’Afghanistan avrebbero dovuto essere resi noti, il presidente Trump li ha definiti con un discorso ripreso in diretta Tv. Ma tutti gli osservatori, americani e non, sono abbastanza concordi nel definire la nuova strategia presidenziale abbastanza oscura e non molto dissimile da quella che aveva caratterizzato il mandato di Obama. Quella che al momento appare una nebulosa senza obiettivi tattici – se non quello strategico finale di “vincere! – e che dovrebbe modularsi senza un’agenda precisa sulle richieste “che vengono dal terreno” ha lasciato perplessa buona parte dei commentatori statunitensi e gli analisti dei Paesi della Nato che, al di là delle dichiarazioni di principio (la fedeltà all’alleato americano), non nascondono le preoccupazioni per un nuovo surge di cui non si capisce né la portata né la quantità e la qualità di nuove possibili truppe, né quali esattamente saranno gli accordi tra Usa, Nato e governo afgano sulla gestione della catena di comando.
Ma la strategia di Trump, costata almeno otto mesi di gestazione e svelata in parte col filtrare ciclico di indiscrezioni di stampa basate su fonti anonime dell’Amministrazione, ha però certamente sollevato due reazioni, diametralmente opposte quanto chiaramente espresse, nei due principali attori regionali: l’Afghanistan, felice e soprattutto sollevato dalle dichiarazioni di Trump, e il Pakistan, additato in modo più violento che in passato come il “cattivo” istituzionale, eterno inaffidabile doppiogiochista, colpevole di ospitare le retrovie talebane.
Contenti a Kabul
| La base di Bagram, caposaldo americano |
Il governo di Kabul aspettava con un certa ansia che il presidente americano svelasse la sua strategia per diversi motivi: il primo, e più cogente, risiede nel fatto che a Kabul c’è un governo debole, con un sistema economico finanziario in caduta libera e che gode ormai di consensi ridotti al lumicino. Il fatto che gli americani decidano di non abbandonare l’Afghanistan – cosa che si poteva temere dai molti tweet di Trump durante la campagna elettorale – significa per Kabul non solo che il magro flusso di denaro garantito dalla permanenza della missione alleata non si arresterà ma che, presumibilmente, aumenterà. Il presidente ha fatto capire di voler sostenere un miglioramento delle forze aeree locali (argomento ribadito anche dal segretario generale della Nato), che sono l’apparato più costoso della guerra, e di essere favorevole all’utilizzo di nuove armi come ha dimostrato la bomba da 11 tonnellate lanciata in aprile nella zona di confine col Pakistan infestata da militanti dello Stato islamico. Infine, anche se non è chiara la quantità di “stivali sul terreno” che Washington è disposta a impiegare, è evidente che un aumento di uomini ci sarà e che lo stesso avverrà, pur se con riluttanza, anche per i partner Nato. Nuove truppe significano più denaro fresco e più spese che ridaranno fiato all’economia di guerra (che che ai tempi in cui la coalizione contava 130mila soldati, andava a gonfie vele), con nuove commesse, posti di lavoro e un possibile rilancio di settori come la logistica e l’edilizia oltre a un rafforzamento della moneta. La presenza resta garantita, sia sul piano militare, sia sul piano politico. Infine Kabul potrebbe sentirsi rassicurata anche dal fatto che, accanto a Trump, ci sono tre generali: il consigliere per la sicurezza McMaster, il titolare della difesa Mattis e il capo di gabinetto Kelly. Dovrebbero esser loro a garantire la continuità (e la mano più pesante) chiesta da mesi dal generale John Nicholson, al comando delle truppe Usa e Nato nel Paese. L’unico vero ostacolo all’interno dell’Amministrazione è infatti andato a casa: con il siluramento di Bannon, il capo stratega della Casa Bianca – il più cauto e il più contrario a un nuovo surge – le cose andranno come devono andare, garantendo a Kabul di tornare ad essere, da Cenerentola del Pentagono, una nuova reginetta, pur se in forma più contenuta che in passato.
Scontenti a Islamabad
 Quanto a Kabul si festeggia, tanto a Islamabad si mastica amaro. Nel discorso di Trump il Pakistan è stato uno degli elementi centrali del “piano” e il responsabile maggiore, nelle parole del presidente, di una guerra che non si riesce a vincere. Tanto rapidi sono stati gli apprezzamenti di Kabul (poche ore dopo il discorso, Trump incassava il plauso dell’ambasciatore afgano a Washington e subito dopo quello di Ghani e del suo governo) tanto veloci sono state le rimostranze pachistane che hanno avuto una buona eco anche nelle dichiarazioni della Cina, il Paese più solidale con Islamabad. Il Pakistan – che versa tra l’altro in un momento complesso della sua vita politica dopo l’uscita di scena del premier Nawaz Sharif per il cosiddetto scandalo Panamaleaks – si è indignato per il tenore delle accuse – per altro non molto diverse da quelle sempre avanzate dall’amministrazione Obama – ma soprattutto perché Trump si è rivolto all’India chiedendole uno sforzo maggiore nel Paese dell’Hindukush: un invito che, alle orecchie pachistane, suona come un via libera a Delhi per rafforzare la testa di ponte già creata in Afghanistan con l’apertura di consolati, l’esborso di aiuti economici e progetti di formazione per l’esercito afgano. Un consolidamento che Islamabad vede come il fumo negli occhi. Infine, Trump ha omesso di ricordare, cosa che la diplomazia americana ha invece sempre fatto, di enumerare almeno gli sforzi del governo contro gli islamisti e il tributo di sangue pagato dai suoi militari nelle aree di confine. Senza contare il fratto che, se i talebani afgani hanno i loro santuari in Pakistan, i talebani pachistani godono in Afghanistan della possibilità di sfuggire alla giustizia del Paese dei puri.
Quanto a Kabul si festeggia, tanto a Islamabad si mastica amaro. Nel discorso di Trump il Pakistan è stato uno degli elementi centrali del “piano” e il responsabile maggiore, nelle parole del presidente, di una guerra che non si riesce a vincere. Tanto rapidi sono stati gli apprezzamenti di Kabul (poche ore dopo il discorso, Trump incassava il plauso dell’ambasciatore afgano a Washington e subito dopo quello di Ghani e del suo governo) tanto veloci sono state le rimostranze pachistane che hanno avuto una buona eco anche nelle dichiarazioni della Cina, il Paese più solidale con Islamabad. Il Pakistan – che versa tra l’altro in un momento complesso della sua vita politica dopo l’uscita di scena del premier Nawaz Sharif per il cosiddetto scandalo Panamaleaks – si è indignato per il tenore delle accuse – per altro non molto diverse da quelle sempre avanzate dall’amministrazione Obama – ma soprattutto perché Trump si è rivolto all’India chiedendole uno sforzo maggiore nel Paese dell’Hindukush: un invito che, alle orecchie pachistane, suona come un via libera a Delhi per rafforzare la testa di ponte già creata in Afghanistan con l’apertura di consolati, l’esborso di aiuti economici e progetti di formazione per l’esercito afgano. Un consolidamento che Islamabad vede come il fumo negli occhi. Infine, Trump ha omesso di ricordare, cosa che la diplomazia americana ha invece sempre fatto, di enumerare almeno gli sforzi del governo contro gli islamisti e il tributo di sangue pagato dai suoi militari nelle aree di confine. Senza contare il fratto che, se i talebani afgani hanno i loro santuari in Pakistan, i talebani pachistani godono in Afghanistan della possibilità di sfuggire alla giustizia del Paese dei puri.
 |
| Divisi: nel sondaggio di Politico.com il 45% degli americani approva l’aumento di truppe. Il 41% è contrario |
Incognite sul futuro
Se lo si guarda da Kabul e da Islamabad l’oscuro piano afgano di Trump resta dunque una nebulosa con luci e ombre non priva di rischi. I rapporti con Kabul sono ottimi ma sono basati sulla debolezza di un governo senza consensi e disposto a tutto pur di ricevere nuovi finanziamenti esterni. Un alleato debole in un quadro complesso. I rapporti col Pakistan rischiano invece di peggiorare e nessuno meglio di Islamabad può far deragliare qualsiasi processo negoziale. Processo su cui merita spendere una parola. Trump ha invitato i talebani a scendere a patti ma li ha anche minacciati, con uno stile da sceriffo, senza alcuna concessione. Una parafrasi delle sue parole l’ha poi fatta due giorni dopo il suo discorso, il generale Nicholson a Kabul che ha apostrofato la guerriglia in turbante “banda di criminali”, dediti al traffico di droga e ai rapimenti a scopo di estorsione. Invitare il nemico al tavolo negoziale minacciandolo di morte e dandogli dell’assassino, può forse funzionare come mossa tattica ma è l’esatto opposto di una strategia diplomatica che dovrebbe, con cautela, costruire le condizioni per far tacere le armi e tentare un dialogo che vada oltre gli insulti. La sensazione è che, dal punto di vista diplomatico, gli Stati Uniti si stiano infilando in un ginepraio che complicherà le cose più che renderle chiare. E se queste son le premesse politiche anche la guerra rischia di essere l’ennesima nebulosa senza via d’uscita.
Il profitto dell’espulsione
 Sarebbero già 5mila i rohingya in fuga che tentano di raggiungere il Bangladesh. Gente che scappa dall’ennesima stretta militare che ha tutta l’aria di un pogrom verso la minoranza musulmana che fugge da un territorio che è appena stato fotografato dal satellite cui ha fatto seguito una denuncia di Human Roights Watch: incendi a macchia di leopardo nelle tre township (unità amministrativa birmana) di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, lungo un percorso di 100 chilometri in aree prossime alla frontiera bangladese. Di questi 5mila però circa 4mila – secondo il magazine birmano Irrawaddy – si trovano nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di Dacca li respingono. Lo hanno già fatto con 550 persone. Ad altre lasciano che passino il confine per avere medicine ma poi devono tornare dall’altra parte, dove c’è il “loro” Paese che però non li vuole. Gli appelli dell’Onu cadono nel vuoto e intanto il governo agita lo spettro di uno “stato islamico” nel cuore del buddista Myanmar, progetto all’origine dell’attacco del 25 agosto a trenta posti di polizia. In una conferenza stampa, il ministro dell’Interno generale Kyaw Swe (i militari gestiscono anche Difesa e Frontiere) ha detto che l’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) vuole stabilirlo nelle township di Maungdaw e Buthidaung.
Sarebbero già 5mila i rohingya in fuga che tentano di raggiungere il Bangladesh. Gente che scappa dall’ennesima stretta militare che ha tutta l’aria di un pogrom verso la minoranza musulmana che fugge da un territorio che è appena stato fotografato dal satellite cui ha fatto seguito una denuncia di Human Roights Watch: incendi a macchia di leopardo nelle tre township (unità amministrativa birmana) di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, lungo un percorso di 100 chilometri in aree prossime alla frontiera bangladese. Di questi 5mila però circa 4mila – secondo il magazine birmano Irrawaddy – si trovano nella terra di nessuno tra i due Paesi e le guardie di Dacca li respingono. Lo hanno già fatto con 550 persone. Ad altre lasciano che passino il confine per avere medicine ma poi devono tornare dall’altra parte, dove c’è il “loro” Paese che però non li vuole. Gli appelli dell’Onu cadono nel vuoto e intanto il governo agita lo spettro di uno “stato islamico” nel cuore del buddista Myanmar, progetto all’origine dell’attacco del 25 agosto a trenta posti di polizia. In una conferenza stampa, il ministro dell’Interno generale Kyaw Swe (i militari gestiscono anche Difesa e Frontiere) ha detto che l’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) vuole stabilirlo nelle township di Maungdaw e Buthidaung.
C’è dunque anche una scusa securitario-terroristica dietro alle violenze in cui sarebbero coinvolti, stando ai racconti che alcuni fuggitivi han fatto a Reuters, anche civili: «Siamo qui perché abbiamo paura per le nostre vite, ma non possiamo attraversare il confine e quindi non sappiamo cosa fare» dice Aung Myaing e aggiunge che militari e civili buddisti saccheggiano e incendiano i loro villaggi, utilizzando anche lanciagranate. E quando il reporter chiede loro della guerriglia risponde: «Non li abbiamo visti, non abbiamo alcuna relazione con loro. Ma il Myanmar non distingue tra i terroristi e i civili. Stanno cacciando tutti i rohingya». Granate, saccheggi, incendi e un bilancio che ha già superato i cento morti.
 |
| La bandiera di Tatmadaw, l’esercito birmano. Non solo militari. Sopra, la mappa degli incendi pubblicata da Hrw |
Le immagini diffuse da Hrw sugli incendi fanno pensare a fotogrammi più vecchi: quelli con cui la stessa organizzazione, nell’autunno scorso, riuscì a stimare a 1500 gli edifici incendiati. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township, la zone dello Stato di Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya.
Sono quelle immagini a rendere più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma l’ipotesi che, dietro alla cacciata di queste genti senza documenti, ci sia anche un piano economico per sfruttare le loro terre. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione delle terre considerate mal sfruttate per affidarle a compagnie private e metterle a profitto, land grabbing per società con grandi mezzi in nome dello sviluppo. Dal 2012 una legge ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari aprendo anche a investitori stranieri: assalto alla foresta (ogni anno 400mila ettari) o a piccoli appezzamenti confiscati visto che la legge ne aboliva una del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya siamo a 1.269mila ettari con un balzo rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012.
La polizia britannica riapre il caso dell’omicidio di Naji al-Ali
In un articolo apparso ieri sulla versione online inglese, al-Jazeera ha reso noto che la polizia britannica ha diramato un appello affinchè chi sia in possesso di informazioni sull’omicidio di Naji al-Ali si faccia avanti. A 30 anni dalla morte. Naji al-Ali, palestinese, vignettista, è noto per essere l’autore di Handala, il bambino rifugiato palestinese […]![]()
I siriani fuggiti in Brasile si ritrovano davanti forti sostenitori del regime di Assad
I siriani in fuga dalla guerra nel loro paese tentano di trovare un luogo in Brasile che possano chiamare casa.
Perché Erdogan ha assunto il comando del MIT turco insieme alla presidenza concedendogli maggiori poteri?
Un nuovo passo per l’ampliamento dei poteri e dell’influenza dei servizi segreti nel Paese per rafforzare il lavoro dell’apparato che fallì nell’individuazione del tentativo di colpo di stato
L’articolo Perché Erdogan ha assunto il comando del MIT turco insieme alla presidenza concedendogli maggiori poteri? sembra essere il primo su Arabpress.
Rohingya, fuga senza fine
Sembra che si chiami Francesco Bergoglio l’ultima speranza dei Rohingya, minoranza musulmana in fuga dal suo Paese e ora respinta sia dal Bangladesh che ha chiuso le frontiere sia dall’India che ne minaccia l’espulsione. Ma il pontefice, che dopo aver ricordato all’Angelus la tragedia birmana e fatto sapere a sorpresa ieri mattina che andrà in Myanmar e in Bangladesh, inizierà il suo viaggio solo il 27 novembre: mancano tre mesi, un tempo sufficiente a ridurre al minimo questa minoranza ormai così vessata e strangolata dalla violenza che ormai i suoi numeri in Myanmar sono ridotti al lumicino.
L’inizio dell’ultimo pogrom è di alcune settimane fa quando i militari birmani hanno stretto d’assedio tre township nella zona orientale dello Stato di Rakhine, la regione al confine con Bangladesh e India dove vivevano oltre un milione di rohingya, una minoranza che in Myanmar non ha diritto alla cittadinanza, non può votare, è considerata immigrazione bangladese illegale e vive in gran parte in campi profughi nel suo stesso Paese. Per reagire all’accerchiamento delle aree di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, il gruppo armato Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) – accusato di terrorismo da Naypyidaw – ha sferrato venerdi scorso un’offensiva contro trenta obiettivi militari, scatenando una vera e propria battaglia con oltre 100 morti e la conseguente repressione – anche a colpi di mortaio – mentre si riprendeva una fuga in realtà mai interrotta dall’ottobre scorso quando si erano verificati incidenti simili. L’uso “sproporzionato” della forza militare – avverte International Crisis Group, un organismo di monitoraggio che da tempo segue la questione – non è solo da condannare in sé ma rischia di favorire la radicalizzazione della minoranza, favorendo la crescita di gruppi armati. Arsa, guidato da Ata Ullah alias Abu Ammar Jununi, rohingya nato in Pakistan che godrebbe di finanziamenti privati pachistani e sauditi, ha lanciato messaggi video di sfida al governo. Ma gli scontri nelle tre città del Nord hanno registrato anche singoli episodi di violenza verso buddisti, indù o altre minoranze.
Il flusso della fuga verso il Bangladesh si ferma quando le acque si calmano ma riprende appena l’esercito stringe la morsa. A metà agosto, la stampa del Bangladesh ha cominciato a dare conto dei nuovi arrivi che già avevano totalizzato un migliaio di profughi, riusciti a passare la frontiera clandestinamente. Ora sono almeno 3mila (in tre giorni), secondo l’Onu. Da quel che si capisce, aumentata la pressione ai posti tradizionali di passaggio dei profughi, i rohingya in fuga hanno trovato nuovi percorsi per sfuggire alle guardie accampandosi in campi informali e senza registrarsi. Ma in tanti sono ora nella no man’s land tra i due Paesi perché Dacca ha detto basta: oltre 80mila sono i rohingya già arrivati in Bangladesh da ottobre e in tutto sono circa mezzo milione, arrivati a ondate successive a partire già dal secolo scorso. Una tragedia senza fine consumata in silenzio ma con un bubbone sempre più purulento che adesso fa rumore anche se, di fatto, non si va oltre le pressioni verbali: il Myanmar non è la Libia e neppure l’Afghanistan o i Balcani. E le parole diritti, pulizia etnica, tortura, stupro, omicidio commuovono ma fino a un certo punto.
 |
| I messaggi di Arsa su Youtube. A dx il simbolo dell’organizzazione |
La situazione è complicata dal fatto che al potere c’è, per la prima volta da decenni, un governo civile guidato, anche se informalmente (la Costituzione glielo vieta), da una Nobel per la pace. Ma la signora Suu Kyi, figlia di un eroe della resistenza anti britannica e icona della battaglia per i diritti e la libertà, è rimasta zitta. O meglio, ha cercato in modo indolore di far digerire l’amara pillola con mezze parole e qualche timido rimedio: l’ultimo consisterebbe nell’applicazione delle raccomandazioni contenute in un dossier scritto da Kofi Annan che chiede al Myanmar la revisione della legge sulla cittadinanza. Ma Suu Kyi deve fare i conti con un potere militare ferocemente contrario alle aperture. Per eccesso di zelo buddista o spinto dal pericolo islamista? La sociologa Saskia Sassen ha spiegato che i generali, casta economica oltreché militare, stanno favorendo l’accaparramento dei terreni del Rakhine, resi sempre più appetibili se chi li possiede fugge e non ha le carte per dimostrarlo. Gli strumenti per opporsi sono scarsi anche se ieri il parlamento ha bloccato la richiesta della minoranza (filo militare) di dichiarare lo stato di emergenza a Maungdaw.
La solidarietà è scarsa a parte quella di Bergoglio, l’unico capo di Stato che ha strigliato Suu Kyi quando alcuni mesi visitò l’Europa. Malaysia e Indonesia fanno accoglienza. Molta l’ha fatto il Bangladesh che ora però chiude. Quanto all’India, fa sapere che vuole rimpatriare i rifugiati sul suolo indiano: 14mila registrati con l’Acnur e, pare, altri 400mila illegali.
Del musakhan, del summacco e di quel che resta della civiltà
Vicino al mercato. Ho sempre vissuto vicino a un mercato, all’estero. Non riesco a pensare a una vita quotidiana che non mette in gioco ciò che gli altri fanno. Cosa comprano. Dove. Per fare cosa. Banale, certo, ma di questi tempi la memoria è affermazione di valori, dignità, conoscenza. Nel mercato di Doqqi, al Cairo,Continua a leggere
Giornalisti palestinesi bersaglio della nuova legge sui crimini informatici
Palestina: la nuova legge sul crimine informatico porta all’arresto di cinque giornalisti collegati ad Hamas. Proteste contro la repressione della libertà di stampa.
Collegare l’Islam alla criminalità e al terrorismo non servirà all’Occidente
Il terrorismo non ha religione, dottrina o identità; è un male assoluto che mira all’umanità senza discriminazioni
L’articolo Collegare l’Islam alla criminalità e al terrorismo non servirà all’Occidente sembra essere il primo su Arabpress.
Nuove violenze nel Rakhine birmano
Nelle prime ore della giornata di ieri un attacco congiunto su una trentina di obiettivi militari nella Birmania occidentale ha scatenato l’ennesima ondata di violenza nello Stato del Rakhine. La regione è sede anche della minoranza musulmana dei Rohingya nel Paese a maggioranza buddista dove la Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi è al governo ma sotto la spada di Damocle di un ancora forte potere militare. L’attacco coordinato è avvenuto nelle aree di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung dopo un’escalation di violenze seguite, nelle ultime settimane, a un ennesimo invio di soldati nella regione che avrebbe spinto alla fuga verso il Bangladesh migliaia di Rohingya, andati a ingrossare le fila di una massa di profughi che da ottobre scorso conta nel Paese vicino già oltre 80mila nuovi rifugiati. Nello stesso periodo di sarebbero verificate nel Rakihine violenze anche contro monaci buddisti, molti dei quali poi evacuati.
Gli scontri di ieri, rivendicati da una sigla nazionalista rohingya – Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) che ha dato notizia delle azioni via twitter – si sarebbero conclusi con un bilancio – secondo fonti governative – di oltre 80 morti: dieci poliziotti, un soldato, undici agenti della sicurezza, un ufficiale dell’immigrazione e 59 sospetti militanti dei circa 150 che, dalla una del mattino, avrebbero scatenato l’attacco. Le Nazioni Unite hanno chiesto alle parti di astenersi da nuove violenze, ormai cicliche nello Stato di Rakhine.
L’azione dell’Arsa è stata messa in relazione alla pubblicazione delle raccomandazioni che l’ex segretario Onu Kofi Annan ha consegnato al governo birmano poche ora prima dei raid anche se – sebbene molto probabilmente il rapporto di Annan venga ritenuto dall’Arsa troppo moderato – l’attacco fa pensare a un’azione preordinata e preparata da tempo, forse proprio a partire dalle violenze scatenate col nuovo “surge” dell’esercito nel Rakhine nelle ultime settimane. Così sembrerebbe di capire anche dal tenore delle dichiarazioni di Arsa secondo cui si sarebbe trattato di un’ “azione difensiva”. La signora Suu Kyi ha condannato le azioni della guerriglia e il suo ufficio ha rilasciato una dichiarazione nella quale si citano estremisti “bengalesi”, il termine con cui i Rohingya – senza cittadinanza né diritti in Myanmar e considerati immigrati illegali – vengono normalmente chiamati. Proprio il documento di Annan, morbido probabilmente per evitare a Suu Kyi uno scontro coi militari, chiede comunque che ai Rohingya siano riconosciuti i diritti che sono loro negati dalla legge del 1982 sulla cittadinanza, di cui il rapporto chiede una revisione: si tratta di raccomandazioni che un comitato ministeriale ad hoc ha ora il compito di studiare e mettere in pratica secondo quanto promesso dalla Nobel. A dimostrazione di quanto sia delicata la situazione in cui si trova il governo civile, il capo delle Forze armate Min Aung Hlaing ha messo in questione l’imparzialità del rapporto e lo ha accusato di una ricostruzione inaccurata.
Atei per protesta
Dal blog In poche parole di Zouhir Louassini
L’articolo Atei per protesta sembra essere il primo su Arabpress.
La nebulosa afgana disastro annunciato. Ora di tornare a casa
 |
| Nicholson durante la conferenza stampa. La foto correda l’articolo sulle esternazioni del generale |
Rinfrancato dal fatto che per ora non sarà mandato a casa e bypassando le più elementari categorie della diplomazia negoziale, il generale Jhon Nicholson, al comando delle truppe Usa e Nato in Afghanistan, ha detto la sua dopo le esternazioni del presidente. Il generale, sicuro del fatto che ormai Trump abbia passato la mano ai McMaster (sicurezza) e Mattis (Difesa) di turno (generali come il suo capo gabinetto Jhon Kelly, pensa che ormai tocchi a lui interpretare anche politicamente la confusa idea che Trump vuole applicare in Afghanistan per vincere la guerra. E così ha definito i talebani una “criminal organization that is more interested in profits from drugs, kidnapping and murder for hire.” Un testo che non mi pare il caso di stare a tradurre…
Forse anche Trump pensa lo stesso ma se le parole del presidente sono state improvvide – come in altri casi – nel suo discorso di due giorni fa sull’Afghanistan, quelle di Nicholson sono una traduzione ancora peggiore. Da un lato invita i talebani – come Trump – a deporre le armi, dall’altro apostrofa la parte che dovrebbe negoziare nel modo che abbiamo riportato. Nemmeno Trump lo sceriffo era giunto a tanto. Sarebbe come se, dovendo negoziare col vostro padrone di casa l’affitto e/o lo sfratto, gli deste del bandito prima ancora di esservi seduti al tavolo. Anche un idiota capisce che se c’è un modo per irritare i talebani questa è la via giusta. Nemmeno più il bastone e la carota. Solo bastoni e, come si evince dalle parole del generale, un bastone sempre più aereo: sempre più raid, bombe dal cielo, droni e omicidi mirati. Nicholson e Trump pensano che i talebani afgani si possano trattare come l’Isis a Raqqa e che anzi siano più o meno la stessa cosa. In un Paese dove l’intelligenza e l’analisi non mancano, quella che si sente è adesso una sola campana che annuncia una stagione pericolosa, dominata dai generali. Che, come la storia insegna, son magari bravi a fare la guerra ma in politica sono un disastro. Purtroppo il governo di Kabul appoggia e la Nato pure. Stiamo andando verso una nuova catastrofe e non si riesce che ad applaudire.
Allora sarebbe bene prendere subito le distanze da questa strategia oscura e muscolare che già si annuncia col fiato corto e danni di lungo periodo. Sarebbe opportuno che i nostri politici pensassero anche all’Afghanistan dove abbiamo quasi mille soldati che stiamo esponendo a un’ennesima guerra peggio guerreggiata delle precedenti e che non risiede certo nei nostri interessi nazionali. Un governo serio si ritirerebbe da una politica avventurista e guerrafondaia e, semmai, impiegherebbe i soldi che ora spende ( circa 500mila euro al giorno) in opere di bene e di pace. Ma, come avvenne per la Libia e prima ancora per l’Iraq, alla fine sappiamo solo dire signorsi e, nel farlo, non facciamo un piacere né ai nostri alleati né – tanto meno – agli afgani. Che iddio protegga quel povero popolo. E che il mio paese abbia un sussulto di orgoglio e intelligenza.
Lo sceriffo, l’Alleanza e le nostre responsabilità
 |
| Marshall Trump, stanco dei polticanti di Washington ha adesso una nuova idea: “Ci penso io”. Ma come non si sa |
E’ una strana “nuova” strategia quella che Donald Trump, e con lui la Nato, sta mettendo in piedi per rinfocolare la guerra infinita che da 16 anni vede impegnata anche l’Italia. Una nuova guerra senza numeri e con molte reticenze, frasi di rito e un plauso incondizionato a un piano che par confuso allo stesso burattinaio che ne dovrebbe tirare le fila. Un piano che non vuole insegnare nulla agli afgani e li invita a fare la pace coi talebani ma che al contempo mira a far fuori i “nemici” con maggior determinazione. Una strategia che chiede nuove truppe ma quante non si sa. Una guerra da modularsi sulle richieste che vengono dal terreno ma che sembra in realtà una nebulosa senza obiettivi che pare rispondere alla domanda che lo stesso Trump si faceva in campagna elettorale: «Che ci stiamo a fare»? L’impressione è che lo sceriffo di New York, dove Trump è nato nel 1946, ancora non lo sappia anche se i suoi generali devono aver convinto il guerrafondaio riluttante che l’Afghanistan bisogna controllarlo.
Quel che Trump e i suoi generali sanno non è solo che, come ha twittato Trump nel 2012, l’Afghanistan è un Paese dove «abbiamo costruito strade e suole per della gente che ci odia» ma l’avamposto da cui, grazie a una decina di basi aeree, gli Stati Uniti possono controllare l’Iran e soprattutto la Russia. Nessuno disvela o ammette questa evidente verità che costò a Washington un lungo braccio di ferro con Karzai che non voleva cedere ai diktat americani.
Il refrain resta il solito: scompaiono diritti e democrazia ma resta la lotta alle basi del terrore anche se, nel caso dei talebani, non son certo una minaccia né per gli States né per l’Europa. Per gli alleati di Trump nella Nato dovrebbe invece esser chiaro che, oggi più di ieri, restare e mandare nuove truppe come Washington chiede, significa limitarsi a sostenere un disegno soprattutto americano pur se assai più vago che in precedenza. Per ora una quindicina di Paesi avrebbero detto si: Londra manderà circa cento soldati e Varsavia altri 30. Ma di altri Paesi, come la Danimarca, il numero resta incerto mentre i tedeschi hanno chiaramente detto no e anche l’Italia, che un pensierino ce l’aveva fatto, ha poi preferito saggiamente declinare l’invito forse per evitare a Gentiloni l’ennesimo grana. Purtroppo anche se Roma non invierà altri soldati noi ne abbiamo già mille in Afghanistan che sarebbe bene far tornare a casa. Lasciarli lì significa accettare supinamente un piano confuso, incerto e dunque pericoloso. Ed esserne dunque corresponsabili.
Sostentamento locale a rischio per l’invasione di una pianta acquatica nel più grande lago d’Etiopia
Il lago è diventato il simbolo della disperata situazione delle risorse naturali etiopi, in un momento in cui una popolazione locale è in costante crescita.
Parliamo di politica: l’Europa e il terrorismo
La soluzione è affrontare le conseguenze o estirpare le radici?
L’articolo Parliamo di politica: l’Europa e il terrorismo sembra essere il primo su Arabpress.
Iran: i membri riformisti in Parlamento premono per la fine dei domiciliari del leader del Movimento Verde
I membri riformisti del Parlamento iraniano stanno provando a revocare gli arresti domiciliari di Mehdi Karroubi, 79enne, leader dell’opposizione, dopo la sua recente ospedalizzazione.
Nawal Saadawi, la femminista che non smette di lottare
Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini
L’articolo Nawal Saadawi, la femminista che non smette di lottare sembra essere il primo su Arabpress.
Regeni, accademici all’estero: “Il ritorno dell’ambasciatore al Cairo? Realpolitik del governo è codarda e ci mette a rischio”
E’ il pomeriggio del 14 agosto, la vigilia di ferragosto, quando il comunicato della Farnesina annuncia che “il Governo italiano ha deciso di inviare l’Ambasciatore Giampaolo Cantini nella capitale egiziana, dopo che – l’8 aprile 2016 – l’allora Capo Missione Maurizio Massari venne richiamato a Roma per consultazioni”. I telefoni cominciano a squillare: la famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore […]
L’articolo Regeni, accademici all’estero: “Il ritorno dell’ambasciatore al Cairo? Realpolitik del governo è codarda e ci mette a rischio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Gli arabi israeliani, un “popolo invisibile”
Realismo sulla situazione dello Stato di Israele, che solo per abitudine o cecità si continua a pensare come democrazia compiuta, come stato coeso e solido. Disse Gideon Levy che i Palestinesi sono un popolo paziente, ma anche Giobbe, il Paziente per eccellenza, al culmine della sua sofferenza chiese ragione a Dio di tanto inesplicabile patire. […]![]()
Monica Capasso: Al di là del mare
Restituire umanità alla narrativa sulle migrazioni. Questa è la prospettiva in cui si dipanano le vicende del romanzo “Al di là del mare” di Monica Capasso. La giovane autrice barese, giurista per formazione e impegnata nell’attivismo e nell’associazionismo, riporta sul… Continue Reading →![]()
Egitto: ondate di rabbia su Internet per la diminuzione dei sussidi ai poveri
Sui social è scoppiata la miccia della furia a causa della nuova decisione del governo di ridurre i sussidi ai poveri per i generi alimentari di base
L’articolo Egitto: ondate di rabbia su Internet per la diminuzione dei sussidi ai poveri sembra essere il primo su Arabpress.
Andarsene o restare? La strategia confusa di Trump sull’Afghanistan
 |
| A metà luglio la Casa Bianca aveva promesso di rivelare il nuovo piano per l’Afghanistan |
Donald Trump sta pensando da qualche mese a cosa fare a Kabul, un luogo in cui non ha ancora messo piede anche se si è intrattenuto al telefono più volte con Ashraf Ghani che già aveva conosciuto negli States. Ci sono sul tavolo diverse opzioni che si potrebbero riassumere in due posizioni abbastanza chiare. La prima : aumentare il numero dei soldati, intensificare i raid aerei e rivedere i laccioli imposti agli Usa da un accordo militare che li vincola ad agire solo dopo aver consultato la Difesa afgana. Seconda opzione: utilizzare un esercito di mercenari e far la guerra senza perdere uomini e consensi. Ma adesso pare ce ne sia una terza di opzione: andarsene complemtamente: full withdrawal, come ha spiegato il segretario alla Difesa Mattis in una conferenza stampa mentre diceva che ormai è questione di poco e presto si saprà quanto tutti stanno aspettando di sapere da ormai un mese, data in cui Trump avrebbe dovuto rendere nota la sua scelta.
Sappiamo che la prima opzione è appoggiata dal Pentagono ma anche da potenti repubblicani come John McCain o da generali come il consigliere per la sicurezza McMaster per non parlare dei papaveri del Pentagono e del comandante in loco John Nicholson, per quanto il generale non sia esattamente nelle grazie di Trump. La seconda opzione ha qualche sostenitore, sia nella famiglia Trump, sia nella lobby dei contractor, ma la terza – full withdrawal – è un’assoluta novità. Come si vede non sono tre opzioni parallele ma tre perpendicolari che viaggiano in opposte direzioni. Tre idee assi lontane l’una dall’altra e così differenti tra loro da giustificare in effetti un certo tentennamento: poche idee chiare insomma in una strategia confusa. Se non fosse un dramma verrebbe da sorridere.
Caro ambasciatore Cantini…
Lettera aperta di Filippo Landi all’ambasciatore Giampaolo Cantini, in procinto di recarsi al Cairo come nostro rappresentante diplomatico in Egitto. Egregio Ambasciatore Giampaolo Cantini, mi perdonerà se mi rivolgo a lei pubblicamente, ma credo che sia importante che si conoscano alcuni fatti alla vigilia del suo arrivo al Cairo. Alla fine di agosto del 2015,Continua a leggere
4 anni dopo un massacro
14 agosto 2013. Cairo. Massacro di Rabaa el Adawye. 4 anni dopo, nell’anniversario, nello stesso giorno, si comunica al pubblico che il governo italiano ha deciso di far ritornare il nostro ambasciatore al Cairo. Senza porre nessuna attenzione ai simboli, alle date, al modo in cui le notizie vengono percepite. A Rabaa el Adawyie, alContinua a leggere
Remare contro l’inquinamento: la missione di un uomo per proteggere i fiumi dell’Iraq per le future generazioni
Negli ultimi sette anni, Nabil Musa ha viaggiato per l’Iraq per promuovere l’importanza di mantenere puliti i corsi d’acqua per le attuali e future generazioni.
Viaggio all’Eden a "Le antiche vie dell’Hospitale"
 XIII incontro sulla Via di San Tommaso
XIII incontro sulla Via di San Tommaso
Villa san Tommaso Majano (Udine)
sulle antiche vie dell’Hospitale,
oltre Gerusalemme
sulle Vie Reali di Persia, vie della Seta,
verso l’altra metà del Mondo
PASSAGGIO IN AFGHANISTAN
ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
A SAN TOMASO DI MAJANO (UD)
Nel frattempo, nel pomeriggio, per i bambini presenti (0-90) laboratorio di aquiloni (l’Afghanistan è il paese degli aquiloni) a cura della Refugees Public School di OIA.
Ore 17.00 Afghanistan, storia, arte, cultura e poesia. Racconti e letture a cura della Refugees Public School di OIA con introduzione di Morena Maresia. Volontari, richiedenti asilo e afghani a cui è già stata riconosciuta la protezione internazionale leggeranno poesie e brani di Rahman Baba, Gialal al-din Rumi, Basir Ahang, Umar Khayyam, Tiziano Terzani e altri.
Ore 19.15 assaggi di cucina afghana a cura di Refugees Public School di OIA (**)
Ore 20.45 “Un altro Afghanistan, oltre il velo del tempo”. Identità etniche e frontiere culturali nel Pamir afghano. Conferenza di Giovanni Pedrini. Testimonianze di Maurizio Peselj e di Valerio Pellizzari che hanno vissuto e studiato la regione del Badakhshan, il corridoio del Wakhan nel Pamir tra Cina, Pakistan e Tagikistan.
Ore 17.30 “Afghanistan Crocevia dell’Asia”, barnabiti in terra afghana. Un altro modo di guardare l’Afghanistan e la sua storia. Incontro con lo scrittore Emanuele Giordana, dialoga con Giovanni Pedrini.
Ore 19.15 cena condivisa (*)
Ore 20.45 “Viaggio all’Eden” Da Milano a Kathmandu (Laterza 2017). Presentazione del libro di Emanuele Giordana. L’autore parlerà anche di progetti e collaborazioni attuali tra Italia e Afghanistan. A fine serata sono graditi interventi e racconti liberi di coloro che hanno vissuto esperienze similari.
“Ultima estate in suol d’amore” di Alma Abate
Dal blog “Con altre parole” di Beatrice Tauro
L’articolo “Ultima estate in suol d’amore” di Alma Abate sembra essere il primo su Arabpress.
Perchè i russi sono indifferenti al conflitto siriano?
“I tanti problemi che ci sono in Russia con i diritti e le libertà assorbono moltissimo tempo… non lasciando energie per le questioni internazionali lontane.”
Egitto in miseria: tolti i sussidi alimentari a chi guadagna più di 84 dollari al mese
mcc43 The New York Times: “Secondo un decreto governativo, pubblicato nel bollettino ufficiale martedì 8 agosto, le persone che guadagnano più di 1.500 pounds (circa 84 dollari) al mese saranno escluse dal diritto alla carta sovvenzionata per i generi di prima necessità; sarà inoltre limitata alle famiglie con un numero di componenti fino a quattro […]![]()
Il Libano e i soldati dello Zio Sam
Gli americani si preparano ad aumentare la loro presenza militare in Libano
L’articolo Il Libano e i soldati dello Zio Sam sembra essere il primo su Arabpress.
Per quelli che… rimandiamoli in Libia
mcc43 Storie per un’Europa più vecchia e gretta quanto più benestante e indifferente. Storie per noi, popolo di santi, poeti e navigatori secondo Benito Mussolini, mentre aggrediva l’Abissinia, e per i Francesi avvolti nella grandeur della Liberté Egalité Fraternitè del continuato saccheggio dell’Africa… Gebreel ha 28-anni, è nato sulle Montagne di Nuba in Sudan, dove il padre fu ucciso in un […]![]()
Oltre il bel tramonto
È una immagine che non parla solo di un bel tramonto. Parla di cambiamenti climatici che cominciano a incidere sulle nostre abitudini. Da sere le spiagge sono piene di famiglie. Non solo di ragazzi, come succede attorno a Ferragosto. Si sta sulla spiaggia a prendere aria, a prendere un poco di aria, vecchi e bambiniContinua a leggere
La visione del Qatar e l’alto prezzo da pagare
Doha gestisce la crisi diplomatica riscrivendo le regole della politica e delle relazioni internazionali
L’articolo La visione del Qatar e l’alto prezzo da pagare sembra essere il primo su Arabpress.
Serraj e Haftar da Macron: una farsa, non un summit
mcc43 Questo articolo di Times of Malta intitolato “A summit pantomine” riassume il ristagno della situazione in Libia, a fronte delle impressioni indotte dai media circa una situazione in via di evoluzione costruttiva. I rapporti fra i vari attori politici sono congelati al deprecato accordo del 2015 a Skhirat. Vedere La Libia e i giochi di […]![]()
È sufficiente cancellare il “premio dello stupro” in Giordania?
Dopo le richieste della società civile, le raccomandazioni della casa reale e la proposta del governo di abolire l’articolo 308 del Codice Penale, il Parlamento giordano ha abrogato la previsione di impunità per lo stupratore nel caso di matrimonio con la vittima
L’articolo È sufficiente cancellare il “premio dello stupro” in Giordania? sembra essere il primo su Arabpress.
Mauro Martini, in memoriam
Sono passati 12 anni dalla morte di Mauro Martini. “Perché ti illudi e resti ancora lì? Non lo sai che la cultura si fa fuori dalle università?” Roma, piazza Cavour. Per essere precisi, proprio sotto il Palazzaccio. O almeno, io quella passeggiata me la ricordo lì, proprio a piazza Cavour. Il tempo, il troppo tempoContinua a leggere
Libia: ne parliamo con Michela Mercuri
Da Sedici Pagine Iniziamo dalla fine. Chi governa in Libia oggi e come si è arrivati a questa situazione? Nel 2011 c’è stata un’azione unilaterale francese voluta dall’allora presidente Sarkozy per mettere le mani non solo sulle risorse energetiche libiche… Continue Reading →![]()
Al Jazeera, la storia continua
E così è ufficiale. Israele ha fatto partire la procedura per chiudere l’ufficio di Al Jazeera e revocare il permesso stampa della tv del Qatar, la prima tv panaraba nella storia dei media della regione. Lo ha confermato il ministro delle comunicazioni, Ayoub Kara. Chiusura non imminente, ha precisato alla Reuters, perché l’iter avrà bisognoContinua a leggere
Sogno americano*
 Greyhound coast to coast. La panamericana. Droghe e lotta armata. Allucinogeni e allucinati. Scuola di illegalità. Rimpatrio alla portoghese. L’ultimo capitolo di Viaggio all’Eden*
Greyhound coast to coast. La panamericana. Droghe e lotta armata. Allucinogeni e allucinati. Scuola di illegalità. Rimpatrio alla portoghese. L’ultimo capitolo di Viaggio all’Eden*
A quelli di noi cui andava stretto persino il Viaggio all’Eden, il volo magico che negli anni Settanta portava verso Kathmandu, si apriva anche un’altra pista. Era il viaggio negli States che proseguiva fino in Messico e da lì, attraverso il Centroamerica, lungo la Panamericana, nella lunga discesa che percorreva le Ande, attraversava la selva e la montagna, raggiungeva il deserto del Perù, risaliva in Bolivia, si allungava fino al Brasile. Era un altro viaggio, naturalmente, ma lo spirito non era per niente diverso. Chi aveva soldi comprava una macchina a New York e correva fino a Frisco, Sognando la California come gli italici Dik Dik avevano tradotto California Dreamin’, cantata dai Mamas and Papas o dai Beach Boys. Ma la maggior parte di noi, denari ne aveva meno e aveva fretta di raggiungere i posti da uno o due dollari al giorno (uscivano allora volumi col titolo South America on …. dollar a day, con cifre per tutte le tasche) e poiché il viaggio negli Usa era competitivo sul prezzo, si sceglieva di cominciare da Nord. Una volta guadagnata la Grande Mela, si saliva su un Greyhound, l’inconfondibile pullman col levriero, per fare in 10 giorni coast to coast. Negli anni Settanta, il volo Lussemburgo-New York costava appena 100 dollari e con altri 500 si poteva star via mesi. Gli Stati Uniti – la cui cultura underground era all’origine dei grandi movimenti degli anni Sessanta-Settanta poi declinati in chiave nazionale – erano solo una tappa veloce per gli squattrinati abituati ai prezzi indiani. Il fascino del rock, della letteratura Beat, dei santoni dell’Hyppismo restava confinato in un tributo ideale – leggere Kerouac o sentire Zappa – e venivamo trascinati inevitabilmente al Sur. Il Messico non era ancora stato sequestrato dalle narcomafie ma era saldamente occupato dalla mafia politica del Partido Revolucionario Institucional, che di rivoluzionario aveva solo il nome e longevità infinita. Laggiù, sorseggiando Tecate in lattina o Carta blanca in bottiglia, ascoltando le frequenze di Radio Mundo, fumando marijuana e andando in cerca del peyote, il cactus magico degli Huicholes, ci ammaestravamo con i libri di Carlos Castaneda, peruviano statunitense che ci aveva affascinato con gli insegnamenti di Don Juan, personaggio forse di fantasia che gli aveva fatto partorire 12 libri tradotti in 17 lingue. La sua «via Yaqui alla Conoscenza» (A scuola dallo stregone, 1968) era un’iniziazione allo sciamanesimo che andava a braccetto con la mistica che ci stregava in Oriente.
 |
| Illustrazione di Maurizio Sacchi. Sotto, a sn foto di Guido Corradi. Sotto a dx foto di Davide Del Boca |
La Panamericana si poteva attraversare con mezzi pubblici scalcinati, autostop che andava alla grande o treni merci frequentati da poveracci locali e da banditi che aspettavano il prossimo gonzo. Molte delle informazioni fondamentali riguardavano le droghe, le chiavi per aprire le Porte della Percezione che nelle Americhe non erano meno presenti che in Asia. Con quei viatici scendevamo fino alla bellissima Colombia in cerca di funghi allucinogeni e la miglior erba del mondo, giù fino alla Quito coloniale e verso le Ande peruviane in cerca del cactus San Pedro, che come il peyote contiene mescalina. Oppure verso l’Amazzonia in cerca della Ayahuasca, la liana degli spiriti dei morti, i cui viaggi allucinati necessitano un curandero. Infine, come tacere della cocaina e non certo quella in foglie masticata dagli indigeni delle Ande. La mafia colombiana con le sue alleanze trasversali ne aveva già fatto un lucroso commercio che partiva dalle raffinerie clandestine sparse nella foresta e che controllava coi suoi manovali assoldati a poco prezzo nei barrio marginali della grandi città o con accordi con la guerriglia che in Colombia controllava intere regioni e amministrava città, tasse, arruolamenti e coltivazioni.
 La rivoluzione era l’altra grande attrattiva di un continente dove gli scritti di Camillo Torres e Che Guevara avevano abbeverato i nostri sogni di giovani ribelli cui già sembrava che la revolucion cubana avesse tradito gli ideali originari. A quell’epoca il Nicaragua era ancora sotto il tallone dei Somoza, la Colombia era una fucina della guerra di guerriglia e in Bolivia la dittatura di Hugo Banzer aveva fatto fuori, una decina di anni prima, il mitico Ernesto detto “che” per quell’intercalare comune tra i porteños, gli argentini di Buenos Aires. Infine c’era stato il colpo di Stato in Cile che aveva assassinato Allende, fatto sparire centinaia di persone e scritto fine sulla via pacifica del socialismo nel Cono Sur. In Sudamerica c’era tutto e il contrario di tutto: la rivoluzione cubana e i forse inevitabili compromessi con l’Urss, i movimenti maoisti, la lotta armata, partiti populisti, puri e duri col fucile in spalla e paramilitari assassini, assoldati spesso dai cartelli della droga capaci di allearsi ora coi primi ora coi secondi sfruttando l’estesissimo odio del Sud per il Nordamerica, odio cui sfuggivamo proprio perché non eravamo yankee. Abimael Guzmán aveva da poco fondato Sendero Luminoso.
La rivoluzione era l’altra grande attrattiva di un continente dove gli scritti di Camillo Torres e Che Guevara avevano abbeverato i nostri sogni di giovani ribelli cui già sembrava che la revolucion cubana avesse tradito gli ideali originari. A quell’epoca il Nicaragua era ancora sotto il tallone dei Somoza, la Colombia era una fucina della guerra di guerriglia e in Bolivia la dittatura di Hugo Banzer aveva fatto fuori, una decina di anni prima, il mitico Ernesto detto “che” per quell’intercalare comune tra i porteños, gli argentini di Buenos Aires. Infine c’era stato il colpo di Stato in Cile che aveva assassinato Allende, fatto sparire centinaia di persone e scritto fine sulla via pacifica del socialismo nel Cono Sur. In Sudamerica c’era tutto e il contrario di tutto: la rivoluzione cubana e i forse inevitabili compromessi con l’Urss, i movimenti maoisti, la lotta armata, partiti populisti, puri e duri col fucile in spalla e paramilitari assassini, assoldati spesso dai cartelli della droga capaci di allearsi ora coi primi ora coi secondi sfruttando l’estesissimo odio del Sud per il Nordamerica, odio cui sfuggivamo proprio perché non eravamo yankee. Abimael Guzmán aveva da poco fondato Sendero Luminoso.
Il viaggio poteva finire bene o male a seconda dell’attività illegale intrapresa. Come e forse più che nel Viaggio all’Eden, il Sudamerica era in effetti una vera scuola di illegalità: traffico di stupefacenti, dollari falsi oppure perdita o furto fasullo di travelers cheques, “assegni turistici” assicurati che, dopo aver incassato l’equivalente mostrando la denuncia (vera) di furto o smarrimento (falsi), venivano poi incassati appena passata la più vicina frontiera nella prima banca dove avrebbero saputo forse solo un mese dopo di aver pagato una seconda volta cheque già rimborsati. Poteva finir bene anche con un altro sistema che, per noi italiani, si era poi dimostrato per anni un ottimo modo di tornare a casa come portoghesi a carico dello Stato. Come in India qualcuno aveva scoperto lo sportello ferroviario “per soli bianchi”, noi avevamo scoperto che le ambasciate italiche in Sudamerica potevano offrire un servizio di rimpatrio gratuito via nave agli emigranti italiani cui l’indigenza non consentiva di pagare il biglietto.
Chi dunque arrivava in Brasile senza ormai più una lira in tasca, andava a batter cassa al consolato
 |
| …ma il sogno restava Kathmandu… |
di San Paolo o di Rio piangendo in sette lingue e mostrando le foto dei parenti e le tasche bucate. Quei diplomatici che non avevano ancora conosciuto le orde di questuanti che affollavano le varie legazioni sulla rotta dell’Eden, compilavano il formulario di rimpatrio fino al porto di Genova con annesso biglietto ferroviario fino alla città natale. Senza ritegno sfruttavamo cinicamente l’antica miseria dei nostri migranti che all’inizio del secolo avevano cercato fortuna nel Nuovo Mondo con alterni destini. Era la scuola dell’Eden e stavamo già pensando a come tornarci perché si favoleggiava di una nave da Rio per Dakar e da lì a Bombay… Discoli, certamente, e sempre in compagnia di cattivi maestri, avremmo importato salsa e merengue, canti rivoluzionari, poncho di alpaca, frasi gergali imparate nel Salvador, cocaina e maria. E avremmo esibito un’altra sequela di tacche sul passaporto che, tra l’altro, nelle Americhe di visti non c’era bisogno. Fatta eccezione per gli Stati Uniti, che per rilasciarlo pretendevano che tu sottoscrivessi di non esser mai stato comunista. Beffare gli yankee con una menzogna burocratica era una delle nostre più grandi soddisfazioni.
Su quelle strade ripetevamo come un mantra l’ultima frase con cui Jack Kerouac aveva terminato Sulla strada – On the Road – uno dei nostri testi sacri: «Così in America quando il sole va giù e io siedo sul vecchio diroccato molo sul fiume a guardare i lunghi, lunghissimi cieli sopra il New Jersey e avverto tutta quella terra nuda che si svolge in un’unica incredibile enorme massa fino alla Costa Occidentale… nessuno sa quel che succederà di nessun altro se non il desolato stillicidio del diventare vecchi, allora penso a Dean Moriarty, penso persino al vecchio Dean Moriarty, il padre che mai trovammo, penso a Dean Moriarty».
* Questo capitolo (leggermente ridotto rispetto all’originale nel libro, è uscito venerdi 4 agosto su il manifesto)
Una lezione di civiltà dalle donne tunisine
Ricorderò il 26 luglio 2017 come un momento epocale, il giorno in cui il Parlamento tunisino ha approvato con 146 voti favorevoli la legge contro la violenza sulle donne. Nonostante la Tunisia venga considerata una pioniera nella difesa dei… Continue Reading →![]()
Afghanistan, la prima vittima della guerra di Trump
 |
| Trump. A sn John Nicholson. Sotto il trailer di War machine |
La prima vittima eccellente della nuova strategia della Casa bianca per l’Afghanistan potrebbe proprio essere la persona che ha sostanzialmente
chiesto al presidente un nuovo “surge”, con un maggior impegno di soldati e soldi a un capo dello Stato che, in campagna elettorale, voleva tirare via anche l’ultimo singolo soldato dal Paese dell’Hindukush.
Stando a un dispaccio di Reuters, in una burrascosa riunione il 19 luglio scorso col segretario alla Difesa James Mattis e il capo del Joint Chiefs of Staff (lo stato maggiore) Joseph Dunford, Trump avrebbe chiesto la testa di John Nicholson, che comanda nel Paese asiatico gli americani e la Nato dal marzo del 2016. La sua colpa? Non aver vinto la guerra… che adesso Trump invece vuole vincere senza indugi. Come? Non si sa. Il suo stratega Steve Bannon e il suo national security adviser H.R. McMaster hanno tentato di blandire Trump nel burrascoso meeting ma non sembra ci siano riusciti.
Se Nicholson sarà fatto secco si vedrà ma la cosa non piacerà al Pentagono. C’è una sorta di guerra tra il presidente e le istituzioni repubblicane. Probabilmente a Trump piace l’idea che la macchina della guerra si rimetta in moto con commesse e dunque lavoro ma non si fida né dei militari né della sua intelligence. A chi darà retta? Teoricamente a metà luglio avremmo dovuto sapere se è vero che gli Usa manderanno nuovi soldati e se è vero che chiederanno agli afgani di cambiare le regole della guerra che, almeno in teoria, ora prevedono che la catena di comando risponda in ultima istanza a Kabul. Si è anche ventilata l’ipotesi di una guerra per procura con i contractor. Ma sono tutte speculazioni e il presidente tace.
Silurare il capo locale dei soldati può essere un modo per far vedere che si ha la situazione in pugno ma non può bastare. Viene in mente il generale Stanley McChristall che, mandato a Kabul per vincere la guerra, si ritrovò sotto il fuco incrociato dopo che la rivista Rolling Stones aveva pubblicato un servizio in cui il generale non le mandava a dire. Fu licenziato e forse sapeva benissimo cosa sarebbe successo dopo le sue dichiarazioni. Forse voleva farsi cacciare. La sua storia è adesso un film (non particolarmente eccitante). La prossima puntata, con Nicholson protagonista, è ancora da scrivere.
Perchè in Yemen non interviene la “coalizione araba”?
Ad oggi nessuna soluzione sembra profilarsi per la crisi yemenita: nessun vincitore, nessun eroe, solo “vittime e carnefici”
L’articolo Perchè in Yemen non interviene la “coalizione araba”? sembra essere il primo su Arabpress.
Il sorriso di un bambino
Sono passati due anni dal conflitto armato in Yemen, un conflitto che ha devastato il paese. APPROFONDIRE Ma ciò che turba lo Yemen è il colera. Maggiori conseguenze ricadono sui minori e sugli adolescenti che è la fascia maggiormente colpita… Continue Reading →![]()
Bologna, 2 agosto 1980
Chissà, forse pensavamo di aver superato la fase più dura. La violenza politica che aveva segnato in modo indelebile la nostra adolescenza, e le stragi per mano ‘ignota’. Chissà perché, di quell’estate ricordo la sensazione che fosse in via di remissione una stagione. La memoria fa singolari selezioni, non sempre affidabili, ma la sensazione dellaContinua a leggere
Global Voices onora la vita dell’attivista digitale Bassel Khartabil, giustiziato dal regime siriano
Onoriamo il lavoro di Bassel, leader nel movimento per la rete digitale aperta, e tutti, persone e organizzazioni, che hanno lottato per la sua liberazione.
Macron il Libico: il restauro delle rovine della Francia
L’insuccesso della politica estera francese in Libia
L’articolo Macron il Libico: il restauro delle rovine della Francia sembra essere il primo su Arabpress.
In arrivo in libreria: “Passaggi in Siria” di Samar Yazbek e “Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città” di Khaled Khalifa
Per una strana coincidenza, tra settembre e ottobre 2017 escono in traduzione italiana due novità di narrativa siriana: Passaggi in Siria, di Samar Yazbek (Sellerio, trad. di Andrea Grechi) e Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città, di Khaled Khalifa (Bompiani, traduttore ancora ignoto). Yazbek e Khalifa sono due scrittori siriani contemporanei: la […]![]()
La privatizzazione degli enti statali
Dopo essere stato il mainstream degli anni ’80, la privatizzazione degli istituti pubblici è di nuovo al centro dei discorsi politici
L’articolo La privatizzazione degli enti statali sembra essere il primo su Arabpress.
Bella scelta, Google Camp!
Al Baglio San Vincenzo ci abbiamo trascorso due lunghe estati. Correva l’anno 2008, e l’estate era stata così calma, il mare per famiglie così rilassante, e soprattutto il tappeto di stelle così bello sopra di noi, sopra il Baglio immerso nella campagna tra Menfi e Sciacca, che l’anno dopo ci tornammo. Al Baglio. E allaContinua a leggere
Quando i capi di stato trascorrono le loro vacanze in Marocco
“Il più bel paese del mondo” non accoglie solo turisti anonimi. Negli ultimi decenni, presidenti, primi ministri e persino sovrani di tutto il mondo hanno fatto del Marocco la mèta delle loro vacanze.
L’articolo Quando i capi di stato trascorrono le loro vacanze in Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Da Raqqa con furore
 |
| Il sito di Amq, voce del “califfato” |
Colpire il nemico fuori dal teatro siriano iracheno. Punirlo per aver annunciato (alcuni giorni fa con un incontro stampa) la presa di Mosul. Attaccare un obiettivo che dia risalto mediatico all’azione esemplare. Sembra questo il ragionamento che ha portato ieri un commando dello Stato islamico, nella sua versione “Territorio del Khorasan”, ad attaccare l’ambasciata irachena a Kabul, nel cuore commercial diplomatico della capitale. Azione rapida e con meccanismi noti: un kamikaze vestito da poliziotto afgano si fa esplodere all’ingresso della legazione irachena; la porta si apre e un commando di tre uomini entra per fare strage. Ma le cose vanno male: un poliziotto viene ferito e mentre i guardiani dell’ambasciata impegnano il commando gli altri riescono a fuggire. Poi escono tutti mentre la legazione viene circondata e finisce sotto il fuoco incrociato della truppe speciali afgane. Dura circa quattro ore l’assedio al commando (dalle 11 del mattino alle 15), poi i tre vengono fatti fuori mentre l’agenzia Amaq, la sirena mediatica del califfato di Al Baghdadi, rivendica l’azione. Fortunatamente sfortunata. Il prezzo lo pagano soprattutto gli uomini del commando anche se due civili hanno perso la vita ed è sempre presto per sapere se non vi siano altre vittime. Le vittime civili della guerra, come ha appena denunciato il rapporto semestrale dell’Onu, sono quelle con i numeri più alti, in un conflitto che si è spostato sempre più nella capitale: degli 1662 morti nei primi sei mesi del 2017, il 20% ha perso la vita a Kabul.
L’attentato sembra indicare il desiderio dello Stato islamico di affermare la sua presenza nella guerra afgana nel tentativo di farla apparire come un pezzo della guerra globale volta alla riconquista di vecchi e nuovi territori della Umma sunnita. Ma la guerra afgana di Al Baghdadi segna pochi successi ed è particolarmente sotto tiro anche da parte dei talebani che non amano affatto questi jihadisti d’importazione che hanno reclutato vecchi quadri espulsi dal movimento o qualche clan, guerrigliero più per convenienza che per fede. Colpire l’ambasciata irachena, un obiettivo davvero inusuale nel panorama diplomatico della capitale, indica poi un cambio di strategia che esce dai binari che hanno sempre condotto le azioni verso la “zona verde”, una città nella città dove c’è il quartier generale della Nato e l’ambasciata americana, il “nemico lontano” per Al Qaeda, il nemico di sempre per i talebani che imputano a Washington l’escalation della guerra, pur coi suoi alti e bassi, e soprattutto la scelta di mantenere un’occupazione militare che, per quanto avallata dal governo locale, mostra sempre più la corda.
Per uscire dall’impasse gli americani stanno pensando a una nuova strategia che per ora è solo una sommatoria di indiscrezioni dove c’è tutto e il contrario di tutto: Trump avrebbe dovuto rendere noto il suo piano a metà luglio ma i giorni passano e la montagna non riesce a partorire nemmeno un topolino. Più soldati? Più aerei? Più omicidi mirati di leader guerriglieri? E come la mettiamo con la missione Nato “Resolute support” che, come dice il nome, dovrebbe essere di sola assistenza tecnica, senza sparare un colpo? Una missione che vede impegnati quasi mille militari italiani. Quanto alle indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi secondo cui truppe italiane e statunitensi sarebbero sbarcate a Farah (sudoccidente), lo Stato maggiore della Difesa ha precisato che attualmente non vi sono soldati italiani a Farah e che comunque le missioni italiane fuori da Camp Arena (base Nato del quadrante Ovest) «non prevedono l’uso delle armi» ma solo training e formazione. Non di meno, a metà agosto circa cento militari italiani si sposteranno a Farah una volta conclusa l’attività esterna di Train Advise e Assist a favore della 3ª brigata del 207˚ Corpo d’Armata dell’esercito afgano dislocata a Qual-eye-naw, 150 Km a Nord di Herat.
Il punto sulla Libia: la diplomazia di Macron ha davvero avuto successo?
Il premier francese è riuscito a fare un enorme passo avanti verso la risoluzione della crisi libica, laddove ONU e Paesi arabi limitrofi hanno fallito
L’articolo Il punto sulla Libia: la diplomazia di Macron ha davvero avuto successo? sembra essere il primo su Arabpress.
Urban Icon
The Dome of the Rock, by Joevito Nuccio
Athens and the Struggle for a Mobile Commons
Originally posted on Refugee Hosts:
In this piece, Tahir Zaman reflects on how new models of citizenship are up-ending the myopia of state-centric responses to displacement. In Athens, a ‘mobile commons’ is opening up, defined by sharing, solidarity and resistance to a state whose priorities reflect more the interests of international capital than the needs…![]()
L’addio all’opposizione armata in Siria
La Russia procede al disarmo dell’opposizione siriana in cambio di influenza e controllo dell’intero Paese
L’articolo L’addio all’opposizione armata in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Bahrain: Ebtisam Al-Saegh, l’attivista dei diritti umani, incriminata per terrorismo
Le autorità del Bahrein perseguitano da sempre l’attivista Al-Saegh per le sue attività di difesa dei diritti umani.
Dobbiamo prepararci per una epoca senza petrolio
Di Abdulrahman Al-Rashed, Asharq al-Awsat (29-07-2017). Il Bahrain era una volta un ricco mercato del commercio di perle. Un giorno le cose sono cambiate in quanto i giapponesi hanno scoperto alternative industriali più economiche e produttive. Il commercio principale del Bahrain è crollato, le barche da pesca si sono fermate e la regione del Golfo […]
L’articolo Dobbiamo prepararci per una epoca senza petrolio sembra essere il primo su Arabpress.
Italiani a Farah: assistere o combattere?
 In seguito alla minaccia di un possibile attentato talebano al governatorato di Farah, soldati italiani e americani si sono spostati nella provincia centroccidentale afgana che ricade sotto la responsabilità militare italiana del Regional Command West della missione Nato Resolute Support. I solerti PIO (Public Information Offfice), distaccati nei “teatri” dove è impegnato l’esercito italiano, solitamente pronti a informare di questa o quella visita e di quel corso di formazione, stavolta però la notizia non l’hanno trasmessa ai giornalisti del loro elenco. Resa nota dai media afgani, non c’è nemmeno nel sito della Difesa dove un’immagine di Gentiloni campeggia sull’approvazione della missione di sostegno alla guardia costiera libica. Bisogna dunque affidarsi alle fonti locali e al portavoce del governatore Nasir Mehri secondo cui americani e italiani sono arrivati aerotrasportati giovedi scorso nella capitale di provincia. Quanti sono non è dato sapere. Non è la prima volta che gli italiani sono a Farah da che la missione Isaf della Nato ha chiuso i battenti tramutandosi in Resolute Support, col compito di formare e assistere l’esercito afgano. Ma se dei bersaglieri dislocati a Farah all’interno di una forza di 200 uomini per lo più italiana qualche mese fa non si è saputo granché – anche allora la notizia era passata abbastanza inosservata – la differenza è che adesso il quadro è cambiato.
In seguito alla minaccia di un possibile attentato talebano al governatorato di Farah, soldati italiani e americani si sono spostati nella provincia centroccidentale afgana che ricade sotto la responsabilità militare italiana del Regional Command West della missione Nato Resolute Support. I solerti PIO (Public Information Offfice), distaccati nei “teatri” dove è impegnato l’esercito italiano, solitamente pronti a informare di questa o quella visita e di quel corso di formazione, stavolta però la notizia non l’hanno trasmessa ai giornalisti del loro elenco. Resa nota dai media afgani, non c’è nemmeno nel sito della Difesa dove un’immagine di Gentiloni campeggia sull’approvazione della missione di sostegno alla guardia costiera libica. Bisogna dunque affidarsi alle fonti locali e al portavoce del governatore Nasir Mehri secondo cui americani e italiani sono arrivati aerotrasportati giovedi scorso nella capitale di provincia. Quanti sono non è dato sapere. Non è la prima volta che gli italiani sono a Farah da che la missione Isaf della Nato ha chiuso i battenti tramutandosi in Resolute Support, col compito di formare e assistere l’esercito afgano. Ma se dei bersaglieri dislocati a Farah all’interno di una forza di 200 uomini per lo più italiana qualche mese fa non si è saputo granché – anche allora la notizia era passata abbastanza inosservata – la differenza è che adesso il quadro è cambiato.
Gli americani hanno fatto sapere che una nuova strategia è allo studio del presidente e del Pentagono: più uomini e più missioni aeree e un nuovo approccio molto combattivo in cui Washington vuole concordare con Kabul più mano libera nelle operazioni speciali. La Difesa americana ha chiesto alla Nato di appoggiare questo nuovo “surge” ma l’Italia ha risposto picche, perlomeno per quel che riguarda l’aumento del nostro contingente che è di circa mille uomini, il secondo per numero dopo quello statunitense. Inoltre, la missione Resolute Support è una “non combat mission” ossia una presenza di mera assistenza tecnica all’esercito afgano che prevede formazione e sostegno ma senza l’uso delle armi. Preparasi a resistere a un attacco della guerriglia però è qualcos’altro anche perché l’arrivo dei militari, stando a informazioni locali, riguarda anche l’impiego di velivoli – droni, elicotteri o caccia – in linea con un massiccio impiego dell’aviazione sempre più utilizzata dal nostro più potente alleato.
Non è stato inutile, lottare per Charlie Gard
Va bene, alla fine Charlie Gard lo hanno soppresso – nel suo «best interest», naturalmente – come volevano fin dall’inizio, avendo impedito al suo babbo e alla sua mamma di fare tutto quello che potevano (e che non era irragionevole) per cercare una sia pur improbabilissima cura. Ma le cose non sono andate come volevano […]![]()
Ordinaria barbarie sulle donne
 |
| Benazir Bhutto: la prima premier donna in Pakistan ma pochi cambiamenti nel Paese |
Un caso di ordinaria barbarie ai danni di due donne, una delle quali minorenne, stuprate nella provincia pachistana del Punjab è stato ieri preso in carico dal Chief Justice del Pakistan, la più alta carica del sistema giudiziario del Paese dei puri. Accanto a una delle ricorrenti pessime notizie che accompagnano la violenza contro le donne ce n’è dunque almeno una positiva. Un caso che rischiava di restare confinato in ambito locale è stato assunto motu proprio da Mian Saqib Nisar, costituzionalista non certo noto per essere un progressista ma che ha deciso di voler andare a fondo in questa terribile storia avvenuta nel cuore del Punjab e che il capo della giustizia pachistana ha appreso dai giornali.
Comincia a metà luglio in un campo di fieno della zona di Muzzafarabad un sobborgo della città di Multan. Una ragazzina di 12-13 anni, che i giornali locali chiamano F, viene violentata da un uomo. Due giorni dopo si riunisce il panchayat, il consiglio degli anziani della zona, che individua il colpevole e stabilisce la pena. Occhio per occhio: il fratello di F si deve vendicare con uno sturo equivalente su N, sorella diciassettenne del colpevole. Pena eseguita e, stando alla stampa locale, addirittura in presenza del primo violentatore e dei suoi parenti. Non è purtroppo una novità e i consigli degli anziani sono spesso accusati di applicare le leggi consuetudinarie in barba alle più elementari norme che regolano il pur modesto apparato difensivo pachistano nei confronti delle donne. Ma questa volta qualcuno non ci sta e viene sporta denuncia dai membri delle due famiglie agli agenti i cui uffici si trovano a Multan, nel Centro contro la violenza sulle donne. A quel punto si muove la polizia e comincia a far scattare le manette: per ora sarebbero già in carcere venti persone mentre proseguono le ricerche sugli altri componenti del panchayat (una quarantina) e mentre il caso arriva agli uffici giudiziari di Islamabad. I due violentatori sarebbero però ancora uccel di bosco.
 |
| La difficoltà di essere donna. Nell’immagine (Dfid Uk)FID ragazze a scuola nel Khyber Pakhtunkhwa |
Il panchayat (assemblea) è un sistema antico diffuso nel subcontinente indiano che resiste da secoli. E’ una delle tante forme di amministrazione del consenso e della giustizia che spesso sfuggono non solo al dettato legislativo nazionale ma persino agli ordini del clero. Ne esistono forme diverse a seconda della tradizione. Nel Nordovest pachistano, area abitata da popolazioni afgane, la jirga assume lo stesso ruolo. Proprio qualche mese fa una di queste assemblee di anziani condannò a morte un ragazzo che era stato ripreso da un telefonino mentre ballava con delle giovanette. Le ragazze sparirono e non è ancora chiaro se, dopo che il caso aveva interessato la magistratura, quelle che erano riapparse fossero davvero le vittime dell’anatema. Si teme siano state uccise. Ma queste punizioni del codice d’onore non fanno parte solo delle popolazioni afgane della montagna, confinate nelle cosiddette aree tribali e strenue avvocate della tradizione: il Punjab è il cuore del Pakistan moderno e Multan è una città di quasi due milioni di abitanti.
 |
| Qandel Baloch; libera e provocatoria. Suo fratello l’ha uccisa |
Un caso famoso (e denunciato) fu quello di Asma Firdous, una donna di 28 anni a cui, nell’aprile del 2011, due uomini tagliarono sei dita, il naso e sfregiarono labbra e braccia. Alla base c’era una disputa col marito e la vendetta si scaricò sulla ragazza. Il rapporto sulla violenza femminile relativo al 2010 e redatto dalla Commissione diritti umani del Pakistan, diceva allora che almeno 800 donne erano state vittime di “delitto d’onore” e punite con la morte mentre altre 2900 erano state violentate, al ritmo di otto al giorno. Il Punjab deteneva il primato. Ancor più noto del caso di Asma è stato quello di Mukhtar Mai, una giovane ragazza punjabi di Muzaffargarh che nel 2002 era stata violentata da quattro uomini per il sospetto di una presunta relazione tra il fratello minore di lei, Shakoor, e una parente. In realtà, grazie alla determinazione della ragazza, che non si suicidò per il disonore e anzi denunciò gli stupratori, si scoprì che l’accusa a Shakoor doveva in realtà coprire la violenza subita dal ragazzo stesso da parte di altri membri del clan. Ne venne fuori un libro (In nome dell’onore), una scuola per ragazze finanziata da Mukhtar Mai e Thumbprint, un’opera teatrale di respiro internazionale. Un altro caso recente è quello di Fouzia Azeem, più nota al grande pubblico come Qandeel Baloch, una giovane ragazza di 26 anni diventata un idolo in Pakistan per le sue performance video, le interviste scioccanti, il modo di esporre il corpo e le continue provocazioni. Suo fratello Waseem, reo confesso, l’ha prima drogata e poi strangolata nel sonno nella casa dei
genitori l’anno scorso sempre a Multan.
Lentamente però anche in Pakistan le cose cambiano: in termini di dati (1000 morti nel 2016) la situazione sembra stabile o peggiore ma è anche vero che ora le donne – anziché uccidersi come vorrebbe la consuetudine – denunciano e la magistratura, come in questo caso, interviene; si lavora su leggi che evitino la scappatoia del delitto d’onore che, ufficialmente, dovrebbe essere considerato un omicidio tout court. Strada in salita e non solo in Asia: nella civile Italia l’abolizione del “delitto d’onore” e del “matrimonio riparatore” è solo del 1981 e le donne che vengono uccise, assai spesso dai loro mariti, conviventi o ex, muoiono al ritmo di una ogni 3 giorni. Quasi 7 milioni, secondo l’Istat, le italiane che nel corso della propria vita hanno subito abusi.
Cucina siriana: “polo”, bevanda di limone e menta
Nelle calde estati di Damasco, è una delle bevande più bevute in tutti i bar e ristoranti: fresco, dolce e facilissimo da preparare, oggi vi proponiamo questa bevanda, conosciuta più comunemente in Siria come “polo”! Ingredienti: 1 litro d’acqua il succo di 5 limoni 70g di zucchero 50g di foglie di menta fresca qualche goccia […]
L’articolo Cucina siriana: “polo”, bevanda di limone e menta sembra essere il primo su Arabpress.
Ogni mattino un Egiziano si sveglia e sa che deve correre più in fretta della povertà…
mcc43 Era la fine del 2016, l’Egitto decise di lasciar fluttuare la moneta, necessario presupposto per ottenere dal Fondo Monetario Internazionale un prestito di 12 miliardi di dollari in tre anni. In un rapporto del Centro Egiziano per i Diritti Economici e Sociali (ECESR) si leggeva che questo avrebbe aumentato il tasso di povertà facendolo […]![]()
“La jihad delle donne. Il femminismo islamico nel mondo occidentale” di Luciana Capretti
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “La jihad delle donne. Il femminismo islamico nel mondo occidentale” di Luciana Capretti sembra essere il primo su Arabpress.
La richiesta di destituire Bashar Al-Assad è caduta: quali sono gli effetti a livello internazionale e regionale?
Di Omar Raddad. Al-Ray al-Youm (24/07/2017). Traduzione e sintesi di Cristina Tardolini Dichiarazioni occidentali e arabe indicano che ci sarebbe stato un rovesciamento nelle posizioni degli attori internazionali e regionali circa il futuro del presidente siriano Bashar al-Assad e del mantenimento del suo ruolo. La fine del regime infatti era stata chiesta e posta come […]
L’articolo La richiesta di destituire Bashar Al-Assad è caduta: quali sono gli effetti a livello internazionale e regionale? sembra essere il primo su Arabpress.
Viaggio all’Eden: venerdi 28 a Milano
 Cosa fu davvero il Viaggio all’Eden? Cosa eravamo noi, protagonisti inconsapevoli di un’epopea in
Cosa fu davvero il Viaggio all’Eden? Cosa eravamo noi, protagonisti inconsapevoli di un’epopea in
cui ognuno faceva la sua strada e il suo trip, parola inglese che significa viaggio in senso lato: a piedi, in macchina o con qualche mezzo psicotropo? Cosa siamo stati veramente? Fuor di dubbio fummo un pezzo di quell’avanguardia giovanile che sconvolse il mondo tra gli anni Sessanta e Settanta. Fuor di dubbio di quell’avanguardia fummo la frangia più anarchica e libertaria. Ma, alla fine della fiera, fummo anche l’avanguardia del turismo di massa e – proprio noi che viaggiavamo con consapevolezza, anticipando di trent’anni il turismo sostenibile ecofriendly – fummo anche gli araldi di una globalizzazione della valigia nel frattempo divenuta trolley. Quel vasto movimento di arrivi e partenze è senz’altro una risorsa ineludibile per tanti Paesi, ma è stata ed è – come un po’ abbiamo raccontato – anche il segno della sua rovina, della fine di un sogno tropicale…
Venerdi 28 luglio alle ore 19 al Rob de matt di Milano Via Enrico Annibale Butti 18 (traversa di viale Jenner) letture di Carlina Torta da Viaggio all’Eden
Tahrir a Gerusalemme?
Via i metal detector. Via anche le telecamere. Via le strutture d’acciaio, sul tipo delle ‘americane’ che si usano in teatro. Nessuno si attendeva che la crisi di Al Aqsa, a Gerusalemme, potesse registrare in meno di due settimane un primo, fondamentale traguardo. La situazione, certo, è ancora delicatissima, ma i fatti concreti ci sono.Continua a leggere
Dai faraoni, una lezione sulla persecuzione delle minoranze religiose in Egitto
L’Egitto sprofonda lentamente nel buco nero dell’intolleranza e l’incapacità dello Stato di proteggere i copti, l’imprigionamento coatto di membri della Fratellanza Musulmana e la volontà di deportare gli uiguri in Cina ne sono le prove inconfutabili
L’articolo Dai faraoni, una lezione sulla persecuzione delle minoranze religiose in Egitto sembra essere il primo su Arabpress.
Jerusalem logo
Mi sono imbattuta in questa foto su Twitter. È la conferma lampante che la Cupola della Roccia è ormai l’unico logo di Gerusalemme. Un logo in absentia, per gli israeliani ebrei. Come se nascondesse il primo e il secondo Tempio. Per i membri delle associazioni radicali, addirittura il Terzo Tempio. Per chi ne vuole sapereContinua a leggere
Ancora minacce agli avanzamenti democratici in Tunisia
Monica Marks ricercatrice associata al programma WAFAW (When authoritarianism fails in the Arab World) del Consiglio Europeo per la ricerca, titolare di una borsa Rhodes. Tra il 2012 e il 2016 ha condotto 1200 interviste in Tunisia nel quadro delle sue ricerche. La settimana scorsa è stata molto pericolosa per la fragile democrazia tunisina. Nei prossimi giorni due progetti di […]
I cultori dello scarto, ma designato come compassione
mcc43 da La cultura dello scarto Non è la prima e purtroppo non sarà neppure l’ultima, ma certamente è una triste vicenda quella del piccolo Charlie Gard. Vicenda complessa in cui si sono sovrapposti aspetti di varia natura, da quello scientifico a quello affettivo, e forse proprio per questo emblematica di un tempo come il nostro […]![]()
Libia: invito a elezioni anticipate
Per risolvere la crisi libica le parti hanno proposto le elezioni anticipate insieme alla cosiddetta “tabella di marcia” incostituzionale annunciata da Al-Sarraj
L’articolo Libia: invito a elezioni anticipate sembra essere il primo su Arabpress.
Il programma “arabista” del Festivaletteratura di Mantova 2017
La vostra blogger preferita (come chi? io, no?) si è spulciata per bene il programma del prossimo Festivaletteratura di Mantova (6-10 settembre 2017) alla ricerca degli incontri con gli autori arabi/di origine araba che sono stati invitati quest’anno, e di cui vi avevo parlato qui. Quindi eccolo qui di seguito*, giorno per giorno. Buona lettura! Mercoledì […]![]()
Gerusalemme: raccontare per capire
Da qualche giorno, accendo la radio e si parla di Gerusalemme. Il telegiornale parla di Gerusalemme. I giornali raccontano Gerusalemme. I riflettori sono puntati sulla città santa e divisa, capitale di tutti o di nessuno. Monte del tempio, spianata delle… Continue Reading →![]()
Il Vicolo cieco, Al Aqsa
mcc43 Questo articolo del blog L’altra Israele espone con grande chiarezza i fatti della crisi di Al Aqsa. Mi preme evidenziare l’incipit del racconto degli eventi: “Un paio di settimane fa un terzetto di arabi israeliani compie un attentato in prossimità della porta dei leoni, uno degli ingressi che porta alla spianata dove sorge la moschea […]![]()
Strage senza fine
 Dopo qualche settimana di apparente tranquillità la guerra afgana torna nella capitale con un’autobomba che il suo guidatore scaglia contro un autobus che sta portando al lavoro – sono le 6.45 del mattino – alcuni impiegati del ministero per le miniere e il petrolio. Non è una tecnica nuova e a farne le spese sono già stati lavoratori dei media o di altri ministeri. Ma non son certo gli alti papaveri dei dicasteri a perdere la vita in un attentato che avrebbe ucciso almeno 36 persone e ne avrebbe ferite altre quaranta anche se nel quartiere abita anche un alto dignitario del governo: Mohammad Mohaqiq, un mullah integralista che sta però dalla parte “giusta” della barricata. La responsabilità viene attribuita ai talebani che non sono comunque rimasti con le mani in mano nei giorni scorsi: la guerra in Afghanistan è pane quotidiano in tutto il Paese e non solo per la guerriglia. E’ di qualche giorno fa una polemica su “fuoco amico” americano che per errore avrebbe colpito militari afgani. Intanto c’è attesa sulla nuova strategia promessa da Trump che prevede un nuovo “surge” nel Paese dell’Hindukush. Ma il presidente fa melina tra indiscrezioni e speculazioni sul numero di soldati da inviare (4mila?) e se è vero che darà carta bianca anche a qualche società di contractor.
Dopo qualche settimana di apparente tranquillità la guerra afgana torna nella capitale con un’autobomba che il suo guidatore scaglia contro un autobus che sta portando al lavoro – sono le 6.45 del mattino – alcuni impiegati del ministero per le miniere e il petrolio. Non è una tecnica nuova e a farne le spese sono già stati lavoratori dei media o di altri ministeri. Ma non son certo gli alti papaveri dei dicasteri a perdere la vita in un attentato che avrebbe ucciso almeno 36 persone e ne avrebbe ferite altre quaranta anche se nel quartiere abita anche un alto dignitario del governo: Mohammad Mohaqiq, un mullah integralista che sta però dalla parte “giusta” della barricata. La responsabilità viene attribuita ai talebani che non sono comunque rimasti con le mani in mano nei giorni scorsi: la guerra in Afghanistan è pane quotidiano in tutto il Paese e non solo per la guerriglia. E’ di qualche giorno fa una polemica su “fuoco amico” americano che per errore avrebbe colpito militari afgani. Intanto c’è attesa sulla nuova strategia promessa da Trump che prevede un nuovo “surge” nel Paese dell’Hindukush. Ma il presidente fa melina tra indiscrezioni e speculazioni sul numero di soldati da inviare (4mila?) e se è vero che darà carta bianca anche a qualche società di contractor.
Dall’altra parte del confine intanto i talebani del Tehreek-i-Taliban Pakistan, i “cugini” pachistani della guerriglia afgana, hanno messo a segno l’ennesima strage a Lahore, città del Punjub, dove un attacco suicida che voleva colpire la polizia locale si è trasformato in una carneficina con almeno 26 vittime tra cui nove poliziotti.
In un caso e nell’altro – e così nella maggior parte delle azioni della guerra sui due fronti caldi – i civili continuano a pagare il prezzo più alto: in Afghanistan, secondo la missione Onu a Kabul, nei primi sei mesi del 2017 il numero di civili uccisi o feriti continua a rimanere elevato. Dal primo gennaio al 30 giugno ci sarebbero stati 1662 civili uccisi e 3581 feriti. I morti raccontano di un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo nel 2016. Il 40% sarebbero imputabili alla guerriglia talebana o allo Stato islamico mentre si ricorda che il solo attacco a Kabul del 31 maggio (senza paternità) ha ucciso 92 civili e ne ha feriti 500 conquistando il primato dell’attacco più stragista dal 2001. I talebani hanno preso le distanze dai dati di Unama contestandone i numeri e le responsabilità: citando le azioni delle milizie di villaggio (Arbakis) o i raid dei droni i cui effetti sono coperti da segreto militare.
RAQQA: L’ALTRA FACCIA DELLA LIBERAZIONE
Fino a qualche tempo fa, gli attivisti di Raqqa Is Being Slaghtered Silently (RBSS) erano portati in palma di mano da molti organi mainstream, fino ad essere insigniti dell’International Press Freedom Award nel 2015. Le loro corrispondenze clandestine da Raqqa, in cui, a rischio della vita, denunciavano i crimini e gli orrori commessi dai tagliagole […]![]()
Le mobilitazioni nel Rif e lo sciopero della fame nella storia del Marocco
Di Maati Monjib. Al-Quds al-Arabi (21-7-2017). Traduzione e sintesi a cura di Raffaele Massara. La scorsa settimana, l’attivista Rabii al-Ablaq è stato ricoverato a causa di un malore dovuto allo sciopero della fame: non è né il primo né l’ultimo caso. Come lui, anche Selima Ziani, ai più nota col soprannome di Sylia, ha annunciato tempo […]
L’articolo Le mobilitazioni nel Rif e lo sciopero della fame nella storia del Marocco sembra essere il primo su Arabpress.
Turchia e USA in Siria
L’inclinazione dei legami tra Ankara e Washington fa crescere i timori in Turchia rispetto alla sua influenza in Siria, soprattutto a seguito delle politiche del presidente Trump
L’articolo Turchia e USA in Siria sembra essere il primo su Arabpress.
Shahr-e Ketab e Diario Persiano
http://bookcity.org/detail/10548/root/papers
Non li abbiamo protetti, i nostri figli
Confesso un dolore, e una impotenza. In questa stagione di violenza, a Gerusalemme, gli agnelli sacrificali sono quasi sempre giovani. Ragazzi. E’ successo anche ieri. Tre ragazzi palestinesi ammazzati per mano israeliana, rispettivamente da un colono, la polizia di frontiera, l’esercito. Palestinese il ragazzo che ha ucciso tre coloni israeliani dentro un insediamento in Cisgiordania.Continua a leggere
Cucina sudanese: al-aswad, insalata di melanzane
La ricetta di oggi ci porta a scoprire un piatto sudanese (per la precisione, del Sudan del sud), il cui nome (al-aswad, “nero”) deriva dal fatto che il principale ingrediente sono le melanzane scure. Ecco come preparare questa deliziosa insalata! Ingredienti: 2 melanzane scure grandi 1 cipolla media 4 spicchi d’aglio 500ml d’acqua 2 cucchiai […]
L’articolo Cucina sudanese: al-aswad, insalata di melanzane sembra essere il primo su Arabpress.
La linea rossa, a Gerusalemme
Le immagini mostrano più delle parole, ormai da tempo. Mai, mai almeno negli ultimi 15 anni, Salaheddin Street è stata così simbolica. La strada commerciale di Gerusalemme est, la strada che conduce a una delle Porte della Città Vecchia meno conosciute ma più frequentate dalla popolazione palestinese. Salaheddin street, la strada che finisce, proprioContinua a leggere
Libya: A Controversy Around an Anti-Ibadi Fatwa
Libya has multiple governments and as such it has multiple poles of would-be official religious authority. One such body is the Supreme Committee for Issuing Fatwas (Al-Lajna al-‘Ulya li-l-Ifta’) connected to the Libyan Interim Government. That government is based in the northeastern city Al-Bayda and is associated with Khalifa Haftar, commander of the Libyan National Army.
Earlier this month, the Supreme Committee kicked off a tremendous controversy by issuing a fatwa (Arabic) that denounces the Ibadis, a non-Sunni, non-Shi’i Muslim sect prevalent in Oman and with a small but significant presence in parts of North and East Africa. The fatwa comes in response to a question about the permissibility of praying behind an Ibadi imam – effectively, a question about whether Ibadis should be considered genuine Muslims or not. The response reads, “Ibadism is a deviant, misguided sect. They are Kharijite Batinists. They hold infidel beliefs, such as their belief that the Qur’an is a created object, and their belief in denying that we will see [God in Paradise], so do not pray behind them and don’t esteem them.”
For context, “Kharijites” is a pejorative term that can refer to a specific early Islamic sect but that also can be used widely as a term of abuse. Describing the intricacies of the historical relationships between Ibadism and Kharijism is, I think, a task best left to specialists, so I won’t attempt it here. “Batinism,” meanwhile, is used here as a pejorative term meaning people who claim to see hidden messages in the Qur’an.
Turning back to the fatwa’s reception, negative reactions came immediately from Libyan Amazigh/Bergers, who saw the fatwa not just as a religious provocation but an ethnic one. Ibadism is sometimes associated with the Amazigh in Libya and vice versa. The Amazigh Supreme Council called the fatwa “a direct incitement for a genocide of the Amazigh people in Libya.” (Read a little background on the Ibadis in Libya here.)
Another negative reaction came from a rival governmental religious body, the Dar al-Ifta’ (House of Issuing Fatwas), whose legal status under the Government of National Accord is now somewhat unclear (it’s been reportedly shut down, but it’s still issuing statements). Although the Dar al-Ifta’ and Grand Mufti Sadiq al-Gharyani have a reputation in many quarters as divisive and even extremist, in this context the Dar al-Ifta’ presented itself as a non-sectarian force working for Libyan unity. In a statement (Arabic), Dar al-Ifta’ denounced the “sectarian chaos that simple-minded idiots and youngsters are trying to ignite among the Muslim citizenry.” (See also here.)
Other Libyan commentators have seen the fatwa as evidence of creeping Salafism/Wahhabism (Arabic) in Libya – for all that the eastern Libyan government and the forces of Haftar are often seen as anti-Islamist and even “secular,” there is a strong Salafi influence on those bodies.
Those are just a few of the reactions in an ongoing domestic controversy. It will be interesting to see whether the pressure and criticism elicit any changes on the part of the Supreme Committee or the eastern government.
Il governo palestinese sta preparando un “piano di emergenza” per sostenere Gerusalemme
Il Consiglio dei Ministri di Ramallah sta preparando un piano di emergenza facendo appello all’aiuto finanziario di tutti i Paesi arabi e islamici
L’articolo Il governo palestinese sta preparando un “piano di emergenza” per sostenere Gerusalemme sembra essere il primo su Arabpress.
Speranza e opportunità tramite il giornalismo per i rifugiati siriani in Giordania
Per i rifugiati siriani in Giordania, il programma radiofonico Syrians Between Us fornisce loro gli strumenti per raccontare le proprie storie.
Ginevra 7 nel disinteresse generale
Il settimo turno dei negoziati per il futuro della Siria si è svolto a Ginevra nell’indifferenza generale. Il mantenimento di Assad al potere è ormai indiscutibile, mentre si prospetta una scissione del Paese
L’articolo Ginevra 7 nel disinteresse generale sembra essere il primo su Arabpress.
La biblioteca di Amanullah
Risistemare la propria biblioteca è un lavoraccio ma anche un sistema piacevole per fare non solo ordine e polvere ma anche qualche piacevole scoperta. Vedi questo articolo sull’Afghanistan a firma Erodoto II uscito su Noi e il mondo, magazine de La Tribuna, giornale romano diretto da mio nonno Tullio Giordana.
Foto d’epoca tra cui re Amanullah e altro, con un invito all’Italia perché stringa rapporti con il re (ferocemente antibritannico).
La data è agosto 1925. Da notare l’artifico grafico “orientalista” della scritta Afghanistan nel titolo
Le stelle dell’estate: Omar Sharif
Sono passati due anni dalla scomparsa del grande attore egiziano
L’articolo Le stelle dell’estate: Omar Sharif sembra essere il primo su Arabpress.
Controversie culinarie. I segreti dei “mezze”
 Hummus, falafel, mezze. Viaggio storico-culturale tra i piatti più caratteristici della cucina mediorientale in compagnia di artisti, blogger, cuochi e rifugiate, un cibo che è spazio di incontro e scambio in tutto il bacino del Mediterraneo nonostante i conflitti che attraversano la regione.
Hummus, falafel, mezze. Viaggio storico-culturale tra i piatti più caratteristici della cucina mediorientale in compagnia di artisti, blogger, cuochi e rifugiate, un cibo che è spazio di incontro e scambio in tutto il bacino del Mediterraneo nonostante i conflitti che attraversano la regione.
Turchia: a un anno dal fallito colpo di Stato
La vittoria di Erdogan sul golpe ha sancito l’inizio di una nuova era per il popolo turco, ma la reazione del Presidente ha irrimediabilmente scosso gli equilibri su cui si fonda l’intera regione
L’articolo Turchia: a un anno dal fallito colpo di Stato sembra essere il primo su Arabpress.
Viaggio all’Eden a Levico Terme
Venerdì 21 luglio, a Levico Terme (ore 21 a Villa Sissi, Grand Hotel Imperial) Massimo Libardi e Fernando Orlandi dialogano del Viaggio all’Eden e degli anni Settanta con Emanuele Giordana. Organizzazione La piccola libreria.
Era davvero il viaggio della vita, ha scritto Enrico Deaglio. Un viaggio iniziato dopo che i Beatles andarono a meditare con Maharishi Mahesh Yogi.
Impossibile dire quanti, dall’Italia, partirono e quanti arrivarono alla meta: migliaia sicuramente, forse di più. Non era come andare a Londra, a New York o a Marrakech. Era un viaggio di mesi, da cui si tornava smagriti, diversi, cambiati. Più lenti, in genere.
Erano altri tempi, più o meno mezzo secolo fa, nella seconda metà del Novecento. La meta era lontana: l’India, il Nepal, l’Afghanistan. Le condizioni del viaggio erano disagevoli: niente aerei, carte di credito, cellulari e bed and breakfast; piuttosto (pochi) traveler’s cheque, scassati uffici del telegrafo, fermo posta, ostelli e tutte le malattie gastrointestinali in agguato. Le utilitarie Fiat non erano attrezzate, i più fortunati viaggiavano sul pulmino Volkswagen, se no erano bus, treni, autostop, con tanto di appuntamenti in caravanserragli.
Fu davvero una grande migrazione, ricordata da un prezioso Baedeker di ricordi,
Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu di Emanuele Giordana; lui – oggi giornalista specializzato in Paesi asiatici – fu uno dei pionieri. Non era per lavoro, non era per cercare fortuna, cose che gli italiani avevano nel sangue da sempre. Non era neppure il Grand Tour che i poeti inglesi dell’Ottocento, specie se di deboli polmoni, compivano nell’Italia degli archi e delle rovine per meditare sull’effimera gioventù. Fu piuttosto un viaggio interiore, individuale
e collettivo, alla ricerca di spiritualità, meditazione, allargamento della conoscenza e, soprattutto, una reazione alla vita materialistica, competitiva e violenta, che si conduceva in occidente.
(dall’invito per la serata)
I nodi della cattiva Storia, a Gerusalemme
Chi ha vissuto a Gerusalemme sa che è proprio Gerusalemme la linea rossa da non superare. Quello che sta succedendo in Città Vecchia è una miccia già accesa. Ma la prudenza non c’è, di questi tempi. E la ‘guerra civile’, stavolta, rischia di scoppiare. Se i fatti sono simboli che narrano una storia più complessa,Continua a leggere
Egitto, Libia e il ruolo della Corte Penale Internazionale
Il tentativo di deturpare il ruolo della Corte Penale Internazionale con l’accusa di istituzione politica da parte di alcuni governi dittatoriali è alla base della demolizione della regione
L’articolo Egitto, Libia e il ruolo della Corte Penale Internazionale sembra essere il primo su Arabpress.
Supporting refugee livelihoods or host stability? The two sides of the coin
For many refugees, the humanitarian programmes focusing on “livelihoods” end up having merely an “accessory” role rather than generating sustainable labour. Civil defence members and civilians put out fire at a camp for Syrian refugees near the town of Qab Elias, in Lebanon’s Bekaa Valley, July 2, 2017. Picture by HASSAN ABDALLAH/Reuters/PA Images. All […]![]()
Egitto – La guerra contro i poveri del regime egiziano: quando la polizia uccide per il decoro
Vogliono sgomberare l’isola di Warraq ad ogni costo per venderla come Tiran e Sanafir! Noi non lasceremo l’isola di Warraq. Noi moriremo sull’isola di Warraq! Warraq è una piccola isola sul Nilo a nord del Cairo popolata da migranti provenienti … Continue reading →
Crisi del Golfo: quale parte sta ingannando l’altra?
Il punto sullo scontro diplomatico tra Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto contro il Qatar, che sta assumendo sempre di più i caratteri di una telenovela
L’articolo Crisi del Golfo: quale parte sta ingannando l’altra? sembra essere il primo su Arabpress.
Un artista siriano ridisegna i potenti della terra come rifugiati vulnerabili
“Quei leader erano in parte responsabili per l’esilio siriano. Forse così capiranno come ci si sente ad essere vulnerabili.”
Egitto, con l’attacco di Hurghada un altro affronto al rilancio del turismo: il 2017 non è più l’anno della svolta
“Non voglio gli egiziani, non è voi che cerchiamo”. La frase che, secondo i testimoni oculari, sarebbe stata pronunciata dall’attentatore di Hurghada, suona come uno smacco, un affronto contro i piani del governo egiziano che sembrava aver scelto il 2017 come l’anno definitivo per il rilancio del turismo. Al momento non c’è ancora nessuna rivendicazione […]
L’articolo Egitto, con l’attacco di Hurghada un altro affronto al rilancio del turismo: il 2017 non è più l’anno della svolta proviene da Il Fatto Quotidiano.
Cosa ci guadagna Washington dalla crisi del Golfo?
L’atteggiamento pacificatore degli USA, che però non trova pieno riscontro nelle attività americane con il Qatar
L’articolo Cosa ci guadagna Washington dalla crisi del Golfo? sembra essere il primo su Arabpress.
Holy (and cruel) basin – 2
Imagine a new paradigm for Israel/Palestine. Imagine today a new paradygm for Jerusalem. The Holy Places. How many hobstacles would you find? These are few lines I wrote some months ago, after my recent journey in the Middle East and my visit to Jerusalem. I visited the Haram al Sharif, in November, and I metContinua a leggere
Holy (and cruel) basin
“any concession or abrogation of existing rights tended to become the thin end of a wedge before which other rights were apt to disintegrate. Chairs, they feared, would become wooden benches, wooden benches iron benches, iron benches fixed stone benches, with the corollary that covering from above against sun and rain and from the sideContinua a leggere
“Essere amiche a Kabul” di Deborah Rodriguez
Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro
L’articolo “Essere amiche a Kabul” di Deborah Rodriguez sembra essere il primo su Arabpress.
L’accordo sul fronte sud della Siria: quali possibilità?
Di Omar Raddad. Al-Ray al-Youm (12/07/2017). Traduzione e sintesi di Cristina Tardolini. L’accordo USA-Russia-Giordania sulla Siria è stato annunciato durante il vertice del G20 tra i presidenti Trump e Putin, subito dopo il fallimento del quinto ciclo di negoziati di Astana per discutere i dettagli della tregua nel sud del Paese. La conclusione degli accordi […]
L’articolo L’accordo sul fronte sud della Siria: quali possibilità? sembra essere il primo su Arabpress.
Gaza deve vivere per la vita di tutta la Palestina
 La vita della popolazione di Gaza è seriamente messa in pericolo e noi, cittadini/e del mondo, associazioni, gruppi, non credenti e credenti di fedi diverse, sentiamo la responsabilità di agire laddove le Risoluzioni hanno fallito, e porre all’attenzione internazionale questo lento genocidio.
La vita della popolazione di Gaza è seriamente messa in pericolo e noi, cittadini/e del mondo, associazioni, gruppi, non credenti e credenti di fedi diverse, sentiamo la responsabilità di agire laddove le Risoluzioni hanno fallito, e porre all’attenzione internazionale questo lento genocidio.
La violenza ad Arsal ci ricorda quanto siano vulnerabili i rifugiati siriani in Libano
Qualsiasi cosa sia accaduta, dobbiamo riconoscere che le reazioni scatenate dopo questi attacchi, per i quali i rifugiati siriani sono tutti presunti colpevoli, sono disumane.
I giornalisti yemeniti, incastrati nel conflitto tra coalizione saudita e i ribelli Huthi, chiedono aiuto
La libertà di stampa nello Yemen rischia di scomparire per sempre.
Venice in peril
Ho visitato la bellissima mostra di tappeti alla Ca’ d’Oro e mi sono fermata nel magnifico chiostro a pianterreno, coi suoi pavimenti coperti di mosaici strabilianti, la vera da pozzo nel cortiletto in cui si affacciano bifore delicate; lontano dalla quotidianità di Venezia, dove i turisti ti sbattono addosso i loro zaini nei vaporetti, orde di … Continua la lettura di Venice in peril →
Mosul libera. Quali prospettive?
Il conflitto apertosi dopo la liberazione di Mosul sarà tra l’Iran e gli Stati Uniti
L’articolo Mosul libera. Quali prospettive? sembra essere il primo su Arabpress.
Afghanistan. E se mettessimo un Viceré con esercito privato?
 |
| Lord Mountbatten, ultimo Viceré in India |
Sarà una nuova guerra, una guerra “speciale” e forse anche “privata”, con modalità già testate dall’Irak allo stesso Afghanistan. Ma se i contractor son sempre stati un riempitivo dei conflitti per la logistica e la sicurezza, davanti a caserme e ambasciate, la nuova strategia del Pentagono, non ancora ufficiale ma inesorabilmente annunciata dalle indiscrezioni, potrebbe prevedere che la guerra per procura affidata a mercenari diventi uno dei nodi della pianificazione del nuovo “surge” afgano. La notizia filtra sulla stampa americana mentre la ministra Pinotti si trova negli Stati Uniti per un incontro con il suo omologo James Mattis che – ha spiegato la ministra – oltre alle vicende siriane è servito per “rimodulare” il contributo italiano pari oggi a poco meno di mille soldati schierati a Herat, il secondo contingente straniero dopo quello statunitense. Le indiscrezioni fanno due nomi pesanti: Erik Prince, il fondatore della famigerata Blackwater e Stephen Feinberg, un miliardario proprietario della DynCorp International, “gigante” – scrive il New York Times – del comparto militare privato. Per ora saremmo solo a suggerimenti richiesti però da due spalle importanti di Trump: Steve Bannon, responsabile delle strategie del presidente e poco favorevole e all’invio di soldati in Afghanistan, e Jared Kushner, senior adviser di Trump e marito di Ivanka. Il piano ha comunque già un nome: “Laos Option”, richiamo alle operazioni segrete scatenate nel Paese confinante col Vietnam per mettere in difficoltà i vietcong.
 |
| Lord Aucklan, governatore del Raj amministrato dalla Compagnia delle Indie. Invase l’Afghanistan. Sotto: Mc Arthur |
L’uso dei contractor potrebbe forse far rientrare i dubbi di Bannon e dei molti che temono una nuova
escalation e dunque nuovi morti tra i soldati a stellestrisce, ma non piace troppo né ai vertici militari in divisa né ai militari, come Mattis o McMaster – consigliere per la sicurezza nazionale –, che vestono adesso panni civili. Sono loro i sostenitori del nuovo impegno che dovrebbe coinvolgere 4 o 5mila soldati americani e qualche altro migliaio di militari Nato anche se per ora continuano a rinviare dichiarazioni ufficiali e numeri. Temono però, non solo i guai che i mercenari hanno combinato in passato, ma soprattutto la possibile erosione del controllo del Pentagono. Il piano, prevede infatti che i “privati” non si limitino a sicurezza e logistica ma anche a operazioni “speciali” ad alto rischio in stretta collaborazione con la Cia. Prince del resto non fa mistero delle sue idee: in maggio ha scritto sul Wall Street Journal che, in una guerra già costata agli Usa 828 miliardi, oltre 2mila soldati uccisi e 20mila feriti, serve un “modello Mc Arthur”, il generale americano che alla fine della seconda guerra mondiale governò il Giappone come un proconsole: esautorò l’Imperatore ma si servì però di soldati americani non certo di privati. Prince immagina invece un “viceré” forse sul modello dell’incarico affidato, dopo l’invasione dell’Irak, a Paul Bremer, il proconsole di Rumsfeld. Scegliere la parola “viceré” fa pensare, più che a Louis Mountbatten, l’ultimo viceré dell’India britannica, ai governatori generali (o viceré) della Compagnia delle Indie, a tutti gli effetti una società commerciale che impiegava un esercito privato. L’idea del vicereame afgano sedurrà Trump?
 Stando alle dichiarazioni di Pinotti, Trump avrebbe invece sedotto gli italiani solo in parte. E l’Italia si opporrebbe all’invio di nuovi soldati in Afghanistan, decisione che richiederebbe un passaggio parlamentare che probabilmente non andrebbe a buon fine. Non tanto forse per una attenta coscienza della guerra quanto perché si presterebbe a creare un ennesimo ostacolo sull’impervio cammino di Gentiloni. Per ora si parla solo di rimodulare e cambiare funzioni. Come si vedrà.
Stando alle dichiarazioni di Pinotti, Trump avrebbe invece sedotto gli italiani solo in parte. E l’Italia si opporrebbe all’invio di nuovi soldati in Afghanistan, decisione che richiederebbe un passaggio parlamentare che probabilmente non andrebbe a buon fine. Non tanto forse per una attenta coscienza della guerra quanto perché si presterebbe a creare un ennesimo ostacolo sull’impervio cammino di Gentiloni. Per ora si parla solo di rimodulare e cambiare funzioni. Come si vedrà.
Gli autori arabi ospiti del Festivaletteratura di Mantova 2017
Al prossimo Festivaletteratura di Mantova (21° edizione, che quest’anno si svolge tra il 6 e il 10 settembre) sono diversi gli autori provenienti dal mondo arabo che saranno ospiti. Ancora non è uscito il programma, che verrà reso noto a fine luglio, ma intanto vi illustro chi sono i “nostri” autori e cosa verranno a […]![]()
Fuoco e cenere, ma il Vesuvio non è il colpevole
mcc43 Il 5 luglio 2017 il Ministero degli Interni, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, ha inviato un fonogramma ai sindacati di categoria: «Si comunica che la Regione Campania, più volte sollecitata, ha rappresentato la propria indisponibilità alla stipula di una convenzione che preveda il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco nelle attività di lotta attiva […]![]()
Egitto – Per quanto possa essere lunga la tua notte, tutto passa
Pubblichiamo una lettera scritta dalla compagna avvocata egiziana Mahienour in cui ricorda della sua prigionia, della solidarietà tra le compagne di cella, delle lotte e della brutalità del sistema di repressione del regime di al-Sisi e dei militari che lo … Continue reading →
La dolorosa mutazione di Ennahda in Tunisia
Thierry Brésillon Nel maggio 2016 Ennahda ratificava una riforma di fondamentale importanza, determinante sia per il proprio futuro che per l’evoluzione dell’islam politico in un nuovo contesto post-autoritario. Essenzialmente si trattava della trasformazione di un movimento, nato a partire dagli anni ’70 come resistenza culturale alla modernizzazione all’occidentale voluta da Habib Bourghiba e passato all’azione politica negli anni ’80, in […]
Una marcia per la giustizia in Turchia
Non ci si aspettano miracoli improvvisi, ma di certo la Turchia non è la stessa dopo la marcia del CHP
L’articolo Una marcia per la giustizia in Turchia sembra essere il primo su Arabpress.





































